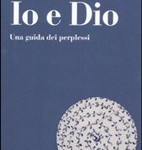TRENTI Zelindo, Dire Dio. Dal rifiuto all’invocazione, Roma, Armando, 2011
“Dire Dio”, oggi, riguarda fortemente il credente, sia quello dotto e specializzato, sia quello di ordinaria cultura, ma desideroso di rendersi ragione di ciò che afferma con la sua fede.
Come il credente “colto” può dire Dio nel mondo culturale contemporaneo?
E’ una domanda che impegna l’autore da tanti anni, nelle sue ricerche, nel suo magistero come docente di Pedagogia Religiosa presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Salesiana di Roma, nelle sue pubblicazioni.
Il saggio, estremamente rigoroso, è condotto a partire da sollecitazioni di alcuni autori contemporanei particolarmente significativi. Costituisce un percorso carico di suggestioni per tutti i credenti, portando a scoprire, in alcuni filoni di pensiero, tracce e inviti ad un discorso, ad un linguaggio, a categorie espressive che consentano di “dire Dio”.
Non vuole tanto essere, secondo lo stile di Trenti, un discorso unilateralmente conclusivo, quanto piuttosto il suggerimento di una pluralità di linee di ricerca lungo le quali poter percorrere un cammino personale ma garantito dall’autorevolezza di pensatori che hanno inciso a fondo sulla filosofia contemporanea.
La provocazione al credente può venire da svariate affermazioni. Può essere quella più immediata e scontata del non credente che afferma: “Crediamo nella constatazione dei fenomeni naturali stabiliti dalla scienza, in quel che è verificato da studi storici e sociali, nell’opportunità di alcuni valori naturali ecc” (Savater 2007), o quella più sottile di Cavalcanti che “passò la vita a cercar se trovar si potesse che Dio non fusse” e che, in questo modo puntualizza la sfida dell’uomo di sempre contro una presenza sentita come soffocante rispetto all’aspirazione ad essere “assolutamente” se stesso, sciolto da qualsiasi legame. Aspirazione ripresa da Sartre: “l’uomo ritrovi se stesso e si persuada che nulla può salvarlo da se stesso, fosse pure una prova valida dell’esistenza di Dio”.
Oltre che affermazione di merito, quella di Sartre è anche affermazione di metodo. Dio è fuori tema! Il tema è l’uomo!
Trenti, a questo punto, fa proprio l’interrogativo di Pascal: “Se l’uomo è fatto per Dio, perché così contrario a Dio; e se non è fatto per Dio, perché così infelice senza Dio?” (Pascal, 367).
La domanda su Dio attiene alla dimensione esistenziale, non è una curiosità intellettuale o, meno ancora, argomento di conversazione salottiera o da talk show televisivo.
L’intento dell’autore non è né polemico né apologetico. Gli interessa esplorare il pensiero contemporaneo, perché esso costituisce l’ambito del nostro pensare, del nostro parlare, del nostro comunicare.
Il punto di partenza del saggio può essere considerato: il credente di fronte al mistero.
Una prima presa di distanza: il mistero non viene rifiutato nell’illuministica prospettiva di essere identificato con la tenebra che verrà dissipata dalla luce progressivamente penetrante della ragione.
Al contrario, il mistero, proprio perché non è commisurato all’uomo, costituisce una provocazione esistenziale per lui.
La filosofia, dal canto suo, con esiti diversi, continua a tematizzare Dio. Il credente tenacemente ne riafferma la presenza nella sua vita. Sono dati di fatto.
Il credente sente che non basta il percorso storico di un umanesimo radicale, ma non basta neppure una via esclusivamente razionale per radicare la fede.
Il pensiero contemporaneo sembra privilegiare altre vie, che l’autore propone di esplorare.
Il primo approccio è col pensiero di Heidegger. L’analisi del suo pensiero viene condotta su un’opera della maturità dell’autore: i due volumi su Nietzsche.
Nietzsche ha affermato: “Dio è morto”; Heidegger afferma perentoriamente che ciò è dovuto al fatto che la cultura occidentale ha perso il contatto col suo fondamento, l’essere.
La metafisica ha spostato la sua ricerca sull’ente che è diventato il suo interrogativo conduttore (Leitfrage) e ha omesso l’interrogativo di fondo (Grundfrage).
Da questa asserzione fondamentale, si deduce, secondo Trenti, che la cultura occidentale ha smarrito la traccia di Dio.
Approfondendo questa nuova prospettiva, l’analisi portata sugli enti scopre in essi la traccia dell’essere, i segni della sua presenza. Una presenza che non ha altra via per manifestarsi che l’ente. Addirittura, l’essere, mentre ne promuove la manifestazione, si sottrae e si rende inafferrabile.
Il pensiero di Heidegger intende restituire alla realtà fondante, l’essere, la piena iniziativa; ne fa il riferimento ultimo e definitivo, che fonda l’esistenza dell’uomo, al quale è affidato il compito di interpretare e rivelare l’essere stesso.
L’essere, fondante e nascosto, è alla base. In questa realtà reale e nascondentesi va collocata la ricerca sulla condizione di mistero che avvolge l’uomo e sul significato esistenziale che ha per lui.
L’essere non è il risultato del pensiero dell’uomo. Ma l’uomo è prodotto dell’essere e, attraverso il linguaggio, è in grado di stabilire una relazione con l’essere.
L’essere, d’altro canto, si può manifestare solo attraverso gli enti.
Heidegger intende restituire alla realtà fondante, l’essere, la piena iniziativa; ne fa il riferimento ultimo e definitivo, che spiega anche l’esistenza dell’uomo, al quale affida il compito di interpretare, rivelare, l’essere stesso nel suo operare.
Heidegger vuole sottolineare che la rivelazione è iniziativa dell’essere e tuttavia l’uomo vi conserva una parte risolutiva: si trova in questo stretto crinale che vede emergere la realtà dall’iniziativa dell’essere, che però sottrae se stesso ad ogni manifestazione.
L’uomo, per Heidegger, è caratterizzato dal linguaggio. Il linguaggio diventa la modalità del suo rapportarsi all’essere.
Heidegger trova che è il linguaggio poetico quello che consente all’uomo questo approccio.
Il linguaggio poetico è essenzialmente evocativo; è in grado di lasciar trasparire e presagire una realtà che fonda le cose e contemporaneamente le trascende.
Ma la prospettiva può essere contemporaneamente rovesciata: il linguaggio come evento dell’essere aperto all’esistenza umana. L’uomo è custode di questa emergenza dell’essere.
Il linguaggio poetico è, a sua volta, evento che lascia trapelare la verità delle cose e manifesta la presenza dell’essere.
Il pensiero di Heidegger è alimentato dalla riflessione nihilista nietzchiana e ne condivide il sentimento di precarietà. In questa condizione di indigenza radicale si situa il ricorso al fondamento. E’ immediatamente percepibile la fecondità di questa intuizione per la ricerca delle condizioni del “dire Dio”.
Per Heidegger, l’uomo sosta come in un’attesa trepida e vigilante d’una rivelazione, che albeggia sempre senza mai illuminarsi.
Si nota che nella parte del saggio dedicata al confronto con Heidegger compaiono riferimenti alla interpretazione di Vattimo, che pure risulta suggestiva per discorso avviato da Trenti.
Insistiamo: Trenti non pretende di battezzare Heidegger; rileva che la sua grande incidenza sulla filosofia contemporanea non esclude, ma consente uno spazio per pensare il mistero e per cogliere un’allusione alla fede religiosa in Dio.
Un’altra suggestione di decisiva rilevanza deriva dalla riflessione ermeneutica, della quale Heidegger è stato maestro.
Trenti introduce a questa dimensione mettendo in evidenza come la sensibilità culturale contemporanea è centrata sull’uomo: da lui parte e a lui ritorna.
Il problema della verità non è più un itinerario della ragione astratta; è un compito di una ragione esistenzialmente impegnata.
Il problema uomo diventa riferimento centrale per ogni ulteriore analisi, compresa quella definitiva sull’essere e sulla verità.
E’ l’uomo che costituisce la domanda e che costruisce il percorso conoscitivo.
La ricerca della verità passa per il filtro dell’esistenza personale. A questo proposito, Trenti fa esplicito riferimento a Kierkegaard.
Il problema del dire Dio si distacca dal procedimento della razionalità funzionale proprio della scienza per assumere la dimensione esistenziale: Dio per l’uomo. Trenti valorizza, in questo contesto, la riflessione antropologica di Scheler. Dio è affermato perché compimento definitivo dell’uomo.
Altro aspetto rilevante è lo spostamento, accentuato dal contributo del pensiero di Martin Buber, dalla centratura sull’individuo a quella sulla relazione interpersonale.
Nel rapporto io-tu, nota Buber, si va con la totalità dell’esistenza. L’esigenza che si impone nel rapporto interpersonale diventa traccia nella ricerca del Tu assoluto.
Dall’insieme delle suggestioni, l’autore afferma che il tema della trascendenza resta da impostare in maniera esistenziale, sia come dato connaturale e costitutivo del vivere umano, sia come insito nell’esistenza ed emergente come presagio.
Si impone l’analisi di “ciò che sono e dei richiami interiori da cui sono attraversato”. Non sono le vie razionali della tradizione quanto piuttosto la coscienza di quanto si vive che porta il richiamo di Dio e consente di affermarlo.
E’ all’interno dell’analisi del mistero che la sua presenza può proporsi, nella libertà di accoglierlo o di negarlo.
Ritornando al processo ermeneutico, si rileva che esso si situa dentro una concezione del linguaggio nuova rispetto a quella tradizionale.
Il linguaggio, più che uno strumento, diventa la condizione del pensare la realtà e del nominarne ciascuna entità, ancora, del comunicare la conoscenza e della partecipazione.
L’uomo è responsabile dell’interpretazione.
Questa istanza fa autorevole riferimento oltre che ad Heidegger anche a Gadamer e a Ricoeur.
L’altra accentuazione, collegata a questa linea di riflessione, è quella legata all’oggetto, l’andare alle cose.
La prospettiva ermeneutica conduce su una traccia feconda. Emerge l’affermazione di una realtà oggettiva che precede l’uomo, ma emerge con altrettanta forza la presenza di una soggettività che tenacemente vuole progettare se stessa. E’ questo il risultato di una ricerca che pone al centro l’esperienza esistenziale umana.
La problematica esistenziale rileva da sempre il dato della finitudine dell’esperienza umana e dell’inappagamento delle sue aspirazioni.
Sulla base di queste considerazioni si può affermare che la trascendenza è chiamata in causa perché l’esistenza non sembra in grado di dare ragione di se stessa. Il richiamo al mistero sembra essere la via, anche se non dicibile in termini empirici.
Trenti dedica una parte consistente del saggio ad una trattazione del processo ermeneutico, dall’esperienza problematizzante del credente al confronto con i testi della tradizione credente. Il riferimento privilegiato è all’elaborazione di Ricoeur e di Gadamer.
Per quanto riguarda le modalità del linguaggio religioso, dopo aver accennato al mito e al rito, l’attenzione viene posta sul simbolo che costituisce una modalità espressiva più interiore e penetrante di dire il divino. Segue un’ampia analisi della simbologia prevalentemente biblica.
Tornando sulla constatazione della finitudine e dell’insoddisfazione, si apre per il credente la strada dell’invocazione di una trascendenza. E’ un procedimento che non risulta tanto come frutto di un ragionamento astratto dalle vicende esistenziali, quanto da un’autocomprensione che coinvolge interamente la concreta esistenza.
Per il credente la trascendenza diventa incontro con la realtà religiosa: dalla certezza e fiducia conferita alla realtà sensibile (Savater) si passa alla certezza e fiducia conferita alla realtà trascendente (credo in Dio). Questa asserzione non implica che l’uomo religioso non apprezzi la realtà nella quale è immerso. Ha una ragione diversa per apprezzarla: la realtà sperimentabile empiricamente diventa segno e richiamo della realtà definitiva.
Per l’approfondimento antropologico e fenomenologico dell’atto di fede viene fatto ricorso al contributo di Max Scheler, che viene ampiamente esposto e analizzato.
Successivamente si passa alla valorizzazione del contributo derivante dal pensiero di Martin Buber, nella sua peculiare prospettiva dialogica. Per Buber la persona umana è costitutivamente in relazione.
La relazione è costitutiva, a partire dall’aria che respiriamo, dal terreno che calpestiamo.
La vita umana non esiste che nella relazione.
La partecipazione, avvertita o inconsapevole, intesse l’esistenza.
La relazione o è piena o non è autenticamente relazione. Un rapporto autentico instaurato con le cose e soprattutto con l’altro può sottendere la relazione costitutiva con la trascendenza; e di conseguenza un richiamo decisivo della verità di un rapporto fondante, che Dio solo compie; si tratta di avvertire tale apertura alla trascendenza come costitutiva e originaria, propria della persona.
Col passaggio al contributo del pensiero di Gabriel Marcel si giunge a tematizzare l’invocazione, terminus ad quem del saggio.
Marcel, impegnato in un’analisi dell’esistenza nella concretezza della situazione reale, si rende attento soprattutto al richiamo trascendente che la attraversa. Le sue indagini tendono a dare volto e linguaggio al presagio interiore, ad indagare il mistero in cui l’esistenza risulta immersa. Nel contesto attuale può offrire una lucida testimonianza di come un credente viva la propria esperienza di fede e di quale apporto la fede possa dare per decifrare l’esistenza in tutto il suo laborioso processo di interpretazione.
Per Marcel dire Dio è legittimo dove l’esistenza, esplorata nelle sue pieghe segrete, ne presagisce e ne esige la presenza: anzi dove questa presenza si impone per conferire autenticità e tenuta all’esperienza.
La sua ricerca è piegata dunque sull’esistenza concreta. Molte delle analisi che propone sottendono una tenace esigenza di definitiva razionalità e di senso: perciò Dio è chiamato in causa.
Marcel non è un sistematico. Anzi spesso si è dichiarato apertamente estraneo all’esigenza di sistematicità. Il suo è un percorso sollecitato da situazioni concrete con cui è chiamato a fare i conti e sulle quali riflette da pensatore e da credente, senza troppo preoccuparsi di definire lo spazio che compete al pensatore e l’attesa che attraversa il credente.
Il primo tema esperienziale preso in considerazione è quello della fedeltà. Essa presuppone un impegno di vita che va al di là della contingenza di una promessa datata. Marcel individua nel riferimento ulteriore e ultimo a Dio il fondamento di una fedeltà che sia per sempre.
Affermare il principio della fedeltà all’istante significa trascendere l’istante.
La ricerca di Marcel è segnata da una scelta fondamentale. Riconosce che alla base della propria riflessione vi è sempre stata un’opzione per l’essere.
Una fedeltà autentica metta in gioco la persona ma contemporaneamente si fonda necessariamente sull’essere. Stringe, per così dire, l’uomo all’essere in un medesimo destino. Risulta caratterizzata “da un’intima comunione fra il personale e l’ontologico”. Ma proprio questa relazionalità mette in gioco essere e persona e li coinvolge in un medesimo processo; trasforma il senso della ricerca.
Non si tratta di trovare soluzione ad un problema, quanto di percepirsi immersi in un mistero che ci supera. Cosicché non si tratta tanto di argomentare per provare, quanto di esplorare per far luce e prendere consapevolezza di una situazione che si vive.
In sintesi pregnante: “I misteri non sono verità che ci trascendono, bensì verità che ci comprendono”. I misteri attraversano e alimentano la vita dell’uomo, testimone d’un’ansia che lo scuote, eppure fiducioso in un’arcana presenza che lo rasserena.
Marcel, in una situazione di precarietà storica ed esistenziale, quale quella determinata dalla II Guerra Mondiale, si trova di fronte ad una duplice alternativa: considerare se stesso (l’uomo) come l’assoluto oppure cercare l’assoluto in un altro diverso da sé:
Marcel si pone sulla seconda opzione. Ma questo altro assoluto non è concepito come esteriore rispetto al sé. Dio non è concepito in termini di causalità, sentito come estraneo all’uomo, come forza che gli si sovrappone. Unità e totalità si salvano solo in termini di interpersonalità, in ultima analisi in un rapporto di amore. Dunque complementarietà e reciproca compenetrazione.
La creazione è per la persona una proposta e un compito. E’ il margine riservato alla persona in faccia alla totalità.
In sintesi, tre affermazioni emergono da queste intuizioni
La vita dell’uomo è dono d’amore da parte di Dio.
L’uomo è costituito libero.
Può rifiutare oppure può rivolgersi a Dio attraverso l’invocazione.
Trenti dedica una parte notevole del saggio all’analisi puntuale del pensiero di Marcel, nel quale sembra riporre la sostanza della sua proposta, che può essere così evidenziata.
L’affermazione della trascendenza è, prima di tutto, sofferta consapevolezza di precarietà e di insufficienza, presentimento di arcana presenza, gesto spontaneo di adorazione. Si tratta di un’esperienza personalissima, incomparabile, in un certo senso incomunicabile.
Trenti conclude il suo saggio cercando, alla luce degli spazi di espressione consentiti dagli autori considerati, di proporre quale può essere un atteggiamento credente nell’ambito culturale e nel linguaggio attuali.
La proposta condotta esplicitamente sul terreno filosofico chiama in causa la teologia per una nuova formulazione della sua indagine scientifica credente, sia dal punto di vista metodologico che da quello contenutistico.
Parimenti è chiamata in causa la pedagogia per una mediazione proponibile nella concreta condizione educativa e didattica attuali.
Lucillo Maurizio