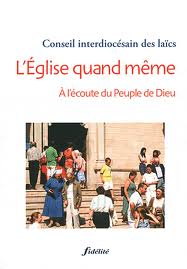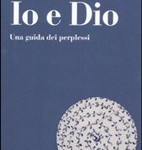Il sistema dei Mercati, con la finanza speculativa che domina su tutto il mondo, si sta mangiando vive l’umanità e la natura. Questo sistema opera ed è obbedito come un dio. Un dio vuoto, fatto di denaro che circola, si moltiplica o si brucia e, circolando, rovina la vita delle persone e del mondo vivente. Eppure in questa emergenza disastrosa governi, istituzioni, stampa e opinion-leaders continuano a pretendere che si faccia qualunque sacrificio per accontentare l’infinita avidità dei Mercati. Anche i sindacati (in particolare la Cisl con un fervore incomprensibile) e i partiti del “centro-sinistra” restano docili all’incantamento e si uniscono al coro che intima di rassicurare i Mercati. Non fanno l’unica cosa che sarebbe loro responsabilità fare per il Paese: progettare e promuovere una cultura della giustizia sociale e una politica di democratizzazione dell’economia che — attraverso un cammino arduo che dovrà coinvolgere gli altri Paesi del mondo — permetta di uscire da questa gigantesca trappola per topi che è il capitalismo finanziario globale. Se in un organismo alcune cellule cominciano a diventare cancerose, non è che le altre, per omologazione, si mettono a diventare malate pure loro. Al contrario, bisogna sviluppare le difese, resistere alla distruzione che vuole avanzare e attivare le forze di guarigione.
un vortice pericoloso
La trappola in cui siamo caduti, preparata da decenni di fede assoluta nel denaro e nel mercato, è sì un dispositivo concreto e ubiquo, ma rimane pur sempre una costruzione culturale. Gli ostacoli che si frappongono alla liberazione, alla sicurezza sociale, alla giustizia, a una società più umana e al rispetto della natura sono in primo luogo ostacoli di ordine culturale, che riguardano la mentalità collettiva, la credulità, la malafede di alcuni e l’ottusa “buonafede” di moltissimi. Le voci che con lucidità hanno studiato i totalitarismi del Novecento (da Horkheimer e Adorno a Foucault, da Arendt a Girard) ci hanno avvertito: il sistema organizzativo che più minaccia la libertà umana e la vita comune, quello più pericoloso per forza, capacità di sovranità e di ricatto, è il sistema economico. Oggi siamo presi nel vortice del disastro permanente che esso causa senza riguardo per nessuno.
Che fare dunque ?
È evidente che serve urgentemente una risposta saggia, lucida, rigorosa, fatta di un accordo politico internazionale per bbattere il potere dei Mercati e riportarlo sotto norme drastiche; per togliere potere di giudizio alle agenzie di rating e demolire il mito della loro neutrale oggettività; per stabilire un assetto fiscale proporzionale alle ricchezze effettivamente possedute; per tutelare il lavoro e i diritti di chi lavora, per garantire i servizi vitali e i beni comuni. Questa politica deve essere intrapresa intanto su scala nazionale. Occorre che ogni governo e ogni Paese comincino a muoversi in questa direzione dando concretezza e credibilità alla possibilità di un nuovo patto internazionale. È ormai chiaro che la famosa e attesa riforma delle Nazioni Unite non può essere una ristrutturazione interna di questo organismo, ma è anzitutto un accordo inedito tra gli Stati del mondo per l’adesione comune alla democrazia intesa anche come democrazia economica, in modo che il mercato non possa più essere una macchina a-umana impazzita che roduce vittime ogni giorno. Una svolta del genere richiede una convergenza interculturale sulla visione comune di una società umanizzata, equa, la cui logica ispiratrice non sia più quella che porta a scommettere sulla rovina di quasi tutta l’umanità e della natura. Se questa è la prospettiva del cambiamento indispensabile a livello internazionale — quanto mai difficile, delicata, lunga, ma pur sempre l’unica che abbiamo — rimane ancora, per ognuno di noi, nella vita quotidiana, la domanda: che fare? La risposta dev’essere costruita con il contributo di molti e ognuno può dare un apporto prezioso. Io proporrei un piccolo decalogo.
un vero decalogo
1. Risvegliarsi, smettendo di consentire con questo sistema e rendendosi conto di quanto sia assurdo e violento.
2. Informarsi, sviluppare l’analisi critica e prendere la parola ovunque per aiutare gli altri a uscire dall’incantamento del dio vuoto.
3. Agire, nelle scelte e nei comportamenti quotidiani, il più possibile secondo altri criteri, diversi da quelli del denaro, della competizione, dell’accumulazione. Questo significa privilegiare gli affetti, la solidarietà, gli imperativi della giustizia, l’ospitalità, l’armonia, la cura per creature e relazioni, la bellezza, la fedeltà alla felicità vera.
4. Educare i figli testimoniando che il senso della vita esiste e non è il denaro, educandoli a un modo di esistere del tutto alternativo alla stupidità dell’homo oeconomicus.
5. Creare o rafforzare nella vita di ogni giorno “zone franche” dove le persone, le relazioni, i doveri e i diritti, i sentimenti e gli affetti contano più del denaro, del potere e dell’interesse.
6. Ritrovarsi con altri (parenti, amici, vicini, persone che sono intenzionate a costruire la cultura della liberazione) per capire cause e conseguenze della crisi, per trovare insieme comportamenti e stili di vita biofili e non necrofili.
7. Stabilire relazioni di amicizia, di reciprocità, di giustizia con le vittime del sistema: poveri, migranti, mendicanti, licenziati, esuberi, irregolari e marginalizzati.
8 . Agire nello spazio pubblico (nel proprio quartiere o comune, nella scuola, nei luoghi di lavoro, sui mezzi di informazione, nelle comunità o associazioni di cui si fa parte) facendo della giustizia, che allestisce condizioni di vita umane per tutti, il metodo per prendere decisioni e per organizzare la convivenza sociale.
9. Sviluppare nella manualità, nel pensiero, nella conoscenza, nelle relazioni un modo creativo di porsi e di fare, perché ogni espressione di autentica creatività è in sé alternativa al sistema del dio vuoto, che si riproduce soffocando le facoltà creative degli esseri umani.
10. Fare pressione in ogni modo nonviolento e costituzionale per spingere amministratori, istituzioni, partiti e sindacati a onorare la loro responsabilità verso il bene comune, anziché fare i collaborazionisti con il Grande Ricattatore.
Sono tutti piccoli passi realizzabili ogni giorno. Di per sé non risolutivi, ma messi insieme ai passi di tanti sono capaci di prire la strada del cambiamento lì dove ora sembra sussistere solo un muro invalicabile. E sono passi che servono a non collaborare con un sistema che pratica, per via finanziaria, l’omicidio e la distruzione di ogni condizione della felicità per cui siamo nati
in “Mosaico di pace” del novembre 2011

![]() Visualizza il testo dell’articolo
Visualizza il testo dell’articolo