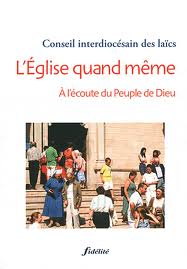Rinunciare alla vita: cedimento o solidarietà?
di Bruno Forte
in “Il sole 24 Ore” del 4 dicembre 2011
Non è facile la riflessione che sto per proporre. Non lo è anzitutto perché davanti al mistero della morte, di qualunque morte, ciò che più si addice è il silenzio. E non lo è perché qualunque parola si dica di fronte a questa morte comunque inquietante – il “suicidio assistito” di Lucio Magri, un uomo pubblico, che ha vissuto con passione la storia dell’Italia repubblicana -, si rischia di essere pregiudizialmente giudicati, quasi che la lettura di quel gesto comporti inevitabilmente una presa di posizione ideologica, una sorta di sentenza scontata a seconda di chi intervenga.
Ecco perché ritengo giusto affermare che quanto cercherò di esprimere è parola “seconda”, che segue al silenzio prolungato della riflessione e della preghiera, cui il mio cuore di credente si è immediatamente aperto di fronte alla notizia, e volutamente rifugge da ogni giudizio sul sacrario della coscienza, in cui solo ciascuno può tentare di entrare per sé, e dove, per chi ha fede, entra unicamente il giudizio dell’amore giusto e misericordioso di Dio.
Lucio Magri, dunque, giovane democristiano negli anni 50, passato poi attraverso le diverse avventure della sinistra italiana, fondatore con altri de Il Manifesto e protagonista di non poche battaglie politiche su posizioni di critica spesso adicale nei confronti dei “vincenti” di turno, ha comprato un biglietto di sola andata per la Svizzera, dove, in un centro a ciò predisposto, in base alle leggi di quel Paese, si è fatto accompagnare fino all’atto estremo del suicidio, per cui tutto era stato accuratamente predisposto. Gli amici, che nulla avevano potuto di fronte alla depressione che aveva invaso quel cuore, specialmente dopo la morte della persona amata, sono stati puntualmente informati una volta compiutosi l’atto estremo, senza ritorno.
Una scelta disperata? Una rinuncia finale a ogni possibile conforto, a ogni sia pur lieve barlume di speranza? O – come qualcuno ha dichiarato – una scelta da rispettare e basta, senza tener conto della possibile ricaduta che inevitabilmente una simile azione, specialmente in quanto compiuta da un uomo pubblico, ha potuto o potrà avere su altri? A rispondere a questi interrogativi può forse aiutare la vicenda stessa di Magri. Siamo nell’Italia della metà degli anni Cinquanta e il dibattito interno al partito di maggioranza relativa, la Democrazia Cristiana, si va facendo incandescente.
Fra i giovani militanti di quella forza politica si forma una consistente minoranza di sinistra, che riconosce i suoi leaders proprio in Lucio Magri e altri. Furono questi a dar voce alla loro insoddisfazione di fronte a quello che ritenevano l’immobilismo sociale e politico dei capi, dando vita al mensile “Il ribelle e il conformista”. Il nome del periodico intendeva ricordare da una parte il foglio “Il ribelle” del partigiano cattolico bresciano, ucciso dai tedeschi, Teresio Olivelli, e dall’altra il romanzo da poco pubblicato di Alberto Moravia “Il conformista”: una sorta di sì gridato al coraggio di chi lotta e dà la vita per la causa, e di no a chi rinuncia a lottare e si arrende alla logica dominante.
L’editoriale del primo numero, uscito nel gennaio 1955, faceva comprendere il perché di quel titolo: ispirandosi a precise «scelte culturali» e ad «atteggiamenti morali», in specie all’«eredità della resistenza e della tradizione dossettiana», il periodico si proponeva come voce e strumento di «un’esigenza strategicamente rivoluzionaria», al cui servizio intendeva elaborare un discorso «rigorosamente politico», tale da giudicare «le forze e la situazione» e individuare «una meta strategica, che definisse i successivi momenti tattici». Compito del mensile voleva essere insomma quello di compiere una «rottura, il lancio delle ipotesi, l’inizio di un dibattito, in una parola, la battaglia delle idee». L’appello era rivolto a tutte le forze giovanili italiane e trasudava – anche nel linguaggio fra l’ispirato e il visionario – di un atteggiamento fondamentale di speranza, di reazione alla stasi, di nuovo inizio in nome di una migliore città futura, accogliente e giusta per tutti.
Sono passati più di cinquant’anni da quel grido di riscossa giovanile. Ora Lucio Magri non può più far sentire la sua voce, come peraltro da tempo mi pare avesse scelto di fare. Se n’è andato volontariamente a cercare la morte in un Paese straniero, paradossalmente proprio quello che la militanza rivoluzionaria di alcuni anni fa avrebbe definito senza scusanti un Paese “borghese”. Il suo ultimo respiro lo ha emesso nell’ambiente ovattato di una clinica deputata ad assistere la volontà di farla finita di alcuni (si calcola un paio di centinaia di persone all’anno), una sorta di tempio della morte desiderata e accompagnata per chi ha decisione e mezzi per farlo. A quanti credono che la vita è dono e che solo al Dio donatore spetta di porle fine, la scelta appare evidentemente inaccettabile, contraria alla vocazione più profonda impressa nel cuore umano dal suo Creatore. Al di là di ogni giudizio morale, però, non mi sembra impropria la domanda se questa sia stata una morte da “ribelle” o da “conformista”.
Di fronte alla deriva rinunciataria e al riflusso nel privato di molta cultura post-ideologica o – come si ama dire – “post- moderna”, l’impressione è di trovarsi dinanzi più a un cedimento che a una ribellione. Senza minimamente giudicare il cuore, oggettivamente ritengo quest’atto tutt’altro che una riscossa anticonformista. Ciò di cui c’è bisogno, in tutti, e specialmente in chi è più provato dall’attuale crisi economica e sociale, è un atto di coraggio, uno sforzo collettivo perché nessuno cada nel baratro: insomma, una “ribellione”, non nel segno della violenza o dell’ideologia rivelatasi asfissiante e totalitaria, ma in quello della solidarietà, del l’amore umile e concreto, di quei piccoli (e grandi) segni di speranza, di cui tutti abbiamo bisogno per vivere, amare e dare agli altri,
specialmente ai giovani, ragioni di vita e di speranza. Riflettere su questa morte potrà aiutarci, forse, ad amare di più la vita e a volerla migliore per tutti.
Il momento della pietas
di Vito Mancuso
in “la Repubblica” del 1° dicembre 2011
Di fronte a un gesto estremo come quello di Lucio Magri è naturale che negli animi si accendano le passioni. E che da queste sorgano giudizi di approvazione o disapprovazione a seconda delle provenienze culturali. Ogni coscienza responsabile sa però che la complessa situazione del nostro mondo non ha certo bisogno di “kamikaze del pensiero” che ripetono aprioristicamente convinzioni vecchie di secoli.
Ha bisogno piuttosto di analisi pacate e di conoscenza oggettiva perché l’etica non divenga un motivo in più di divisione, ma realizzi la sua vera missione di far vivere in armonia gli esseri umani.
E in questa prospettiva si impone alla mente una prima inderogabile condizione: rispetto.
Aggiungo che se c’è una situazione in cui hanno senso le parole di Gesù «non giudicare» (Matteo 7,1), è proprio quella nella quale un essere umano sceglie di porre fine alla sua vita. Sostengo in altri termini che, di contro a una tradizione secolare che non ha esitato a condannare nel modo più crudo i suicidi, oggi il compito della teologia e della fede responsabile è di sospendere il giudizio,
offrire dati, produrre analisi, al fine di generare pietas.
La riflessione umana presenta un dato sorprendente: mentre tutte le grandi tradizioni spirituali dell’umanità, sia religiose sia filosofiche, condannano senza mezzi termini l’omicidio, per il suicidio le cose non sono altrettanto chiare. Nelle religioni rimangono di gran lunga prevalenti le posizioni di condanna, com’è il caso di ebraismo, cristianesimo, slam, e poi di induismo, buddhismo, confucianesimo. Il medesimo orientamento di condanna è maggioritario in filosofia, come mostrano Platone, Aristotele, Kant, Hegel, Heidegger. Tra i filosofi però si danno anche punti di vista che giungono a non condannare, talora anzi a valutare positivamente, il suicidio: così gli epicurei, gli stoici, Montaigne, Nietzsche, Jaspers. Ma l’aspetto veramente sorprendente, soprattutto per un cristiano, è il fatto che la Bibbia non condanni mai, in nessun luogo, il suicidio. L’hanno osservato nel ‘900 i maggiori teologi contemporanei, tra cui Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Hans Küng. «Il suicidio non viene mai esplicitamente vietato nella Bibbia», scrive Barth, aggiungendo che si tratta di «un fatto veramente seccante per tutti quelli che volessero comprenderla e servirsene in senso morale!».
Sono una decina i suicidi narrati dalla Bibbia e per nessuno vi è una condanna. Anzi un suicida, per l’esattezza Sansone, viene perfino ricordato dal Nuovo Testamento tra i padri della fede. Non deve stupire quindi che nella Bibbia si ritrovino parole come queste: «Meglio la morte che una vita amara, il riposo eterno che una malattia cronica» (Siracide 30,17). Nel libro di Giobbe si legge di uomini che «aspettano la morte», «che la cercano più di un tesoro», «che gioiscono quando la trovano» (Giobbe 3,21-22), e non per condannare questi uomini, perché chi viene condannato è piuttosto chi sostiene con arroganza e intransigenza la prospettiva contraria come i cosiddetti amici di Giobbe cioè i dogmatici Elifaz, Bildad, Zofar, Elihu.
Certo, tutti sanno che dalla Bibbia emerge soprattutto il messaggio della sensatezza e della sacralità della vita, quello secondo cui la nostra vita è «nelle mani di Dio» (Salmo 16,5), in Dio è «la sorgente della vita» (Salmo 36,10) ed esiste quindi una sorta di rifugio imprendibile dentro cui la nostra energia spirituale più preziosa, detta tradizionalmente anima, non corre pericolo: «Non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima» (Matteo 10,28).
Alla luce di questi dati emerge che il compito dei cristiani oggi non è di emettere condanne qualificando negativamente e sofferte scelte di chi si suicida. È piuttosto di vivere la fede nella dimensione spirituale dentro cui l’anima vive al sicuro, anche quando il corpo tradisce. È da questa prospettiva spirituale che io giungo a valutare negativamente il suicidio, e a lottare perché la fiducia verso la vita non venga mai meno, ma si possa assaporare ogni istante l’energia vitale che ci è stata data (se da un Dio personale o dall’impersonalità del processo cosmico, a questo riguardo è una questione secondaria).
Concludendo l’articolo sul compagno di tante battaglie, ieri Valentino Parlato scriveva della necessità di «affrontare l’attuale, e storica, crisi della sinistra, per ridare alle donne e agli uomini la speranza di un cambiamento, di una uscita dall’attuale stato di mortificazione degli esseri umani».
Ottimo obiettivo, ma per raggiungerlo io non conosco modo migliore di ospitare fino all’ultimo dentro di sé un sentimento di gratitudine verso la vita in tutte le sue manifestazioni, quel medesimo sentimento che ha portato Violeta Parra a comporre e a cantare la sua bellissima canzone Gracias a la vida.
Liberi di vivere e morire
di Paolo Flores D’Arcais
iin “il Fatto Quotidiano” del 2 dicembre 20112
Se la tua vita non appartiene a te, amico lettore, ne sarà padrone un altro essere umano, finito e fallibile non meno di te. Ti sembra accettabile? Su questa terra infatti si agitano e scontrano solo e sempre volontà umane, una volontà anonima e superiore che si imponga a tutti, oggettivamente o intersoggettivamente, è introvabile. Chi ciancia della volontà di Dio è blasfemo (come può pensare di conoscere ciò che è incommensurabile con la piccolezza umana?). In realtà attribuisce a Dio la propria volontà, lucrando sulla circostanza che nessun Dio potrà querelarlo per diffamazione. Il Dio cattolico di Küng considera lecita l’eutanasia, il Dio altrettanto cattolico di Ratzinger l’equipara all’omicidio. Perché in realtà si tratta dell’opinione di Küng e dell’opinione di Ratzinger, umanissime entrambe e non più autorevoli della tua. Perciò, rispetto alla tua vita, o il padrone sei tu o il padrone è un altro “homo sapiens”, eguale a te in dignità (così Kant, e ogni democrazia anche minima), vescovo, primario ospedaliero, pater familias o altra “autorità” che sia. Ma poiché siamo tutti eguali, deve anche valere il reciproco: se il padrone della tua vita può essere qualcun altro, tu potrai a tua volta decidere della sua vita contro la sua volontà. Se c’è davvero qualcuno che accetterebbe si faccia avanti. Ma non ce n’è nessuno. Nella realtà esistono solo “homo sapiens” finiti, fallibili e peccatori come te e come me, amico lettore, che pretendono di imporre alle altrui vite la loro personale volontà, ma mai accetterebbero di essere soggetti ad analoga mostruosa prevaricazione.
PERCIÒ, senza perifrasi: il suicidio assistito è un diritto? Sì. Fa tutt’uno col diritto alla vita e alla libertà, inscindibili. La “Vita” che qualcuno vuole “sacra” è infatti la vita umana, non il “bios” in generale (ogni volta che prendiamo un antibiotico, come dice la parola, facciamo strage di “vita”), e la vita umana è tale perché singolare e irripetibile, cioè assolutamente MIA. Se non più mia, ma a disposizione di volontà altrui, è già degradata a cosa: “Instrumentum vocale”, dicevano giustamente gli antichi.
Per Lucio Magri la vita era ormai solo tortura. Per Mario Monicelli la vita era ormai solo tortura. Per porvi fine, Lucio Magri ha dovuto andare in esilio e Mario Monicelli gettarsi dal quinto piano.
La legge italiana vieta infatti una fine che non aggiunga dolore al dolore già insopportabile: su chi ti aiuta incombe una condanna fino a 12 anni di carcere. E per “assistenza” al suicidio si intende anche quella semplicemente morale! Due casi raccapriccianti di anni recenti: un coniuge accompagna l’altro nell’ultimo viaggio (solo questo: la vicinanza) e deve patteggiare una pena di oltre due anni, altrimenti la sentenza sarebbe stata assai più pesante. Una signora di 54 anni, affetta da paralisi progressiva, decide di andare da sola in Svizzera, proprio per non coinvolgere la figlia.
Che tuttavia le prenota il taxi per disabili che la porterà oltre frontiera. È bastato per l’incriminazione: ha dovuto patteggiare un anno e mezzo di carcere.
MA QUANDO si vuole porre fine alla tortura che ormai ha saturato la propria esistenza, si ha sempre bisogno di assistenza: il pentobarbital sodium non si trova dal droghiere, solo un medico lo può procurare. L’alternativa è appunto l’esilio o lo strazio estremo dell’angoscia aggiuntiva: gettarsi sotto un treno o nel vuoto o nella morte per acqua. Le anime “virili” che si sono concessi perfino l’ironia (“se uno vuol farla finita ha mille modi, senza piagnistei di ‘aiuto’”: i blog ne sono pieni), hanno davvero oltrepassato la soglia del vomitevole.
Altre obiezioni grondano comunque ipocrisia o illogicità. “Se vedi uno che si sta impiccando che fai, rispetti la sua libertà o intanto lo salvi?”. Ovvio che lo salvo, poiché potrebbe essere un momento di sconforto. Ma i casi di cui parliamo sono sempre e solo riferiti a scelte lungamente maturate, ponderate, ribadite. Lucidamente e incrollabilmente definitive (a maggior ragione se chi vuole morire subito è un malato terminale comunque condannato morte). Da rispettare, dunque, se a una persona si vuole bene davvero: anche se la fine della sua tortura ci procura il dolore della sua assenza per sempre.
ALTRETTANTO pretestuosa l’accusa che il medico verrebbe costretto a praticare l’eutanasia a chiunque la chieda. Nessuno ha mai avanzato questa richiesta, ma solo il diritto – per il medico che questo aiuto vuole dare – di non rischiare il carcere come un criminale. Spiace perciò particolarmente che Ignazio Marino, clinico e cittadino dai molti meriti, abbia dichiarato: “Non dividiamoci tra ‘pro vita’ e ‘pro morte’, il tifo da stadio non è giustificabile di fronte alla fragilità umana”.
A parte la scurrilità del “tifo da stadio”: essere “pro choice” non è essere “pro morte” ma per la libertà di ciascuno di decidere liberamente, mentre troppi “pro vita” sono semplicemente “pro tortura”, poiché pretendono di imporla a chi invece la vive come peggiore della morte. Tu hai tutto il diritto di dire che mai e poi mai ricorrerai al suicidio assistito, che la sola idea ti fa orrore. Ma che diritto hai di imporre questo rifiuto a me, cui fa più orrore la tortura, visto che siamo cittadini eguali in dignità e libertà?
Il cardinal Martini e la morte
di Armando Massarenti
in “Il Sole 24 Ore” del 4 dicembre 2011
Nell’introduzione al recente «Meridiano» dedicato a Carlo Maria Martini, Marco Garzonio ricorda la copertina che il cardinale scrisse per la Domenica del Sole 24 Ore il 21 gennaio 2007, «Io, Welby e la morte». «A un mese di distanza dalla morte di Piergiorgio Welby, l’uomo malato di Sla cui la Chiesa non aveva concesso i funerali religiosi» ricorda Garzonio, Martini scriveva: «Con lucidità ha chiesto la sospensione delle terapie di sostegno respiratorio, costituite negli ultimi nove anni da una tracheotomia e da un ventilatore automatico». Il cardinale ai tempi era già affetto dal Parkinson, ed era consapevole degli effetti progressivamente invalidanti della malattia. «Si può allora immaginare – scrive Garzonio – quanto le sue argomentazioni fossero arricchite dalla sofferenza provata sulla propria pelle oltreché dalle ragioni della teologia, del diritto e della morale». Si incentravano in particolare sulla nozione di “accanimento terapeutico”: «Per stabilire se un intervento medico è appropriato non ci si può richiamare a una regola generale quasi matematica, da cui dedurre il comportamento adeguato, ma occorre un attento discernimento che consideri le condizioni concrete, le circostanze e le intenzioni dei soggetti coinvolti. In particolare non può essere trascurata la volonta del malato, in quanto a lui compete – anche dal punto di vista giuridico, salvo eccezioni ben definite – di valutare se le cure che gli vengono proposte, in tali casi di eccezionale gravità, sono effettivamente proporzionate». Ecco, il punto è tutto in quel «non può essere trascurata la volontà del malato». Ancor più laicamente io direi che la volontà del malato è decisiva. Ma la cauta espressione del cardinal Martini, presa sul serio, sarebbe già sufficiente per evitare lo scempio della nostra libertà previsto dalla legge sul testamento biologico elaborata dall’attuale Parlamento.
Il dibattito
- Di chi è la mia vita? di Aldo Antonelli in il dialogo del 2 dicembre 2011
- Libertà vs coercizione di Cinzia Sciuto in MicroMega del 30 novembre 2011
- “Pro vita” vs “pro morte”? Botta e risposta tra Ignazio Marino e MicroMega di Ignazio Marino e Cinzia Sciuto in MicroMega del 2 dicembre 2011
- Il medico salva, non uccide di Marco Travaglio in il Fatto Quotidiano del 2 dicembre 2011
- Lucio e il volo di Giancarla Codrignani in l’Unità del 2 dicembre 2011
- Suicidio. «Scegliere la vita nonostante tutto» intervista a Lytta Basset a cura di Anne-Sylvie Martéthoz in Riforma del 2 dicembre 2011 (settimanale delle chiese Evangeliche Battiste, Metodiste e Valdesi)
- Disporre della propria vita lusso supremo della civiltà di Adriano Sofri in la Repubblica del 1 dicembre 2011
- Rispettare la coscienza di Enrico Peyretti del 30 novembre 2011
- Come dare senso alla vita di Michela Marzano in la Repubblica del 30 novembre 2011
- Necrologio di un “non-rivoluzionario” di Heiner Boberski in www.wienerzeitung,at del 25 novembre 2011 (nostra traduzione)
- La Chiesa, la morte e il libero arbitrio di Dacia Maraini in Corriere della Sera del 6 dicembre 2011