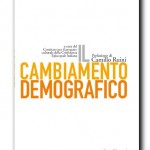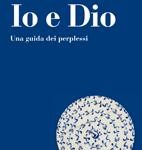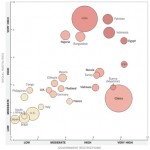Dopo secoli in cui la natura era più forte dell’umanità e l’uomo doveva difendersi da essa, oggi è proprio l’ambiente che è diventato fragile, sovente vittima dell’uomo, al punto che l’uomo ormai con la sua potenza nucleare è in grado di distruggere la terra. Così siamo diventati al massimo grado responsabili della terra e della nostra potenza: in quest’ottica ciò che è più difficile è non cedere all’eccesso e alla dismisura. La sfida etica ci chiede di acquisire la padronanza del nostro potere tecnico-scientifico, ponendo un limite alle nostre azioni e ai nostri progetti e riconoscendo che esistono diritti della natura, dell’ambiente, di tutti i nostri co-inquilini sul pianeta. Occorre fare questo passo a livello di coscienza sociale, fino a esprimere questi diritti mediante istituti e legislazioni giuridiche. E se l’ambiente è titolare di diritti, noi umani abbiamo dei doveri, una precisa responsabilità che, se non assunta o violata, ci rende trasgressori della legge necessaria all’abitare la terra, al costruire un mondo più sinfonico e più bello.
È quindi necessaria un’etica della responsabilità che si preoccupi dell’avvenire della specie umana e della terra. Hans Jonas l’ha così formulata: «Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana sulla terra». Se un tempo la responsabilità significava rispondere dei propri atti passati e presenti, ora essa è tale anche verso l’avvenire del pianeta e dell’universo. È il futuro in cui gli abitanti della terra saranno le nuove generazioni, i nostri figli, i nostri nipoti, che richiede la mia responsabilità oggi, perché oggi l’uomo può distruggere la terra: da questo potere nascono obblighi e doveri. Come siamo giunti a elaborare un «contratto sociale», così oggi dobbiamo andare al di là del sociale e del politico per elaborare un «contratto naturale», un contratto con l’ambiente! Questo senza mai dimenticare che questione ecologica e questione sociale sono due aspetti del medesimo disordine da noi provocato, due frutti della medesima volontà di potenza, del medesimo sfruttamento che non conosce doveri né limiti, del medesimo edonismo che pensa solo a se stessi, senza gli altri e contro gli altri. Quando si giunge a trattare le persone solo in funzione della loro capacità di produrre e di possedere, si finisce anche per trattare la natura e gli esseri viventi solo in funzione di un loro possibile sfruttamento, del loro valore di mercato…
Ma accanto alla responsabilità vi è un’altra necessità per un’etica rispettosa della terra: la sobrietà.
Parola detestata questa, spesso anche derisa, eppure oggi siamo più consapevoli che mai del fatto che le risorse della terra non sono infinite, lo sviluppo non è in costante crescita, la produzione non è illimitata, i consumi non possono più essere sfrenati. Per questo bisogna ritornare a quella parola attestata con grande frequenza nella Regola di Benedetto: mensura, misura. Misura del cibo, dei consumi, del tempo libero, del lavoro… Misura, cioè sobrietà, moderazione, attitudini attraverso le quali noi umani riconosciamo il nostro limite di terrestri. Misura, in senso ecologico, significa lasciar cadere le pretese non attinenti ai bisogni fondamentali ma indotte o addirittura imposte come esigenze alienanti dalla società dei consumi. Occorre che ci liberiamo dei desideri superflui per acquisire anche una capacità critica, una libertà, e non essere piegati alle richieste prepotenti del mercato. Talvolta occorre anche una rinuncia o, per usare un altro termine bandito dal nostro linguaggio, un sacrificio, cioè la disponibilità a privarci di qualcosa, nel caso che la nostra soddisfazione passeggera provochi danno all’ambiente e alle creature di cui siamo co-inquilini, ad altre genti o ad altri popoli.
Integrare la nostra situazione nel mondo è decisivo per conoscere la nostra identità terrestre e saper vivere il nostro rapporto con la terra, questo «terzo satellite di un sole detronizzato dal suo seggio centrale, divenuto astro pigmeo errante tra miliardi di stelle in una galassia periferica di un universo in espansione» (Edgar Morin). La terra è l’unico pianeta sul quale, almeno per oggi, sappiamo esistere questa specie di animali biologici ma anche esseri culturali, gli animali umani: umani nel senso che l’uomo non è compiuto pienamente se non dalla cultura e nella cultura; umani nel senso che sanno sentirsi responsabili degli altri co-inquilini animali, vegetali e minerali, responsabili per tutti; umani perché capaci di com-passione, di soffrire con questa terra, capaci di sim-patia con tutte le creature; umani perché atti ad abitare la terra, ricercando e perseguendo la pace: una pace non solo tra gli uomini ma cosmica, cioè lo shalom, la vita piena per tutta a terra.
Un’etica della responsabilità ambientale per tutta la terra
di Enzo Bianchi
in “Jesus” n. 10 dell’ottobre 2011
ALTRI CONTRIBUTI
Il valore etico dell’idea di una «decrescita felice»
di Giannino Piana
in “Jesus” n. 10 dell’ottobre 2011
Nonostante la crisi economica mondiale, la convinzione che è possibile una crescita illimitata è ancora oggi largamente diffusa, al punto che è divenuta l’ideologia dominante della nostra società. La misurazione di ogni scelta personale e sociale secondo criteri mercantili e quantitativi, l’affermarsi di una competitività radicale, la tendenza a ricercare il profitto immediato e il guadagno facile sono altrettanti assiomi che stanno alla base di tale orientamento e che hanno acquisito una consistente credibilità a seguito del crollo dei sistemi a economia pianificata dei Paesi del socialismo reale e della conseguente rivincita di una forma di capitalismo selvaggio favorito dal processo di globalizzazione in corso. La logica che soggiace a questa ideologia dell’espansione continua è la logica dell’«avere» e del «consumare», la quale si appoggia sulla creazione di bisogni sempre nuovi, indotti dall’esterno mediante la pressione sociale — i media esercitano al riguardo una funzione determinante — e in larga misura alienanti.
Le conseguenze di questo processo, che qualcuno ha giustamente definito come una delle peggiori e più disastrose utopie, sono oggi sotto gli occhi di tutti. L’accumulo della ricchezza privata con sempre maggiori spoliazioni collettive e perciò con l’incremento della marginalità sociale, il crescente indebitamento degli Stati — il nostro ha, in proposito, un primato poco lusinghiero — , la riduzione del lavoro a merce con la tendenza al ridimensionamento dei salari e dei diritti e, da ultimo (ma non ultimo per ordine di importanza), l’ampiezza della crisi ecologica, a causa sia del degrado ambientale che della progressiva riduzione delle risorse disponibili, denunciano il verificarsi di una situazione dai risvolti drammatici. Se poi si allarga lo sguardo — come oggi è doveroso fare, stante la stretta interdipendenza esistente tra i vari popoli della terra — al contesto mondiale, appaiono evidenti i segni dello stato di grave squilibrio in atto e delle profonde ingiustizie che ne sono la causa. L’economia dei Paesi ricchi, che crea forme di sperequazione intollerabili nella distribuzione della ricchezza sia tra le nazioni che tra le classi sociali, scarica il suo impatto globale sugli ecosistemi dei Paesi più poveri, accentuando le condizioni di disagio in cui vivono.
La considerazione che la crescita non può essere infinita, che ha dei limiti che devono finire per imporsi, non è, d’altra parte, di per sé nuova. Già agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso il Mit (Massachusetts Institute of Technology) con il rapporto sui Limiti dello sviluppo (Milano I 972) — la traduzione corretta del testo originale inglese sarebbe piuttosto «limiti alla crescita» — metteva in evidenza con chiarezza come la crescita economica non avrebbe potuto continuare indefinitamente a causa della limitata disponibilità di risorse naturali e della limitata capacità di assorbimento delle sostanze inquinanti da parte del pianeta. La consapevolezza di questo fatto è cresciuta negli ultimi decenni, al punto che vi è chi ha cominciato a teorizzare la «decrescita» — il primo a introdurre tale ipotesi è stato Serge Latouche, noto economista ed ecologista parigino — come via da percorrere per ristabilire gli equilibri infranti e dare avvio a un processo di vera umanizzazione.
Lungi dal costituire una rinuncia che mortifica le possibilità di espressione della persona, la decrescita, che comporta il rifiuto del consumismo e l’abolizione del superfluo, è considerata da chi la sostiene una opportunità — per questo si parla di decrescita «serena» o «felice» (a questa ultima dizione si rifa in particolare il movimento fondato in Italia da Maurizio Pallante) — , cioè come un mezzo per dare sempre più spazio ai valori immateriali, a quelli relazionali in particolare, e per migliorare la qualità della vita. Essa implica anzitutto l’adozione di alcune scelte prioritarie in campo socioeconomico e politico, quali l’attenzione privilegiata ad assicurare a tutti cibo e farmaci, la preoccupazione per la preservazione della biodiversità, la regolazione del clima, la depurazione delle acque e dell’aria, la protezione dalle inondazioni, la prevenzione dalle malattie, ecc. Ma implica anche l’adozione di precise scelte personali, quali la pratica del riciclo dei rifiuti, la preferenza data alle energie alternative, l’abolizione degli sprechi alimentari e dell’abuso di risorse naturali; e l’elenco potrebbe continuare.
La posta in gioco è, in definitiva, culturale ed etica. Si tratta di decidere se si vuole assegnare il primato alla ricerca del benessere economico a ogni costo o si vuole invece privilegiare la ricerca della felicità, la quale implica anche la limitazione dei bisogni materiali — specialmente se superflui o alienanti —e l’acquisizione di stili di vita capaci di fare spazio a istanze valoriali che restituiscano alla vita il suo senso vero e favoriscano una più equa distribuzione dei beni tra gli uomini. A queste condizioni infatti la decrescita acquisisce un significato altamente positivo poiché diviene occasione di una autentica crescita umana.