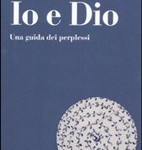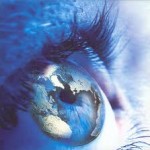è il tema dell’incontro di Todi delle associazioni cattolicche italiane sull’impegno politico oggi
In questo articolo vorremnmo dare rilievo al dibattito che si è aperto, in queste ultime settimane Italia, sulla presenza dei cattolici nella vita politica italiana.
La rete di associazioni che coinvolge milioni di persone, ma che costituisce ancora un’entità pre-politica si incontrerà il prossimo lunedì a Todi sul tema «La buona politica per il bene comune». E’ il primo passo di quella «la straordinaria sfida» lanciata dal cardinal Bagnasco, «Non possumus nunc silere», «non possiamo ora tacere».
Il Cardinale Bagnasco a Todi
Bene comune, di terra e di cielo
“Il punto sorgivo della presenza sociale e civile dei cattolici: il primato della vita spirituale, quel guardare fermamente al volto di Cristo”, senza il quale “i cristiani sarebbero omologati alla cultura dominante e a interessi particolari”.
Lunedì 17 ottobre, a Todi, invitato dal Forum del mondo del lavoro, il card. Angelo Bagnasco – Arcivescovo di Genova e Presidente della CEI – ribadisce che “la Chiesa non cerca privilegi, né vuole intervenire in ambiti estranei alla sua missione, ma deve poter esercitare liberamente questa sua missione”. I cristiani, infatti, “sono diventati nella società civile massa critica, capace di visione e di reti virtuose, per contribuire al bene comune che è composto di “terra” e di “cielo”.
“La sensibilità e la presenza costante della Chiesa sul versante dell’etica sociale è sotto gli occhi di tutti” ha evidenziato il Cardinale Presidente, facendo riferimento “ai grandi problemi del lavoro, dell’economia, della politica, della solidarietà e della pace: problemi che oggi attanagliano pesantemente persone, famiglie e collettività, specialmente i giovani”.
“La giusta preoccupazione verso questi temi – ha aggiunto – non deve però far perdere di vista la posta in gioco che è forse meno evidente, ma che sta alla base di ogni altra sfida: una specie di metamorfosi antropologica”.
E ha spiegato: “Senza un reale rispetto di questi valori primi, che costituiscono l’etica della vita, è illusorio pensare ad un’etica sociale che vorrebbe promuovere l’uomo ma in realtà lo abbandona nei momenti di maggiore fragilità. Ecco perché nel “corpus” del bene comune non vi è un groviglio di equivalenze valoriali da scegliere a piacimento, ma esiste un ordine e una gerarchia costitutiva”.
“Il bene – ha concluso il Presidente della CEI – è possibile solo nella verità e nella verità intera”.
 Relazione Todi.doc
Relazione Todi.doc
«Per l’Italia una rotta, non un salvagente»
intervista ad Andrea Riccardi a cura di Giovanni Grasso
in “Avvenire” del 13 ottobre 2011
«Vorrei subito invitare tutti alla calma: l’appuntamento di Todi non è l’atto fondativo di nuova formazione politica. Per essere espliciti: niente cose bianche, balene, pesciolini e men che meno ambizioni leaderistiche da parte di nessuno». Lo storico Andrea Riccardi , fondatore della Comunità di Sant’Egidio (che tiene a precisare di essere tra gli «invitati e non tra gli organizzatori» del convegno tuderte) spiega: «I cattolici (o, come leggo sui giornali, il Vaticano, la Cei…) non stanno lanciando un’Opa sulla politica italiana. Questa è pura fantasia. Stanno invece cominciando a riflettere in modo approfondito su qual è la domanda che oggi rivolge il Paese e quali possono essere le risposte agli italiani».
E, dunque, qual è l’interpretazione autentica del convegno di Todi?
Non è un convegno ecclesiale né un congresso di partito. Ma un momento di concertazione e di concentrazione di intelligenze e volontà che intendono riflettere sulla crisi del Paese. Un gruppo di laici cattolici, tra l’altro provenienti da diverse esperienze, che intendono cominciare a ragionare su quale possa essere il loro contributo per la rinascita del Paese.
Eppure si continua a sospettare e a straparlare di un nascente partito della Chiesa o di Bagnasco…
L’iniziativa è stata promossa autonomamente da un gruppo di laici, che da sempre dialogano con la gerarchia, ma che sono consapevoli della loro autonoma e specifica responsabilità rispetto all’impegno politico e civile.
Le chiedo: perché muoversi proprio oggi?
Un ciclo politico si è chiuso, quello della mai nata II Repubblica. Una fase, l’età di Berlusconi, in cui il Paese ha pensato di affidare le proprie sorti a partiti o fronti capeggiati dall’uno o l’altro leader. Ora c’è da riscoprire il valore dell’impegno e della partecipazione, perché si è creato un profondo distacco tra Palazzo e Paese. Le istituzioni comunitarie del nostro Paese sono in difficoltà e tra queste la famiglia sta sopportando un peso tremendo. Ma per promuovere la partecipazione e rilanciare l’Italia bisogna ridare idee, pensieri, sentimenti.
E quale può essere oggi il contributo dei cattolici all’Italia?
Credo che oggi l’Italia domandi ai cattolici, ma ovviamente non solo a loro, un contributo di responsabilità e pensiero. Responsabilità, di fronte alla crisi economica internazionale, nella quale si colloca il nostro Paese con gravi difficoltà. Pensiero, rispetto ai grandi cambiamenti avvenuti nella nostra società, che deve interrogarsi sul modello antropologico dell’uomo e della donna come si è andato configurando in quella che io chiamo la ‘ triste époque’ degli ultimi dieci anni; che deve fare i conti con un futuro che non è di crescita, ma caratterizzato da tante difficoltà. E allora le sfide che ci attendono sono quelle della difesa della vita, della riscoperta del lavoro e del sacrificio, della solidarietà tra le generazioni, con particolare attenzione ai giovani e alla terza età, vere questioni del presente e del futuro.
I tempi, però, stringono… Il Paese ha bisogno di un rilancio immediato.
Rilanciare il Paese significa innanzitutto rilanciarlo in Europa, il che implica un pensiero europeo, che oggi difetta. Come confrontarci con l’Asia, con gli emergenti, con i Brics, se non nel quadro europeo? Altrimenti saremmo una fragile barchetta. Inoltre dovremo affrontare una stagione di sacrifici, dopo un periodo caratterizzato dallo sperpero. E tutto questo implica un pensiero. L’Italia non ha solo bisogno di salvagenti, ma soprattutto di una rotta.
E quale può essere questa rotta?
Ci troviamo in un momento delicato: all’emergenza internazionale ed economica si somma l’emergenza politica nazionale. Vedo che si parla di elezioni nel 2012. La politica ha bisogno di pensieri lunghi, di ricreare innanzitutto cultura politica. Il grande divario è avvenuto tra politica e cultura: le culture politiche si sono spente. Una vera cultura di destra, nel nostro Paese, forse non c’è nemmeno mai stata. Mentre quella di sinistra è in crisi da tempo. Non così la cultura dei cattolici, che in questi anni è stata alimentata e promossa.
Si parla molto oggi della necessità di una svolta. La chiedono le opposizioni, ma anche molti sponenti della stessa maggioranza. Si parla di transizione, decantazione, unità nazionale. Lei che ne dice?
La storia recente del nostro Paese è caratterizzata da una serie di cicli che si sono interrotti drammaticamente: pensiamo alla crisi dello Stato liberale, con l’avvento del fascismo, alla fine del regime con la guerra, alla caduta nell’ignominia della Prima Repubblica. Dobbiamo dare una svolta, ma anche assicurare una transizione pensata e responsabile. Si è già rotto il ciclo dell’età del bengodi, non possiamo permetterci altri traumi.
Tra le forze politiche è polemica permanente su federalismo e su sistema elettorale. Lei che ne pensa?
L’Italia a mio parere è più municipalista che federalista. Non è tanto il Paese delle venti Regioni, quanto quello delle cento città e dei villaggi di campagna. Da qui dovremo ripartire. Quanto al sistema elettorale, credo che occorra ristabilire un rapporto autentico tra elettore e cittadino, restituendo a quest’ultimo il diritto di scelta. Per il resto non ho mai creduto al potere messianico dell’ingegneria costituzionale. Oggi il primato è ricostruire un tessuto responsabile nella vita di una società atomizzata.
C’è un’attenzione spasmodica da parte dei media e della classe politica sull’appuntamento di Todi, ci si chiede in modo quasi maniacale dove sfocerà…
Io dico questo: le reti della società sono distrutte o molto danneggiate. Nelle periferie urbane non ci sono più le sezioni di partito, rappresentanze un tempo forti si sono rattrappite, i legami familiari e di amicizia si sono allentati. C’è molta solitudine. Restano solo le parrocchie, con le associazioni e le comunità che accolgono e promuovono. Di fronte a questo spettacolo desolato, il mondo dei laici cattolici può rilanciare delle idee forti: famiglia, vita, solidarietà, lavoro, mondo. Mi sembrano cose importanti, più di sapere se ci sarà o meno un nuovo partito, se sarà di centro, di destra o di sinistra. Lasciamo correre la forza disarmata e disarmante delle idee, in un mondo troppo povero di idee e di speranza.
“C’è un grave problema etico dobbiamo ridare la speranza”
intervista a Franco Miano, presidente dell’Azione Cattolica, a cura di Annalisa Cuzzocrea
in “la Repubblica” del 13 ottobre 2011
Passare dalla rassegnazione alla speranza, coniugare coscienza personale e coscienza collettiva, recuperare un terreno comune di valori, saper coniugare politica e morale. E’ il messaggio che l’Azione cattolica porta all’incontro di Todi. «E’ urgente – dice il presidente Franco Miano – bisogna insegnare ai giovani il coraggio e la responsabilità. Per ora stiamo dando solo il cattivo esempio».
Perché è importante in questo momento un confronto tra le più diverse componenti del mondo cattolico?
«Il Paese ha bisogno di esercizi di dialogo e di impegno comune. Serve un nuovo patto educativo per rilanciare il Paese, bisogna ristabilire una base condivisa di valori per poi passare all’azione, e mettere al centro concetti come lavoro, famiglia, giustizia sociale, legalità, sviluppo del mezzogiorno».
C’è un decadimento di valori, un impoverimento dell’etica?
«C’è un grande problema etico. Come ha detto il cardinale Bagnasco nella sua prolusione, come lo stesso Papa ha ricordato a Lamezia Terme, è necessario che ciascuno – anche come credente – sappia assumersi le proprie responsabilità. Serve una cultura della serietà e del sacrificio per imparare a assumere responsabilmente la vita».
Il mondo cattolico cerca unità per pesare di più?
«Se pesare vuol dire essere una lobby, imporre un potere, prendere interessi di parte, no, non ci interessa. Ma se significa pesare per il bene comune, incidere nella realtà per renderla migliore, allora ben venga».
Ben venga l’unità dei cattolici in politica?
«Non è ancora chiaro l’obiettivo verso cui andiamo, non vedo ancora passi tali da far pensare a uno scopo simile. Vado a partecipare al seminario, e si vedrà. Quel che penso sia fondamentale, è dare speranza alle giovani generazioni».
Stiamo dando il cattivo esempio?
«Non c’è dubbio, è così. E invece bisogna insegnare il coraggio, non quello della pacca sulla spalla, ma quello che viene dalla responsabilità che come generazione di adulti siamo in grado di esercitare fino in fondo».
“È un Paese pieno di macerie ma non rifonderemo la Dc”
intervista a Gennaro Iorio, rappresentante dei Focolari, a cura di Marco Ansaldo
in “la Repubblica” del 13 ottobre 2011
«I vescovi, ma anche noi come associazioni cattoliche, ci rendiamo tutti conto che è il momento di una riflessione comune. Ci sono risposte da dare di fronte a un Paese alle prese con macerie da un punto di vista etico, culturale e di prospettiva politica. Todi sarà una tappa importante, ma noi è già da tempo che parliamo di questi argomenti anche in altri centri». Gennaro Iorio è il rappresentante del movimento dei Focolari.
È dunque da tempo che state affrontando questo argomento?
«È un cammino che la Chiesa e i cattolici fanno da anni. C’è una ricchezza di movimenti e di associazioni che avevano l’esigenza di confrontarsi sui valori».
Ma ora il contesto è cambiato.
«Sì, questo incontro assume una rilevanza diversa. Anche a causa della crisi economica. Ma ci è ben chiaro in ogni caso che possiamo salvare l’Italia solo stando in Europa. E a partire dalla prolusione che farà il cardinale Bagnasco vogliamo essere l’humus culturale che poi potrà essere raccolto da progetti nuovi o da partiti politici. Di quest’ultimo aspetto tutti parlano, la cosa però non è all’ordine del giorno della riunione».
Il direttore dell’Avvenire, Tarquinio, ha scritto che in passato i cattolici si sono trovati ad essere più marginali stando nel centro-sinistra. Si possono già stabilire ora delle appartenenze nello schieramento politico?
«Dopo la fine della Dc la presenza dei cattolici in politica si è un po’ diluita. E mi pare che sia nel centro destra che nel centro sinistra non ci siano stati protagonisti cattolici. Certamente l’esperienza di Romano Prodi è stata importante. E credo che di fronte alla crisi sia necessario interrogarsi come rispondere. C’è ancora tanta strada da fare, e non tutti i cattolici ritengono che l’unica da percorrere sia quella di un partito. Tuttavia, di fronte al berlusconismo che ha monopolizzato il Paese da vent’anni, si aprono degli spazi».
L’obiettivo può essere una rinascita della Dc?
«Io sono nato dopo il 1970. Ho pianto per la caduta del Muro di Berlino. Sono domande che forse si fanno altre persone. Ma vedo il mio Paese che affonda, e questo non mi piace».
“Gli ultimi 10 anni una triste époque serve un nuovo progetto per i cattolici a Todi le basi per un confronto”
intervista ad Andrea Riccardi a cura di Marco Ansaldo
in “la Repubblica” del 14 ottobre 2011
«Ci interrogheremo sul futuro dell´Italia, non sul fare un partito o no. C´è da fare un investimento sul tessuto della società, un investimento culturale. In questa fase sono importanti le idee».
Rifugge dal ruolo di “deus ex machina” dell´iniziativa. «Macchè “deus”. Intanto, manca la “machina”», risponde con spirito sottraendosi alla domanda. Ma il professor Andrea Riccardi, storico cattolico e fondatore della Comunità di Sant´Egidio, è l´uomo su cui stanno convogliando molte delle attenzioni riguardanti il Forum delle associazioni cattoliche. Lunedì, a Todi, il convegno potrebbe fare da grembo alla nascita di un nuovo soggetto politico.
Siamo alla vigilia di una riunione che potrebbe segnare un momento importante per la politica italiana. Ma non ci sono forse troppe attese?
«È vero, si è caricato questo convegno di tante attese. Non perché non sia importante, ma perché c´è una grande domanda fra la gente e nel Paese. Domanda di idee, di prospettive e di visioni. Si tratterà però di un momento significativo, come approdo al lavoro svolto dagli attori del Forum, in particolare da Raffaele Bonanni. C´è poi il lavoro quotidiano di tanti movimenti ecclesiali accanto alla gente. Se Todi si è caricato di attesa probabilmente è perché c´è bisogno di luoghi di speranza».
Sotto il profilo concreto di che cosa si discuterà?
«Insisto sull´aspetto delle idee. Idee con i piedi per terra, maturate nella realtà, nel mondo del lavoro, nel radicamento sociale, in una Chiesa ben inserita nel tessuto del Paese e che “vede” la crisi».
Però non c´è il rischio di trovarsi in conflitto con un´altra iniziativa che punta alla nascita di un nuovo soggetto politico, quella in embrione di Luca di Montezemolo?
«Montezemolo ha avuto il merito di porre il problema del dopo. Si tratta di cose diverse. Nel processo che porta al convegno di Todi, e che andrà oltre, c´è un pensare prossimo alla politica, ma distinto. Più che la matrice di un partito, c´è un grembo di idee, di visioni e di speranze. Un percorso che nel variegato tessuto cattolico è in atto da tempo. È un´amicizia pensante fra cattolici, ma dialogante con i laici. Un´amicizia responsabile».
Non sono formule vacue?
«Queste non sono parole, né un fumo che nasconde qualcosa. La nostra società ha bisogno di pensieri lunghi e di sguardi in avanti. Perché la nostra politica si è impoverita di cultura, con un dibattito urlato che interessa la gente sempre meno».
Il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei, terrà la prolusione dei lavori. C´è chi ha scritto che questo sarà il suo partito. Non ci metterà il cappello sopra?
«Guardiamo alla prolusione di Bagnasco ai vescovi: è il suo messaggio all´Italia. Lui ha partecipato a vari convegni di riflessione. La sua presenza a Todi non mi meraviglia. Non so cosa dirà, ma non credo che su questa iniziativa voglia mettere il cappello nè la corona. Fra i suoi messaggi è rimasto ignorato quello che sottolinea la responsabilità dei laici cattolici nella vita politica. Un passaggio da guardare con attenzione. Bagnasco non prenderà la testa delle legioni cattoliche verso la politica. Piuttosto, darà un contributo autorevole a un dialogo polifonico».
Dunque prima il progetto e poi la ricerca di un leader?
«Sì, condivido l´impostazione. Penso che in Italia si conoscano poco tante personalità in grado di emergere. E in un momento in cui siamo tutti dominati dalla fretta trovo estremamente positivo il fatto di prenderci il tempo per un progetto da proporre. È anche questa la novità e lo spirito di diversità che contraddistingue Todi: dialogare con i politici, ma non farsi travolgere dal botta e risposta. Poi, per la mia formazione di studioso, è l´approccio giusto».
Avete dei nomi, dei punti di riferimento negli attuali schieramenti?
«Parlarne sarebbe sviante. Come detto, ci troviamo all´inizio di un discorso pre-politico».
Todi può essere l´inizio di una risposta al dopo Berlusconi?
«Vedo che si parla di elezioni nel 2012. Gli italiani hanno bisogno di risposte alle loro tante domande. Siamo in un periodo grave, con un tessuto sociale lacerato e a rischio di tensioni conflittuali. Ci vuole una transizione verso un nuovo ciclo politico: responsabile, paziente e pensata.
Ci siamo trovati negli ultimi dieci anni in quella che chiamo la “triste epoque”. Forse in Italia una vera cultura di destra non c´è mai stata. Quella di sinistra si trova in crisi. Non è così, però, per la cultura dei cattolici. Che in questi anni, come si vede, è sempre stata alimentata e promossa».
«Il Pd raccolga la sfida di una nuova politica»
intervista a Beppe Fioroni, a cura di Maria Zegarelli
in “l’Unità” del 14 ottobre 2011
Un’entità pre-politica, per ora. Una rete di associazioni che coinvolge milioni di persone.
L’appuntamento dei cattolici a Todi, in programma lunedì prossimo, «La buona politica per il bene comune», è infondo la conseguenza diretta di quel monito lanciato durante l’ultima prolusione dal cardinal Bagnasco, «Non possumus nunc silere», «non possiamo ora tacere». Per Beppe Fioroni è «un treno partito, che non si fermerà». Il punto è chi nell’attuale quadro politico sarà in grado di coglierne «la straordinaria sfida».
Fioroni, lei da cattolico impegnato politicamente come guarda all’appuntamento di Todi?
«Credo che nel panorama dell’Italia di oggi Todi rappresenti un elemento di novità molto importante. In un Paese dove paure e insicurezze portano tutti a chiudersi nel proprio egoismo, con una politica che dà l’idea di essere lo strumento con il quale i furbi realizzano i propri interessi a discapito degli altri, trovare una mobilitazione all’insegna della responsabilità penso sia il segnale di una rivoluzione del bene. Da lì si parte non per ricostruire un partito nuovo ma per lavorare, come sale e lievito, affinché si torni al futuro con una politica nuova».
Ma è o no la premessa per dare vita alla cosiddetta Cosa bianca?
«Da Todi parte un messaggio che diventerà un messaggio di popolo, si calerà nei territori per chiedere una vera offerta politica diversa da quello che c’è oggi. E si lancia una sfida ai soggetti politici esistenti: chi vuole interloquire deve dimostrare di essere all’altezza».
E il Pd secondo lei è all’altezza, può essere l’interlocutore di questo soggetto culturale e sociale, come si definisce?
«Se i cattolici fanno questa iniziativa è perché avvertono la necessità di una politica diversa e il Pd deve rendersi conto che se ritiene quel mondo un interlocutore fondamentale, senza il quale non si governa l’Italia, deve saper rispondere a una richiesta di proposte e iniziative politiche concrete. E i primi ad avere interesse ad avviare questo percorso devono essere i cattolici impegnati n politica».
Cioè, in buona sostanza, secondo lei il Pd così come è oggi non è all’altezza?
«Il Pd e il Pdl fanno entrambi un errore sostanziale. Non hanno capito che per incrociare quel mondo bisogna essere rispettosi e la prima cosa da fare è smettere di pensare che siano un “franchising”. Il Pd non può pensare di rispondere su tre o quattro cose e dire di tacere su tutto il resto. Quello è un mondo che nella seconda Repubblica ha guardato a destra e se oggi avvia una iniziativa di interlocuzione è perché vuole un cambiamento ».
Il Pdl li ha delusi, il Pd non li convince. Dipende dal fatto che non è sufficiente parlare di giustizia sociale e povertà, ma bisogna dare segnali concreti anche sui temi ticamente sensibili. È questo che pensa?
«Dico che il Pd deve cambiare approccio perché etica della vita e etica sociale hanno il medesimo fondamento. La testimonianza e l’impegno di un cattolico in politica in questo senso non deve essere considerata dal Pd come pesante libertà di coscienza, ma come una straordinaria opportunità per rappresentare la società e dire a quel mondo che può stare in questo partito. Nel campo dei diritti non può esserci la “valorialità fai da te”: sarebbe la codificazione del relativismo».
Che succede se il Pd non assume questo approccio? Lei se ne andrà e contribuirà a trasformare questo soggetto sociale e culturale in soggetto politico?
Se il Pd non saprà raccogliere la sfida vuol dire che decide di rivolgere la testa indietro e rinunciare a essere quello che voleva per tornare a essere ciò che è già stato. Sarebbe un grande peccato».
Ma lei non risponde alla domanda. È tentato di lasciare il Pd davanti a questi nuovi scenari in evoluzione?
«Io voglio che il mio partito rappresenti quel mondo, che mi dia la possibilità anche attraverso la mia azione di far sentire quel mondo rappresentato. Questo voglio».
Lei sostiene che il Pd rischia di tornare ad essere quello che era. E i cattolici non sono tentati di tornare ad essere quello che erano, tutti uniti nella Balena bianca eppur del nuovo Millennio?
«Quello che può diventare questo movimento è funzione di quello che i cattolici impegnati in politica sapranno fare. Se non saranno all’altezza quel treno è comunque partito e non si fermerà».
Il direttore di Avvenire, Tarquinio, sostiene che i cattolici hanno avuto un ruolo marginale in politica.
«Vorrei ricordare al direttore che se la legge 40 è stata approvata, lo si deve ai popolari che l’hanno votata e sostenuta. Se le scuole paritarie e cattoliche oggi hanno molti meno fondi di quelli che ha garantito Prodi quando era al governo è perché i cattolici di centrosinistra non sono stati affatto irrilevanti».
Lei è uno degli interlocutori di quel mondo. Ci aiuta a capire in che cosa consiste questa richiesta di nuova politica?
«L’iniziativa di Todi parte da alcune riflessioni su quanto la politica ha fatto durante la seconda Repubblica. Sono tre i fondamenti su cui si è retto questo impianto che oggi quel mondo ci dice di modificare profondamente. Intanto la politica ha pensato che fosse nuovo e moderno rimuovere il concetto dell’agire fondato sui valori e quindi ha scardinato identità e appartenenze. In secondo luogo ha proposto una scissione tra il desiderio e il valore, ancora a scapito di quest’ultimo. Infine ha barattato la partecipazione con l’esaltazione della comunicazione, facendo saltare il rapporto tra l’eletto e l’elettore».
Come si dovrebbe ricostruire su queste macerie?
«Tornando all’idea che l’impegno in politica sia finalizzato al bene comune e non personale. Per questo il cardinale Bagnasco ha lanciato un monito ai cattolici, perché c’è bisogno di una nuova partecipazione per “pulire l’aria”, per rimettere al centro valori, etica della vita e etica sociale».
Premette e avvisa: «La fede non può in alcun modo sostituire la conoscenza puntuale dei problemi, che è una condizione necessaria perché le decisioni assunte dalla politica siano efficaci e producano buoni risultati». Giorgio Campanini, per lunghi anni professore di Storia delle dottrine politiche all’Università di Parma e poi di Etica sociale a Lugano e di Teologia del laicato alla Pontificia Università Lateranense a Roma, ha appena compiuto 80 anni e ragiona di politica e di fede, di religioni e di Stato e del rapporto non sempre facile tra cristianesimo e potere. E riflette sull’Italia e sulla Chiesa, i suoi vescovi e i suoi laici impegnati e disimpegnati, in un travagliato momento politico per il Paese. Voce di riferimento per la comunità ecclesiale durante la stagione postconciliare, senza sconti per nessuno.
Professore, perché la conciliazione tra il cristiano e la politica è difficile?
«Per un cristiano la politica è “servizio”, ma poi deve stare attento e non fare pasticci tra l’etica del successo e l’etica della testimonianza ».
Ma lei da cosa parte?
«Dal Vangelo, perché lì dentro ci sono gli strumenti per l’analisi. Prenda la questione della competenza. Rilegga Luca, quando il Signore spiega che chi ascolta le sue parole è come un uomo che ha costruito la casa sulla roccia e quando viene la tempesta e il fiume rompe gli argini la casa sta in piedi perché era costruita bene. Insomma, per operare bene in politica non basta la buona volontà, la buona fede, come si dice, e nemmeno una personale vita di pietà».
E lo spirito di servizio, altra formula spesso abusata?
«C’è un’ipocrisia con la quale spesso il potere usa quella formula, mentre essenzialmente persegue fini di successo e di affermazione personale o di gruppo. È il tema delle distorsioni: clientelismo, favoritismi vari, uso improprio della capacità di persuasione del politico fino ad arrivare alla corruzione. Ma c’è un’altra questione da analizzare, e cioè la zona grigia che sta tra la vera e propria corruzione, cioè un reato, e l’esercizio del potere discrezionale, che non è reato ma non vuol dire che sia ammesso, se esso diventa improprio. Per un cristiano che fa politica non basta astenersi dalla corruzione, occorre anche dare un’esemplare testimonianza, per esempio stando lontani da chi – parenti, amici, finanziatori, sostenitori – sollecita un uso disinvolto del potere, aiuti, posti e via di seguito. Si chiama “rigore morale” e oggi è una sorta di chimera».
Come giudica l’attuale momento politico?
«È uno dei più tristi della storia della Repubblica, ma non è tutta colpa della politica. Una notevole responsabilità l’ha l’opinione pubblica, che ha preferito l’intrattenimento televisivo, che non chiede informazione corretta, che ha deciso di non partecipare alla vita civile. E quando sono i cattolici ad aver perso passione per la città, cioè l’amore per le cose comuni, per dirla con Giorgio La Pira, il guaio è grande. Negli ultimi trent’anni i cattolici se ne sono andati dalla politica, hanno messo nel cassetto le proprie “virtù sociali”, hanno deciso di non andare a votare».
Peccato di omissione?
«Non faccio il confessore. Osservo solo che la disinformazione va bene, che si è accettata la delega passiva, che in giro c’è una riluttanza forte a informarsi sui programmi dei partiti e le personalità dei candidati, che “tutto va bene” e chi dissente è guardato con sospetto. Domando: davvero è senza importanza che l’etica pubblica sia sparita dall’orizzonte?».
Secondo lei da quando è accaduto?
«Da Craxi in poi è iniziata una fase involutiva della politica».
Che i cattolici non sono stati in grado di contrastare…
«Esattamente. Da una parte ci si era illusi che occupando ancora il potere con la Dc si poteva salvare qualche cosa. Dall’altra, l’episcopato italiano ha creduto, venuta meno la Dc, di poter gestire direttamente il rapporto tra la Chiesa e la politica. Ma ha demotivato i laici cattolici. Se l’episcopato parla sempre, perché dovrebbero poi intervenire i laici? L’esempio più recente è la Settimana sociale di Reggio Calabria: attenzione al messaggio del Papa e alla relazione del cardinale Bagnasco e silenzio sul lavoro delle commissioni dove parlavano i laici. Qualche difetto c’è».
Senza il cardinale Ruini in questi anni sarebbe stato peggio?
«Da molti anni la Cei gestisce in prima persona il rapporto con la politica. Io credo che, invece, i vescovi dovrebbero intervenire solo in casi eccezionali. La Gaudium et spes sottolinea la responsabilità dei laici. C’è qualcosa che non va nell’applicazione del Concilio».
Cosa bisogna cambiare?
«Bisogna scovare qualche organismo ecclesiale che dia voce ai laici ed esprima l’opinione dei cattolici e non solo dei vescovi. Può essere il Comitato permanente delle Settimane sociali, ma deve essere guidato da un laico e non da un vescovo. Oppure il Forum del progetto culturale, ma vescovi e cardinali devono fare un passo indietro».
Per dire che cosa?
«Per parlare, innanzitutto. Le faccio un esempio: sui 150 anni dell’unità d’Italia non c’è alcun documento su cosa i cattolici si attendono, su cosa vogliono che sia realizzato. Hanno parlato solo vescovi e cardinali. Sulla crisi politica non è stato elaborato nulla e non basta assolutamente per essere contenti mettere in fila le prolusioni del cardinale Bagnasco alle Assemblee e ai Consigli permanenti della Cei. I laici cattolici parlano e scrivono in ordine sparso e non c’è nessuno che si preoccupi di dare loro voce unitaria».
È soltanto questione di forma o anche di contenuto?
«La passione civile latita anche dai pulpiti, dalla catechesi, dalla prassi quotidiana: è paura della politica. Il cattolicesimo italiano sta diventando intimistico e soffre della stessa malattia della società: ciascuno si fa gli affari propri».
E sui “valori non negoziabili”?
«Sull’argomento ho delle riserve. L’esistenza di Dio è un valore non negoziabile. Ma quando si dilata troppo questa categoria si cade in più di un equivoco e si impedisce alla politica di avere cittadinanza. La politica è l’arte della mediazione. Prenda la vita, pacificamente valore non negoziabile. Ma non basta l’affermazione, perché poi si tratta di capire come la si difende in un particolare momento storico, cioè come si negozia sulle scelte. Qui i cattolici possono anche dividersi tra loro, arrivando a scelte politiche diverse, senza che ciò debba creare scandalo».
L’attuale Governo su questo piano secondo lei va promosso?
«Si può dire che ha impedito qualche deriva radicale sulla questione dell’eutanasia. Ma sulle politiche a favore della famiglia il mio giudizio è pesantemente negativo. E poi ci sono problemi come la questione dell’etica privata distinta da quella pubblica, la sindrome da presidenzialismo, la subordinazione dei valori agli interessi, l’uso strumentale, a volte, dell’etica evangelica, l’apparenza a scapito della sostanza».
Molti tendono a dare la colpa a Silvio Berlusconi. Lei che ne pensa?
«Magari fosse così! Auguro a Berlusconi lunga vita da pensionato. Ma non è lui il problema. È la cultura che in questi anni è stata imposta: arrivista, erotizzata, basata sulla visibilità. Piace agli italiani, ma non dovrebbe piacere ai cattolici».
IL DIBATTITO SULLA STAMPA
IL FORUM DI TODI
I cattolici, la politica, il futuro dell’Italia
“Sembra stagliarsi all’orizzonte la possibilità di un soggetto culturale e sociale di interlocuzione con la politica, che sia promettente grembo di futuro”. Così il cardinale Bagnasco accennava il 26 settembre, nella sua Prolusione, al profilarsi di una nuova stagione di presenza dei cattolici al servizio del Paese. Una necessità sempre più avvertita nel laicato cattolico; è stato questo il fondamento del Forum di Todi di lunedì 17 ottobre, al quale hanno partecipano cattolici di diversa ispirazione impegnati nella società, nella cultura, nell’economia e nell’informazione, radunati dalla consapevolezza che c’è bisogno di un nuovo slancio per far uscire l’Italia dal pantano di una crisi – etica e non solo economica – di difficile soluzione. In questo dossier raccogliamo tutta la documentazione prodotta da Avvenire sul tema.
“Oggi la Chiesa non sembra più accontentarsi di questi riconoscimenti formali, o anche di alcuni vantaggi che i governi assegnano alla religione prevalente nella nazione, a fronte del prezioso ruolo che essa svolge a vari livelli. Di qui la domanda ai cattolici di essere più presenti e propositivi sulla scena politica”
“Parlare di un partito dei cattolici rivela un’esigenza generale e un pericolo da scongiurare. La prima risponde al bisogno dell’intero Paese di recuperare l’accezione negletta di «bene comune»… Il pericolo è che, sull’onda dell’emergenza, si creino attese di rinnovamento fondate solo sulla buona volontà (con frustrazione collettiva in caso di insuccessi)… Il contributo dei cattolici alla rigenerazione del Paese è possibile se frutto di un’elaborazione di cultura politica…”
“Ciò che emerge è la volontà di non farsi strumentalizzare da chicchessia. I cattolici di Todi non intendono diventare solo un serbatoio di voti per le formazioni politiche esistenti: anche per questo Costalli ha avvertito che «chi si chiude nel fortino degli attuali partiti rischia di essere travolto». Libertà è reclamata infine anche nei rapporti con i vescovi.” (ndr.: la libertà non è una concessione. La si sceglie)
“lavori in corso a pieno ritmo, il cui esito finale sembra essere la costruzione di un’area clerico-moderata – lobby o partito che sia – di centro-destra, senza Berlusconi, ancorata ai «valori non negoziabili» di vita e famiglia declinati dai vescovi e ai temi cari al mondo cattolico (scuola confessionale e sussidiarietà), sul modello del Ppe”
“Le verità strettamente religiose… messe in secondo piano. In primo piano, invece, quelle che riguardano l’etica sociale. Così il cristianesimo si è assicurato un ruolo importante anche in una società secolarizzata come l’attuale…. In questo quadro di accettazione della laicità si deve intendere anche l’attuale sforzo per ridare voce ai cattolici anche in Italia.”
“quale atteggiamento può assumere il Pd di fronte a queste novità dell’arcipelago cattolico? Spesso non si hanno orecchie attente ad ascoltare e comprendere… Talvolta vi è persino una diffidenza, alimentata da radicati pregiudizi laicisti… Proprio i cattolici, che insieme ad altri hanno contribuito a scrivere la Costituzione e a tessere la rete delle istituzioni democratiche, possono essere una risorsa per chi vuole un Paese più libero e più giusto”
“Il 19 luglio scorso è stato presentato alla stampa il manifesto «La buona politica per il bene comune»… Il 17 ottobre, sui contenuti del manifesto, sarà organizzato un seminario [Todi] … All’orizzonte non c’è la prospettiva del partito dei cattolici, ma l’esigenza di ricercare laicamente nuove modalità per incidere nella formazione di nuovi equilibri delle rappresentanze con altre espressioni culturali e politiche della società italiana”
“Il segnale mediaticamente più recente e rilevante è stato l’intervento (quasi una lectio magistralis) di Ermanno Olmi in… uno spazio da grandi ascolti per un padre nobile della cultura cattolica contemporanea… In vista di Todi, la domanda è legittima: qual è lo stato di salute della cultura cattolica? I fermenti non mancano, e nemmeno le scelte di prospettiva”
“la domanda che dobbiamo porci di fronte al fermento politico che sembra attraversare il cattolicesimo italiano non è «Dc o non Dc?», ma «Gentiloni o Sturzo?». Un abisso separa la soluzione clerico-moderata gentiloniana… che vede i cattolici come supporto ad uno schieramento esistente… da quella sturziana… [in cui] dei cattolici si assumono l’onere di elaborare una mediazione politica… che riflette la loro ispirazione e che può essere condivisa da altri”
“E l’assemblea di Todi può aiutare a riempirlo? «L’incontro di lunedì non sarà politico in senso stretto… Eppure avrà a che fare con la politica»… «La crisi è profonda ed è urgente interrogarsi sul futuro del Paese. I cattolici… oggi sentono la responsabilità di essere parte di una comunità nazionale. È questa, credo, la coscienza con cui ci si incontra a Todi»”
“All’inizio dei lavori del seminario ci sarà una prolusione affidata al presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Angelo Bagnasco, e questa scelta non è facilmente comprensibile alla luce della necessaria laicità dell’avvenimento: sa tanto di ipoteca clericale su un incontro nel quale i protagonisti sono i laici cattolici impegnati nelle varie realtà associative.” “Il Pdl e i suoi alleati più o meno prezzolati hanno corroso l’impalcatura ideale su cui è stata costruita la Costituzione. In mezzo a tanta incertezza, chiaro è dunque il rischio che si profila: un Pdl in salsa cattolica con timbro vaticano. Una “Cosa bianca”, irrimediabilmente vecchia e ben poco attraente, rispetto alla quale i cattolici hanno un solo dovere: opporsi.”
“Lunedì, a Todi, si riunisce la carovana cattolica. Un’assemblea mai vista dal dopoguerra ad oggi. Oltre cento rappresentanti. Per la prima volta saranno insieme tutte le principali sigle dell’area bianca….”
“Dall’incontro di Todi ci si aspetta «uno spirito d’apertura al confronto e alla ricerca tra esperienze di impegno diverse… Non abbiamo risposte predefinite» scandisce il presidente dell’Azione cattolica. «Prima vi è da far maturare tra i cattolici un “nuovo sentire” che abbia al centro il bene comune… Poi si vedrà quale sarà la forma anche organizzativa più utile per far maturare un legame più stretto tra i cittadini e le istituzioni»”
“Altri ancora – mi sembra il progetto migliore – sperano nasca non un «partito» né solo una «scuola di politica», ma un luogo di studio, di libero confronto tra cristiani liberi e adulti, «un soggetto culturale e sociale di interlocuzione con la politica, che – coniugando strettamente l’etica sociale con l’etica della vita – sia promettente grembo di futuro, senza nostalgie né ingenue illusioni».”
“L’appuntamento [di Todi] sarà aperto da Bagnasco in persona con una prolusione che molti prevedono «impegnativa» sul piano delle scelte future. «Il cardinale ha accettato il nostro invito e ne siamo lietissimi. Ma l’obiettivo è sollecitare i laici a darsi da fare». Il titolo del meeting è la “La buona politica per il bene comune. I cattolici protagonisti della politica italiana»… «In un nuovo modello di sviluppo… i politici devono essere dei francescani, devono dare l’esempio»”
“«A creare questa nostra Italia, il cattolicesimo fu d’ostacolo: gli elementi cattolici che vi parteciparono furono per lo più imbevuti di semi-giansenismo e di giobertismo della cui perfetta ortodossia è lecito dubitare». Bisogna partire da questa frase di Adolfo Omodeo per capire l’ispirazione del nuovo saggio di Massimo Teodori, ‘Risorgimento laico. Gli inganni clericali sull’unità d’Italia’”
“Il pluralismo delle scelte politiche dei cattolici è una realtà consolidata ed evocarne l’unità sul piano sociale e culturale non è meno fuorviante che farlo sul piano politico.” “”Animare” è verbo impegnativo; ed è molto diverso dal verbo “contare”. «Non vogliamo essere più contati, ma contare» ha detto il rettore della cattolica Lorenzo Ornaghi a coronamento volontaristico delle sue tesi “neoguelfe”. Ma se questo è lo scopo basta un patto scritto o tacito con il potere di turno, specie quando si dichiara “compiacente”, come nel caso di Berlusconi. Con il noto seguito di amarezze. Se invece si tende ad “animare”, il percorso è più arduo”
“Nell’area ecclesiastica ha vinto alla fine la strategia tenacemente portata avanti da Casini da due anni: nessuna alleanza con Berlusconi, rimozione del premier e poi creazione di un partito moderato non confessionale”
“In zona di ‘ndrangheta, di crisi, di disperazione, Benedetto XVI sceglie l’immagine della «terra sismica», e non solo «dal punto di vista geologico» ma anche «strutturale, comportamentale e sociale»: una terra «dove… una criminalità spesso efferata ferisce il tessuto sociale, in cui si ha la continua sensazione di essere in emergenza». Di qui l’elogio alle «sorprendenti» capacità di reazione dei calabresi… E l’appello prepolitico all’impegno nella società”
“Papa Benedetto XVI torna a lanciare il suo invito, questa volta particolarmente pressante, al laicato cattolico perché «non faccia mancare il suo contributo di competenza e di responsabilità per la costruzione del bene comune». E non per interessi di parte.” (ndr.: anche della chiesa)
“La sintesi quantitativa – la ricerca non si pone l’orizzonte qualitativo-valutativo delle scelte – mostra una interessante mappa dell’Italia, sicuramente utile a operatori politici e a gerarchie ecclesiastiche per elaborare strategie e pastorali.” (ndr.: ci si può basare solo su dati numerici quantitativi?)
“l’Italia cattolica è cambiata, e molto rapidamente, negli ultimi anni. Lo dimostra con dovizia di dati e con esemplare chiarezza il libro di Roberto Cartocci che fornisce una mappa della dimensione e della distribuzione territoriale dei cattolici in Italia…” “Questa ulteriore conferma della diversità territoriale del nostro paese pone ai cattolici e alla Chiesa una doppia sfida: recuperare il nord in via di accentuata secolarizzazione, e sottrarre il sud confessionale a quell’ attaccamento alla ritualità e a quella fascinazione per gli aspetti magico-tradizionali della religione che hanno a lungo depresso l’espressione autentica della fede e lo sviluppo dei movimenti cattolici. Senza soddisfare questo duplice obiettivo un nuovo partito dei cattolici non potrà farsi troppe “illusioni”.”
“Come si fa a pensare anche solo per un attimo di costringere la cultura dei cattolici in una nicchia? E per fare cosa poi? Una Dc degli anni Duemila? Un partito confessionale o di testimonianza? Si tratterebbe di iniziative anacronistiche, germinate più dal tentativo di occupare… uno spazio politico di mero potere che dalla volontà di affermare valori e cultura cattolici”
“Il referendum – o comunque una nuova legge elettorale – può aprire una strada nuova, comune a cattolici e laici, per una democrazia con meno polemiche – anche interne al Pd – ma più trasparente e rappresentativa.”
“a me interessa di più registrare questa vivacità del risveglio dei laici credenti. Auspico però che nel fare le scelte e nel decidere gli schieramenti consultino quella bussola. Perché tutti e quattro quei punti cardinali sono decisivi per una “politica buona” e possono rivelarsi decisivi per il bene del Paese che in questa crisi sembra davvero aver perso la bussola.”