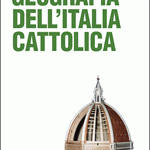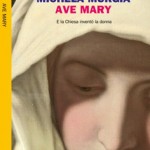Una voglia di responsabilità politica
Gli anni Novanta hanno trasmesso ai politici del nuovo secolo una certezza: la definitiva scomparsa del partito cattolico. Giuseppe Dossetti affermava nel 1994: «Non ci sarà una generazione di
cattolici al potere; una seconda chance non ci sarà… la Democrazia cristiana non ha più senso». La Dc allora appariva delegittimata (anche se vale ricordare che alle elezioni del 1992 aveva preso il
29,7%dei voti, peraltro suo minimo storico). Sembrava rappresentare il vecchio, il corrotto, la commistione tra politica e vita religiosa. «Democristiano» era divenuta un’espressione dalla valenza negativa. Il nuovo era altrove. I cattolici si divisero, confluendo con Berlusconi (che raccolse buona parte dell’elettorato ex democristiano) o cominciando un viaggio con la sinistra. Presidiare il centro, anche per il sistema elettorale bipolare, è stata impresa difficile. Avvenne la diaspora politica dei cattolici. Scomparve la Repubblica dei partiti (per dirla con Pietro Scoppola), quella anomalia italiana, caratterizzata dalla centralità della Dc e dall’opposizione del partito comunista. L’Italia stava diventando un Paese «normale»? Così è sembrato a tanti, finché negli ultimi tempi è cresciuta la coscienza, ormai diffusa, che la Seconda Repubblica non sia mai veramente nata. Siamo ancora in una lunga transizione, di cui non si vede la fine.
Ultimamente anche il giudizio sui cinquantadue anni di storia della Dc si è trasformato. Non si tratta di occasionali riabilitazioni. Quella vicenda è stata rivisitata da storici come Agostino Giovagnoli, che hanno mostrato come la Dc sia stata il «partito dell’Italia» e della costruzione della democrazia. Anche a livello quotidiano, nelle conversazioni tra la gente si nota un cambiamento semantico: «democristiano» non è più termine negativo, anzi in genere esprime apprezzamento per la professionalità dei politici di quella scuola. A ben vedere il partito cattolico non è stato una meteora politica. Da quando le masse entrarono sulla scena elettorale, dopo la legge sul suffragio universale del 1912, si aprì il problema della rappresentanza cattolica. Ci fu, dal 1919 il popolarismo di Sturzo fino al 1926; poi venne dal 1942 la Dc, per iniziativa di De Gasperi e mons. Montini. Per più di mezzo secolo, l’Italia ha avuto un partito cattolico al centro del sistema. E con esso, due classi dirigenti cattoliche, intrecciate ma distinte: i vescovi e i politici. In alcuni periodi (prima di don Sturzo, durante il fascismo e dopo il 1994) non c’è stata una classe politica cattolica laica. In ogni caso, la Chiesa ha fatto sentire la sua voce in pubblico, impastata com’è con la storia italiana e con gli italiani. Oggi si riparla di una nuova volontà di presenza dei cattolici in politica. Ma dagli anni Novanta la realtà è la diaspora dei politici e degli elettori cattolici. Benedetto XVI ha ripetutamente invitato i cattolici (specie i giovani) a considerare una rinnovata partecipazione alla politica. Negli ultimi decenni però tante energie cattoliche si sono concentrate su vari mondi sociali, evitando la politica, che appariva poco praticabile.
Del resto il cattolicesimo italiano, nel suo aspetto multiforme, rappresenta la più importante rete sociale del Paese, alle cui spalle esiste una tradizione e una rinnovata elaborazione di pensiero e di valori. È un patrimonio non trascurabile in un Paese in cui si sono consumate tante risorse sociali e morali. D’altra parte il mondo dei cattolici vive in presa diretta con le difficoltà e le povertà degli italiani nella crisi economica e si sente poco rappresentato dalla politica. Il card. Bagnasco, come presidente della Cei, ha sottolineato spesso la valenza sociale e il radicamento del cattolicesimo italiano. Siamo allora di fronte alla gestazione di un nuovo partito cattolico? Forse è un fantasma che, da una parte, inquieta e rimette in discussione il centrodestra e, dall’altra, constata la crisi del contagio tra le culture del cattolicesimo democratico e della sinistra all’origine del Pd.
Certo c’è un malessere diffuso tra i cattolici, che si accompagna alla consapevolezza di avere valori, idee e esperienze. È diffusa l’aspirazione a una visione che dia speranza in un tempo di sacrifici e che ricollochi internazionalmente un Paese ripiegato su se stesso, come ha affermato Lucio Caracciolo su Avvenire. Malessere, aspirazioni, senso di responsabilità hanno messo in movimento da anni un processo tra cattolici: questi stanno riflettendo sulla crisi, raccogliendo stimoli dal contatto quotidiano con i problemi degli italiani (attraverso una fitta rete sociale e pastorale), ma anche riprendendo un patrimonio di riflessione e di etica. I cattolici italiani sono una realtà articolata, in cui i diversi ambienti e organizzazioni, un tempo più autoreferenziali, sono in dialogo maggiormente serrato. Pochi se ne sono accorti. Se il nuovo partito cattolico sembra una notizia d’estate, bisogna però constatare una diffusa voglia di responsabilità di questi ambienti. La Dc non rinasce, ma è in corso — e non da oggi — un processo di condensazione di pensieri e volontà tra i cattolici. Non è facile classificarlo con le attuali categorie della scena politica. Certamente esprime la coscienza che non si può fare politica senza idee, valori, contatto con la gente. Questo processo è forse uno stimolo a che la transizione di questi anni non sia infinita.
in “Corriere della Sera” del 15 luglio 2011
La difficile rinascita della “cosa bianca”
di Agostino Giovagnoli
in “la Repubblica” del 19 luglio 2011
Torna la Dc? Così sembrerebbe, sentendo le voci che si sono intrecciate, all’interno del mondo cattolico, nelle ultime settimane. L’improvvisa scoperta che la frana del berlusconismo è più rapida
del previsto ha spinto ad immaginare nuove iniziative politiche evocando l’ormai lontana esperienza democristiana. Ma molte circostanze storiche, presenti alle origini della Dc o nel corso della sua storia, oggi non ci sono più. La Democrazia cristiana è nata nel contesto di un disastro nazionale di enormi proporzioni, la Seconda guerra mondiale, che ha portato lo Stato italiano quasi alla dissoluzione. In altre condizioni, la Santa Sede non avrebbe accolto le pressanti richieste degli Alleati perché la Chiesa si impegnasse a fondo nella ricostruzione italiana, anche sul piano politico.
Nel dopoguerra, inoltre, era ancora vivo tra i cattolici il desiderio di superare definitivamente una estraneità alla vita politica nazionale cominciata con il Risorgimento. I modelli sociali e politici del secolo breve, poi, li spinsero a formare anch’essi un grande partito di massa e l’aspirazione ad uscire da una secolare condizione di miseria, diffusa nell’Italia del dopoguerra, ha orientato la Dc verso una politica economicamente interclassista e politicamente inclusiva.
L’elenco potrebbe continuare a lungo, ma già questi elementi evidenziano un punto cruciale: nella Dc l’unità politica dei cattolici si è saldata ad un progetto storico strettamente legato alla ituazione e alle esigenze del tempo. Non a caso, pur con il determinante sostegno della Chiesa, l’iniziativa fu presa e condotta da laici, anzitutto da De Gasperi e dal gruppo degli ex popolari, e in seguito, con la seconda generazione di La Pira e Dossetti, Fanfani e Moro, l’influenza dei leader democristiani sul mondo cattolico si è ulteriormente accresciuta. Nella Dc, infatti, l’unità dei cattolici ha svolto – singolarmente – una funzione laica a sostegno dello Stato e proprio tale duplice natura spiega le molte peculiarità di questo partito che è sempre stato al governo e mai all’opposizione, che non si è mai diviso malgrado le molte tendenze presenti al suo interno, eccetera.
Tutto ciò è stato riassunto dall’espressione “centralità democristiana”. Centralità è altra cosa da centro. La Dc non è stata (solo) un partito di centro, è stata (soprattutto) un partito centrale nel sistema politico e nella società italiana. È stata, insomma, il “partito italiano”. Rifare la Dc oggi non significa solo realizzare nuovamente l’unità politica dei cattolici (impresa già in sé piuttosto difficile), ma perseguire anche un progetto politico “nazionale” (opera ancora più impegnativa) e saldare efficacemente tra loro queste due cose (sfida addirittura eccezionale perché legata a condizioni storiche particolari). Nei molti incontri, dibattiti e interventi di queste settimane è emersa tra i cattolici l’esigenza di interrogarsi sui riflessi politici di una comune sensibilità su temi etici o sociali. In questo senso, si può parlare di una spinta unitaria più forte rispetto ad un passato recente, caratterizzato prevalentemente dalla tendenza alla diaspora. Istituzione ecclesiastica e associazionismo cattolico, infine, possono favorire ulteriormente tale unità. Ma per rifare la Dc sarebbe anzitutto necessaria una classe politica laica, capace di un disegno di grande respiro storico.
Al momento – tra i cattolici, come pure altrove – appare invece ancora embrionale una riflessione storica e politica adeguata alle sfide dell’ora. L’impressione è che, al di là delle intenzioni, anche ora chi parla di “rifare la Dc” possa prevalere di fatto il più limitato obiettivo di creare un partito di centro, vicino all’istituzione ecclesiastica, facilmente minoritario o di dimensioni limitate, impegnato su specifiche battaglie etiche, oscillante fra governo e opposizione, ecc. Si tratta di altra cosa rispetto ad un partito centrale, a vocazione nazionale e con un progetto politico laico, “condannato”, per così dire, a guidare il Paese per un lungo periodo, prima del lungo declino e del tracollo finale.
Non tutti i cattolici, peraltro, pensano ad un partito che esprima prioritariamente le loro posizioni.
C’è, infatti, chi guarda piuttosto ad un acquisire maggiore peso nei diversi schieramenti, favorendo convergenze su questioni specifiche. Ci si propone di far nascere un’area di centro, divisa tra partiti diversi ma unita da una visione cattolica del bene comune e animata da cattolici provenienti dal mondo associativo, economico e sindacale. In questo caso, la distanza dalla Dc è evidenziata soprattutto dalla rinuncia ad un progetto politico forte e dal rischio della subalternità a gruppi di potere, politici od economici, che ricorda il clerico-moderatismo di inizio novecento. La Dc, invece, ambiva a mostrare, attraverso il confronto con gli altri e la prova dei fatti, la validità dei valori espressi dalla cultura politica dei cattolici. Rifare oggi la Democrazia cristiana, insomma, è tutt’altro che facile.
Altri contributi sul tema:
“tra le «condizioni» per formare la «nuova generazione di politici cattolici» auspicata dal Papa, c’è «il superamento dell’ideologia della diaspora»… c’è «l’instaurazione di nuove relazioni tra mondo politico, ecclesiale e civile». Una frase che consegna alla storia la stagione ruiniana dei «rapporti» tra «vertici»… «occorre pensare a un reale protagonismo del laicato»… andare verso un nuovo «codice di Camaldoli»”
Don Pino De Masi è vicario generale della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi “«’Libera’ è impegnata da anni nella difficile battaglia per il riutilizzo dei beni confiscati. Con i sequestri e le acquisizioni si ottengono due risultati: si ridimensiona il potenziale economico delle cosche e si mette in moto una vera e propria rivoluzione culturale… centinaia di giovani non emigrano più, fedeli alla consegna che si sono dati: che a lasciare la Calabria debbano essere le ‘ndrine, e non loro».”
“L’imponente spostamento di voti dalla Lega e dal Pdl alle posizioni opposte, è spiegabile solo col mutato atteggiamento dei cattolici praticanti,”
“non di un nuovo partito si sente il bisogno, ma in generale di un nuovo modo di fare politica, il che in primo luogo vuol dire nuove modalità di selezione della classe dirigente e garanzia, per i cittadini, di un’effettiva possibilità di scelta dei propri rappresentanti.”
“Anche nellaChiesa sta montando il disagio. L’accoglienza di quelle voci che rifiutano di essere considerate contestatrici è già ravvisata anche qui – guarda caso – nelle Costituzioni del Concilio Vaticano II. Perché allora non ci poniamo tutti la domanda: “Se non ora quando?”.