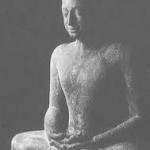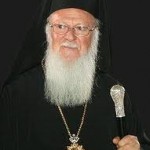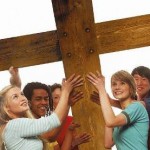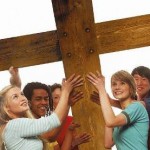
Un mare di giovani provenienti da tutto il mondo (si calcola che ai momenti di incontro con Papa Benedetto XVI siano stati oltre un milione e mezzo, di cui più di centomila gli italiani).
Una folla gioiosa e festante per le vie di Madrid. Una stupenda tavolozza di colori, di bandiere, di magliette, di volti, un coro di voci di ogni genere, un fiume in piena di canti, di parole, di risate. E poi, quegli stessi giovani raccolti nel silenzio prolungato dei momenti di adorazione, attenti e riflessivi nei tempi delle catechesi, spontanei e generosi, stanchi e felici, pronti sempre a ricominciare la giornata con entusiasmo. E noi, vescovi e sacerdoti, educatori e catechisti, insieme con loro, a condividere cibo ed esperienze, testimonianza e fatica, fede e gioia profonde, sin dai giorni dei cosiddetti “gemellaggi” nelle principali città della Spagna. Tutto questo e molto di più è stata la XXVI Giornata Mondiale della Gioventù (GMG), tenutasi nella capitale spagnola in questo agosto infuocato. Alcuni media hanno dato evidenza a qualche chiassosa contestazione di “laicisti” radicali (certamente non “laici”, se con questo termine si vuole intendere la posizione di chi rispetta tutte le posizioni e le identità): la violenza verbale (e talvolta non solo) di qualche scalmanato ha trovato la sua smentita migliore nella risposta del tutto non violenta e serena dei giovani, che hanno semplicemente continuato a cantare, testimoniando gioia e amicizia, simpatia e bellezza della loro scelta di fede.
Stando con questi ragazzi, parlando loro con fiducia e trasparenza, ascoltandoli e vedendoli nei tanti momenti di incontro, non ho potuto non chiedermi quale messaggio venga da loro a tutti noi e alla nostra Europa in crisi economica e morale. Provo a dare qualche risposta, certo però che ciò che si è vissuto in questi giorni a Madrid ha un potenziale di vita e di speranza ben più grande di quanto immediatamente si possa rilevare. In primo luogo questi ragazzi hanno saputo testimoniare che libertà e impegno non solo non si oppongono, ma sono l’una il volto dell’altro: se si pensa ai sacrifici che hanno affrontato (dormendo per giorni in sacco a pelo nelle condizioni anche più proibitive, e mangiando in una maniera che definire sobria è già molto…) e alla gioia con cui li hanno vissuti, ci si rende conto che nessuno avrebbe potuto costringerli a tanto se non ci fosse stata in ciascuno una scelta libera e consapevole di volerci essere. Qui sta la bellezza dei cammini di preparazione che hanno portato questi ragazzi a vivere la GMG, ma qui emerge anche la straordinaria capacità dei nostri giovani di saper fare scelte consapevoli e responsabili di impegno e di dedizione. Vedendoli, mi è venuta tante volte in mente la frase fulminante di Paul Ricoeur a proposito del rapporto fra libertà e necessità: “C’est l’amour qui oblige”. Solo per amore si fa liberamente quello che nessun obbligo esteriore e nessun oro del mondo potrebbe portarti a fare.
Una seconda impressione che ho ricevuto da questi giovani è quella della loro trasparenza, della lealtà e della limpidezza dei loro occhi, dei loro sguardi, del loro cuore. Il loro stare insieme in un clima di amicizia semplice e festoso, dimostra come tanti, veramente tanti giovani di oggi siano molto migliori di come qualcuno vorrebbe dipingerli nel loro insieme. Di fronte allo scenario della politica non solo nostrana, che suscita tante volte disaffezione e perfino disgusto, soprattutto quando si sente dai responsabili della cosa pubblica l’appello alla solidarietà e alla rinuncia senza vederne le conseguenze nella vita e nello stile propri di chi queste rinunce le chiede, questi ragazzi sono una sfida vivente a credere che un mondo diverso e migliore sia non solo possibile, ma necessario e urgente. Nel volto e nel cuore di questi ragazzi la speranza torna a essere l’anticipazione militante dell’avvenire, la passione per ciò che è possibile e bello per tutti, l’inizio di quel mondo nuovo che tira nel presente degli uomini qualcosa della bellezza del futuro promesso di Dio.
Infine, è la radice profonda del comportamento dei giovani a Madrid che mi sembra debba far pensare tutti: essi ci sono andati per ascoltare parole forti, tutt’altro che accomodanti, come quelle che Benedetto XVI sa dire con la sua intelligenza e la fede del suo cuore. Il loro ascolto, il loro entusiasmo li ha accomunati al di là delle differenze e perfino delle distanze di lingue, di culture, di condizioni sociali e politiche, dimostrazione ineccepibile di come il Vangelo sia ancora oggi e forse ancor più che in altri momenti della storia buona novella per amare, sperare e dare la vita per gli altri. E il Vangelo è sfida e dono a vivere quell’esodo da sé senza ritorno in cui consiste propriamente l’amore: un amore certo impossibile alle sole capacità umane, ma che diventa possibile con la grazia di Dio. Questo possibile, impossibile amore hanno incontrato e annunciato i giovani convenuti a Madrid: l’alternativa al vuoto di valori, all’assenza di senso, all’evasione egoistica e inconsistente, esiste, ed è l’impegno di amore al servizio del bene comune, sostenuto dalla fede e dall’amore che il Dio crocifisso ha offerto alla storia di tutti.
Mi chiedo se da questi giovani non venga a tutti noi una proposta capace di scuotere le nostre paure, i nostri calcoli mediocri, le nostre fughe nel privato. La proposta di un Dio più che mai giovane, attuale e necessario come giovane e necessario è per tutti l’amore, per vivere e dare senso e bellezza alla vita.
in “Il Sole 24 Ore” del 21 agosto 2011
Le parole del Papa

-
24 agosto 2011
-
Santa Messa conclusiva
21 agosto 2011
-
Veglia di preghiera con i giovani
20 agosto 2011
-
Visita alla Fondazione “Instituto San José”
20 agosto 2011
-
Incontro con i Comitati organizzatori della GMG
20 agosto 2011
-
Omelia Messa per i seminaristi
20 agosto 2011
I testi integrali dei discorsi e delle omelie di Benedetto XVI alla Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid, nel sito del Vaticano: > JMJ 2011 Madrid
GMG di Madrid online!
Racconta live la tua esperienza

iGMG è un’applicazione creata in occasione della Giornata Mondiale delle Gioventù 2011 di Madrid. Ricca di contenuti audio e video sarà la tua compagna di viaggio in questo evento popolato da giovani di tutto il mondo. All’interno di questa applicazione troverai un diario giornaliero che ti permetterà di appuntare, giorno per giorno, i luoghi visitati, le esperienze vissute, una piccola riflessione; inoltre potrai aggiungere gli amici conosciuti, scattare foto o registrare dei video e tenerli “inseriti” nella giornata in modo che questi momenti diventino ricordi indelebili della tua vita. Sarà possibile anche condividere tutto ciò sulla tua bacheca di Facebook.
Guarda l’articolo – 6/07/2011
La prossima GMG da Madir a Rio de Janeiro

Da Madrid il cuore guarda già a Rio de Janeiro, dove si svolgerà la prossima Giornata Mondiale della Gioventù, dal 23 al 28 luglio 2013.
Nell’udienza generale di mercoledì 24 agosto, il Papa ne ha presentato anche il tema, tolto dal Vangelo: “Andate e fate discepoli tutti i popoli” (Mt 28,19).
Con ancora negli occhi e nel cuore la “formidabile esperienza di fraternità e di incontro con il Signore, di condivisione e di crescita nella fede” vissuta tra i circa due milioni di giovani di tutto il mondo che hanno partecipato alla Gmg di Madrid, il Papa ha voluto immediatamente avviare la preparazione del prossimo appuntamentio che avrà una tappa significativa nella prossima domenica delle Palme, quando la Gmg sarà celebrata a livello diocesano attorno all’espressione paolina “Siate sempre lieti nel Signore” (Fil 4,4).
Ripercorrendo i momenti delle giornate di Madrid – “un grande dono” – Benedetto XVI ha espresso le emozioni suscitate dall’entusiasmo con il quale i giovani e la Spagna lo hanno accolto e accompagnato fino alla celebrazione conclusiva, avvenuta domenica scorsa, 21 agosto.
L’impressione più viva che il Papa ha detto di conservare “con gioia nel cuore” è quella che hanno saputo suscitare i circa due milioni di giovani presenti, con la loro disponibilità a portare nel mondo “la speranza che nasce dalla fede”.
Dopo Madrid.
Come Benedetto XVI ha innovato le GMG
 Sono almeno tre le novità che con questo papa caratterizzano le Giornate Mondiali della Gioventù:
Sono almeno tre le novità che con questo papa caratterizzano le Giornate Mondiali della Gioventù:
gli spazi di silenzio, l’età giovanissima, la passione di testimoniare la fede nel mondo.Dopo ogni suo viaggio fuori d’Italia, Benedetto XVI ama tracciarne un bilancio nell’udienza generale del mercoledì successivo.
Fece così dopo la Giornata Mondiale della Gioventù di Colonia, nell’agosto del 2005:
> Riflessione sul pellegrinaggio a Colonia
Non lo fece invece tre anni dopo, di ritorno da Sydney, perché era luglio e in questo mese le udienze generali sono sospese. Ma il papa commentò più tardi quella sua trasferta australiana nel discorso che tenne alla curia romana per gli auguri di Natale del 2008, riprodotto in questo recente servizio di www.chiesa:
> A Madrid risplende una stella
Questa volta, di ritorno da Madrid, ecco la riflessione che mercoledì 24 agosto Benedetto XVI ha dedicato alla terza Giornata Mondiale della Gioventù del suo pontificato:
> “Oggi vorrei riandare brevemente con il pensiero…”
Da questa e dalle sue precedenti riflessioni, è evidente che Benedetto XVI vede le Giornate Mondiali della Gioventù come un momento saliente della sua missione di successore di Pietro.
A una semplice osservazione esterna, questi ultimi raduni mondiali manifestano almeno tre caratteri distintivi e nuovi, che a Madrid sono apparsi con particolare visibilità.
*
Il primo è il silenzio. Un silenzio prolungato, intensissimo, che cala nei momenti chiave, in una marea di giovani che fino a subito prima esplodevano di gioia festante.
La Via Crucis è uno di questi momenti. Un altro, ancor più impressionante, è quello dell’adorazione dell’ostia santa durante la veglia notturna. Un terzo è stato quello della comunione durante la messa conclusiva.
L’adorazione silenziosa dell’ostia santa è un’innovazione introdotta nelle Giornate Mondiali della Gioventù da Benedetto XVI. Il papa si inginocchia e con lui si inginocchiano sulla nuda terra centinaia di migliaia di giovani. Tutti protesi non al papa ma a quel “nostro pane quotidiano” che è Gesù.
Il violento scroscio temporalesco che a Madrid ha preceduto l’adorazione eucaristica, creando notevole scompiglio, ha reso ancor più impressionante l’irrompere di tale silenzio. E altrettanto è accaduto la mattina dopo, nella messa. L’inaspettata cancellazione della distribuzione della comunione – per non chiarite ragioni di sicurezza – non ha prodotto disordine e distrazione nella distesa sterminata dei giovani ma, al contrario, un silenzio di compostezza e intensità sorprendenti, una “comunione spirituale” di massa di cui non si ricordano precedenti.
*
Un secondo carattere distintivo di quest’ultima Giornata Mondiale della Gioventù è l’età media molto bassa dei convenuti, 22 anni.
Questo significa che molti di essi vi hanno preso parte per la prima volta. Il loro papa è Benedetto XVI, non Giovanni Paolo II, che hanno conosciuto solo da bambini. Essi sono parte di una generazione di giovani e giovanissimi molto esposta a una cultura secolarizzata. Ma sono nello stesso tempo il segnale che le domande su Dio e i destini ultimi sono vive e presenti anche in questa generazione. E ciò che muove questi giovani sono proprio queste domande, alle quali un papa come Benedetto XVI offre risposte semplici eppure potentemente impegnative e attrattive.
I veterani delle Giornate Mondiali della Gioventù c’erano, a Madrid. Ma soprattutto tra le decine di migliaia di volontari che si sono prestati per l’organizzazione. O tra i numerosi sacerdoti e religiose che hanno accompagnato i giovani, e le cui vocazioni sono sbocciate proprio in precedenti Giornate Mondiali della Gioventù. È ormai assodato che questi appuntamenti sono un vivaio per le future leadership delle comunità cattoliche nel mondo.
*
Un terzo carattere distintivo è la proiezione “ad extra” di questi giovani. A loro non interessano affatto le battaglie interne alla Chiesa per un suo ammodernamento al passo con i tempi. Sono lontani anni luce dal “cahier de doléances” di certi loro fratelli maggiori: per i preti sposati, per le donne prete, per la comunione ai divorziati risposati, per l’elezione popolare dei vescovi, per la democrazia nella Chiesa, eccetera eccetera.
Per loro, tutto questo è irrilevante. A loro basta essere cattolici come papa Benedetto fa vedere e capire. Senza diversivi, senza sconti. Se alto è il prezzo con il quale siamo stati salvati, il sangue di Cristo, alta dev’essere anche l’offerta di vita dei veri cristiani.
Non è la riorganizzazione interna della Chiesa, ma la passione di testimoniare la fede nel mondo a muovere questi giovani. Il papa glielo stava per dire con queste parole, nel discorso interrotto dal temporale:
“Cari amici, non abbiate paura del mondo, né del futuro, né della vostra debolezza. Il Signore vi ha concesso di vivere in questo momento della storia, perché grazie alla vostra fede continui a risuonare il suo nome in tutta la terra”.
Il vaticanista americano John L. Allen ha definito i giovani convenuti a Madrid “Evangelical Catholics”:
> Big Picture at World Youth Day: ‘It’s the Evangelicals, stupid!’
__________
La nota di Catholic News Service a proposito della “comunione spirituale” durante la messa conclusiva:
> ‘Spiritual Communion’: Youths learn a traditional concept the hard way
__________
Su un’altra innovazione introdotta da Benedetto XVI nell’ultima Giornata Mondiale della Gioventù:
> Papa Benedetto confessore. L’esordio a Madrid
__________
di Sandro Magister
Altri contributi sulla GMG:
26 agosto 2011
“Un ebreo, Benjamin, due musulmane, Farah e Dieynaba, degli scout col fazzolettone, dei membri del Movimento eucaristico dei giovani, dei fan di Taizé, degli accompagnatori di giovani nella loro diocesi, una persona convertita da poche settimane… I giovani del gruppo Coexister hanno passato la settimana a Madrid. Alla GMG, hanno fatto molti incontri che hanno portato a grandi dibattiti: con i giovani cristiani del mondo intero, ma anche tra loro”
“È molto difficile esprimere una valutazione della GMG da poco terminata a Madrid in questo mese d’agosto 2011, appena scesi dal pullman di ritorno da Madrid… desideravo sostenere e accompagnare i giovani dell’associazione Coexister che avevano deciso di parteciparvi insieme, cattolici, musulmani ed ebrei”
24 agosto 2011
L’arcivescovo di Madrid: «Il Papa si è comportato come un padre, ha voluto incontrare tutti. Abbiamo sperimentato l’espressione concreta della comunione». Yago de la Cierva: nelle difficoltà i ragazzi sono stati un esempio di civiltà.
– Annuncio vocazionale che vince la mediocrità di Antonello Mura
– Madrid rilancia l’evangelizzazione
– E anche l’economia sorride
22 agosto 2011
“La massa di ragazzi convenuta dai cinque continenti e da ben 193 Paesi, nonostante prima l’afa, poi la tempesta, quindi la mancanza d’acqua e poi una notte quasi insonne, hanno accolto con gioia e passione ancora ieri mattina Benedetto XVI nell’immenso campo attorno alla base aerea… Per molti osservatori il Papa è uscito dalla Spagna non solo con un successo rafforzato di immagine, ma anche con un risultato politico concreto”
“«Se Dio è buono, perché mi ha caricato di così tanto dolore», chiede il giovane cattolico Pablo, dopo aver visto due milioni di suoi coetanei, cantare e pregare per eccesso di gioia”
21 agosto 2011
Dal Rapporto del Censis emerge un volto dei giovani italiani di oggi ben diverso: “non hanno alcuna fiducia nella lotta collettiva per cambiare il mondo e dunque preferiscono adattarsi.”
“Il mondo va a rotoli, l’Europa barcolla, lo spettro del collasso dell’economia aleggia nel Vecchio Continente, il futuro è incerto soprattutto per le giovani generazioni, ma nell’ultima settimana Madrid è stata pacificamente invasa da un pezzo di umanità che non sembra segnata dalla paura e dal pessimismo”
20 agosto 2011
“Tra questi Antonio, pugliese che studia a Roma, e che tutti i venerdì sera distribuisce la cena alla persone che vivono per strada a Porta Pia. E Irene, al terzo anno di liceo, che a Novara si occupa del catechismo ai bambini rom. E Lena, che ad Anversa tutti i sabati fa un doposcuola per bambini di diverse nazionalità per favorire l’integrazione. Il Papa li ha guardati e benedetti tutti.”
“…Poi però parli con loro (senza microfono) e scopri che le preoccupazioni ci sono, e ci sono anche le sofferenze; c’è a volte la malattia, c’è il senso di precarietà causato dalla mancanza di lavoro. Ma non c’è angoscia. C’è, al contrario, una profonda fiducia nell’uomo e nelle sue risorse, perché tutti vivono una fede che non è fondata su una teoria o su una filosofia. Dicono di aver fatto l’incontro che ha cambiato la loro vita.”
.
.
19 agosto 2011
Benedetto XVI e la verità. “E’ nel dialogo, è nell’incontro con l’alterità che ci si accosta alla verità. Lì imparo a non vedere me stesso e le mie idee come il tutto, come un assoluto. Senza questo atteggiamento, la religione diventa ideologia. Un atteggiamento che, se applicato fino in fondo, avrebbe secondo me conseguenze di vasta portata nella Chiesa cattolica.”
“La Giornata mondiale umanitaria, celebrata oggi, rappresenta un’opportunità per esprimere il nostro apprezzamento e gratitudine per le donne e gli uomini che lavorano in condizioni difficili e, talvolta, pericolose e che dedicano il loro lavoro e le loro vite al servizio dell’umanità”
“Chiede loro [ai giovani] di non cedere «agli impulsi ciechi ed egoisti, alle proposte che lusingano, ma che… lasciano il vuoto»… Nella terra del laico Zapatero mette in guardia da coloro che… si arrogano il diritto di decidere ciò che è la verità, il bene e il male, ciò che giusto o ingiusto, sino a chi è degno di vivere e chi no… la polemica del Papa non è diretta. Non spinge ad uno scontro ideologico con la cultura laica. Rivendica il contributo positivo dei valori cristiani”
“resta particolarmente importante chiarire cosa s´intenda qui con fatto religioso. Perché alcuni dei ragazzi che partecipano alla Giornata non sono credenti; come non tutti coloro che rompono le vetrine sono criminali o tutti coloro che gridano libertà sono democratici… in definitiva, ad attirare tanti giovani a radunarsi è unicamente la razionalità del sacro, un desiderio di ascoltare la verità e di far parlare la coscienza”
“Guardando i volti dei cinquemila autoconvocati dei centri sociali, dei partiti comunista e repubblicano, delle associazioni laiche come anche dei cristiani di base e di altre associazioni cattoliche fermamente contrarie all’opulenza del cerimoniale approntato, e confrontandoli con quelli dei gruppi di pellegrini, fedeli e scout raccolti per festeggiare Benedetto XVI si ha l’impressione di guardare le stesse persone, due facce della stessa medaglia.”
” non è fatta di “bambini papalini” la gioventù che arriva alle Giornate. È’ uno spaccato di carne viva di una generazione (o di una fascia di generazione), che cerca solidarietà, fraternità, autenticità di valori e il difficile dialogo con quel soggetto misterioso chiamato Dio” Ma “Nessuno vuole mai ascoltarli (i giovani) su come loro vorrebbero vedere la Chiesa nel terzo millennio. Vescovi, cardinali e papi li considerano come persone da “orientare”.
18 agosto 2011
“La sera di mercoledì 17 agosto erano parecchie migliaia i partecipanti alla marcia organizzata da più di un centinaio di associazioni di laici, atei e cristiani progressisti, appoggiati dagli “indignati” per denunciare il costo delle Giornate Mondiali della Gioventù (GMG), che si svolgono a Madrid a partire dal 15 agosto.””
“Buenos catolicos y catolicas usan preservativos” “spiace vedere giovani cattolici (quelli con la maglietta rossa e quelli con lo zainetto) non entrare in dialogo e restare separati per una questione di idee. In mezzo ai tanti incontri e alle tante catechesi che si tengono in questi giorni, forse non sarebbe stato male organizzare anche una tavola rotonda…” (ndr.: finalmente un giornalista che fa il suo mestiere: informa e riflette)
“La “profezia” di questa Gmg2011, celebrata solo otto mesi dopo la conclusione di quel 2010 che nella storia della Chiesa verrà certamente ricordato come “l’anno zero” dell’istituzione clericale, consiste anche in quel milione e mezzo di famiglie che, inviando i loro figli poco più adolescenti a Madrid, dimostrano di fidarsi ancora del cattolicesimo. Perché hanno un Papa che, quando parla, è umile e dice sempre la verità.”(ndr.: Non è solo Gesù Cristo la via la verità e la vita? l’enfasi sui numeri sa tanto di prova muscolare più che di prova evangelica)
“Bisogna affrontare il problema con saggezza e prudenza, ma non si può fare finta di niente e accantonare l’intera questione come accaduto negli ultimi anni. Con una crisi sempre più prepotente e in una società così precaria è pericoloso se le persone si sentono escluse, e Londra non è poi così lontana…”
“Può la Chiesa italiana rifiutarsi di affrontare nella fase attuale la questione dell’8 per mille, che pesa sul bilancio dello stato per oltre mille milioni?” “La via maestra, la più dignitosa per la Chiesa, è che la Cei nella seduta del suo prossimo Consiglio permanente a settembre annunci di lasciare allo Stato una quota cospicua dei finanziamenti”.
.
.
17 agosto 2011
“Per alcuni atei, il mantenere l’identità europea sarebbe un motivo sufficiente per mettere da parte la lunga inimicizia tra loro e le chiese””a differenza degli Stati Uniti – dove le dispute fra atei e credenti sono aspre e persistenti – in Europa i non credenti conservatori hanno trovato alleati pronti in alcuni leader religiosi del continente, in particolare in papa Benedetto XVI”
“Pur mostrandosi all’attacco per quanto riguarda il posto del cattolicesimo in Spagna, il cardinale Antonio Maria Rouco Varela ha fatto molta attenzione a non esprimere critiche nei confronti del governo socialista e a non ricordare le leggi contro le quali la Chiesa si è levata in questi ultimi anni, come il matrimonio omosessuale o la liberalizzazione dell’aborto. Una netta differenza rispetto ad altri discorsi od omelie sentite nel passato”
“il 75% della popolazione spagnola continua a dichiararsi cattolico (tra i giovani il 53%)… ma solo il 15% degli spagnoli va a messa “quasi tutte le domeniche” (tra i giovani il 9%)… Evaristo Villar, prete e teologo… portavoce dell’associazione Redes cristianas (reti cristiane) che parteciperà ad una manifestazione contro la celebrazione delle GMG: “La separazione del trono e dell’altare fa parte del messaggio di Cristo. Ora, la gerarchia cattolica della Chiesa spagnola, che gode di molte sovvenzioni, fa troppa politica e assume posizioni retrograde che dimostrano le sue reticenze a modernizzarsi””
“da Papa teologo ha cercato di trasmettere con immagini vive ai ragazzi della GMG i misteri della fede cattolica, come quando a Colonia, sei anni fa, paragonò il cambiamento che avviene nella consacrazione eucaristica alla fissione nucleare” (ndr.:Non mi sembra che il neoediorialista della Stampa, già vaticanista del Giornale, abbia scelto l’esempio migliore. I misteri della fede non hanno bisogno di queste pseudodelucidazioni scientifiche, che hanno l’effetto di confondere più che di chiarire. Utilizzare poi la fissione nucleare, la rottura del nucleo di un atomo, per “spiegare” l’eucaristia, cioè l’espressione della massima unione possibile, del massimo amore, è davvero troppo. Non è oltretutto un’idea originale, già utilizzata da altri nel passato per “spiegare” l’immagine della sindone, suscitando giustificata ilarità. Un maggiore spirito critico non guasterebbe)