
“Ritroviamo il coraggio di parlare con gli atei”
intervista a Gianfranco Ravasi
Cattolici e atei, credenti e agnostici: faccia a faccia nella Parigi dei Lumi per un vertice inedito promosso dal cardinale Gianfranco Ravasi, ministro della Cultura vaticano. Partner del dialogo, che si svolgerà tra il 24 e il 25 marzo, sono l’Unesco, la Sorbona, l’Institut de France, il “parlamento dei sapienti” che riunisce le cinque grandi accademie francesi. È una pagina nuova nella storia della Chiesa, il tentativo di affrontare il Terzo millennio smettendola di considerare atei ed agnostici come nemici o handicappati spirituali.“Anticlericalismo e Clericalismo” vanno superati, è l’opinione del porporato. Perché “chiudersi nel proprio recinto è una malattia sia per le religioni che per il mondo laico e per una scienza che pretenda di dare le risposte a tutte le domande”. L’iniziativa è sorta per impulso di Benedetto XVI, che nel 2009 affermò a Praga che andava stimolato il confronto con i non-credenti e indicò nel Cortile dei Gentili dell’antico Tempio di Gerusalemme lo spazio, dove gli aderenti ad altre religioni potevano accostarsi al Dio Sconosciuto.
Sul sagrato di Notre Dame, dove si terrà uno spettacolo per i giovani, arriverà un videomessaggio del Papa.

Cardinale Ravasi, partite dalla Francia, l’Anticristo dell’Illuminismo.
Sì, ho voluto scegliere Parigi proprio perché è un vessillo di laicità, ma devo dire subito che ho trovato un mondo laico interessato a un confronto vero sui grandi temi.
Voglia di convertire?
Non è questo lo scopo. Non parliamo di evangelizzazione. L’obiettivo è il dia-logo. Il confronto fra due Logoi, tra visioni del mondo che si misurano sulle questioni alte dell’esistenza. Quando mi trovo di fronte a un ateo come Nietzsche o al discorso marxista o scientista, io ascolto, rispetto, valuto. Le religioni e i sistemi ideologici sono letture del reale e del cosmo ed è bene che si confrontino.
Superando l’atteggiamento classico secondo cui il non-credente è un’anitra zoppa?
Il credente e l’ateo sono ciascuno portatori di un messaggio, che è ‘performativo’ poiché coinvolge l’esistenza. Sono contento di avere come interlocutori a Parigi personalità come Julia Kristeva, semiologa e psicanalista agnostica o il genetista Axel Kahn.
Su cosa ragionare?
All’Unesco si discuterà tra credenti e laici sul ruolo della cultura ma anche delle donne nella società moderna, sull’impegno per la pace e la ricerca di senso in un mondo che è contemporaneamente secolarizzato e religioso. Alla Sorbona il tema è emblematico: Lumi, religioni, ragione comune.
All’Institut de France il dibattito sarà su economia, diritto, arte.
Sperando di trovare punti di incontro?
Non interessano incontri o scontri generici né di accordarsi su una vaga spiritualità. E non si tratta nemmeno di un asettico convegno di matematica. Ciò che conta è mettere a confronto visioni di vita alternative, ragionando in ultima istanza su alcune domande capitali.
Lei ha detto recentemente che la Chiesa deve imparare ad abbattere i propri muri.
Spesso abbiamo un linguaggio eccessivamente connotato ed escludente. Dobbiamo riconoscere che esistono visioni diverse della realtà e che dal mondo laico ci vengono rivolte domande profonde rispetto alle quali non possiamo essere evasivi.
Quali questioni considera capitali?
Le domande sul senso dell’esistenza, sull’oltre-vita, sulla morte. E ancora, la domanda sulla categoria di verità.
C’è già nel processo a Gesù: cos’è la verità?
È qualcosa che ci precede, che è ‘in sé’? Oppure, come affermano i moderni, è l’elaborazione del soggetto secondo i differenti contesti?
Immagina Parigi come tappa di una ricerca sull’etica universale, quel Weltethos che il teologo Hans Kueng espose a Benedetto XVI a Castegandolfo dopo la sua elezione?
Penso piuttosto che si possa aprire il discorso, senza sincretismi, su ciò che significa Natura e legge naturale.
Vale la pena di indagare sulle radici ultime, che precedono le ragioni delle religioni e delle ideologie. Porre a confronto le differenti concezioni di essere ed esistere significa mettersi autenticamente a ricercare, senza pretendere di sapere a priori.
Troppe volte si è diffusa la sensazione che con l’arrivo del pensiero scientifico moderno sia stato segnato un anno zero, che annulli le elaborazioni della cultura precedente, specie quella greca e cristiana.
Invece?
Trovo tanti scienziati aperti a riflettere sulle categorie filosofiche dell’esistenza.
C’è un tema su cui si dovrebbe riflettere di più nella civiltà contemporanea?
La potenza del male. Bisogna esserne consapevoli. Gli atteggiamenti susseguenti possono essere diversi. Per Albert Camus, nell’assenza di Dio, la risposta finale è il suicidio. Per George Bernanos, al di là di tutte le difficoltà e fragilità, la presenza divina non abbandona mai l’umano.
La Chiesa è pronta a fare i conti con la decristianizzazione in atto nel continente europeo?
Le categorie statistiche sono insufficienti per misurare il reale. Serve un metodo qualitativo per misurare dall’interno i comportamenti sociali e personali. Harvey Cox, che aveva scritto la ‘Città secolare’, ora sostiene di essersi sbagliato. Assistiamo ad un ritorno del Sacro e a una nostalgia del Religioso, che però non trova una risposta nel istituzioni religiose. Così si manifesta in varie espressioni: movimenti, New Age, devozionalismo, spiritualismo.
Qual via d’uscita propone?
Il cristianesimo deve tornare alle sue grandi risposte. Riuscendo a guarire il palato della società, deformato da una secolarizzazione che cerca spiritualità a basso profilo.
Non pensa che vi sia nella Chiesa ancora troppa paura della modernità?
Io nutro rispetto per la modernità, ma rivendico la legittimità di criticare una modernità superficiale, inodore, incolore, nemmeno immorale bensì a-morale. Come dice Goethe nel Faust: abbiamo dimenticato il Grande Maligno, sono rimasti i Piccoli Mascalzoni.
in “il Fatto Quotidiano” del 20 marzo 2011
Parlare con gli atei

di Paolo Flores d’Arcais
Stimato cardinal Ravasi, ho letto con crescente interesse l’intervista – impegnata e soprattutto impegnativa – che ha concesso a Marco Politi per questo giornale. Le sue parole mi hanno colpito, tra l’altro, per un tono appassionato di autenticità che non sempre si avverte in altri uomini di Chiesa del suo altissimo livello gerarchico. Lei enuncia come obiettivo delle sue iniziative “il dialogo” con gli atei, dunque un parlarsi-fra che non aggiri la controversia, anzi, visto che lo intende come “il confronto tra due Logoi, tra visioni del mondo che si misurano sulle questioni alte
dell’esistenza”. E perché non ci siano dubbi che tali “Logoi” debbano essere anche quelli più radicalmente conflittuali con la fede cattolica, esemplifica con gli ateismi di stampo nicciano, marxista, scientista: insomma tutto il “vade retro” del moderno relativismo (condannato dagli ultimi due Pontefici come incubatore di nichilismo). Ateismi radicali che, aggiunge, “io ascolto, rispetto, valuto”.
DI PIÙ
Marco Politi molto opportunamente insiste: “Superando l’atteggiamento classico secondo cui il non-credente è un’anatra zoppa?”. Bella metafora, in effetti, per stigmatizzare l’atteggiamento paternalistico che spinge ancora troppo spesso la Chiesa a scegliere come interlocutori solo quei “gentili” (“Cortile dei gentili” si intitola la sua iniziativa) che sembrano soffrire la condizione della mancanza di fede come un’amputazione ontologica o esistenziale. “Atei” sì, ma “alla ricerca di Dio”. Sembra proprio che invece lei questa volta voglia promuovere il confronto con l’intera costellazione dell’ateismo hard: “non interessano incontri o scontri generici, né di accordarsi su una vaga spiritualità” perché “quel che conta è mettere a confronto visioni di vita alternative” smettendola di “essere evasivi” rispetto alle “profonde domande che ci vengono rivolte dal mondo laico”. Apprezzo “toto corde”. Del resto dirigo da un quarto di secolo una rivista di adamantina laicità (tanto che viene spesso tacciata di “laicismo” proprio perché non è laicità “rispettosa”, da anatre zoppe) che del confronto senza diplomatismi con uomini di fede, anche della Chiesa gerarchica, si è fatta un punto d’onore. Praticandolo.
Spero perciò sinceramente che alle sue parole seguano i fatti. Non solo a Parigi, anche in Italia.
Negli ultimi anni l’atteggiamento è stato però di segno opposto. Il dia-logo con l’ateismo è stato sistematicamente rifiutato dalla Chiesa gerarchica e anche da lei personalmente. Si tratta di una verità inoppugnabile, di cui purtroppo posso dare testimonianza diretta. Quando nell’anno del giubileo MicroMega pubblicò un almanacco di filosofia dedicato a Dio, con saggi in maggioranza di ispirazione atea, l’allora prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, cardinal Ratzinger, non solo accettò di collaborare con un suo testo, ma anche di presentare il numero in una controversia pubblica con me al teatro Quirino di Roma, gremito all’inverosimile e con duemila persone che seguirono il dibattito sulla strada attraverso altoparlanti di fortuna. Se guardo ai due o tre anni successivi, posso constatare che accettarono pubbliche controversie i cardinali Schönborn, Tettamanzi, Piovanelli, Caffarra, Herranz e infine nel 2007, presso la Scuola normale superiore di Pisa, il patriarca di Venezia Angelo Scola.
Da allora l’atteggiamento della Chiesa gerarchica si è rovesciato. MicroMega ha proseguito nella volontà di un confronto franco, “ragionando in ultima istanza su alcune domande capitali”, secondo quanto lei dice di auspicare. Ma ci siamo trovati di fronte al muro di un sistematico rifiuto. Sia chiaro, un Principe della Chiesa ha tutto il diritto di rifiutare il confronto se non ritiene l’interlocutore all’altezza, senza con ciò smentire la sua volontà di dia-logo. Pretende solo atei più autorevoli. Ma visti i precedenti fin troppo lusinghieri in fatto di porporati che hanno accettato la discussione con Micro-Mega e con me, non è certo questo il motivo del rifiuto.
SUL QUALE
non provo neppure ad avanzare ipotesi. Mi interessa il futuro. Vorrei prenderla in parola, nella sua volontà di “dia-logo”, e organizzare con lei occasioni di confronto proprio con il metodo e sui temi che lei illustra nell’intervista. Discutere tra atei-atei e Chiesa gerarchica per “ricercare senza pretendere di sapere a priori”, su questioni che spaziano dal “senso dell’esistenza” alla “oltrevita, la morte, la categoria della verità” o “su ciò che significa Natura e legge naturale”, visto che da qui nascono le questioni eticamente sensibili che sempre più affollano l’agenda politica non solo italiana.
Si tratta, del resto, di temi previsti nel confronto con il cardinal Ratzinger, che non fu possibile affrontare per mancanza di tempo (vi era anche quello del Gesù storico, che certamente a lei, biblista di fama, interesserà). La invito dunque alle “Giornate della laicità” che si svolgeranno a Reggio Emilia dal 15 al 17 aprile, a cui hanno rifiutato di partecipare i quindici cardinali che abbiamo invitato, e nelle quali potrà discutere con atei non “anatre zoppe” come Savater, Hack, Odifreddi, Giorello, Pievani, Luzzatto, e buon ultimo il sottoscritto. Se poi la sua agenda non le
consentisse di accogliere questo invito, le propongo di organizzare insieme, lei ed io, una serie di confronti nei tempi e luoghi che riterrà opportuni. Devo però dirle, in tutta franchezza, che non riesco a liberarmi dalla sensazione – negli ultimi anni empiricamente suffragata – che il “dia-logo” che lei teorizza voglia invece eludere il confronto proprio con l’ateismo italiano più conseguente.
Con la speranza che i fatti mi smentiscano e che lei possa accettare la mia proposta, le invio intanto i miei più sinceri auguri di buon lavoro.
in “il Fatto Quotidiano” del 22 marzo 2011
La Chiesa in dialogo

di Jacques Noyer
La Chiesa cattolica vuole entrare in dialogo tanto nel cammino ecumenico quanto negli incontri interreligiosi. Vuole perfino aprire il dialogo con gli atei. Non si può che essere contenti di queste iniziative, totalmente in armonia con quel Dio di dialogo di cui Gesù ci ha rivelato il volto. La Trinità è dialogo. La Rivelazione è dialogo. L’evangelizzazione è dialogo.
Ma il dialogo presuppone che gli interlocutori accettino tra loro una certa uguaglianza e riconoscano in sé una certa fragilità. Ci si ritrova sotto lo sguardo di una ragione, di uno spirito di cui si accetta l’arbitraggio e si rinuncia così a conoscere in anticipo l’ultima parola verso cui ci si mette in cammino. Ma non si capisce bene come le istituzioni possano dialogare. Nazioni, partiti, organizzazioni diverse possono avere negoziati di pace, trattative d’alleanza, complicità d’azione.
Ma non possono dialogare. Se un rappresentante fosse colpito dalle argomentazioni dell’altro, non potrebbe più rappresentare la sua organizzazione. Si è condannati ad avere solo dei dialoghi tra sordi. Questo non significa che questi dibattiti non possano condurre, in seguito, nelle istituzioni, ad un’evoluzione del loro punto di vista, ma per niente al mondo accetteranno di dire che il cambiamento è avvenuto ascoltando l’altro: sarebbe ammissione di debolezza!
Le Chiese e le religioni possono dialogare ancor meno di altre istituzioni poiché le loro convinzioni sono presentate come sacre e quindi intangibili. Bloccate nelle loro certezze, possono al massimo cercare insieme delle formule sottili che nascondano le differenze. La stagnazione dell’ecumenismo, il blocco del dialogo teologico interreligioso ne sono la prova. Ugualmente, è proprio l’impossibilità del dialogo tra l’islam e l’ebraismo a rendere impossibile la pace in Israele. Le religioni sono più atte a fare la guerra, o almeno ad incoraggiarla, che a vivere il dialogo della comunità fraterna.
Se le religioni non possono dialogare, invece lo possono fare gli uomini, credenti o non credenti.
Ed è proprio quello che accade in tutti i quartieri in cui vivono credenti di diverse religioni o semplicemente in tutti gli incontri amichevoli che accompagnano la vita sociale quotidiana. Sono molteplici le testimonianze sull’esistenza e sulla fecondità di questi luoghi informali di parola.
Quando vediamo le folle dei paesi arabi sollevarsi in nome dei diritti umani per esigere un po’ più di democrazia, come non ammirare la forza del dialogo condiviso nell’ambito della mondializzazione o della laicità? Dio mi guardi dal vedervi il risultato di una certa evangelizzazione! Sarebbe un recupero odioso. Ma nessuno può negare di potervi vedere il lavoro dello Spirito, e il Dio in cui credo certo ne è felice!
Sì, la Chiesa, questo popolo in cui vive lo Spirito, perché è fatta di uomini e di donne immersi nel mondo, può dialogare col mondo. E lo fa da venti secoli. Lo fa oggi come ieri. Ma se la Chiesa è quell’istituzione gerarchica dalla dottrina intangibile e dalla Verità Posseduta, allora non può farlo.
Se l’istituzione organizzasse il dialogo invece di averne paura, se essa stessa fosse dialogo tra i suoi membri, se la Chiesa si assumesse il rischio di desacralizzare il suo discorso di ieri e i suoi orpelli storici per cercare, oggi, adesso, la Verità con tutte le nazioni, essa potrebbe essere, come la sua Vocazione le chiede, il dialogo in cui lo Spirito fa nuove tutte le cose.
in “Témoignage chrétien” n° 3436 del 17 marzo 2011 (traduzione: finesettimana.org)
RASSEGNA STAMPA
25 marzo 2011
“Per i cristiani, la Verità ci precede, nella persona di Cristo. Mentre agli occhi della cultura contemporanea, ciascuno di noi la costruisce. Da questa differenza derivano concezioni diverse del bene e del male, della libertà, della giustizia”
“L’esigenza di razionalità – che è essenziale – non fa scomparire quelle dimensioni del vissuto che sono il sacro, l’immaginario, l’istintivo o anche l’affettivo e evidentemente la credenza… (che non ha un significato univoco, perché mescola rappresentazioni più o meno razionali, credenze affettive, fede, fiducia, nel senso della fides latina)”
“«’L’incontro è differente e più profondo del dialogo. Questo è uno scambio che si situa al livello delle idee e della visione del mondo. L’incontro riguarda la nostra umanità nel suo cuore più profondo, la realtà della nostra persona con tutto quello che essa ha di debole e bello»”
“il dialogo costringe ciascuno ad essere méthorios, … cioè «colui che sta sulla frontiera», ben radicato nel suo territorio, ma con lo sguardo che si protende oltre il confine e l’orecchio che ascolta le ragioni dell’altro
“La circostanza non va giù a un gruppo di fedeli… «Le parole e gli atti di Gentilini sono incompatibili con il messaggio evangelico»… E lo sceriffo padano [discusso esponente leghista, noto per le sue pesanti esternazioni contro immigrati e omosessuali]? Non si scompone: «Dicano quello che vogliono… sono un cattolico praticante io, mica un comunista»”
“Il Cortile dei Gentili è cominciato ieri alle 15 nella sala XI dell’Unesco, a Parigi… si succedono autorità… ambasciatori… Getachew Engida… Gianfranco Ravasi… Giuliano Amato, protagonista di un intervento che fa pensare [che] evidenzia lo spostamento dei confini del bene e del male che è in atto… Fabrice Hadjadjj, filosofo e scrittore, che [invita] a cercare l’uomo non nell’efficienza ma «nell’epifania del suo volto»”
“«Mi interessa l’umanesimo, la differenza tra l’umanesimo cristiano e quello dei Lumi, e come quest’ultimo può rispondere alle questioni della nostra epoca… Non si tratta di distruggere la religione, come hanno tentato di fare i totalitarismi, ma neanche di accettarla: serve un lavoro di rivalutazione della memoria»”
“Il Gesù di cui parla Joseph Ratzinger nel suo libro appena uscito (Gesù di Nazaret – Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, che segue il primo volume pubblicato nel 2007) non è invece Gesù, bensì il Cristo dogmatizzato dai Concili di Nicea (325) e Calcedonia (451), dominati e decisi dagli imperatori di Roma, che con il Gesù della storia nulla ha a che fare e anzi contraddice e nega sotto ogni aspetto essenziale.” (ndr.: diversità non vuol dire per forza di cose opposizione. Certamente permane il problema di come far interagire l’ermeneutica storica con l’ermeneutica della fede)
24 marzo 2011
- Ragione comune di Dominique Greiner in La Croix del 24 marzo 2011 (nostra traduzione)
“coloro che non credono, coloro che si dicono senza Dio non sono necessariamente indifferenti. Capaci di mobilitarsi per la promozione di valori universali, possono anche essere interessati a sentir parlare di Dio. Allo stesso tempo, il loro impegno può anche essere stimolante per quello dei cristiani”
“Fino agli anni ’70 del secolo scorso coloro che rifiutavano Dio lo facevano in maniera argomentata, proponendo un sistema costruito in parallelo – o in opposizione – al cristianesimo. Quindi c’era una base comune a partire dalla quale era possibile il dialogo. “Oggi le giovani generazione non conoscono veramente il termine Dio. Non esiste nella loro cultura””
“Dopo l’annuncio avvenuto a Roma nel dicembre del 2009 da parte di Benedetto XVI, il Cortile dei gentili… prende il via ufficialmente a Parigi, giovedì 24 e venerdì 25 marzo… Una scommessa in società fortemente secolarizzate… Per il cardinale Gianfranco Ravasi… questo dialogo è tuttavia possibile… malgrado la persistenza di forti sospetti tra i due mondi
“L’idea del Cortile dei Gentili corrisponde sicuramente ad un bisogno autentico sentito dai credenti illuminati e dalle persone di buon senso in ricerca. Benedetto XVI lo situa accanto al dialogo con le religioni.”
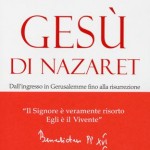
















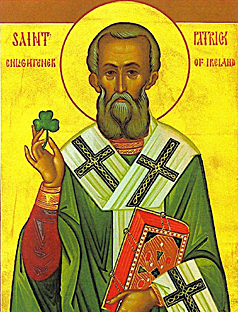 La plenaria consente un confronto diretto con i collaboratori, membri e consultori, i quali, vivendo la loro esperienza in tanti Paesi diversi, possono fornire un quadro complessivo sullo stato della comunicazione nel mondo. Quella di quest’anno ha avuto un significato e uno sviluppo particolari, perché è stata inaugurata dall’incontro con il Papa. Le sue parole sono state illuminanti proprio per farci capire quale deve essere il punto fermo: capire che la Chiesa è chiamata a dialogare con gli uomini di oggi, sempre più impregnati da una cultura digitale. Si tratta, in sostanza, di allargare gli orizzonti della diaconia della cultura. È quello che chiede il Papa quando raccomanda di conoscere, di capire i nuovi linguaggi attraverso i quali l’uomo contemporaneo si esprime, comunica ciò che egli è, ciò che egli percepisce.
La plenaria consente un confronto diretto con i collaboratori, membri e consultori, i quali, vivendo la loro esperienza in tanti Paesi diversi, possono fornire un quadro complessivo sullo stato della comunicazione nel mondo. Quella di quest’anno ha avuto un significato e uno sviluppo particolari, perché è stata inaugurata dall’incontro con il Papa. Le sue parole sono state illuminanti proprio per farci capire quale deve essere il punto fermo: capire che la Chiesa è chiamata a dialogare con gli uomini di oggi, sempre più impregnati da una cultura digitale. Si tratta, in sostanza, di allargare gli orizzonti della diaconia della cultura. È quello che chiede il Papa quando raccomanda di conoscere, di capire i nuovi linguaggi attraverso i quali l’uomo contemporaneo si esprime, comunica ciò che egli è, ciò che egli percepisce.
