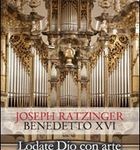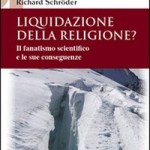Padre Jean-Pierre, 60 anni, è il priore di Notre-Dame de l’Atlas – unico monastero cristiano maschile nell’Africa del Nord – installato da più di dieci anni a Midelt, in Marocco.
Quando contempla il paesaggio dal giardino del monastero, padre Jean-Pierre vi legge tre dimensioni della vita che condivide con i suoi fratelli. Ai suoi piedi, il giardino, coltivato a meli e mandorli, che è uno dei luoghi di lavoro della comunità, gli ricorda che “fratello” è una parola da vivere concretamente ogni giorno. Un po’ oltre, le case in cui vivono – a volte con difficoltà – delle famiglie musulmane gli ricordano che lui è ospite del popolo marocchino accanto al quale vorrebbe testimoniare che “la fraternità e la pace sono un dono di Dio fatto agli uomini”. Infine, linea scura all’orizzonte, l’Alto Atlante dominato dal monte Ayache (3757 metri) lo invita “al silenzio, all’ascesi, alla contemplazione, all’assoluto”. Ma, precisa, ci sono anche le nuvole! “Mi ricordano che il mio io troppo chiacchierone mi impedisce di ascoltare gli altri, il totalmente Altro.”
Padre Jean-Pierre, 60 anni, è il priore di Notre-Dame de l’Atlas – unico monastero cristiano maschile nell’Africa del Nord – installato da più di dieci anni a Midelt, in Marocco (1). C’entra forse qualcosa il fatto che egli sia nato a due chilometri dall’abbazia di Aiguebelle à Montjoyer, nella Drôme, abbazia madre dell’Atlas. “È vedendo vivere Frère Gabriel che ho deciso di diventare monaco, conferma. Non aveva niente, ma aveva trovato la vera felicità.”
A quell’epoca, Jean lavorava alla distilleria dell’abbazia. Durante la pausa di mezzogiorno correva dai 15 ai 20 chilometri, sognava di fondare una famiglia felice e di seguire una carriera sportiva.
Eppure, a 23 anni, quello che allora a Montjoyer chiamavano “il comico” divenne “l’inclassificabile”. Qualificato per i campionati francesi, rinunciò al desiderio di diventare maratoneta, alla casa e ai capelli lunghi per entrare – malgrado l’opposizione della sua famiglia – all’abbazia di Aiguebelle, prima tappa di un’esistenza che lo avrebbe portato a diverse riprese sul continente africano.
La prima volta fu per raggiungere il monastero di Kutaba, in Camerun. Vi resterà nove anni, prima di diventare eremita nelle Alpi dell’Alta Provenza. “È là che ho saputo della morte dei monaci di Tibhirine, spiega. Non avevo capito nulla del senso della loro presenza, ma il dono della loro vita ha definitivamente chiarito la loro vocazione che era di essere là per amare Dio, l’Algeria, gli algerini. Il cuore del Vangelo, è l’amore fino al dono di sé.” Un anno dopo, riparte quindi, questa volta per il Marocco, dove c’è dal 1988 a Fès una dépendence dell’Atlas, diventata il luogo su cui è ripiegata la comunità. Poi fa parte del piccolo gruppo di frati costituitosi ad Algeri nella speranza di tornare a Tibhirine, prima di essere eletto priore dell’Atlas e formalmente trasferito a Fès.
“A Fès, racconta Jean-Pierre, la comunità stava allo stretto e aveva pochi contatti con la popolazione. Le Suore francescane missionarie di Maria, stabilite a Midelt, 200 chilometri più a sud, desideravano lasciare il convento per vivere in luoghi più adatti a loro. Mi sono quindi recato alla Kasbah Myriem il 2 febbraio 1999. Faceva freddo. Ma sono stato conquistato dal luogo, dove, da allora, godiamo i benefici della lunga presenza delle suore, del capitale di fiducia che resta acquisito.” La comunità conta oggi tre fratelli. L’altro Jean-Pierre, detto “l’anziano”, 87 anni, radioso e grave, ultimo testimone di Tibhirine; José Luis, 63 anni, dirigente di commercio diventato a 47 anni monaco di Santa Maria de Huerta in Spagna, uomo insieme franco e generoso, a volte percorso dall’urgenza; e Jean-Pierre, semplice e posato, abitato da un’instancabile fiducia. Frère Godefroy, ufficiale di marina diventato monaco di Aiguebelle, dovrebbe presto raggiungerli.
Questi monaci, che vivono secondo la regola dell’ordine cistercense di stretta osservanza, si ritrovano sette volte al giorno, fin dalle quattro del mattino, in cappella per pregare. Tra i molteplici compiti da svolgere, Jean-Pierre, l’unico che può guidare, si occupa degli acquisti, in gran parte al suk e nel negozio di alimentari di Hussein. Jean-Pierre detto “l’anziano” è incaricato della contabilità e fa il portinaio. José Luis, fratello incaricato dell’ospitalità, è anche molto occupato nei lavori intrapresi nel monastero da dieci anni.
Questi lavori devono molto alle qualità di costruttore di Jean-Pierre. A 18 anni, questo innamorato di vecchie pietre aveva comperato nel suo villaggio natale un edificio in rovina che era appartenuto
ad una struttura monastica e l’aveva restaurato. Più tardi, a Notre-Dame de Kutuba, aveva migliorato gli edifici delle piantagioni di caffé. A Midelt, ha trasformato la cappella, chiuso il chiostro, ristrutturato l’insieme del monastero. Ora quello che era il garage ospita la cappella Charles de Foucauld, benedetta da Mons. Vincent Landel, arcivescovo di Rabat, il 21 maggio, giorno del 15° anniversario della morte dei monaci di Tibhirine, ai quali è dedicato un memoriale. Il locale dove si trovavano le vasche per la tintura della lana è diventato la cappella del Padre Albert Payriguère (1883-1959), che vi riposa da circa un anno. Il laboratorio di tessitura ha lasciato il posto ad una comoda foresteria per accogliere i cristiani residenti in Marocco, nonché gli ospiti di passaggio alla ricerca, come dice mons. Landel, di “un luogo-sorgente dove prendersi il tempo di lasciarsi amare da Dio, di lasciarsi spogliare, e di comprendere meglio quanto il contatto con l’islam è un invito ad approfondire la propria fede cristiana”.
Appassionato di archivi, Jean-Pierre ha anche condotto delle ricerche sull’eredità spirituale della Chiesa in Marocco. Ha studiato i rapporti che esistono tra Charles de Foucauld e Notre-Dame de l’Atlas, si è entusiasmato per la testimonianza di quattro testimoni che amerebbe veder uscire dalla dimenticanza: Padre Albert Peyriguère, discepolo di Charles de Foucauld che si stabilì a El-Kbab, in una tribù di Berberi; padre Charles-André Poissonnier (1897-1938), eremita francescano che si stabilì a Tazert, dove morì a 40 anni di tifo; Élisabeth Lafourcade (1903-1958), membro dell’istituto secolare “Gesù operaio”, che divenne la “toubiba” (dottoressa) di Ksar-Es-Souk; Cécile Prouvost (1921-1983), francescana missionaria di Maria, che divenne nomade tra i nomadi e le cui “sorelle” continuano la missione a Tattioune. I loro ritratti, dipinti da un pittore di Midelt, sono appesi alle pareti della sala del capitolo.
“Questi quattro testimoni ci mostrano quale debba essere la nostra presenza cristiana su questa terra d’islam, spiega Jean-Pierre. Una vita ‘con’, una vita di condivisione, di amicizia, secondo l’ultimo comandamento di Gesù: ‘Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato’ (Gv 15,12). Tutti e quattro hanno servito fino al limite delle loro forze, fino al dono della loro vita, per Amore. Con i sette fratelli di Tibhirine, è la stessa voce che ci giunge, la stessa linea spirituale che ci è tracciata.”
Al loro seguito, i fratelli dell’Atlas proseguono in una dolce austerità e in una reale precarietà la loro ricerca di Dio, aprendosi al contempo al mondo musulmano che li circonda. Vivono un dialogo quotidiano, in costante ricerca del giusto equilibrio tra chiusura ed apertura, con i loro vicini che fanno attenzione a che non siano disturbati nell’ora della preghiera e che chiedono loro talvolta di intercedere per loro. Due volte al giorno, condividono il tè alla menta a cui li invitano Omar e Baha, dipendenti del monastero, e anche un po’ “di casa”. A volte vanno anche nelle famiglie che li invitano a condividere il loro pasto. Il 22 maggio hanno ricevuto gli operai che li avevano aiutati durante i lavori, insieme alle loro famiglie e ai due imam delle moschee vicine.
“Noi siamo, come indica lo stemma di Notre-Dame de l’Atlas, un segno sul monte, conclude Jean- Pierre. Viviamo qui il mistero di Nazareth e quello della Visitazione che Christian de Chergé considerava una festa ‘quasi patronale’ della comunità dell’Atlas. Come Maria che parte per incontrare Elisabetta, noi andiamo ad incontrare ‘l’altro’”…
Se il paesaggio che contempla dal frutteto evoca per Jean-Pierre l’essenziale della vita monastica, allo scriptorium dove va ogni giorno dopo le prime lodi mattutine vi sono segni discreti ma di rara intensità che esprimono bene la sua vocazione. Sulla sua scrivania ha messo un quadretto con tre fotografie, quelle di padre Peyriguère, di padre Gabriel, morto due anni fa, e di Élisabeth Lafourcade. È lì che, nell’oscurità colma di silenzio, si dedica, accanto ai suoi fratelli, alla lectio divina, e ascolta al levar del giorno l’appello alla preghiera del muezzin.
(1) Due libri sono dedicati al monastero: Un signe sur la montagne, di Raymond Mengus, Éd. Salvator, p. 185, € 19.
Un monastère cistercien en terre d’islam, di Étienne d’Escrivian, Éd. Cerf, p. 272, € 20.
in “La Croix” dell’11 giugno 2011 (traduzione: www.finesettimana.org)