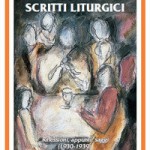Raimon Panikkar, Vita e parola. La mia Opera, Jaca Book, Milano 2010 (pp. 158, euro 16,00)
Il 26 agosto 2010 si spegne, all’età di 92 anni, Raimon Panikkar, personalità ricca e complessa, profeta del dialogo e maestro dell’esperienza mistica.
Da qualche anno, con grande coraggio, la Jaca Book sta curando la pubblicazione dell’Opera Omnia di Panikkar a cura dell’Autore stesso e di Milena Carrara Pavan, che hanno organizzato i numerosi scritti in dodici volumi tematici (ma che arrivano a 17 poiché alcuni volumi sono in due tomi). È da notare anche che l’iniziativa dell’editore italiano è la prima in assoluto e sebbene Panikkar vivesse in Spagna e parlasse numerose lingue, sarà in italiano che comparirà per la prima volta l’edizione integrale delle sue Opere.
Sono quattro i volumi finora pubblicati, probabilmente cinque entro la fine dell’anno. Ma abbiamo la fortuna della pubblicazione – pochi mesi prima della sua morte – del volumetto di cui facciamo la recensione e che contiene le 16 Prefazioni riscritte da Panikkar a tutti i volumi che compongono il piano dell’Opera Omnia. Un testo dunque preziosissimo per accostarsi integralmente, anche se in modo essenziale e sintetico, alla pluriformità di un pensiero e di una esperienza di vita estremamente ricchi e stimolanti. Il volume è arricchito da una ampia nota biografica a cui manca solo la data della sua recente scomparsa.
Nella Prefazione è Panikkar stesso a definire il contenuto del volume: “Mi era stato chiesto in più occasioni di elaborare una sintesi del mio pensiero, di pubblicare, cioè, un testo che potesse intitolarsi La mia Opera. Mi sono reso conto che in effetti il lavoro l’avevo già fatto, avendo preparato in questi ultimi anni le introduzioni ai vari volumi dell’Opera Omnia” (p. 7). Ecco dunque tutto il valore di questo agile volumetto, estremamente denso e ricco. Peraltro, come sottolinea Panikkar, queste introduzioni sono anche un preziosissimo accesso non solo al suo pensiero, ma anche alla sua vita, essendo le due cose strettamente interconnesse: “Colgo l’occasione per sottolineare che tutti i miei scritti rappresentano non solo un problema intellettuale della mia mente, ma una preoccupazione del mio cuore e, ancor più, un interesse reale della mia intera esistenza, che ha cercato per prima cosa di raggiungere chiarezza e profondità studiando seriamente i problemi della vita umana […] Ora che ho fatto lo sforzo di riunire i miei scritti per argomenti, mi accorgo che lo schema di questa Opera Omnia rappresenta il percorso non solo del mio pensiero ma anche della mia vita, senza esaurirne, come dicevo, l’esperienza. I miei scritti coprono un lasso di circa settant’anni, in cui mi sono dedicato ad approfondire il senso di una vita umana più giusta e piena” (pp. 7-8). In questa prospettiva, aggiunge Panikkar, “non ho vissuto per scrivere, ma ho scritto per vivere in modo più cosciente e aiutare i miei fratelli con pensieri che non sorgono soltanto dalla mia mente, ma scaturiscono da una Fonte superiore che si può forse chiamare Spirito” (p. 8). In seguito, sintetizza in modo estremamente chiaro tutto il suo itinerario di vita: “Attratto fin da giovane dalla spiritualità, mi sono avvicinato allo studio delle religioni approfondendo prima la religione in cui sono nato e cresciuto, il cristianesimo, scoprendo poi la religione di mio padre, l’induismo, e subendo infine il fascino del buddhismo, pur rimanendo fedele alla mia origine cristiana. Con tale bagaglio di esperienze e conoscenze mi sono aperto in forma spontanea al dialogo con le diverse culture e religioni, avendolo già vissuto interiormente. Non si può scoprire infatti la verità di un’altra religione se non la si vive in profondità dall’interno […] Dalla rielaborazione della Trinità, che considero il fulcro del cristianesimo, sono giunto alla formulazione della mia visione della realtà che ho chiamato cosmoteandrica. Per comunicare agli altri ciò che non può essere descritto direttamente sono ricorso al mito, al simbolo e al culto, che sono alla base di ogni formulazione di fede, sviluppandone l’ermeneutica. Sono sempre stato attratto dalla filosofia come amore per la verità e per il Mistero. Non volendo chiudermi in un mondo di speculazione astratta, mi sono aperto alla vita che mi sta attorno nella sua concretezza e ho scoperto che non era profana ma sacra, da qui il mio interesse per i problemi che riguardano la secolarità” (pp. 8-9).
Vediamo ora, nello specifico, come è articolato il densissimo volume. È questo anche un modo per accostarci all’articolazione dell’Opera Omnia che raccoglie – come detto – per temi e con la supervisione dell’Autore stesso, tutti gli scritti di Panikkar.
Il primo capitolo – Mistica, pienezza di vita – contiene il saggio che fa da introduzione al tomo 1 del primo volume dell’Opera Omnia, intitolato Mistica e spiritualità. A proposito del volume – già pubblicato – Panikkar scrive che “è in parte autobiografico in quanto tratta del tema più importante della mia vita, che ha ispirato in forma discreta tutti i miei scritti, così da divenirne una chiave ermeneutica indispensabile” (p. 11). La mistica, per Panikkar, altro non è che esperienza integrale della vita; in questa prospettiva, essa non è “un privilegio di pochi prescelti, ma la caratteristica umana per eccellenza. L’uomo è essenzialmente un mistico” (p. 12). La mistica è qualcosa che “non disumanizza” (p. 13); è “esperienza gioiosa” (p. 14), appunto in quanto esperienza integrale della Vita, di “quella vita che non è mia benché sia in me; quella vita che, come dicono i Veda, non muore, che è infinita, che alcuni definirebbero divina: Vita, tuttavia, che si ‘sente’ palpitare, o, per meglio dire, semplicemente vivere in noi” (p. 15). In questo senso, l’esperienza mistica è quella che “ci permette di godere pienamente della Vita” (p. 16). Ne consegue allora, che “il grande ostacolo a che scaturisca spontaneamente in noi l’esperienza della Vita è la nostra preoccupazione per il fare a scapito dell’essere, del vivere. La mistica, quindi, richiede una certa maturità, che è più facile raggiungere al crepuscolo della vita” (p. 18).
Il secondo saggio – Spiritualità, il cammino della vita – fa da introduzione al tomo 2 del primo volume. Se la mistica è l’esperienza suprema della realtà, la spiritualità viene intesa da Panikkar come il “cammino per giungere a tale esperienza” (p. 21). È evidente che i cammini sono stati e sono molti. Ma una spiritualità per l’oggi dovrà comunque essere integrale: “vuol dire che deve coinvolgere l’uomo nella sua totalità” (p. 21), e quindi, nel linguaggio di Panikkar, fare sintesi tra quattro dimensioni che sarebbero, invece, nella cultura di oggi divise, con il rischio di frammentare e alienare l’uomo. Le quattro dimensioni, che una genuina spiritualità deve ricomporre, sono sōma, psychē, polis, kosmos. Anzitutto, l’uomo non ha, ma è sōma, corpo. Ne deriva che una spiritualità “che faccia astrazione dal corpo umano, che lo sottovaluti o che lo releghi come cosa secondaria, sarebbe monca” (p. 22). Ma l’uomo è anche psychē, anima, cioè pensiero, immaginazione, fantasia, volontà. L’uomo inoltre è anche polis, non è cioè individuo, ma società, collettività, chiesa, famiglia. “La dicotomia (mortale!) tra individuo e collettività si trova proprio alla base delle tensioni di ogni specie” (p. 22). Infine, l’uomo è kosmos: non è solo società ma universo, mondo. Cioè non è e non può essere separato dagli animali, dalle cose, dalla terra; e allora la terra non può essere arbitrariamente sfruttata perché non è ‘l’altro’ ma è parte costitutiva dell’uomo. In questo quadro antropologico, Dio è insieme immanente e trascendente: “è nella stessa quaternitas degli elementi che definiscono l’uomo che si incontra il divino” (p. 24). Solo in questa prospettiva possiamo comprendere come la spiritualità genuina non sia affatto qualcosa che disincarni, ma anzi qualcosa che – componendo i frammenti, mettendo insieme interno ed esterno, alto e basso – aiuta piuttosto a vivere la Vita integralmente. Nel senso dell’incarnazione, dove “i problemi della terra non possono essere separati da quelli del cielo” (p. 26). E una tale spiritualità non potrà che aprirsi al dialogo interculturale e interreligioso: “Non bisogna perdere di vista il fatto che, considerando la situazione attuale dell’umanità, nessuna religione, nessuna civiltà, nessuna cultura ha la forza sufficiente o è in grado di dare all’uomo una risposta soddisfacente: le une hanno bisogno delle altre. Non si può pretendere che la soluzione per l’insieme dell’umanità, d’ora in poi, possa venire da un’unica fonte […] bisogna sforzarsi perché avvenga una mutua fecondazione tra le differenti tradizioni umane” (p. 25).
Il terzo saggio – Religione e religioni – fa da introduzione all’omonimo, secondo volume dell’Opera Omnia, di imminente pubblicazione. Il titolo intende sottolineare “l’ambiguità della parola ‘religione’ che al singolare rappresenta l’apertura costitutiva dell’uomo al mistero della vita mentre al plurale indica le diverse tradizioni religiose” (p. 27). In questa prospettiva, l’esperienza di Dio – ma meglio sarebbe dire, in senso ancora più ampio, l’esperienza integrale della Vita – non è e non può essere monopolio di nessuna religione. Ogni religione ne esprime una parte, ma non la esaurisce. Le religioni “sono vie che conducono gli uomini verso la loro pienezza”, in qualunque modo poi si concepisca questa pienezza. Le vie sono tante: alcune sono costituite dalle religioni tradizionali, altre sono vie nuove, a cui spesso è difficile dire se possano o meno essere chiamate religioni. Ne deriva che nessuna religione (o cultura, o tradizione) può pretendere “di esaurire la gamma universale dell’esperienza umana” (p. 28) e che quindi il pluralismo sia, soprattutto oggi, una stringente necessità: “l’incontro-dialogo tra religioni, ideologie e concezioni del mondo è un imperativo umano dei nostri giorni” (p. 28). E in questo incontro Panikkar comprende anche la possibilità del dialogo con un certo umanesimo ateo in quanto, comunque, impegnato in un medesimo sforzo per il perfezionamento umano. Questo è quanto Panikkar chiama ecumenismo ecumenico. Esso “tenta di arrivare a un fecondo arricchimento reciproco e di accettare una critica delle tradizioni religiose del mondo senza tralasciare per questo di riconoscere il ruolo unico spettante a ognuna di esse. Come le confessioni cristiane riconoscono un Cristo di cui non possiedono il monopolio, un Cristo che le unisce tutte quante, senza dovere per questo esserne amalgamate, così le distinte tradizioni dell’umanità riconoscono un humanum (diversamente interpretato alla stessa maniera in cui vi sono interpretazioni divergenti di Cristo) non manipolabile da chicchessia, cioè trascendente. Fedeli a questo humanum, discutono tra loro tentando di avvicinarsi all’ideale” (p. 29). Ebbene, solo un tale atteggiamento che rinuncia alla pretesa di monopolio su ciò che la religione rappresenta, potrebbe aprire ad un fecondo dialogo dialogale, con l’unico obiettivo di aiutare l’uomo a raggiungere la sua pienezza.
Il terzo volume dell’Opera Omnia – Cristianesimo – dà anche il titolo al quarto saggio. Qui Panikkar distingue tre diversi livelli contenuti nella parola ‘cristiano’: esso può essere l’aggettivo di cristianità, cioè riferirsi ad una civiltà. Nel Medioevo, ad esempio, era impossibile essere cristiani senza appartenere alla cristianità. Ma cristiano può anche alludere alla religione cristianesimo: fino a non molto tempo fa era difficile dirsi cristiano senza riconoscersi appartenente al cristianesimo. Ma cristiano, sostiene Panikkar, può anche riferirsi a cristianìa, cioè alla possibilità di riconoscersi cristiano “come atteggiamento personale, senza appartenere alla cristianità o aderire al cristianesimo in quanto struttura istituzionale” (p. 31). Si tratta di una coscienza cristiana più matura che, soprattutto per il terzo millennio che si è appena aperto, sembra costituire un forte appello. Essere cristiano come membro della cristianità appartiene infatti al passato o semmai, come dice Panikkar, “ai sogni di alcuni nei confronti del futuro” (p. 32), ma sembra non parlare più alla maggioranza dei cristiani. Il cristianesimo come religione ha preso posto nella coscienza cristiana a cominciare dal declino della cristianità come regime politico-religioso. Ma il cristianesimo come religione deve confrontarsi con le altre religioni esistenti e ciò mette in crisi la sua purezza dottrinale. Da qui l’emergere, oggi, di quella che Panikkar chiama cristianìa (Christlicheit, in tedesco; christianness, in inglese), e cioè la “confessione di una fede personale, che adotta un atteggiamento analogo a quello di Cristo, nella misura in cui Cristo rappresenta il simbolo centrale della propria vita” (p. 35), e che comporta un rendersi indipendenti rispetto alla sovraistituzionalizzazione del cristianesimo ufficiale. “Si tratta di un mutamento ecclesiale nella stessa autocomprensione cristiana” (p. 35). Ciò non significa, precisa Panikkar, disprezzare o ignorare le strutture giuridiche e gli apparati istituzionali, ma solo non identificarsi con essi. Si tratta di superare, non di respingere: è una nuova autocomprensione per la quale “ci si è resi indipendenti da un ordine politico fisso e determinato (cristianità)”, come anche “dall’identificazione tra essere cristiano e l’accettazione di una serie determinata di dottrine (cristianesimo)” (p. 38). In questa prospettiva, cristianìa apparterrebbe piuttosto alla dimensione mistica, che, peraltro, ha bisogno di istituzioni. Ebbene, proprio questa nuova autocomprensione mistica, dice Panikkar, sembra essere l’urgenza dei nostri giorni.
Il quarto volume dell’Opera Omnia, è dedicato all’induismo. Il quinto e il sesto saggio costituiscono rispettivamente le introduzioni al primo e al secondo tomo del volume. Non ci soffermiamo su queste densissime introduzioni che hanno il grande merito di aiutare noi occidentali a comprendere meglio il cuore di una tradizione molto diversa dalla nostra. Il settimo saggio – Buddhismo – costituisce l’introduzione al quinto volume dell’Opera Omnia e raccoglie i testi di Panikkar su ciò che possiamo ritenere il messaggio fondamentale di questa religione. Un’impresa quasi paradossale, dato il carattere fondamentalmente apofatico del buddhismo. Caratteristica del buddhismo è infatti l’affermazione della non-realtà della realtà ultima: essa è niente. Ma, osserva Panikkar, “il buddhismo non afferma che l’Assoluto è un niente, che non esiste in generale un qualche cosa, ma piuttosto che nessun essere corrisponde a quel qualche cosa […] Significherebbe quindi falsare completamente il buddhismo, se si volesse fargli affermare che bisogna pensare l’Assoluto come un Niente; l’Assoluto non deve essere pensato, perché, in tal caso, si sarebbe costretti a pensarlo come Essere o non-Essere, ed esso «non è» nessuna delle due cose” (p. 75).
I saggi successivi – Pluralismo e interculturalità e Dialogo interculturale e interreligioso – sono le introduzioni ai due tomi del volume Culture e religioni in dialogo, il sesto dell’Opera Omnia. Sono saggi molto densi, perché vanno a toccare uno dei temi su cui Panikkar si è espresso di più e per il quale ha combattuto con maggiore convinzione: il tema del dialogo. Un tema oggi molto urgente, a motivo dei cambiamenti a cui il nostro mondo è andato incontro negli ultimi decenni e che hanno visto popoli e culture venire tra loro in contatto e mescolarsi, creando, spesso, scontri di civiltà e problemi di convivenza: “La verità di una tradizione si scontra con quella dell’altra e il dialogo rappresenta l’unica via per la sopravvivenza” (p. 77). Per l’analisi del contenuto del primo saggio, rimandiamo alla recensione che abbiamo fatto dell’intero tomo. I temi del pluralismo e del dialogo sono ripresi anche nel secondo saggio, il nono, che, come detto, costituisce l’introduzione al secondo tomo. Panikkar definisce un “mito nascente” della nostra epoca, un mito unificante, quello secondo cui l’uomo avvertirebbe sempre più l’insufficienza delle proprie culture e delle proprie religioni e tenderebbe verso una sorta di unità della famiglia umana, “nell’ottica globale di una cultura dell’uomo che abbraccia tutte le civiltà e le religioni come tante sfaccettature che si arricchiscono e stimolano a vicenda” (p. 91). Questo mito, curiosamente, prosegue Panikkar, si presenterebbe come l’opposto del vecchio mito del “monogenismo”, che ci presentava “l’unità della razza umana sottolineandone l’origine unica” (p. 92). Oggi, l’unità dell’umanità “ci appare molto meno al suo inizio che non al suo termine” (p. 92). A lungo andare, “i sistemi di pensiero sembrano convergere su tutti i piani: la mutua fecondazione appare non solo possibile, ma auspicabile […] L’altro comincia a diventare un altro polo di noi stessi. Il confronto porta alla complementarietà” (p. 93). Dagli altri si può imparare e grazie agli altri si può crescere. Ma, conclude Panikkar, sarebbe un errore e un pericolo operare sintesi frettolose: “prima di arrivare a una qualche visione d’insieme dobbiamo studiare le dottrine, conoscere i fatti e scoprire lo spirito di un’altra tradizione” (p. 95). È dunque necessario un lungo e umile lavoro; si tratta di “conoscere quanto meglio possibile la nostra tradizione, sviluppare l’empatia e la comprensione, renderci conto che scoprire le altre religioni è al contempo approfondire e purificare la nostra e che iniziarci a un’altra tradizione non può che arricchirci” (p. 96).
Il decimo saggio – Induismo e cristianesimo – introduce l’omonimo volume focalizzato sul dialogo tra le due culture alle quali “l’autore appartiene fin dalla nascita e alle quali è stato fedele in tutta la sua vita: ha continuato sempre a sentirsi profondamente cristiano e autenticamente hindū” (p. 97). Per un cristiano il dialogo tra le religioni – afferma Panikkar – deve rispettare tre condizioni: “1. Si deve rimanere fedeli alla tradizione cristiana. Questo è il problema teologico; 2. Non si devono violare le altre tradizioni; devono essere interpretate secondo la loro stessa autocomprensione. Questo è il problema ermeneutico; 3. Non si deve mettere da parte l’esame critico della cultura contemporanea. Questo è il problema filosofico” (p. 102). All’esame di queste tre condizioni sono dedicate le pagine del saggio. L’undicesimo saggio introduce invece l’omonimo ottavo volume dell’Opera Omnia con il titolo Visione trinitaria e cosmoteandrica: Dio-Uomo-Cosmo. Qui Panikkar presenta una sua visione della realtà, una cosmovisione che, a grandi linee, intende riprendere il tema cristiano della Trinità. Essa si situa come una terza, grande, visione, che cerca di superare i limiti delle due visioni precedenti, quella monista e quella dualista. La visione monista, fondandosi sulla ragione, intende ridurre ad unità i dati che le si presentano, giungendo al concetto di Essere: l’Essere è uno, l’Uno, o semplicemente la Realtà. “La ragione, per intendere, esige la reductio ad unum, come dicevano gli scolastici […] Se vogliamo intendere razionalmente la realtà, dovremo arrivare al monismo […] In breve, se non vogliamo rinunciare alla razionalità dovremo affermare che in ultima istanza tutto è Dio, o Essere, o Spirito, o Materia, o Energia, o Nulla” (p. 116). All’opposto, la visione dualista riconosce due irriducibili sfere della realtà: il materiale e lo spirituale. La via di uscita al dilemma tra monismo e dualismo è costituita dalla visione a-dualista o advaita, che è quella che Panikkar fa propria. Si tratta di superare il razionalismo, ma senza cadere nell’irrazionalismo. La realtà “è costituita da tre dimensioni relazionate le une con le altre – la perichōrēsis trinitaria – così che non solo una non esiste senza l’altra, ma tutte sono intrecciate inter-in-dipendentemente. Tanto Dio, quanto il Mondo e l’Uomo presi separatamente, o a sé, senza relazione con le altre dimensioni della realtà, sono semplici astrazioni della nostra mente” (p. 117).
Il volume nono dell’Opera Omnia – Mistero ed ermeneutica – è costituito da due tomi. L’introduzione al primo tomo – Mito, simbolo, culto – costituisce il dodicesimo saggio, mentre il saggio Fede, ermeneutica, parola introduce il secondo tomo. Il quattordicesimo saggio – Filosofia e teologia – introduce l’omonimo decimo volume dell’Opera Omnia. Nella prospettiva di Panikkar, filosofia e teologia sono inseparabili perché si implicano vicendevolmente. La filosofia è da lui intesa “non solo come amore della saggezza, ma anche come saggezza dell’amore” (p. 127). La filosofia, scrive ancora Panikkar, “è un tipo di amore molto particolare. È saggezza, la saggezza dell’amore, la saggezza che è contenuta nell’amore […] E la saggezza nasce quando l’amore del sapere e il sapere dell’amore si fondono spontaneamente” (p. 128). Ne consegue che una tale filosofia non può non cristallizzarsi in uno stile di vita, anzi è l’espressione della vita stessa. “Una filosofia che tratti solo di strutture, teorie, idee e si isoli dalla vita, eviti la prassi e reprima i sentimenti, non è solamente unilaterale perché non prende in considerazione altri aspetti della realtà, ma è cattiva filosofia […] Perciò tutte le tradizioni sostengono che per fare veramente filosofia si richiede cuore puro, mente ascetica, vita autentica. L’attività filosofica esige un coinvolgimento totale” (p. 128). La riflessione deve cioè divenire carne, e il pericolo della astrazione intellettuale è grande. “Un professore per me è «uno che professa», vale a dire che esprime una «professione», una confessione, con la totalità della sua vita”, esattamente come un religioso autentico “è colui che lotta, che si sforza per arrivare all’unione armoniosa del sacro e del secolare” (p. 129). La teologia descrive anch’essa questa esigenza di coinvolgimento in una immersione totale nella vita, in una comunione piena con la Realtà.
Il saggio successivo, il quindicesimo, introduce il volume undicesimo dell’Opera Omnia, intitolato Secolarità sacra. Secolarità sacra è – secondo Panikkar – “lo stile di vita cui siamo chiamati, superando la dicotomia tra il sacro e il profano” (p. 135). E aggiunge: “non si tratta di fuggire dal mondo, ma di trasfigurarlo. Bisogna ‘trovare’ il sacro e ‘scoprirne’ la via secolare” (p. 135). Non si tratta, in altre parole, di negare la trascendenza del divino, ma bensì di cogliere “l’immanenza del sacro nelle viscere stesse del mondo” (p. 135). Si tratta di re-imparare a cogliere la sacralità del mondo, senza confondere immanenza e trascendenza. “Se si riduce tutto il reale al meramente secolare, si soffoca la realtà privandola del suo carattere di infinitezza e libertà. Ma, allo stesso tempo, negare alla secolarità il suo carattere reale e definitivo, degrada la vita umana a un semplice gioco senza importanza reale, né dignità. Forse una delle ragioni della crisi apparentemente universale dell’umanità attuale è che non si è riusciti a operare una sintesi tra sacro e secolare” (p. 137). L’ultimo saggio, il sedicesimo, introduce l’ultimo volume dell’Opera Omnia, dedicato a Spazio, tempo e scienza. Il volume racchiude articoli e scritti che riguardano la scienza, apparsi nel primo periodo della vita di Panikkar.
Speriamo di essere riusciti a far cogliere, in queste pagine inevitabilmente troppo sintetiche, almeno qualche frammento della ricchezza e pluriformità di un pensiero e di una esperienza di vita che – crediamo – ha segnato profondamente il nostro tempo e non cesserà di parlare al nostro futuro.
Massimo Diana

![]() Omelia Guardia 28 agosto
Omelia Guardia 28 agosto![]() Omelia Guardia, 29 agosto pomeriggio.doc
Omelia Guardia, 29 agosto pomeriggio.doc![]() Omelia Guardia, 29 agosto 2011.doc
Omelia Guardia, 29 agosto 2011.doc