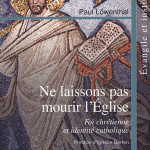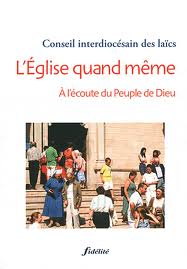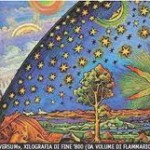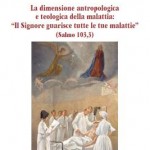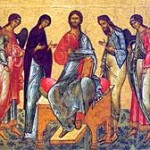Tra atei e credenti basta il pensiero
intervista a Bruno Forte a cura di Marco Roncalli
«Una teologia per la vita» (La Scuola, pp. 248, euro 14,50) è il libro intervista di Marco Roncalli a monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto e teologo di fama. Il testo, da cui riprendiamo qui un brano, viene presentato oggi alle 18 al teatro Rossetti di Vasto e domani , sempre alle 18, al teatro Marruccino di Chieti.
Discutendo pensatori come Andrea Emo, Massimo Cacciari e Vincenzo Vitiello, lei chiede alla fede e alla ragione di essere agoniche, di accettare la sfida, la lotta…
«Una ragione troppo sicura di sé, una ragione ideologica, diventa violenta e totalitaria. Una fede che non faccia spazio al dubbio, un credente che non voglia essere il povero ateo che ogni giorno si sforza di cominciare a credere, rischia di fare della sua fede una rassicurazione comoda. Dunque, fede e ragione sono agoniche, chiamate ad accettare la lotta, la passione per la verità, e proprio così si aprono all’amore, la parola che il Nuovo Testamento adopera per esprimere la forma più alta dell’incontro. Insomma, dobbiamo arrivare allo stupore della ragione, che è pure l’approdo della più severa disciplina del pensiero, della filosofia spinta fino in fondo. È forse lì che la ragione avverte meglio il fremere di una voce di silenzio: ‘l’ultimo Dio’, per dirla con Heidegger, non viene prima, ma oltre la ragione e le sue pretese, oltre i naufragi delle sue violenze. Nelle profondità del desiderio, la ragione si riconosce assunta e superata da un orizzonte altro, più grande: sul piano speculativo la ragione indagante oltre sé stessa si ferma meditante sull’abisso ‘dell’Inizio’, ineludibile sponda… Questo stupore mi pare la condizione per aprirsi anche al possibile avvento dell’Altro nella propria vita, cui schiude la fede. È la verità che non si può possedere, ma dalla quale siamo posseduti, che si fa a noi guida, che rende la fede necessaria alla nostra vita: di questo ho parlato proprio con amici come Massimo Cacciari, Vincenzo Vitiello e Giulio Giorello…».
Persone con cui ha scritto «Trinità per atei», a ricordarci la complementarità di teologia e filosofia.
«La teologia necessita nel suo cammino dell’indagine filosofica, ma allo stesso tempo la filosofia ha bisogno della teologia. Si deve passare dal cogito ergo sum cartesiano, che sembrava esaurire nella capacità speculativa dell’io ogni problematicità filosofica, al cogitor ergo sum, al ‘sono pensato, dunque esisto’, come ci ricorda la teologia. La riflessione ci porta a un Dio che fa spazio all’altro, ma che allo stesso tempo crea uno spazio di indagine profonda in noi stessi».
Dimenticavo una cosa sui nomi che mi ha appena citato… Sono accomunati dal fatto che non hanno mai la pretesa di avere risposte per tutto.
«E infatti ho dovuto rinunciare a tenere aperto il dialogo con quei pensatori che avevano invece la presunzione di sapere tutto…».
Qualche nome: almeno un italiano?
«Odifreddi e i suoi fragili “pamphlets” contro Dio e il cristianesimo».
Lo conosce personalmente?
«Venne a visitarmi e stetti a pranzo con lui. Si ipotizzava un lavoro insieme. Volli ascoltarlo. Poi gli dissi chiaramente che non potevo scrivere un libro con lui su Dio. Per lui Dio può essere tutt’al più un giocattolo da smontare… per me è il mistero santo, su cui si gioca tutto.
Per lui tutto è scontato, ci sono formule che risolvono tutti i problemi. No, non ci siamo. Il dialogo deve essere fra teologia e filosofia, appunto fra interrogazione e ascolto, aperti entrambi alla forza della verità che irrompe…».
Secondo lei chi è il vero ateo? E l’agnostico?
«Certo non chi dice con nonchalance di non credere in Dio, chi è indifferente tout court, ma chi pensa fino in fondo il dramma della fede, vive in una condizione di ricerca e di sofferenza, e denuncia il dolore di non credere… Ogni non banale non credere resta indissociabile dall’infinito dolore dell’assenza, da un senso di orfananza e d’abbandono, quale solo la morte di Dio può creare nel cuore dell’uomo, nella storia del mondo. Il pensante dunque è, per certi versi, a modo suo, un credente, anche quando non confessa una fede, quanto meno una persona che sta vicino ad un credente più di quanto lui stesso pensi… Insomma uno che non nega Dio con presunzione, ma che ne sperimenta con dolore l’assenza. Agnostico è chi pensa di non poter conoscere Dio, di non poter nulla dire sul mistero. Di per sé l’ateismo implica una negazione più radicale. Ecco perché penso che non possa esistere. Dopo il pensiero debole, con la sua visione di un essere che non è, ma accade, sempre proteso sul baratro del nulla, dopo la crisi delle ideologie, ritengo sia difficile negare Dio, quanto meno sottrarsi alla sfida del mistero. Se vogliamo, pure il credente è un agnostico, uno cui non basta certo la “gnosi” volgare delle soluzioni a buon mercato del problema più alto… Siamo tutti in ricerca verso il Mistero che ci sorpassa. All’interno del credere o non credere ci sono due possibili atteggiamenti radicali, quello di chi pensa, di chi pone domande vere e vive la sofferenza della ricerca, e quello di chi non pensa più. Ecco io credo che dobbiamo incontrarci nel pensare, anche se questo reca fatica o sofferenza… Altrimenti è il credente a diventare una specie di ateo, quando ad esempio trasforma la sua fede in una sorta di ideologia, senza vivere l’inquietudine sofferta, appassionata di una ricerca, di una vera e propria lotta con Dio. Ecco perché, credenti e no, siamo sempre sulla soglia».
Sempre sulla soglia, ma anche sempre sulla stessa zattera della condizione umana che, in apparenza, se uno non crede, s’infrange sulla sponda della morte. Questo vuol dire dolore, ogni volta che tocca qualcuno che hai amato…
«Sì, ma, appunto, solo a uno sguardo immediato, di superficie. Certo, non nego la domanda sul dolore.
Senza la morte non ci sarebbe il pensiero, la vita, la vita del pensiero, la dignità del vivere. È la morte che lascia aperto il bisogno di senso. Ed è il dolore che rivela la vita a sé stessa più fortemente della morte: l’avventura umana sta tutta nell’ammettere la tragicità della morte, non fuggendola, non esorcizzandola o nascondendola. Riconoscerla non significa solo imparare a morire, ma lottare per dare senso alla vita, alla bellezza di esistere. Come diceva Maritain, bisogna riconoscersi “mendicanti del cielo”, cercando gesti e parole che vincano quello che appare l’ultimo orizzonte. Perciò la condizione dell’essere umano è quella del pellegrino, sempre in viaggio, alla ricerca di una patria lontana, che a nel cuore la nostalgia di un Oltre. Il nostro tempo sembra vivere a volte nell’illusione di mete raggiunte, nella sazietà del giorno, nella compiutezza dei propri percorsi: sta qui la “malattia mortale”. Tu sei morto quando il tuo cuore non vive più l’inquietudine e la passione del domandare. E questo vale anche per la via di Dio: nell’esperienza dell’incontro con Lui la grande tentazione è quella di fermare la vita… Quando non si ha più il desiderio di cercare, ci si allontana da Dio. È questo il senso più profondo della legge della Croce».
in “Avvenire” del 30 novembre 2011
Forte Bruno, Una teologia per la vita, Brescia, Editrice La Scuola, 2011, pp. 245, E. 14.50
In un intenso colloquio con il saggista Marco Roncalli, il vescovo-teologo Bruno Forte mette in relazione teologia e filosofia, religione ed estetica, educazione e vita quotidiana. Un libro che racconta la ricerca di Dio nel nostro tempo segnato dai problemi del confronto tra identità e dialogo, della globalizzazione e del futuro del cristianesimo, affrontando temi e interrogativi che toccano la vita di credenti e non credenti.