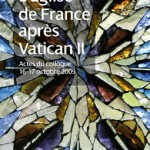Il prossimo mese di luglio Benedetto XVI incontrerà di nuovo degli artisti, meno di due anni dopo il precedente incontro nella Cappella Sistina (vedi foto).
Che l’arte, assieme ai santi e più ancora della ragione, sia “la più grande apologia della fede cristiana” è una tesi che Benedetto XVI ha sostenuto più volte.
Per lui la bellezza è “la via più attraente ed affascinante per giungere ad incontrare ed amare Dio”.
Ma questa tesi non ha affatto vita facile oggi, cioè almeno da quando, un paio di secoli fa, “si è spezzato il filo dell’arte sacra”: come ha titolato lo storico dell’arte Timothy Verdon un suo saggio su “L’Osservatore Romano” del 28 marzo 2008.
Enrico Maria Radaelli, filosofo dell’estetica, nel suo ultimo libro pone una domanda paradossale:
“Che cosa imparerebbero i milioni di fedeli che visitano la Cappella Sistina se le sue nobili pareti e la sua celebre volta, invece che da Michelangelo, fossero state dipinte da un Haring, un Warhol, un Bacon, un Viola, un Picasso?”.
Il nuovo saggio di Radaelli ha per titolo: “La bellezza che ci salva”. E il sottotitolo è tutto un programma: “La forza di ‘Imago’, il secondo Nome dell’Unigenito di Dio, che, con ‘Logos’, può dar vita a una nuova civiltà, fondata sulla bellezza”.
Sono trecento pagine di alta metafisica e di teologia, avvalorate da una prefazione del filosofo del “senso comune” Antonio Livi, sacerdote dell’Opus Dei e professore alla Pontificia Università Lateranense.
Ma sono pagine anche di critica sferzante alla deriva che ha travolto un fecondo rapporto durato secoli tra arte e fede cristiana. Senza risparmiare le alte gerarchie della Chiesa, che Radaelli accusa di aver abdicato al loro ruolo magisteriale, di faro della fede e quindi anche dell’arte cristiana.
Per invertire la rotta, Radaelli scrive che non basta qualche sporadico incontro tra il papa e gli artisti. A suo giudizio è necessario convocare nella Chiesa “un dibattito universale, non meramente artistico, ma teologico, liturgico, ecclesiologico, filosofico, un simposio pluriennale e multidisciplinare, il cui nome potrebbe essere il semplice ma chiaro ‘Stati generali della bellezza’”.
Radaelli fa i nomi di coloro che da lui interpellati, in Vaticano e fuori, hanno aderito all’idea: il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del pontificio consiglio della cultura; il cardinale Mauro Piacenza, prefetto della congregazione per il clero; il cardinale Albert Malcolm Ranjith, arcivescovo di Colombo ed ex segretario della congregazione per il culto divino; l’abate Michael John Zielinski, vicepresidente della pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa; Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani; Valentino Miserachs Grau, preside del pontificio istituto di musica sacra; Timothy Verdon, presidente dell’ufficio per la catechesi nell’arte dell’arcidiocesi di Firenze; Roberto de Mattei, storico, vicepresidente del Centro Nazionale delle Ricerche; Nicola Bux, consultore della congregazione per il culto divino e dell’ufficio delle celebrazioni liturgiche pontificie; Ignacio Andereggen, membro della pontificia accademia di san Tommaso d’Aquino.
Con piglio polemico, Radaelli osserva che “ci vuole più coraggio” a organizzare questi “Stati generali della bellezza” che un Cortile dei Gentili. Perché – spiega – dialogare fuori del tempio col mondo profano sarà anche giusto e meritorio, ma prima ancora le gerarchie della Chiesa dovrebbero provvedere a far sì che la cattedrale della dottrina non vada in rovina, “piena com’è di inconsci ma non meno veri luterani, ariani, gnostici, pelagiani”.
Ma non è detto che nel Cortile dei Gentili la questione messa a fuoco da Radaelli sia taciuta. Nel primo di questi incontri di dialogo voluti da Benedetto XVI e attuati dal cardinale Ravasi, tenuto a Parigi nel marzo del 2011, c’è stato un oratore che l’ha proposta all’attenzione di tutti in forma bruciante.
Questo oratore è Jean Clair, storico dell’arte di fama mondiale, membro dell’Accademia di Francia e conservatore generale del patrimonio artistico francese.
Inoltre, il 2 giugno, festa dell’Ascensione di Gesù al Cielo, su “L’Osservatore Romano” il teologo Inos Biffi ha sviluppato il tema della “bellezza della verità di Dio” con accenti consonanti a quelli del saggio di Radaelli: altro segnale di attenzione autorevole alla questione.
Ecco qui di seguito alcuni passaggi degli interventi di Jean Clair e di Inos Biffi.
__________
CULTO DELL’AVANGUARDIA E CULTURA DI MORTE
di Jean Clair
Parigi, Cortile dei Gentili, 25 marzo 2011
[…] Ci sono nella storia della Chiesa episodi singolari come, nel XII e XIII secolo, la stupefacente moda dei Goliardi, chierici itineranti che scrivevano poesie erotiche e canzoni da taverna parecchio oscene, e che si dedicavano a fare parodie burlesche di messe e sacramenti della Chiesa. Ma i goliardi agivano così per criticare una Chiesa di cui denunciavano gli errori. Nulla di tutto ciò, oggi, negli artisti d’avanguardia, che non hanno rapporti con la Chiesa, e neanche voglia di burlarsene. Il movimento dei goliardi era legato a un’epoca di grande religiosità e di grande misticismo, non a una manifestazione di indifferenza.
Potrebbero essere solo le singolari deviazioni di qualche bello spirito, se la proliferazione di queste incursioni estetiche nelle chiese di Francia, e la comunanza della loro natura, esibizionista e spesso coprolalica, non inducesse a interrogarci sulla relazione che il cattolicesimo intrattiene oggi con la nozione di Bellezza.
Mi limiterò a pochi esempi:
– In una piccola chiesa della Vandea nel 2001, accanto alla cassa di un santo guaritore per il quale si viene da lontano in pellegrinaggio, si installa un’altra cassa colma di antibiotici.
– Più recentemente, nel battistero di una grande chiesa a Parigi si installa un’immensa macchina che fa colare liquido plastificante, lo sperma di Dio, su enormi certificati di battesimo, venduti sul posto a 1500 euro l’uno.
– A Gap, il vescovo presenta un’opera di un artista d’avanguardia, Peter Fryer, che rappresenta Cristo nudo con le braccia distese, legato su una sedia elettrica, come una Deposizione dalla Croce.
– Nel 2009, in una piccola chiesa di Finistère, una spogliarellista, Corinne Duval, nell’ambito di un happening di danza contemporanea, sovvenzionata dal ministero della cultura, termina danzando nuda sull’altare. […]
Quel che vedo rinascere e svilupparsi in questi culti libertini così simili a quelli che praticano certe sette gnostiche del secondo secolo mi sembra effettivamente una nuova gnosi, secondo la quale la creatura è innocente, il mondo è malvagio e il cosmo imperfetto.
Non sono un teologo, ma come storico delle forme sono colpito, in queste opere culturali dette “d’avanguardia” che oggi pretendono di far entrare nelle chiese la gioia della sofferenza e del male – mentre un tempo il culto tradizionale le combatteva con la sua liturgia –, dalla presenza ossessiva degli umori del corpo, privilegiando lo sperma, il sangue, il sudore, o il marciume, il pus nella frequente evocazione dell’aids. Naturalmente anche l’urina che – a proposito del “Piss Christ” dell’artista Andres Serrano, “imprescindibile star del mondo dell’arte e del mercato” secondo M. Brownstone – viene proclamata “portatrice di luce” in un’omelia del sacerdote, Robert Pousseur, allora incaricato di iniziare il clero francese ai misteri dell’arte contemporanea. […]
La Chiesa si è lasciata affascinare dalle avanguardie fino al punto di presumere che l’immondo e gli abomini offerti alla vista dai suoi artisti siano le migliori porte d’accesso alla verità del Vangelo. Nel frattempo sono state segnate diverse tappe che non oso definire come una deriva.
Negli anni ’70, la Chiesa non voleva conoscere dell’arte contemporanea altro che l’astrazione. Dopo le vetrate di Bazaine a Saint Séverin ci furono le vetrate di Jean Pierre Reynaud all’Abbazia di Noirlac, poi quelle commissionate a Morellet e a Viallat per Nevers, e di Soulages per l’abbazia di Conques, Il volto non esisteva più, il corpo non esisteva più, il crocifisso stesso fu allora sostituito da due pezzi di legno o di ferro saldati. Le lotte sanguinose dell’iconoclasmo sembravano non essere mai accadute. L’iconoclastia ormai era un fatto normale. […]
Quante sono, nei musei di Stato, le opere che riguardano l’iconografia cattolica? 60 per cento? 70 per cento? Dalle crocifissioni alle deposizioni nel sepolcro, dalle circoncisioni ai martiri, dalle natività ai San Francesco d’Assisi… Contrariamente agli ortodossi che si inginocchiano e pregano davanti alle icone, anche quando esse si trovano ancora nei musei, è raro, nella Grande Galleria del Louvre, vedere un fedele fermarsi e pregare davanti a un Cristo in croce o davanti a una Madonna. Bisogna rimpiangerlo? A volte lo penso. La Chiesa dovrebbe domandare la restituzione dei suoi beni? Mi capita di pensare anche questo. Ma la Chiesa non ha più alcun potere, contrariamente ai Vanuatu o agli Indiani Haida della Colombia Britannica, che hanno ottenuto la restituzione degli strumenti della loro fede, maschere e totem… La Chiesa si vergognerebbe di essere stata all’origine dei più prodigiosi tesori visivi che si siano mai avuti? Non potendo riaverli indietro, non potrebbe almeno prendere coscienza dell’obbligo che non li si può lasciare senza spiegazione davanti a milioni di visitatori dei musei? […]
La religione cattolica mi è apparsa per molto tempo come la più rispettosa del senso, la più attenta alle forme e ai profumi del mondo. È in essa che si incontra anche la più profonda e la più avvincente e sorprendente tenerezza. Il cattolicesimo mi sembra innanzitutto una religione non del distacco, né della conquista, né di un Dio geloso, ma una religione della tenerezza.
Non ne conosco altra che per esempio abbia a tal punto esaltato la maternità. […] Quale religione ha dipinto tante volte, da Giotto a Maurice Denis, il bambino in tutte le posizioni dell’infanzia, gesti, sguardi, passioni di bambino, con le sue golosità e curiosità, quando è in piedi sulle ginocchia della madre? Come la Chiesa attuale ha potuto voltare le spalle a una tale ricchezza? […]
Nell’opera d’arte nata dal cristianesimo c’è anche altro, rispetto alla felicità visiva e alla pietà. C’è anche un approccio euristico del mondo. […] L’artista è al servizio di Dio, non degli uomini, e se dipinge la creazione, conosce le meraviglie del creato, custodisce nel suo spirito il fatto che queste creature non sono Dio, ma la testimonianza della bontà di Dio, e che sono lode e canto di allegrezza. Mi domando dove questa allegria si possa ancora sentire, quella che si sentiva in Bach o in Haendel, in queste manifestazioni culturali, così povere e così offensive per l’orecchio e per l’occhio, alle quali ormai le chiese aprono il loro culto.
Qui senza dubbio è stata e rimane oggi la grandezza della Chiesa: essa è nata dalla contemplazione e dall’adorazione di un bambino che nasce, e si fortifica con la visione di un uomo che risuscita. Tra questi due momenti, la Natività e la Pasqua, non ha smesso di lottare contro la “cultura della morte”, come dice così giustamente.
Questo coraggio, questa ostinazione rendono ancor più incomprensibile la sua tentazione di difendere opere che, ai miei occhi, alle “porte della mia carne”, sanno soltanto di morte e di disperazione.
Un Dio senza la presenza del Bello è più incomprensibile di un Bello senza la presenza di un Dio.
(Traduzione di Flora Crescini ed Enrica Zaira Merlo, a cura del Centro Culturale di Milano).
__________
QUANDO SI RESPIRA IL SOFFIO DELLA BELLEZZA
di Inos Biffi
Da “L’Osservatore Romano” del 2 giugno 2011
[…] La teologia per definizione “dice Dio”. E questo “dire” la verità di Dio ha una sua bellezza. […] Ne era persuaso sant’Agostino che parlava di “splendore della verità”, e al quale faceva ripetuta eco Tommaso d’Aquino, […] attribuendo la prerogativa di essere “splendore e bellezza” al Verbo, che nel mistero della sua trasfigurazione e della sua ascensione l’ha effusa e riversata nella sua stessa umanità gloriosa, termine inesausto della contemplazione dei beati. […]
Si dice che i dogmi sono veri. Bisogna continuare, e dire che i dogmi sono belli. […] Occorre proseguire e osservare che la bellezza del mistero non è solo quella che traspare dal discorso teologico, come estetica intellettuale, tramite l’”ordinamento architettonico delle idee”, ma anche […] quella che si effonde dalle “cattedrali di pietra”, ossia nell’estetica della visibilità e, aggiungiamo, della poesia, della musica.
Si trovano allora attratte dalla divina bellezza la “sensibilità”, l’emotività, l’immaginario e l’estaticità che, sotto l’impulso attraente del mistero, a loro volta lo manifestano e lo espandono.
Richiamiamo gli inni di Ambrogio o di Manzoni, o le Laudi di Jacopone da Todi, ma soprattutto la “Divina commedia” di Dante, che non è un corso di teologia dogmatica, eppure equivale alla più alta, e si direbbe inarrivabile, versione poetica della fede e dei suoi dogmi: è il “bello” cristiano, portato ai vertici sublimi della poesia.
Con questo il dogma non è solo dichiarato e “affermato” come bello, e ad apparire tale non è solo la verità esposta e commentata, ma è diventato bello nel modo originale della poesia.
In questa linea dell’estetica, potremmo anche richiamare quanto il mistero sia stato e sia ancora reso “incantevole” dalla musica sacra, liturgica e non liturgica, che inizia al mistero stesso, proponendolo e facendolo gustare nella forma del canto e della melodia. I repertori musicali della Chiesa, un immenso patrimonio di messe, di oratori, di mottetti, sono a loro volta cattedrali musicali. […]
È quello che è sempre avvenuto nella tradizione cristiana, che ha guardato al mistero con “illuminati gli occhi del cuore” (Ef 1, 18). […] E proprio per l’esercizio della verità e della bellezza della fede è sorta la cultura cristiana, frutto più che di amabile e ossequioso dialogo, di sorprendente e inedita creatività. […]
Una proposta per i cinquant’anni del Vaticano II
LA VIA SOPRANNATURALE PER RIPORTARE PACE TRA PRIMA E DOPO IL CONCILIO
di Enrico Maria Radaelli
La discussione che si sta svolgendo sul sito internet di Sandro Magister tra scuole di diverse e opposte posizioni riguardo a riconoscere nel Concilio ecumenico Vaticano II continuità o discontinuità con la Tradizione, oltre che chiamarmi in causa direttamente fin dalle prime battute, tocca da vicino alcune pagine preliminari del mio recente libro “La bellezza che ci salva”.
Il fatto di gran lunga più significativo del saggio è la comprovata identificazione delle “origini della bellezza” con quelle quattro qualità sostanziali – vero, uno, buono, bello – che san Tommaso d’Aquino dice essere i nomi dell’Unigenito di Dio: identificazione che dovrebbe chiarire una volta per tutte il fondamentale e non più eludibile legame che un concetto ha con la sua espressione, vale a dire il linguaggio con la dottrina che lo utilizza.
Mi pare doveroso intervenire e fare così alcuni chiarimenti per chi vuole ricostruire quella “Città della bellezza” che è la Chiesa e riprendere così l’unica strada (questa è la tesi del mio saggio) che può portarci alla felicità eterna, che ci può cioè salvare.
Completerò il mio intervento con il suggerimento della richiesta che meriterebbe essere fatta al Santo Padre affinché, ricordando con monsignor Brunero Gherardini che nel 2015 cadrà il cinquantesimo anniversario del Concilio (cfr. “Divinitas”, 2011, 2, p. 188), la Chiesa tutta approfitti di tale straordinario evento per ripristinare la pienezza di quel “munus docendi”, di quel magistero, sospeso cinquant’anni fa.
Riguardo al tema in discussione, la questione è stata ben riassunta dal teologo domenicano Giovanni Cavalcoli: “Il nodo del dibattito è qui. Siamo infatti tutti d’accordo che le dottrine già definite [dal magistero dogmatico della Chiesa pregressa] presenti nei testi conciliari sono infallibili. Ciò che è in discussione è se sono infallibili anche gli sviluppi dottrinali, le novità del Concilio”.
Il domenicano si avvede infatti che la necessità è di “rispondere affermativamente a questo quesito, perché altrimenti che ne sarebbe della continuità, almeno così come la intende il papa?”. E non potendo fare, come ovvio, le affermazioni che pur vorrebbe fare, padre Cavalcoli le gira nelle domande opposte, cui qui darò la risposta che avrebbero se si seguisse la logica “aletica”, veritativa, insegnataci dalla filosofia.
Prima domanda: È ammissibile che lo sviluppo di una dottrina di fede o prossima alla fede già definita sia falso?
Caro padre Cavalcoli, lei per la verità avrebbe tanto voluto dire: “Non è ammissibile che lo sviluppo di una dottrina di fede o prossima alla fede già definita sia falso”. Invece la risposta è: sì, lo sviluppo può essere falso, perché una premessa vera non porta necessariamente a una conclusione vera, ma può portare pure a una o più conclusioni false, tant’è che in tutti i Concili del mondo – persino nei dogmatici – si confrontarono le più contrastanti posizioni proprio a motivo di tale possibilità. Per avere lo sperato sviluppo di continuità delle verità rivelate per grazia non basta essere teologi, vescovi, cardinali o papi, ma è necessario richiedere l’assistenza speciale, divina, data dallo Spirito Santo solo a quei Concili che, dichiarati alla loro apertura solennemente e indiscutibilmente a carattere dogmatico, tale divina assistenza se la sono garantita formalmente. In tali soprannaturali casi avviene che lo sviluppo dato alla dottrina soprannaturale risulterà garantito come veritiero tanto quanto sono già state divinamente garantite come veritiere le sue premesse.
Ciò non è avvenuto all’ultimo Concilio, dichiarato formalmente a carattere squisitamente pastorale almeno tre volte: alla sua apertura, che è quel che conta, poi all’apertura della seconda sessione e per ultimo in chiusura; sicché in tale assemblea da premesse vere si è potuti giungere a volte anche a conclusioni almeno opinabili (a conclusioni che, canonicamente parlando, rientrano nel III grado di costrizione magisteriale, quello che, trattando di temi a carattere morale, pastorale o giuridico, richiede unicamente “religioso ossequio”) se non “addirittura errate”, come riconosce anche padre Cavalcoli contraddicendo la sua tesi portante, “e comunque non infallibili”, e che dunque “possono essere anche mutate”, sicché, anche se disgraziatamente non vincolano formalmente, ma “solo” moralmente il pastore che le insegna anche nei casi siano di incerta fattura, provvidenzialmente non sono affatto vincolanti obbligatoriamente l’obbedienza del fedele.
D’altronde, se a gradi diversi di magistero non si fanno corrispondere gradi diversi di assenso del fedele non si capisce cosa ci stiano a fare i gradi diversi di magistero. I gradi diversi di magistero sono dovuti ai gradi diversi di prossimità di conoscenza che essi hanno con la realtà prima, con la realtà divina rivelata cui si riferiscono, ed è ovvio che le dottrine rivelate direttamente da Dio pretendono un ossequio totalmente obbligante (I grado), tali come le dottrine loro connesse se presentate attraverso definizioni dogmatiche o atti definitivi (II grado). Sia le prime che le seconde si distinguono da quelle altre dottrine che, non potendo appartenere al primo gruppo, potranno essere annoverate al secondo solo allorquando si sarà appurata con argomenti plurimi, prudenti, chiari e irrefutabili la loro connessione intima, diretta ed evidente con esso nel rispetto più pieno del principio di Vincenzo di Lérins (“quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum est”), garantendo così al fedele di trovarsi anch’esse dinanzi alla conoscenza più prossima di Dio. Tutto ciò, come si può capire, si può ottenere soltanto nell’esercizio più consapevole, voluto e implorato dalla e sulla Chiesa del “munus”, del magistero dogmatico.
La differenza tra le dottrine di I e II grado e quelle di III è data dal carattere certamente soprannaturale delle prime, che invece nel terzo gruppo non è garantito: forse c’è, ma forse anche non c’è. Quel che va colto è che il “munus” dogmatico è: 1) un dono divino, dunque 2) un dono da richiedere espressamente e 3) un dono la cui non richiesta non offre poi alcuna garanzia di assoluta verità, mancanza di garanzia che sgancia il magistero da ogni obbligo di esattezza e i fedeli da ogni obbligo di obbedienza, pur richiedendo loro religioso ossequio. Nel III grado potrebbero trovarsi indicazioni e congetture di ceppo naturalistico, e il vaglio per verificare se, depuratele da tali eventuali anche microbiche infestazioni, è possibile un loro innalzamento al grado soprannaturale può compiersi solo ponendole a confronto col fuoco dogmatico: la paglia brucerà, ma il ferro divino, se c’è, risplenderà certo in tutto il suo fulgore.
È ciò che è successo alle dottrine dell’Immacolata Concezione e dell’Assunzione, oggi dogmi, articoli cioè di fede appartenenti oggi di diritto al secondo gruppo. Fino rispettivamente al 1854 e al 1950 esse appartennero al gruppo delle dottrine opinabili, al terzo, alle quali si doveva nient’altro che “religioso ossequio”, pari pari a quelle dottrine novelle che, più avanti elencate qui in breve e sommario inventario, si affastelleranno nel più recente insegnamento della Chiesa dal 1962. Ma nel 1854 e nel 1950 il fuoco del dogma le circondò della sua divina e peculiare marchiatura, le avvampò, le vagliò, le impresse e infine in eterno le sigillò quali “ab initio” già erano nella loro più intima realtà: verità certissime e universalmente comprovate, dunque di diritto appartenenti al ceppo soprannaturale (il secondo) anche se fino allora non formalmente riconosciute sotto tale splendida veste. Felice riconoscimento, e qui si vuol appunto sottolineare che fu riconoscimento degli astanti, del papa in primo luogo, non affatto trasformazione del soggetto: come quando i critici d’arte, dopo averla esaminata sotto ogni punto di vista e indizio utili ad avvalorarla o smentirla – certificati di provenienza, di passaggi di proprietà, prove di pigmentazione, di velatura, pentimenti, radiografie e riflettografie – riconoscono in un quadro d’autore la sua più indiscutibile e palmare autenticità.
Quelle due dottrine si rivelarono entrambe di fattura divina, e della più pregiata. Se qualcuna dunque di quelle più recenti è della stessa altissima mano lo si riscontrerà pacificamente col più splendido dei mezzi.
Seconda domanda: Può il nuovo campo dogmatico essere in contraddizione con l’antico?
Ovviamente no, non può in alcun modo. Infatti dopo il Vaticano II non abbiamo alcun “nuovo campo dogmatico”, come si esprime padre Cavalcoli, anche se molti vogliono far passare per tale le novità conciliari e postconciliari, pur essendo il Vaticano II un semplice se pur solenne e straordinario “campo pastorale”. Nessuno dei documenti richiamati da dom Basile Valuet alla sua nota 5 dichiara un’autorevolezza del Concilio maggiore di quella da cui esso fu investito fin dall’inizio: nient’altro che una solenne e universale, cioè ecumenica, adunanza “pastorale” intenzionata a dare al mondo alcune indicazioni solo pastorali, rifiutandosi dichiaratamente e ostentatamente di definire dogmaticamente o di colpire d’anatema alcunché.
Tutti i maggiorenti neomodernisti o semplicemente novatori che dir si voglia i quali (come sottolinea il professor Roberto de Mattei nel suo “Il concilio Vaticano II. Una storia mai scritta”) furono attivi nella Chiesa fin dai tempi di Pio XII – teologi, vescovi e cardinali della “théologie nouvelle” come Bea, Câmara, Carlo Colombo, Congar, De Lubac, Döpfner, Frings col suo perito, Ratzinger; König col suo, Küng; Garrone col suo, Daniélou; Lercaro, Maximos IV, Montini, Suenens, e, quasi gruppo a sé, i tre maggiorenti della cosiddetta scuola di Bologna: Dossetti, Alberigo e oggi Melloni – nello svolgimento del Vaticano II e dopo hanno cavalcato con ogni sorta di espedienti la rottura con le detestate dottrine pregresse sullo stesso presupposto, equivocando cioè sull’indubbia solennità della straordinaria adunanza; per cui si ha che tutti costoro compirono di fatto rottura e discontinuità proclamando a parole saldezza e continuità. Che vi sia poi da parte loro e poi universalmente oggi desiderio di rottura con la Tradizione è riscontrabile almeno: 1) dal più distruttivo scempio perpetrato sulle magnificenze degli altari antichi; 2) dall’egualmente universale odierno rifiuto di tutti i vescovi del mondo tranne pochissimi a dare il minimo spazio al rito tridentino o gregoriano della messa, in stolida e ostentata disobbedienza alle direttive del motu proprio “Summorum Pontificum”. “Lex orandi, lex credendi”: se tutto ciò non è rigetto della Tradizione, cos’è allora?
Malgrado ciò, e la gravità di tutto ciò, non si può però ancora parlare in alcun modo di rottura: la Chiesa è “tutti i giorni” sotto la divina garanzia data da Cristo nei giuramenti di Matteo 16, 18 (“Portæ inferi non prævalebunt”) e di Matteo 28, 20 (“Ego vobiscum sum omnibus diebus”) e ciò la mette metafisicamente al riparo da ogni timore in tal senso, anche se il pericolo è sempre alle porte e spesso i tentativi in atto. Ma chi sostiene un’avvenuta rottura – come fanno alcuni dei maggiorenti anzidetti, ma anche i sedevacantisti – cade nel naturalismo.
Però non si può parlare neanche di saldezza, cioè di continuità con la Tradizione, perché è sotto gli occhi di tutti che le più varie dottrine uscite dal e dopo il Concilio – ecclesiologia; panecumenismo; rapporto con le altre religioni; medesimezza del Dio adorato da cristiani, ebrei e islamici; correzione della “dottrina della sostituzione” della Sinagoga con la Chiesa in “dottrina delle due salvezze parallele”; unicità delle fonti della Rivelazione; libertà religiosa; antropologia antropocentrica invece che teocentrica; iconoclastia; o quella da cui è nato il “Novus Ordo Missæ” in luogo del rito gregoriano (oggi raccattato a fianco del primo, ma subordinatamente) – sono tutte dottrine che una per una non reggerebbero alla prova del fuoco del dogma, se si avesse il coraggio di provare a dogmatizzarle: fuoco che consiste nel dar loro sostanza teologica con richiesta precisa di assistenza dello Spirito Santo, come avvenne a suo tempo con il “corpus theologicum” posto a base dell’Immacolata Concezione o dell’Assunzione di Maria.
Tali fragili dottrine sono vive unicamente per il fatto che non vi è nessuna barriera dogmatica alzata per non permettere il loro concepimento e uso. Però poi si impone una loro fasulla continuità col dogma per pretendere verso di esse l’assenso di fede necessario all’unità e alla continuità (cfr. le pp. 70ss, 205 e 284 del sopraddetto mio libro “La bellezza che ci salva”), restando così tutte in pericoloso e “fragile borderline tra continuità e discontinuità” (p. 49), ma sempre al di qua del limite dogmatico, che infatti, se applicato, determinerebbe la loro fine. Anche l’affermazione di continuità tra tali dottrine e la Tradizione pecca a mio avviso di naturalismo.
Terza domanda: Se noi neghiamo l’infallibilità degli sviluppi dottrinali del Concilio che partono da precedenti dottrine di fede o prossime alla fede, non indeboliamo la forza della tesi continuista?
Certo che la indebolite, caro padre Cavalcoli, anzi: la annientate. E date forza alla tesi opposta, come è giusto che sia, che continuità non c’è.
Niente rottura, ma anche niente continuità. E allora cosa? La via d’uscita la suggerisce Romano Amerio (1905-1997) con quella che l’autore di “Iota unum” definisce “la legge della conservazione storica della Chiesa”, ripresa a p. 41 del mio saggio, per la quale “la Chiesa non va perduta nel caso non ‘pareggiasse’ la verità, ma nel caso ‘perdesse’ la verità”. E quando la Chiesa non pareggia la verità? Quando i suoi insegnamenti la dimenticano, o la confondono, la intorbidano, la mischiano, come avvenuto (non è la prima volta e non sarà l’ultima) dal Concilio a oggi. E quando perderebbe la verità? (Al condizionale: si è visto che non può in alcun modo perderla). Solo se la colpisse d’anatema, o se viceversa dogmatizzasse una dottrina falsa, cose che potrebbe fare il papa e solo il papa, se (nella metafisicamente impossibile ipotesi che) le sue labbra dogmatizzanti e anatematizzanti non fossero soprannaturalmente legate dai due sopraddetti giuramenti di Nostro Signore. Insisterei su questo punto, che mi pare decisivo.
Qui si avanzano delle ipotesi, ma – come dico nel mio libro (p. 55) – “lasciando alla competenza dei pastori ogni verifica della cosa e ogni successiva conseguenza, per esempio del se e del chi eventualmente, e in che misura, sia incorso od ora incorra” negli atti configurati. Nelle primissime pagine evidenzio in specie come non si possono alzare gli argini al fiume di una bellezza salvatrice se non sgombrando la mente da ogni equivoco, errore o malinteso: la bellezza si accompagna unicamente alla verità (p. 23), e tornare a far del bello nell’arte, almeno nell’arte sacra, non si riesce se non lavorando nel vero dell’insegnamento e dell’atto liturgico.
Quello che a mio avviso si sta perpetrando nella Chiesa da cinquant’anni è un ricercato amalgama tra continuità e rottura. È lo studiato governo delle idee e delle intenzioni spurie nel quale si è cambiata la Chiesa senza cambiarla, sotto la copertura (da monsignor Gherardini nitidamente illustrata anche nei suoi libri più recenti) di un magistero volutamente sospeso – a partire dal discorso d’apertura del Concilio “Gaudet mater ecclesia” – in una tutta innaturale e tutta inventata sua forma, detta, con ricercata imprecisione teologica, “pastorale”. Si è svuotata la Chiesa delle dottrine poco o nulla adatte all’ecumenismo e perciò invise ai maggiorenti visti sopra e la si è riempita delle idee ecumeniche di quegli stessi, e ciò si è fatto senza toccarne in alcun modo la veste metafisica, per natura sua dogmatica (cfr. p. 62), per natura sua cioè soprannaturale, ma lavorando unicamente su quel campo del suo magistero che inferisce unicamente sulla sua “conservazione storica”.
In altre parole: non c’è rottura formale, né peraltro formale continuità, unicamente perché i papi degli ultimi cinquant’anni si rifiutano di ratificare nella forma dogmatica di II livello le dottrine di III che sotto il loro governo stanno devastando e svuotando la Chiesa (cfr. p. 285). Ciò vuol dire che in tal modo la Chiesa non pareggia più la verità, ma neanche la perde, perché i papi, persino in occasione di un Concilio, si sono formalmente rifiutati sia di dogmatizzare le nuove dottrine sia di colpire d’anatema le pur disistimate (o corrette o raggirate) dottrine pregresse.
Come si vede, si potrebbe anche ritenere che tale incresciosissima situazione andrebbe a configurare un peccato del magistero, e grave, sia contro la fede, sia contro la carità (p. 54): non sembra infatti che si possa disobbedire al comando del Signore di insegnare alle genti (cfr. Matteo 28, 19-20) con tutta la pienezza del dono di conoscenza elargitoci, senza con ciò “deviare dalla rettitudine che l’atto – cioè ‘l’‘insegnamento educativo alla retta dottrina’ – deve avere” (Summa Theologiae I, 25, 3, ad 2). Peccato contro la fede perché la si mette in pericolo, e infatti la Chiesa negli ultimi cinquant’anni, svuotata di dottrine vere, si è svuotata di fedeli, di religiosi e di preti, diventando l’ombra di se stessa (p. 76). Peccato contro la carità perché si toglie ai fedeli la bellezza dell’insegnamento magisteriale e visivo di cui solo la verità risplende, come illustro in tutto il secondo capitolo del mio libro. Il peccato sarebbe d’omissione: sarebbe il peccato di “omissione della dogmaticità propria alla Chiesa” (pp. 60ss), con cui la Chiesa volutamente non suggellerebbe sopranaturalmente e così non garantirebbe le indicazioni sulla vita che ci dà.
Questo stato di peccato in cui verserebbe la santa Chiesa (si intende sempre: di alcuni uomini della santa Chiesa, ovvero la Chiesa nella sua componente storica), se riscontrato, andrebbe levato e penitenzialmente al più presto anche lavato, giacché, come il cardinale José Rosalio Castillo Lara scriveva al cardinale Joseph Ratzinger nel 1988, il suo attuale ostinato e colpevole mantenimento “favorirebbe la deprecabile tendenza […] a un equivoco governo cosiddetto ‘pastorale’, che in fondo pastorale non è, perché porta a trascurare il dovuto esercizio dell’autorità con danno al bene comune dei fedeli” (pp. 67s).
Per restituire alla Chiesa la parità con la verità, come le fu restituita ogni volta che si trovò in simili drammatiche traversie, altra via non c’è che tornare alla pienezza del suo “munus docendi”, facendo passare al vaglio del dogma a 360 gradi tutte le false dottrine di cui oggi è intrisa, e riprendere come “habitus” del suo insegnamento più ordinario e pastorale (nel senso rigoroso del termine: “trasferimento della divina Parola nelle diocesi e nelle parrocchie di tutto il mondo”) l’atteggiamento dogmatico che l’ha sopranaturalmente condotta fin qui nei secoli.
Ripristinando la pienezza magisteriale sospesa si restituirebbe alla Chiesa storica l’essenza metafisica virtualmente sottrattale, e con ciò si farebbe tornare sulla terra la sua bellezza divina in tutta la sua più riconosciuta e assaporata fragranza.
Per concludere, una proposta
Ci vuole audacia. E ci vuole Tradizione. In vista della scadenza del 2015, cinquantesimo anniversario del Concilio della discordia, bisognerebbe poter promuovere una forte e larga richiesta al Trono più alto della Chiesa affinché, nella sua benignità, non perdendo l’occasione davvero speciale di tale eccezionale ricorrenza, consideri che vi è un unico atto che può riportare pace tra l’insegnamento e la dottrina elargiti dalla Chiesa prima e dopo la fatale assemblea, e quest’unico, eroico, umilissimo atto è quello di accostare al soprannaturale fuoco del dogma le dottrine sopra accennate invise ai fedeli di parte tradizionista, e le contrarie: ciò che deve bruciare brucerà, ciò che deve risplendere risplenderà. Da qui al 2015 abbiamo davanti tre anni abbondanti. Bisogna utilizzarli al meglio. Le preghiere e le intelligenze debbono essere portate alla pressione massima: fuoco al calor bianco. Senza tensione non si ottiene niente, come a Laodicea.
Questo atto che qui si propone di compiere, l’unico che potrebbe tornare a riunire in un’unica cera, come dev’essere, quelle due potenti anime che palpitano nella santa Chiesa e nello stesso essere, riconoscibili l’una negli uomini “fedeli specialmente a ciò che la Chiesa è”, l’altra negli uomini il cui spirito è più teso al suo domani, è l’atto che, mettendo fine con bella decisione a una cinquantennale situazione piuttosto anticaritativa e alquanto insincera, riassume in un governo soprannaturale i santi concetti di Tradizione e audacia. Per ricostruire la Chiesa e tornare a fare bellezza, il Vaticano II va letto nella griglia della Tradizione con l’audacia infuocata del dogma.
Dunque tutti i tradizionisti della Chiesa, a ogni ordine e grado come a ogni particolare taglio ideologico appartengano, sappiano raccogliersi in un’unica sollecitazione, in un unico progetto: giungere al 2015 con il più vasto, consigliato e ben delineato invito affinché tale ricorrenza sia per il Trono più alto l’occasione più propria per ripristinare il divino “munus docendi” nella sua pienezza.
__________
Il libro di Enrico Maria Radaelli “La bellezza che ci salva” (prefazione di Antonio Livi, 2011, pp. 336, euro 35,00) può essere richiesto direttamente all’autore (enricomaria.radaelli@tin.it) o alla Libreria Hoepli di Milano (www.hoepli.it).
__________
POST SCRIPTUM 1 / LA REPLICA DI FRANCESCO ARZILLO
L’appello del professor Enrico Maria Radaelli, accorato e sofferto, suscita simpatia ma anche qualche perplessità sia di contenuto sia di metodo.
Partirei dalla coda, ossia dai tempi. Radaelli pone l’anno 2015 quale orizzonte temporale di riferimento per un pronunciamento di carattere dogmatico sulle questioni pendenti. Tuttavia egli richiama quale esempio la proclamazione dogmatica dell’Immacolata, per la quale la Chiesa ha invece atteso non pochi secoli. Gli storici del dogma conoscono le resistenze dei domenicani, che solamente nell’Ottocento furono definitivamente superate: il plurisecolare lavoro teologico e spirituale favorì in tal modo una proclamazione quasi unanimemente condivisa nella Chiesa.
È da ammirare questo modo di procedere, che fa della Chiesa cattolica – per dirla paradossalmente – l’opposto di quella monarchia autoritaria che non pochi tra i non cattolici immaginano. Una cosa è infatti il potere del Magistero supremo, un’altra cosa è la questione del modo e dei tempi del suo esercizio, che sono soggetti a ovvi canoni prudenziali.
C’è quindi da chiedersi: se ci sono voluti secoli per una proclamazione dogmatica in un contesto caratterizzato ancora da una certa omogeneità di linguaggio e di formazione teologica, come si può pensare che le odierne dispute possano risolversi con atti dogmatici nel giro di pochi anni, in un contesto di radicale pluralismo culturale ed epistemologico? La definizione dogmatica presuppone infatti, di regola, una preparazione niente affatto semplice.
La linea di Benedetto XVI appare diversa: seminare – come nel caso del ripristino del rito antico – e attendere che la semina porti frutto a suo tempo.
Un secondo punto. Si potrebbe di certo – dopo attenta indagine – riconoscere che alcune delle nuove dottrine conciliari e postconciliari siano collocate nel II livello, come sostiene il padre Giovanni Cavalcoli. Ma anche se ciò non fosse, la cosa non dovrebbe turbare più di tanto il fedele cattolico, anche se teologo. È bene ribadire che lo Spirito Santo non assiste i pastori solamente nel momento della definizione (di I o di II livello, per esprimersi secondo la nota scala di durezza richiamata dal professor Radaelli). Lo Spirito li assiste sempre, anche nei pronunciamenti di III livello, ai quali, come Radaelli stesso riconosce, è dovuto un “religioso ossequio dell’intelletto e della volontà” (art. 752 del codice canonico).
La necessità di questo assenso anche interno è il punto più trascurato, oggi, sia dai neomodernisti sia dai tradizionalisti. Il fatto che si tratti di pronunciamenti non irreformabili non significa che i fedeli non debbano seguirli come espressione della via più sicura. Ciò non esclude la possibilità che le persone competenti sollevino qualche dubbio nelle forme e nei modi propri, tali da non turbare l’ordinato svolgimento della vita ecclesiale. Ma ciò non può di certo comportare l’instaurarsi di magisteri paralleli, neppure sul fronte tradizionalista: effetto che sarebbe paradossale, dopo le giuste polemiche contro il consolidato magistero parallelo dei teologi progressisti sui mass-media.
Un terzo punto, infine. Il bel dibattito in corso su www.chiesa e sul blog Settimo Cielo dimostra che è possibile approfondire la portata dell’ermeneutica della continuità solamente entrando nel merito dei singoli problemi. La discussione sulla libertà religiosa lo ha rivelato assai chiaramente. È evidentemente fruttuoso lo sforzo volto a capire e a individuare esattamente il nocciolo che attiene all’essenza della dottrina sotto la mutevolezza degli accidenti storici: fermo restando, ovviamente, che questo nocciolo ci deve essere e deve essere mantenuto fermo, per evitare il rischio di cadere nel relativismo.
Questo esame delle dottrine “al microscopio”, ma anche “al telescopio” della profondità storica, riserverebbe piacevoli sorprese, nel senso auspicato dall’ermeneutica della continuità. Esso potrebbe mostrare che lo Spirito Santo non ha abbandonato la Chiesa cinquant’anni fa. E che non è certo venuta meno la promessa del Signore: “Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28, 16-20).
Roma, 16 giugno 2011
__________
POST SCRIPTUM 2 / LA REPLICA DI GIOVANNI CAVALCOLI
Caro professor Radaelli,
ho letto con molto interesse le sue considerazioni e le sue proposte circa l’autorevolezza delle dottrine nuove del Concilio Vaticano II, che lei pone, con dom Basile Valuet, al III grado, mentre io, almeno per alcune, la porrei al II.
Il III grado contiene sia dottrine “de fide et moribus” che disposizioni pastorali. Qui il Magistero, trattando materia di fede o prossima alla fede, non intende definire che quanto insegna è di fede, per cui non definisce se si tratta di dottrine definitive o infallibili oppure no. La dottrina della fede è di per sé è infallibile perché assolutamente e perennemente vera, ma qui la Chiesa, pur trattando di materia di fede o prossima alla fede, non chiede, come Lei ben riconosce, un vero assenso di fede, ma un semplice “ossequio religioso della volontà” per il fatto che qui la materia trattata non appare con certezza essere di fede. Questo ovviamente non vuol dire che possa essere sbagliata.
Viceversa, al II grado la Chiesa richiede un vero e proprio atto di fede, benchè non si tratti ancora della fede divina e teologale con la quale aderiamo alle dottrine del I grado, che sono i veri e propri dogmi definiti. La fede richiesta al II grado si chiama “fede ecclesiastica” o anche semplicemente “cattolica” ed è quella fede che abbiamo nell’infallibilità del Magistero della Chiesa in quanto assistito dallo Spirito Santo.
Qui aderiamo con la fede, perchè qui appare con chiarezza, magari per mezzo di opportune dimostrazioni, che si tratta di materia di fede e, se si tratta di dottrine nuove, è possibile mostrarle come chiarificazione, esplicitazione o deduzione di o da precedenti dottrine definite o dati rivelati. È questo il caso delle dottrine nuove del Concilio, se non tutte, almeno di alcune, le principali, come per esempio la definizione della liturgia, della rivelazione, della Tradizione o della Chiesa.
Quanto alla “pastoralità” del Concilio, è vero, è stato un Concilio pastorale, ma non solo pastorale, bensì anche dottrinale e addirittura dogmatico: basterebbe citare il titolo di due suoi documenti, chiamati appunto “Costituzioni dogmatiche”. Questo i papi del postconcilio lo hanno detto più volte, anche se hanno detto con altrettanta chiarezza che il Concilio non ha definito dichiaratamente o esplicitamente nuovi dogmi, quindi è indubbio che la sua dottrina non si pone al I grado.
È importante questa distinzione tra il dottrinale e il pastorale, perché, quando un Concilio presenta un insegnamento dottrinale, attinente benchè indirettamente alla Rivelazione, non può sbagliare. Anche se si tratta di dottrine nuove, non può tradire o smentire la Tradizione. Viceversa, le direttive o disposizioni di carattere pastorale o lo stesso stile pastorale di un Concilio non sono mai infallibili, a meno che non si tratti di contenuti di fede concernenti l’essenza dell’azione pastorale, ed anzi sono normalmente mutevoli e rivedibili, possono essere meno opportune o addirittura sbagliate, per cui devono essere abrogate. Questa può essere la “paglia” del III grado, ma non certo eventuali pronunciamenti dottrinali! Questi, accostati al “fuoco” del dogma, splendono di maggiore bellezza!
Anche certe disposizioni pastorali del Concilio potrebbero essere “paglia”. Ed anzi, secondo me e non solo secondo me, lo sono state e lo sono per il fatto che, messe alla prova dei fatti, dopo quarant’anni, richiedono di essere riviste o corrette per i cattivi risultati che hanno dato. Mi riferisco per esempio a quanto anche lei dice: l’eccessiva indulgenza del Magistero nei confronti degli errori o l’eccessivo ottimismo nei confronti del mondo moderno, nonché l’eccessiva esaltazione dei valori umani e la debole esaltazione dei valori cristiani, soprattutto cattolici.
Ciò ha consentito la penetrazione dappertutto, anche nella gerarchia, di queste tendenze, ulteriormente esasperate da una ben concertata macchina pubblicitaria internazionale organizzata dal centro-Europa (per esempio la rivista “Concilium”). I vescovi, come osservò a suo tempo padre Cornelio Fabro, ne restarono intimiditi, sicchè oggi è assai difficile liberarsi da questa situazione, perché chi dovrebbe intervenire è egli stesso connivente con l’errore.
Altro errore pastorale del Concilio è stato quello di indebolire il potere del papa rafforzando eccessivamente quello dei vescovi, col risultato che si è verificata quella “breviatio manus” del papa, della quale parlava Amerio: il pontefice è rimasto isolato nello stesso episcopato. Ovviamente, grazie all’assistenza dello Spirito santo, egli conserva ed applica il suo ruolo di maestro della fede e nemico dell’errore; ma purtroppo spesso gli interventi della Santa Sede in questo campo – che non mancano affatto – hanno scarsa per non dire scarsissima eco nell’episcopato e fra i teologi, quando a volte non si hanno addirittura delle opposizioni, ora subdole, ora sfrontate.
Su questa materia occorre recuperare un certo stile precedente il Concilio, che portava buoni risultati, ovviamente senza cadere in certi eccessi di severità e di autoritarismo del passato. I papi del postconcilio sono papi crocifissi, abbandonati come Cristo dai suoi. Altro che “trionfalismo”! È uso dei prepotenti fare le vittime.
Sono d’accordo con lei nel sostenere o meglio nel constatare con Amerio che dall’immediato periodo postconciliare a tutt’oggi il Magistero dice sì la verità – e come non potrebbe? – ma non la dice tutta. Tace alcune verità per un eccessivo timore dei non-cattolici e di non apparire abbastanza moderno. Le preoccupazioni ecumeniche, e peraltro di ecumenismo troppo pacifista e accondiscendente, sembrano prevalere sul dovere di evangelizzare e di correggere chi sbaglia, invitandolo all’unità “cum Petro e sub Petro”.
Occorre allora recuperare verità dimenticate, delle quali dò solo qualche esempio, sapendo bene, con lei, di sfondare una porta aperta: il valore realistico della verità, il valore intellettuale-concettuale della conoscenza di fede, il valore sacrificale, espiativo e soddisfattorio della redenzione, la natura e le conseguenze del peccato originale, la congiunzione della giustizia e della misericordia divine, gli attributi divini dell’impassibilità e dell’immutabilità, la distinzione fra natura e grazia, la predestinazione, l’esistenza di dannati nell’inferno, la possibilità di perdere la grazia col peccato mortale, l’esistenza dei miracoli e delle profezie, il dovere di lavorare per la conversione dei non-cattolici al cattolicesimo.
Vorrei dirle, però, caro professore, che non deve credere che dottrine conciliari come quelle della prospettiva universale della salvezza, del dialogo con la modernità, dell’ecumenismo, della libertà religiosa o delle verità contenute nelle altre religioni contrastino con le precedenti verità, anche se si tratta di dimostrare la continuità. Si tratta solo di una migliore conoscenza o di aspetti nuovi di quelle medesime verità che vengono insegnate in quelle dottrine.