
http://www.chiesacattolica.it/

http://www.chiesacattolica.it/

Verso Lisbona 2020: il punto su Matematica
Sono stati pubblicati nei giorni scorsi, a cura della Commissione europea, due rapporti che raccolgono gli esiti delle ultime rilevazioni internazionali relative alle competenze dei 15enni europei in scienze e in matematica.
Androulla Vassiliou, commissario europeo per l’istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù, nell’introduzione al volume dedicato alla matematica, sottolinea l’importanza strategica per i giovani di una solida cultura in questo campo, non solo per rispondere ad un interesse personale, ma anche per un utile impiego nel lavoro e nella vita quotidiana.
Il rapporto prende in considerazione l’impatto delle modalità di insegnamento della matematica nei diversi sistemi scolastici, anche con l’intenzione di suggerire una migliore diffusione di buone pratiche a sostegno dei percorsi di insegnamento.
L’Europa assiste ad una costante diminuzione di studenti nelle facoltà matematiche, scientifiche e tecnologiche, oltre al permanere di un annoso squilibrio nel numero di studenti e studentesse frequentanti questo tipo di facoltà.
L’attuale crisi finanziaria rafforza il convincimento che sia di cruciale importanza un’attenzione e una cura crescenti per l’istruzione scientifica e matematica che permetta alle giovani generazioni di affrontare le problematiche future con un sicuro bagaglio di conoscenze.
Il volume ricorda che le rilevazioni internazionali, fin dal 2009, hanno indicato per i 15enni europei scarse competenze matematiche e stabilito, per il 2020, una riduzione nel numero dei ragazzi insufficientemente preparati di almeno il 15%.
| tuttoscuola.com | venerdì 18 novembre 2011 |
Verso Lisbona 2020: il punto sulle Scienze
Tra le più recenti pubblicazioni della Commissione europea, va considerata quella che raccoglie in un complesso organico le rilevazioni sulle competenze in Scienze dei 15enni dei 31 Paesi europei solitamente coinvolti nelle rilevazioni internazionali.
L’insegnamento scientifico fa parte delle competenze chiave che debbono possedere i giovani cittadini europei, tuttavia lo studio evidenzia come solo 8 Paesi abbiano delle strategie didattiche nazionali complessive per la promozione di questa disciplina.
Pochi inoltre sono i Paesi che pongono in essere politiche specifiche per equilibrare la percentuale di studenti e studentesse coinvolti negli studi scientifici o per incoraggiarli ad abbracciare carriere scientifico – tecnologiche.
Di contro, si rileva che due terzi dei Paesi che hanno partecipato alle rilevazioni indicano vari soggetti specializzati a livello nazionale in grado di organizzare formazione, aggiornamento per insegnanti e iniziative dedicate agli studenti.
Per quanto riguarda la didattica, tutti i Paesi, Italia compresa, iniziano ad insegnare Scienze con un approccio integrato e multidisciplinare, salvo poi, durante la scuola secondaria di secondo grado declinare l’insegnamento scientifico per singole discipline come la chimica o la biologia.
Un approccio ancora forse troppo strettamente disciplinaristico è presente, in molti casi, anche all’università dove gli studenti hanno maggiore libertà nello scegliere i soggetti all’interno dei programmi di studi.
–>
| tuttoscuola.com | venerdì 18 novembre 2011 |
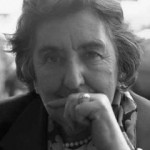
Il 1° novembre di due anni fa si spegneva all’ospedale San Paolo di Milano Alda Merini. La notizia mi raggiunse a sera, mentre rientravo da un viaggio in America Centrale, e a comunicarmela era un giornalista che naturalmente voleva intervistarmi, riconoscendo la vicinanza che la poetessa aveva testimoniato a più riprese e in pubblico nei miei confronti. Effettivamente l’amicizia era sorta quando io vivevo a Milano e si era manifestata da parte mia anche in tre prefazioni che avevo scritto ad altrettanti suoi poemetti di forte intensità spirituale. Ma soprattutto il filo era tenuto dalle sue interminabili telefonate che intrecciavano il suo affetto per me col libero sfarfallio della sua fantasia e con una sorprendente caratteristica che la assimilava agli antichi rapsodi o aedi.
La Merini, infatti, creava spesso le sue poesie oralmente e spingeva il suo interlocutore a raccoglierle per scritto o semplicemente – come nel mio caso – le affidava all’ascolto. Devo riconoscere di essermi pentito di non aver cristallizzato quella voce nelle righe di un foglio, e d’essermi solo lasciato condurre dal flusso delle sue immagini, così inquiete e cangianti, delle sue parole iridescenti come in un caleidoscopio, del balenare delle sue intuizioni spesso folgoranti.
L’ultima telefonata fu da quel l’ospedale ove era ricoverata e ove veniva curata, credo, a fatica, dato il suo temperamento insofferente di ogni continuità o regolarità, anche terapeutica.
Nello stesso timbro della voce intuivo la fatica che si univa a una sorta di «basso continuo» destinato esplicitamente a me. Alda, infatti, non si era rassegnata alla mia partenza da Milano per Roma: la considerava come una fuga o un tradimento nei confronti non solo suoi ma anche di una città che mi amava. Nella sua casa lungo i Navigli, immersa nella confusione, persino nel degrado, lei mi aveva accolto la prima delle poche volte in cui la visitai, con una vera e propria festa. Aveva costellato di mazzi di fiori il disordine estremo delle sue cose, aveva convocato un violinista e il suo cantante preferito che metteva in musica i suoi versi e si era messa lei stessa al pianoforte, che suonava con passione, per offrirmi un benvenuto caloroso secondo una sua tipica cifra simbolica, ossia l’eccesso nel donare.
Infatti, cercando spesso di rifiutare i suoi molteplici regali, io combattevo quella che chiamo la sua “autodepredazione”, che si manifestava nei confronti di tutti, attuando quel motto, che mi pare fosse di D’Annunzio, secondo il quale «io ho solo ciò che ho donato». Ma, ritornando a quell’ultimo dialogo telefonico dall’ospedale, un argomento era stato dominante. Di lì a poco io avrei presentato a Benedetto XVI, nella Cappella Sistina, quasi trecento artisti provenienti da tutto il mondo, secondo ogni genere di arte. Naturalmente avevo invitato anche lei che desiderava «dire alcune cose al Papa», come mi ripeteva. Già aveva pensato all’abito da indossare, mutando mille volte parere e convincendosi alla fine che sarei stato io a trovarle quello adatto. Il 21 novembre 2009, data dell’incontro, si avvicinava e lei, dal letto dell’ospedale, percepiva l’impossibilità di quella sua enuta a Roma e ne soffriva.
Mi confidò, allora, di essersi decisa a scrivere una lettera a Benedetto XVI che ammirava, pur essendo stata legata idealmente e appassionatamente alla figura di Giovanni Paolo II.
Evidentemente ritenevo che fosse solo un sogno, nonostante l’ostinazione con cui mi ripeteva di farmi tramite per la consegna. Lei confermava che l’avrebbe dettata ad alcuni suoi amici e amiche che l’assistevano e che aveva convinto a preparare dipinti o foto o testi che accompagnassero la sua lettera. In verità, dopo la sua morte, preso com’ero dai preparativi del l’incontro della Sistina, non pensai più a quel progetto di Alda, né ricevetti mai la lettera che avrei dovuto presentare al Papa.
La sorpresa è stata forte quando alcuni mesi fa, per una semplice coincidenza – stavo preparando un altro incontro di Benedetto XVI con gli artisti, in occasione dei suoi 60 anni di sacerdozio, evento che si è realizzato il 4 luglio scorso – ebbi una fotocopia della lettera che effettivamente Alda Merini aveva dettato il 28 ottobre 2009, a tre giorni di distanza dalla sua morte. Dattiloscritta su carta intestata dell’«Azienda Ospedaliera San Paolo Polo Universitario – Ufficio Relazioni col Pubblico», lo scritto reca in finale la sua tipica firma-sigla e al suo interno custodisce tutta la trasparenza dell’umanità, della spiritualità, della storia sofferta della poetessa.
C’è il rimando ai suoi “allievi”, c’è la confessione delle colpe («io sono un guado pieno di errori»), c’è la dimensione mistica della sua esperienza personale («ho incontrato faccia a faccia il Signore») e c’è anche il riferimento al suo desiderio frustrato di incontrare nella Sistina il Papa: «Avrei voluto venire da lei ma me l’hanno proibito per la mia salute e per riguardo ad Ella» (suggestivo questo segno di umiltà nella consapevolezza della sua “sregolatezza”). Ampio è lo spazio riservato ai sentimenti materni che hanno tormentato tutta la sua esistenza. Le righe sono quasi intrise di lacrime e striate di amarezza e si fanno fin confuse attraverso il velo della sofferenza. Ritorna alla fine la sua confessione di colpa la fa equiparare alla Maddalena. E a suggello – al di là dell’invocazione di rito «per la malattia e la guarigione di Alda Merini» – ecco un fulminante guizzo poetico: «Abbracci le donne, sono fredde come il ghiaccio».
Credo sia significativo – ora a distanza di anni – far conoscere questa testimonianza di una poetessa che è stata amata da tanti lettori e lettrici e che è stata ascoltata con emozione da tanti giovani (ne sono stato spesso testimone) quando in pubblico narrava senza pudore la sua esperienza drammatica nei manicomi, le sue lacerazioni, i suoi ardori, le sue ascesi mistiche, la sua carnalità spirituale. È anche un modo per esprimerle gratitudine per un ascolto, una stima e un affetto che mi aveva sempre riservato, giungendo fino al punto di dedicarmi a mia insaputa un’intera sua raccolta poetica, La clinica dell’abbandono, pubblicata da Einaudi nel 2003.
A conclusione di questo ricordo molto personale mi tornano in mente alcuni versi di uno dei suoi scritti da lei prediletti, il Magnificat dedicato a Maria la madre di Gesù, raffigurata nel gesto della “Pietà” michelangiolesca, ossia la “deposizione” del corpo del Figlio, gesto che s’incrocia, però, con la memoria della maternità che accoglie il suo bambino sulle ginocchia: «Miserere di me, che sono caduta a terra/come una pietra di sogno./Miserere di me, Signore, che sono un grumo di lacrime./Miserere di me, che sono la tua pietà./Mio figlio,/grande quanto il cielo./Mio figlio, che dorme sulle mie gambe…».
in “Il Sole 24 Ore” del 13 novembre 2011
Io sono come la Maddalena
di Alda Merini
Ospedale San Paolo
Milano, 28 ottobre 2009
Sua Santità Benedetto XVI
Santo Padre, mentre La ringrazio, La prego di tenere conto dei continui omaggi molto belli fatti da alcuni miei allievi, fra i quali Giuliano, i quali, pur onorandoLa, sono assai lontani da Lei. Noi poveri peccatori cerchiamo di onorarLa con disegni e preghiere, ma non vorremmo toccare l’ambito della superbia in cui è facile cadere. Grazie a Dio il Cristianesimo trionfa ma attenti alle false meretrici e peccatrici perché Dio ama i peccatori come noi.
Io sono un guado pieno di errori che ho fatto e di cui mi pento.
Santo Padre ho sentito la Terra Santa perché ho incontrato faccia a faccia il Signore. Io sono vissuta nella sporcizia, ho servito San Francesco e avrei voluto venire da Lei ma me lo hanno proibito per la mia salute e per riguardo ad Ella. «Peccatore come sono» ma madre sicura che non meritava 4 figli. Sono belli ma non cattolici, alcuni di loro non sanno di essere battezzati. Vanno a derubare la loro mamma ma sono sempre doni caro Santo Padre. Questi buoni ladroni sono la mia consolazione e moriranno con me, con i miei dolori.
Hanno pianto, non avevano la mamma.
Ma la mamma è sempre stata con loro, non li ha mai abbandonati. Oh dolce è stato il mio destino al quale ho lasciato i miei anni. Come è vera la storia di Maddalena, anche io come Maddalena.
Abbracci le donne sono fredde come il ghiaccio. Per la malattia e la guarigione di Alda Merini

Dopo l’informativa sindacale di una decina di giorni fa, anche in un altro recente incontro con i referenti degli Uffici scolastici regionali il Miur ha confermato che si va verso la possibile revisione delle Indicazioni per scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, assumendo a riferimento le Indicazioni per il curricolo varate dal ministro Fioroni.
Si tratta di una scelta molto chiara che, a quanto sembra, ha trovato il consenso del mondo sindacale e dovrebbe incontrare anche i favori degli insegnanti.
Per arrivare alla eventuale revisione delle Indicazioni, il ministero sta seguendo contestualmente varie piste di lavoro, la prima delle quali è il monitoraggio previsto dal regolamento per il primo ciclo (dpr 89/2009), affidato all’Ansas, che ha predisposto un apposito questionario (che le scuole potranno compilare entro il 30 novembre) in linea da una settimana.
Le prime valutazioni sul questionario sono sostanzialmente positive per il suo taglio “laico” rispetto alle riforme Gelmini. Potrebbe rappresentare effettivamente una opportunità per le scuole sia per una autovalutazione interna delle attività svolte in questo triennio sia per esprimere osservazioni e proposte utili per l’annunciata revisione delle Indicazioni.
Una cosa è certa: la scuola chiede, dopo anni di cambiamenti all’insegna della discontinuità, di mettere finalmente una parola ferma sulla definizione degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi di competenza: una volta per tutte.
Per arrivare a quel traguardo il ministero è obbligato a tempi rapidi, ma ha fatto sapere che intende operare raccogliendo, oltre agli esiti del monitoraggio, anche documentazione di buone pratiche.
Se tutto andrà bene (sperando anche che vi sia ampia condivisione sulle scelte) le Indicazioni revisionate potrebbero essere pronte dal prossimo settembre (ma non significa che entreranno in vigore da quella data), avviando un processo di assestamento nelle scuole e di pianificazione delle produzione editoriali dei libri di testo.
–>
| tuttoscuola.com | lunedì 14 novembre 2011 |

Gli errori di interpretazione e la sottovalutazione dell’attuale crisi economica sono stati gravi e perdurano.
Sono state male interpretate le sue vere origini, cioè il crollo della natalità, e le conseguenze che hanno portato all’aumento delle tasse sul PIL per assorbire i costi dell’invecchiamento della popolazione. E sono stati sottovalutati gli effetti delle decisioni prese per compensare questi fenomeni, soprattutto con la delocalizzazione produttiva e con i consumi a debito.
Non sono stati poi presi nella giusta considerazione l’urgenza di intervenire e i criteri da seguire per sgonfiare il debito prodotto. Non è stato quindi previsto il crollo di fiducia che ha condotto al ridimensionamento dei valori delle Borse e alla crisi del debito.
A questo punto le soluzioni non sono più tante.
Per ridurre il debito totale – pubblico, delle banche, delle imprese, delle famiglie – e riportarlo ai livelli precedenti alla crisi, cioè a circa il 40 per cento in meno, è immaginabile, ma non raccomandabile, cancellarne una parte con una specie di concordato preventivo in base al quale i creditori vengano pagati al 60 per cento.
È pensabile, ma si tratta di un’ipotesi senza prospettive, inventare qualche nuova bolla per compensare il debito con una crescita di valori mobiliari o immobiliari.
È valutabile – ma speriamo sia solo una tentazione – una tassazione della ricchezza delle famiglie, sacrificando però una risorsa necessaria allo sviluppo e producendo allo stesso tempo un’ingiustizia.
Si può anche ricercare una via di sviluppo rapido, grazie a una crescita di competitività, che nella crisi globale non è però facile generare. Non ci sono capitali da investire, le banche sono deboli, il problema demografico penalizza la domanda e gli investimenti. In questo contesto, inoltre, i consumi a debito non sono nemmeno immaginabili.
I paesi occidentali sono costosi e per renderli economici in tempo breve si dovrebbe intervenire sul costo del lavoro. Interventi di stampo protezionistico per sostenere le imprese non competitive produrrebbero però svantaggi per i consumatori e ridurrebbero i consumi già in declino.
Si potrebbe svalutare la moneta unica, ma questa iniziativa condurrebbe all’aumento dei prezzi di beni importati.
Qualcuno, per sgonfiare il debito, pensa anche all’inflazione. Ma l’inflazione non si accende se la crescita economica è pari a zero, se i salari sono fermi, se incombe l’ombra della disoccupazione e se diminuiscono persino i prezzi delle materie prime.
Si potrà affermare che la spirale inflazionistica non si avvia finché c’è sfiducia nella propria moneta. La questione è che oggi non ci si può fidare di nessuna valuta: tutte, compresi euro e dollaro, sono deboli.
L’inflazione non parte anche perché la liquidità non circola, ma soprattutto perché quella creata dalle banche centrali ha sostituito quella prodotta dai sistemi bancari per sostenere la crescita a debito.
Il primo problema oggi non è quindi l’inflazione ma la deflazione. I mercati stanno infatti privilegiando la liquidità. Questo perché in regime deflazionistico il valore della moneta cresce, mentre durante l’inflazione decresce.
Far progredire l’economia oggi senza aumentare il debito pubblico significa correlare i tassi di interesse al PIL. Nei paesi con un debito pubblico superiore al 100 per cento del PIL, è evidente che, per ottenere una crescita dell’1 per cento senza fare aumentare il debito, bisogna avere tassi non superiori all’1 per cento, penalizzando in questo modo i risparmi.
La soluzione è in mano ai governi e alle banche centrali che devono realizzare un’azione strategica coordinata di reindustrializzazione, rafforzamento degli istituti di credito e sostegno dell’occupazione.
Questo richiederà tempo, un tempo di austerità nel quale ricostituire i fondamentali della crescita economica.
Ma soprattutto i governi devono ridare fiducia ai cittadini e ai mercati attraverso una “governance” adatta ai tempi, che, oltre a garantire adeguatezza tecnica, sia anche un modello di leadership. Cioè uno strumento per raggiungere l’obiettivo del bene comune.
__________
Tra i numerosi interventi di Ettore Gotti Tedeschi sul crollo della natalità come causa ultima dell’attuale crisi economica mondiale, ecco una sintesi dell’articolo da lui pubblicato l’estate scorsa su “Atlantide”, rivista della Fondazione per la sussidiarietà, dell’area di Comunione e liberazione:
> Riprendiamo a fare figli e l’economia ripartirà
Su “L’Osservatore Romano” del 27 agosto 2011 Gotti Tedeschi si è pronunciato con ancor più energia contro la tassazione dei patrimoni privati, sostenuta da politici, sindacalisti, economisti, imprenditori e uomini d’affari di diversi paesi, oltre che da numerosi esponenti cattolici:
> L’orizzonte di Noè, per una vera soluzione della crisi
Gotti Tedeschi è inoltre fermamente contrario a una tassazione delle transazioni finanziarie in un paese come l’Italia, nel quale il risparmio delle famiglie è molto elevato. A suo giudizio questo risparmio privato, invece che punito con nuove tasse, dovrebbe essere indirizzato, con garanzie da parte dello Stato, a finanziare le imprese medie e piccole che sono l’ossatura dell’economia produttiva italiana.
__________
Una netta stroncatura del documento del pontificio consiglio della giustizia e della pace è venuta anche da un economista laico italiano di grande autorevolezza, il professor Francesco Forte, successore all’Università di Torino sulla cattedra che fu del grande economista liberale Luigi Einaudi, governatore della Banca d’Italia e poi presidente della repubblica dal 1948 al 1955:
> Il professor Forte boccia il temino targato Bertone
In Francia un commento critico del documento è venuto dal professor Jean-Yves Naudet, dell’Université Paul Cézanne d’Aix-Marseille III, presidente dell’Associazione degli economisti cattolici:
> Un texte qui doit inviter à la réflexion
__________
Il documento del 24 ottobre 2011 del pontificio consiglio della giustizia e della pace:
E la presentazione che ne hanno fatto il cardinale Turkson, monsignor Toso e l’economista Becchetti:
> Conferenza stampa del 24 ottobre 2011
__________
L’enciclica “sociale” di Benedetto XVI:
__________

Dio sparse i semi della diversità
Dopo il diluvio e la scialuppa di salvataggio di Noè, l’umanità ricresce e si raccoglie nella valle di Scin’ar. Costruisce una montagna a forma di torre per abitare in cielo. Nelle illustrazioni dell’episodio si vede un’opera incompiuta, ma secondo la lettera della scrittura sacra l’edificio ha raggiunto il suo culmine. L’impresa di abitare il cielo non viene interrotta, è invece fallita. E il più fantastico edificio mai concepito da una storia, degno perciò di un grandioso insuccesso. La divinità interviene dopo l’ultima pietra. Sulle labbra dei costruttori spiccano a zampillo le innumerevoli lingue del mondo, napoletano compreso. Non è un castigo ma un dono. L’umanità, fornita di un solo indirizzo e di una sola lingua, si era ridotta alla concordia di un termitaio, di un alveare. Il fervore dell’ opera aveva cancellato le scelte e le diversità. Erano diventati maestranze di una sola impresa.
La divinità con la consegna delle lingue restituisce la varietà, il viaggio, l’arbitrio. Babele è la parola che riassume il balbettio frenetico di una lingua sbriciolata in mille altre nuove. Così la divinità disperde la specie umana «sopra i volti di tutta la terra». Il progetto è chiaro: la sparge a seme dai ghiacciai ai deserti per farla attecchire ovunque, inestirpabile. Si allontanarono dall’ombelico di una valle, si moltiplicarono i suoi centri. Il dono delle lingue non servì solo a disperdere ma pure a attecchire. I nostri emigranti impararono le parole delle patrie seconde per radicarsi in fretta nella terra nuova. Sovrapposero ai loro affettuosi dialetti i vocabolari delle nazioni, generose con loro più della patria matrigna che non li riconosceva per figli. Scrive Garcìa Màrquez in Cent’anni di solitudine: «Non si è di nessun posto finché non si ha un morto sottoterra». Penso diversamente che non si è di nessun posto finché non se ne cantano le canzoni, finché non si è invitati a ballare a una festa di nozze.
Ho imparato a scuola il latino e il greco. Ho poi aggiunto per mio conto altre grammatiche, alfabeti.
Quando inizio una nuova lingua mi sembra di piantare un albero dal seme. Lentamente affiora dal silenzio, come da sottoterra e avvia la sua lenta crescita. A volte non arriva a farsi albero e resta cespuglio. Mezza vita fa ascoltavo e parlavo kiswahili in un villaggio della Tanzania, di sera sotto un gran mandorlo indiano. Come allora mi accorgo che una lingua è un albero e pronunciarla è stare nel campo della sua ombra.
in “Corriere della Sera” del 10 novembre 2011
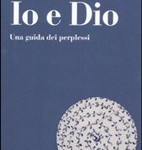
in dialogo con Vito Mancuso
Continuo la riflessione avviata nel numero scorso sull’ultimo libro di Vito Mancuso (Io e Dio. Una guida dei perplessi, Garzanti, 2011). Un secondo problema sul quale mi soffermo, dopo aver esaminato quello della relazione comunitaria (Noi e Dio), riguarda il carattere personale di Dio. A proposito dell’esistenza di Dio e della sua dimostrazione Mancuso si diffonde ampiamente con lo sviluppo di varie argomentazioni. Le sue posizioni sono molto chiare. Egli sostiene che la ragione può dimostrare l’esistenza di un essere o un bene assoluto ma non il suo carattere personale. Alla scoperta di un Dio personale, egli sostiene, si può pervenire solo con argomenti sviluppati all’interno dell’esperienza di fede (in particolare, ma non solo, cristiana), argomenti quindi validi solo per i credenti. Esaminiamo brevemente il significato e le motivazioni di queste posizioni. esiste un Assoluto Mancuso più volte ripete che non vi devono essere dubbi sull’esistenza di un Essere, di un Bene, di una Vita assoluti. È innegabile che esista «l’essere-energia… dentro la quale tutti siamo venuti all’esistenza, verso la quale tutti camminiamo e nella quale tutti con la morte saremo assorbiti. Siamo emersi dall’essere-energia come da una sorgente… e in questa stessa sorgente, alla fine pensabile come porto, ritorneremo quando la nostra libertà non esisterà più. Questo è un semplice dato di fatto…» (pp. 108-109). «Se poniamo Assoluto=Essere, è evidente che l’Assoluto esiste» (p. 109). Riflettendo in questo modo, però, arriviamo «solo a ciò che comunemente viene detto Essere o anche Totalità, Assoluto, Uno, Tutto» (p. 109). «Se si intende questo, è chiaro che Dio esiste, è evidente che c’è. È il Dio di Spinoza su cui si struttura tutta la sua Ethica…» (ib.). Lo ripete poco dopo: «È chiaro che il bene, nel senso di bonum, esiste… Ciò di cui posso conoscere l’esistenza riflettendo seriamente con la mia ragione è quanto Pascal chiamava Dio dei filosofi e si potrebbe chiamare anche Assoluto, Sommo Bene, Uno, Tutto. È la cifra di molte altre speculazioni» (p. 110). Si deve notare che anche se «evidente» o «un dato di fatto», tuttavia non è detto che questa Realtà suprema sia affermata da tutti, perché, in ogni caso, l’acquisizione e la conseguente affermazione è risultato di esperienze vissute con consapevolezza, è un’interpretazione razionale della vita, che consente di vivere in pienezza, ma che, come tale, potrebbe anche non essere raggiunta. Mancuso qualifica questa esperienza come spirituale e la collega alle «altre forme mediante cui è giunta a espressione la dimensione spirituale, come la pittura, la scultura, la danza, il teatro, la poesia, la musica» (p. 114). Sono «invenzioni umane» «ma l’orizzonte dischiuso da queste discipline inventate dagli uomini non è necessariamente falso. Lo è per chi non ha idea di che cosa vi sia in gioco, per chi non sente queste dimensioni dell’essere ritenendole solo un bizzarro passatempo o un proficuo investimento. Ma per chi vive per esse, a volte per esse soffre la fame, e vi dedica tutta la vita, non esiste nulla di più reale e concreto. Si tratta di invenzioni, sì, ma nel senso etimologico del termine» (p. 114), cioè di scoperte della realtà profonda della vita. «Inventare [infatti] nella sua radice latina (invenire) significa ‘imbattersi in qualcosa, trovare, scoprire’. L’invenzione è anzitutto scoperta» (p. 115). Come accade a molti cultori della scienza che hanno scoperto energie e leggi della natura prima ignote e non utilizzate, così nel mondo dello spirito umano esistono possibilità di «invenzioni». Per esemplificare Mancuso richiama il fascino della bellezza. «Chiunque abbia avuto una reale esperienza estetica sa che si è trattato al contempo di qualcosa di estatico, qualcosa che l’ha fatto uscire da sé verso una dimensione più grande, preesistente, rispetto alla quale tuttavia non si è sentito estraneo ma coappartenente» (p.115). Ciò vale per tutte le esperienze ‘spirituali’: «quando si esce da sé senza tuttavia perdersi, ma ritrovandosi a un livello più alto»; vale, ad esempio, per «l’emozione purissima che una poesia, un quadro, una musica, una preghiera, una carezza fa sorgere dentro di noi». Mancuso si chiede: «come nominare questa dimensione più grande alla quale tuttavia si sente di appartenere: regno della suprema bellezza, dell’armonia compiuta, della pace del cuore, della luce buona dell’essere?» (p. 115). Risponde: «il complesso di termini quali ‘Dio, divino, divinità’ racchiude i simboli più efficaci ‘inventati’ dalla mente umana per nominare questa realtà avvolgente, materna e paterna, che si dischiude alla mente e al cuore in alcune peculiari esperienze vitali… Tali immagini cercano di portare al pensiero… una realtà che c’è da sempre» attraverso di esse «lo spirito… attinge il profondo dell’uomo» (pp. 115-116). È vero quindi che Dio è «invenzione» umana «per quanto attiene al concetto, ma questo non implica che la realtà cui rimanda il termine Dio sia falsa» (p.114), anzi la concretezza dell’esperienza induce la certezza della sua esistenza. Il Bene, la Vita, la Verità, la Bellezza esistono in forma piena e si esprimono in modo parziale e frammentario in noi. il carattere personale di Dio è dato di fede Mancuso però nega che questa realtà assoluta a cui si perviene riflettendo sulle varie esperienze umane, possa già essere scoperta come «persona», dotata, cioè, di conoscenza e di amore. La realtà divina a cui si perviene riflettendo sulla forza che sostiene il processo vitale è impersonale, è la «potenza neutra dell’essere-energia» (p. 108): «Così arrivo non a Deus, ma arrivo a Deum» (p. 109), a quello che S. Anselmo designava come «ciò di cui non si può pensare uno più grande». L’assoluto a cui si perviene con la riflessione di ragione «questo bonum impersonale non sarà conoscibile con certezza razionale come bonus, come Dio personale» (p. 110). Se quindi «si intende dire che sopra questa totalità onnicomprensiva dell’essere-energia, o al di fuori di questa totalità, o dentro di essa in una dimensione più profonda, o chissà dove altro ancora, vi sia un essere personale a cui potersi rivolgere dicendo Abbà-Padre, allora non è più evidente, non lo è per nulla, che tale Deus esista» (p.109). La realtà a cui si perviene non è «il tenero Abbà-Padre di Gesù. Di questo non si potrà mai conoscere razionalmente l’esistenza. Con buona pace del dogma cattolico» (p. 110). Mancuso nega quindi che a questo stadio il divino possa essere termine di una relazione personale, possa essere invocato, benedetto, lodato, adorato. Il Dio personale, come quello della tradizione ebraico-cristiana, lo si conosce solo per la rivelazione e lo si incontra solo nell’esercizio della fede. Senza questa esperienza personale non si può affermare l’esistenza del Dio credo per la testimonianza di Gesù. Egli conclude: «Sto dicendo, in un certo senso, che Dio esiste solo per chi lo fa esistere. Chi lo fa esistere avrà trovato ponte tra la sua fame e sete di giustizia e il senso ultimo del mondo: verus pontifex maximus» (p. 428). Potrebbe suscitare confusione il fatto che il carattere personale di Dio sia difeso con chiarezza da Mancuso e sia argomentato con lo stesso tipo di ragionamento con il quale egli afferma l’esistenza ‘evidente’ di un Assoluto. Scrive infatti: «la mia fede in Dio si determina come fede in un Dio certamente personale, dato che, in quanto principio di tutte le cose, Dio è anche al principio della personalità che quindi non deve e non può essere esclusa dal suo essere» (p. 79). Per questo aspetto Mancuso riassume la sua posizione con le parole di Immanuel Kant: «Anche se vi vedrete costretti a desistere dal linguaggio del sapere, vi sarà sufficiente un linguaggio, che pur vi resta, di una salda fede, giustificato dalla più rigorosa ragione» (Critica della Ragion pura, (1781) citata a p. 108). Egli ricorda anche che lo stesso filosofo nella prefazione alla seconda edizione della sua famosa opera scriveva: «Ho dunque dovuto sospendere il sapere per far posto alla fede» (ib. (1787) citato a p. 114). Come si vede si tratta di un «linguaggio della salda fede»; esso si svolge però sorretto da una «rigorosa ragione» e segue le regole dell’argomentazione logica. L’esperienza di fede inizia e si sviluppa per dinamiche di testimonianza che precedono la ragione, anche se la coinvolgono nel suo sviluppo e nell’analisi del suo fondamento. L’esercizio della fede non nasce per conclusione di ragionamenti, ma la ragione entra in azione quando il credente cerca la motivazione delle sue scelte e intende spiegarne il fondamento. Si dovrebbe forse aggiungere che anche chi non vive la fede, può già partire dalla consapevolezza della propria tensione vitale e dall’esercizio del proprio amore per argomentare che il Tutto che l’avvolge e lo sostiene è un Tu che, conoscendolo e amandolo, può condurre là dove la vita tende come a compimento. Mi sembra che in fondo sia questa «la sfida che attende la teologia cristiana contemporanea» (p. 426). Solo alcuni dei molti stimoli preziosi che il libro del giovane teologo può offrire alla ricerca attuale di Dio. La sua diffusione può favorire tale ricerca da varie parti avvertita
in “Rocca” del 15 novembre 2011
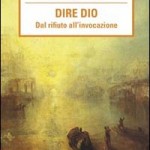
TRENTI Zelindo, Dire Dio. Dal rifiuto all’invocazione, Roma, Armando, 2011
“Dire Dio”, oggi, riguarda fortemente il credente, sia quello dotto e specializzato, sia quello di ordinaria cultura, ma desideroso di rendersi ragione di ciò che afferma con la sua fede.
Come il credente “colto” può dire Dio nel mondo culturale contemporaneo?
E’ una domanda che impegna l’autore da tanti anni, nelle sue ricerche, nel suo magistero come docente di Pedagogia Religiosa presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Salesiana di Roma, nelle sue pubblicazioni.
Il saggio, estremamente rigoroso, è condotto a partire da sollecitazioni di alcuni autori contemporanei particolarmente significativi. Costituisce un percorso carico di suggestioni per tutti i credenti, portando a scoprire, in alcuni filoni di pensiero, tracce e inviti ad un discorso, ad un linguaggio, a categorie espressive che consentano di “dire Dio”.
Non vuole tanto essere, secondo lo stile di Trenti, un discorso unilateralmente conclusivo, quanto piuttosto il suggerimento di una pluralità di linee di ricerca lungo le quali poter percorrere un cammino personale ma garantito dall’autorevolezza di pensatori che hanno inciso a fondo sulla filosofia contemporanea.
La provocazione al credente può venire da svariate affermazioni. Può essere quella più immediata e scontata del non credente che afferma: “Crediamo nella constatazione dei fenomeni naturali stabiliti dalla scienza, in quel che è verificato da studi storici e sociali, nell’opportunità di alcuni valori naturali ecc” (Savater 2007), o quella più sottile di Cavalcanti che “passò la vita a cercar se trovar si potesse che Dio non fusse” e che, in questo modo puntualizza la sfida dell’uomo di sempre contro una presenza sentita come soffocante rispetto all’aspirazione ad essere “assolutamente” se stesso, sciolto da qualsiasi legame. Aspirazione ripresa da Sartre: “l’uomo ritrovi se stesso e si persuada che nulla può salvarlo da se stesso, fosse pure una prova valida dell’esistenza di Dio”.
Oltre che affermazione di merito, quella di Sartre è anche affermazione di metodo. Dio è fuori tema! Il tema è l’uomo!
Trenti, a questo punto, fa proprio l’interrogativo di Pascal: “Se l’uomo è fatto per Dio, perché così contrario a Dio; e se non è fatto per Dio, perché così infelice senza Dio?” (Pascal, 367).
La domanda su Dio attiene alla dimensione esistenziale, non è una curiosità intellettuale o, meno ancora, argomento di conversazione salottiera o da talk show televisivo.
L’intento dell’autore non è né polemico né apologetico. Gli interessa esplorare il pensiero contemporaneo, perché esso costituisce l’ambito del nostro pensare, del nostro parlare, del nostro comunicare.
Il punto di partenza del saggio può essere considerato: il credente di fronte al mistero.
Una prima presa di distanza: il mistero non viene rifiutato nell’illuministica prospettiva di essere identificato con la tenebra che verrà dissipata dalla luce progressivamente penetrante della ragione.
Al contrario, il mistero, proprio perché non è commisurato all’uomo, costituisce una provocazione esistenziale per lui.
La filosofia, dal canto suo, con esiti diversi, continua a tematizzare Dio. Il credente tenacemente ne riafferma la presenza nella sua vita. Sono dati di fatto.
Il credente sente che non basta il percorso storico di un umanesimo radicale, ma non basta neppure una via esclusivamente razionale per radicare la fede.
Il pensiero contemporaneo sembra privilegiare altre vie, che l’autore propone di esplorare.
Il primo approccio è col pensiero di Heidegger. L’analisi del suo pensiero viene condotta su un’opera della maturità dell’autore: i due volumi su Nietzsche.
Nietzsche ha affermato: “Dio è morto”; Heidegger afferma perentoriamente che ciò è dovuto al fatto che la cultura occidentale ha perso il contatto col suo fondamento, l’essere.
La metafisica ha spostato la sua ricerca sull’ente che è diventato il suo interrogativo conduttore (Leitfrage) e ha omesso l’interrogativo di fondo (Grundfrage).
Da questa asserzione fondamentale, si deduce, secondo Trenti, che la cultura occidentale ha smarrito la traccia di Dio.
Approfondendo questa nuova prospettiva, l’analisi portata sugli enti scopre in essi la traccia dell’essere, i segni della sua presenza. Una presenza che non ha altra via per manifestarsi che l’ente. Addirittura, l’essere, mentre ne promuove la manifestazione, si sottrae e si rende inafferrabile.
Il pensiero di Heidegger intende restituire alla realtà fondante, l’essere, la piena iniziativa; ne fa il riferimento ultimo e definitivo, che fonda l’esistenza dell’uomo, al quale è affidato il compito di interpretare e rivelare l’essere stesso.
L’essere, fondante e nascosto, è alla base. In questa realtà reale e nascondentesi va collocata la ricerca sulla condizione di mistero che avvolge l’uomo e sul significato esistenziale che ha per lui.
L’essere non è il risultato del pensiero dell’uomo. Ma l’uomo è prodotto dell’essere e, attraverso il linguaggio, è in grado di stabilire una relazione con l’essere.
L’essere, d’altro canto, si può manifestare solo attraverso gli enti.
Heidegger intende restituire alla realtà fondante, l’essere, la piena iniziativa; ne fa il riferimento ultimo e definitivo, che spiega anche l’esistenza dell’uomo, al quale affida il compito di interpretare, rivelare, l’essere stesso nel suo operare.
Heidegger vuole sottolineare che la rivelazione è iniziativa dell’essere e tuttavia l’uomo vi conserva una parte risolutiva: si trova in questo stretto crinale che vede emergere la realtà dall’iniziativa dell’essere, che però sottrae se stesso ad ogni manifestazione.
L’uomo, per Heidegger, è caratterizzato dal linguaggio. Il linguaggio diventa la modalità del suo rapportarsi all’essere.
Heidegger trova che è il linguaggio poetico quello che consente all’uomo questo approccio.
Il linguaggio poetico è essenzialmente evocativo; è in grado di lasciar trasparire e presagire una realtà che fonda le cose e contemporaneamente le trascende.
Ma la prospettiva può essere contemporaneamente rovesciata: il linguaggio come evento dell’essere aperto all’esistenza umana. L’uomo è custode di questa emergenza dell’essere.
Il linguaggio poetico è, a sua volta, evento che lascia trapelare la verità delle cose e manifesta la presenza dell’essere.
Il pensiero di Heidegger è alimentato dalla riflessione nihilista nietzchiana e ne condivide il sentimento di precarietà. In questa condizione di indigenza radicale si situa il ricorso al fondamento. E’ immediatamente percepibile la fecondità di questa intuizione per la ricerca delle condizioni del “dire Dio”.
Per Heidegger, l’uomo sosta come in un’attesa trepida e vigilante d’una rivelazione, che albeggia sempre senza mai illuminarsi.
Si nota che nella parte del saggio dedicata al confronto con Heidegger compaiono riferimenti alla interpretazione di Vattimo, che pure risulta suggestiva per discorso avviato da Trenti.
Insistiamo: Trenti non pretende di battezzare Heidegger; rileva che la sua grande incidenza sulla filosofia contemporanea non esclude, ma consente uno spazio per pensare il mistero e per cogliere un’allusione alla fede religiosa in Dio.
Un’altra suggestione di decisiva rilevanza deriva dalla riflessione ermeneutica, della quale Heidegger è stato maestro.
Trenti introduce a questa dimensione mettendo in evidenza come la sensibilità culturale contemporanea è centrata sull’uomo: da lui parte e a lui ritorna.
Il problema della verità non è più un itinerario della ragione astratta; è un compito di una ragione esistenzialmente impegnata.
Il problema uomo diventa riferimento centrale per ogni ulteriore analisi, compresa quella definitiva sull’essere e sulla verità.
E’ l’uomo che costituisce la domanda e che costruisce il percorso conoscitivo.
La ricerca della verità passa per il filtro dell’esistenza personale. A questo proposito, Trenti fa esplicito riferimento a Kierkegaard.
Il problema del dire Dio si distacca dal procedimento della razionalità funzionale proprio della scienza per assumere la dimensione esistenziale: Dio per l’uomo. Trenti valorizza, in questo contesto, la riflessione antropologica di Scheler. Dio è affermato perché compimento definitivo dell’uomo.
Altro aspetto rilevante è lo spostamento, accentuato dal contributo del pensiero di Martin Buber, dalla centratura sull’individuo a quella sulla relazione interpersonale.
Nel rapporto io-tu, nota Buber, si va con la totalità dell’esistenza. L’esigenza che si impone nel rapporto interpersonale diventa traccia nella ricerca del Tu assoluto.
Dall’insieme delle suggestioni, l’autore afferma che il tema della trascendenza resta da impostare in maniera esistenziale, sia come dato connaturale e costitutivo del vivere umano, sia come insito nell’esistenza ed emergente come presagio.
Si impone l’analisi di “ciò che sono e dei richiami interiori da cui sono attraversato”. Non sono le vie razionali della tradizione quanto piuttosto la coscienza di quanto si vive che porta il richiamo di Dio e consente di affermarlo.
E’ all’interno dell’analisi del mistero che la sua presenza può proporsi, nella libertà di accoglierlo o di negarlo.
Ritornando al processo ermeneutico, si rileva che esso si situa dentro una concezione del linguaggio nuova rispetto a quella tradizionale.
Il linguaggio, più che uno strumento, diventa la condizione del pensare la realtà e del nominarne ciascuna entità, ancora, del comunicare la conoscenza e della partecipazione.
L’uomo è responsabile dell’interpretazione.
Questa istanza fa autorevole riferimento oltre che ad Heidegger anche a Gadamer e a Ricoeur.
L’altra accentuazione, collegata a questa linea di riflessione, è quella legata all’oggetto, l’andare alle cose.
La prospettiva ermeneutica conduce su una traccia feconda. Emerge l’affermazione di una realtà oggettiva che precede l’uomo, ma emerge con altrettanta forza la presenza di una soggettività che tenacemente vuole progettare se stessa. E’ questo il risultato di una ricerca che pone al centro l’esperienza esistenziale umana.
La problematica esistenziale rileva da sempre il dato della finitudine dell’esperienza umana e dell’inappagamento delle sue aspirazioni.
Sulla base di queste considerazioni si può affermare che la trascendenza è chiamata in causa perché l’esistenza non sembra in grado di dare ragione di se stessa. Il richiamo al mistero sembra essere la via, anche se non dicibile in termini empirici.
Trenti dedica una parte consistente del saggio ad una trattazione del processo ermeneutico, dall’esperienza problematizzante del credente al confronto con i testi della tradizione credente. Il riferimento privilegiato è all’elaborazione di Ricoeur e di Gadamer.
Per quanto riguarda le modalità del linguaggio religioso, dopo aver accennato al mito e al rito, l’attenzione viene posta sul simbolo che costituisce una modalità espressiva più interiore e penetrante di dire il divino. Segue un’ampia analisi della simbologia prevalentemente biblica.
Tornando sulla constatazione della finitudine e dell’insoddisfazione, si apre per il credente la strada dell’invocazione di una trascendenza. E’ un procedimento che non risulta tanto come frutto di un ragionamento astratto dalle vicende esistenziali, quanto da un’autocomprensione che coinvolge interamente la concreta esistenza.
Per il credente la trascendenza diventa incontro con la realtà religiosa: dalla certezza e fiducia conferita alla realtà sensibile (Savater) si passa alla certezza e fiducia conferita alla realtà trascendente (credo in Dio). Questa asserzione non implica che l’uomo religioso non apprezzi la realtà nella quale è immerso. Ha una ragione diversa per apprezzarla: la realtà sperimentabile empiricamente diventa segno e richiamo della realtà definitiva.
Per l’approfondimento antropologico e fenomenologico dell’atto di fede viene fatto ricorso al contributo di Max Scheler, che viene ampiamente esposto e analizzato.
Successivamente si passa alla valorizzazione del contributo derivante dal pensiero di Martin Buber, nella sua peculiare prospettiva dialogica. Per Buber la persona umana è costitutivamente in relazione.
La relazione è costitutiva, a partire dall’aria che respiriamo, dal terreno che calpestiamo.
La vita umana non esiste che nella relazione.
La partecipazione, avvertita o inconsapevole, intesse l’esistenza.
La relazione o è piena o non è autenticamente relazione. Un rapporto autentico instaurato con le cose e soprattutto con l’altro può sottendere la relazione costitutiva con la trascendenza; e di conseguenza un richiamo decisivo della verità di un rapporto fondante, che Dio solo compie; si tratta di avvertire tale apertura alla trascendenza come costitutiva e originaria, propria della persona.
Col passaggio al contributo del pensiero di Gabriel Marcel si giunge a tematizzare l’invocazione, terminus ad quem del saggio.
Marcel, impegnato in un’analisi dell’esistenza nella concretezza della situazione reale, si rende attento soprattutto al richiamo trascendente che la attraversa. Le sue indagini tendono a dare volto e linguaggio al presagio interiore, ad indagare il mistero in cui l’esistenza risulta immersa. Nel contesto attuale può offrire una lucida testimonianza di come un credente viva la propria esperienza di fede e di quale apporto la fede possa dare per decifrare l’esistenza in tutto il suo laborioso processo di interpretazione.
Per Marcel dire Dio è legittimo dove l’esistenza, esplorata nelle sue pieghe segrete, ne presagisce e ne esige la presenza: anzi dove questa presenza si impone per conferire autenticità e tenuta all’esperienza.
La sua ricerca è piegata dunque sull’esistenza concreta. Molte delle analisi che propone sottendono una tenace esigenza di definitiva razionalità e di senso: perciò Dio è chiamato in causa.
Marcel non è un sistematico. Anzi spesso si è dichiarato apertamente estraneo all’esigenza di sistematicità. Il suo è un percorso sollecitato da situazioni concrete con cui è chiamato a fare i conti e sulle quali riflette da pensatore e da credente, senza troppo preoccuparsi di definire lo spazio che compete al pensatore e l’attesa che attraversa il credente.
Il primo tema esperienziale preso in considerazione è quello della fedeltà. Essa presuppone un impegno di vita che va al di là della contingenza di una promessa datata. Marcel individua nel riferimento ulteriore e ultimo a Dio il fondamento di una fedeltà che sia per sempre.
Affermare il principio della fedeltà all’istante significa trascendere l’istante.
La ricerca di Marcel è segnata da una scelta fondamentale. Riconosce che alla base della propria riflessione vi è sempre stata un’opzione per l’essere.
Una fedeltà autentica metta in gioco la persona ma contemporaneamente si fonda necessariamente sull’essere. Stringe, per così dire, l’uomo all’essere in un medesimo destino. Risulta caratterizzata “da un’intima comunione fra il personale e l’ontologico”. Ma proprio questa relazionalità mette in gioco essere e persona e li coinvolge in un medesimo processo; trasforma il senso della ricerca.
Non si tratta di trovare soluzione ad un problema, quanto di percepirsi immersi in un mistero che ci supera. Cosicché non si tratta tanto di argomentare per provare, quanto di esplorare per far luce e prendere consapevolezza di una situazione che si vive.
In sintesi pregnante: “I misteri non sono verità che ci trascendono, bensì verità che ci comprendono”. I misteri attraversano e alimentano la vita dell’uomo, testimone d’un’ansia che lo scuote, eppure fiducioso in un’arcana presenza che lo rasserena.
Marcel, in una situazione di precarietà storica ed esistenziale, quale quella determinata dalla II Guerra Mondiale, si trova di fronte ad una duplice alternativa: considerare se stesso (l’uomo) come l’assoluto oppure cercare l’assoluto in un altro diverso da sé:
Marcel si pone sulla seconda opzione. Ma questo altro assoluto non è concepito come esteriore rispetto al sé. Dio non è concepito in termini di causalità, sentito come estraneo all’uomo, come forza che gli si sovrappone. Unità e totalità si salvano solo in termini di interpersonalità, in ultima analisi in un rapporto di amore. Dunque complementarietà e reciproca compenetrazione.
La creazione è per la persona una proposta e un compito. E’ il margine riservato alla persona in faccia alla totalità.
In sintesi, tre affermazioni emergono da queste intuizioni
La vita dell’uomo è dono d’amore da parte di Dio.
L’uomo è costituito libero.
Può rifiutare oppure può rivolgersi a Dio attraverso l’invocazione.
Trenti dedica una parte notevole del saggio all’analisi puntuale del pensiero di Marcel, nel quale sembra riporre la sostanza della sua proposta, che può essere così evidenziata.
L’affermazione della trascendenza è, prima di tutto, sofferta consapevolezza di precarietà e di insufficienza, presentimento di arcana presenza, gesto spontaneo di adorazione. Si tratta di un’esperienza personalissima, incomparabile, in un certo senso incomunicabile.
Trenti conclude il suo saggio cercando, alla luce degli spazi di espressione consentiti dagli autori considerati, di proporre quale può essere un atteggiamento credente nell’ambito culturale e nel linguaggio attuali.
La proposta condotta esplicitamente sul terreno filosofico chiama in causa la teologia per una nuova formulazione della sua indagine scientifica credente, sia dal punto di vista metodologico che da quello contenutistico.
Parimenti è chiamata in causa la pedagogia per una mediazione proponibile nella concreta condizione educativa e didattica attuali.
Lucillo Maurizio
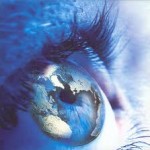
Tutti vorrebbero conoscere il futuro dell’ umanità. È più di una semplice curiosità o di un sfizio dell’ immaginazione. Si tratta di un bisogno arcano, da sempre nascosto nel profondo delle aspirazioni di ciascuno. Gli strumenti statistici e le analisi della società, tuttavia, riescono oggi, malgrado l’ invalicabilità del limite, a dirci qualcosa su come sarà probabilmente il mondo di domani. O, almeno, come potrebbe presentarsi la condizione di vita sulla Terra, se i parametri attuali rimanessero costanti. Cosa evidentemente insicura. È questo l’ argomento dell’ importante rapporto di quest’ anno del Fondo dell’ Onu per la popolazione. Il quadro che emerge sul futuro dell’ umanità appare veramente molto interessante. Intanto si conferma un dato del presente che riguarda il censimento complessivo. Dal 31 ottobre il nostro pianeta ha 7 miliardi di abitanti, un miliardo in più rispetto a 12 anni fa e 6 rispetto all’ Ottocento. Fin qui abbiamo a che fare non con le previsioni ma con una constatazione di base. L’ aumento demografico si consolida. Tanto che, se i tassi di crescita resteranno gli attuali, gli inquilini della Terra toccheranno nel 2100 la quota di 15 miliardi. Ma sappiamo anche che la tendenza attuale – come è già avvenuto prima – decrescerà nel futuro. Una prima riflessione s’ impone e riguarda la distribuzione degli incrementi che coinvolgono l’ emisfero nord in modo sensibilmente inferiore rispetto a quello centrale e meridionale. Nell’ Europa Occidentale ci sono oggi 170 abitanti per chilometro quadro. Nell’ Africa subsahariana 70. Maa nessuno viene in mente di affermare che in Europa ci sono troppe persone. Le ragioni macrodemografiche sono ovviamente complesse, coinvolgendo sia gli atteggiamenti economici che le identità culturali. In ogni caso il ritmo di aumento delle natalità, con il concorso effettivo della vita media, connesso con l’ invecchiamento occidentale, contribuirà di sicuro ad una forma di mescolamento migratorio inevitabile. Il documento delle Nazioni Unite, tuttavia, guarda soprattutto alle probabili modalità di configurazione dell’ ordine sociale dell’ avvenire. Si è registrato una costante intensificazione della mobilità, non soltanto da Paese a Paese, ma anche tra i diversi continenti. E, cosa abbastanza significativa, un processo di urbanizzazione crescente che si realizzerà in modo massiccio nei prossimi 40 anni. Qui si indica già un campo su cui attivare politiche adeguate, viste le tendenze all’ accentramento di popolazione di vasta scala nelle città. D’ altronde, il ruolo politico delle grandi metropoli sta diventando sempre più consapevolmente un perno del processo d’ integrazione democratica. Qui s’ incontrano demografia e cultura democratica. Il rapporto dà, però, in modo esplicito alcune indicazioni chiare sui giovani, cui è riconosciuto un potenziale enorme a causa del fatto che la metà della popolazione mondiale sarà composta da persone con meno di cinquant’ anni. Poiché l’ 80% proverrà da continenti in via di sviluppo, puntare su istruzione, salute e occupazione è interesse unanime. Stesso discorso anche per la condizione femminile che appare addirittura, tra le righe del resoconto, un elemento chiave per il bene comune dell’ umanità. L’ emancipazione del genere femminile, in costante accentuazione, garantirà insieme all’ acquisizione di un ruolo e di un’ identità specifica delle donne, un protagonismo fondamentale nell’ educazione delle successive generazioni. Due osservazioni di straordinaria rilevanza devono essere accompagnate a questi fatti. In primo luogo la constatazione, valida a livello globale, che non è possibile uno sviluppo complessivo dell’ umanità senza che le dinamiche spontanee siano supportate da interventi precisi e razionali che garantiscano equità nell’ accesso alle risorse. Questo primo punto è imprescindibile per scongiurare catastrofi umanitarie ed esiti negativi in termini di miseria e di impossibile sopravvivenza, specialmente nei Paesi cerniera che hanno rapidamente accesso a tassi di crescita significativi. In secondo luogo, come emerge con chiarezza nelle conclusioni del rapporto, è insensato lavorare su progetti neo-malthusiani di controllo e limitazione delle nascite perché le crisi non verranno certo dall’ aumento della popolazione, ma dalle diseguaglianze culturali, ambientali ed economiche che possono insinuarsi. Per adesso, anzi, è una costante la crescita economica legata alla crescita demografica. Investire in politiche sociali, senza più territori determinati e chiusi, significa trasferire inevitabilmente a livello planetario l’ applicazione di certe prerogative etiche un tempo affidate agli Stati nazionali. Intervenire laddove gli sprechi sono estenuanti, pianificare un controllo degli investimenti, vuol dire garantire un’ espansione dell’ umanità in un mondo vivibile tendenzialmente e senza problemi da tutti. Appare, in tal senso, impossibile non guardare alla famiglia come soggetto sociale privilegiato nel permettere educazione, salute e formazione etica civilizzatrice della prole. Si deve riconoscere, insomma, che solo nel tessuto domestico si formano le categorie etiche fondamentali e si constata la pratica dell’ equa dignità tra i sessi, nonché la fiducia nel grado di umanizzazione che s’ intende diffondere a livello intergenerazionale. Dà comunque soddisfazione, per una volta, intravedere un quadro complessivo in cui non è la crescita di umanità ma la diminuzione d’ immoralità a minacciare il futuro. Un futuro, conviene precisare, che o è umano o non esiste. E per questo può pensarsi anche nel segno dell’ ottimismo.
Repubblica
02 novembre 2011

Tutte le analisi sull’attuale crisi economica indicano la necessità di «cambiare i nostri comportamenti e i nostri stili di vita. Tuttavia, sembra che a una simile lucidità non si accompagni una reale disponibilità al cambiamento. Anche quando pareva che vi fosse un consenso sulla necessità di un cambiamento di rotta, come nel caso della riforma del sistema pensionistico, sui termini delle modifiche da operare vi era poi un disaccordo tale che la sua realizzazione appariva frutto di una costrizione imposta piuttosto che un compromesso accettato in vista di un bene comune». Sembrano parole indirizzate al contesto italiano quel le a firma della Commissione famiglia e società dell’episcopato francese rese note lo scorso febbraio nel documento Crescere nella crisi. Esso, infatti, si rivolge a quel «malessere più generale » costituito dalla mancanza di «fiducia negli altri e nella collettività nazionale », che, assieme alla lucidità rispetto a un futuro incerto, generano «una grande angoscia, della quale la prossima generazione rischia di essere la prima vittima». Sullo stesso tema e con tonalità simili sono anche intervenuti i vescovi irlandesi (cf. in questo numero a p. 474).
J.-C. Descubes, Commissione famiglia e società Conferenza dei vescovi di Francia
Il testo dell’articolo è disponibile in formato pdf
![]() Visualizza il testo dell’articolo
Visualizza il testo dell’articolo
«Solidale con tutti coloro che soffro no a causa della crisi economica», il Consiglio per la giustizia e la pace della Conferenza episcopale irlandese ha pre sentato il 21 febbraio scorso una di chiarazione aggiungen do «la sua voce a tutte quelle che si levano per domandare un cambiamento positivo nella nostra società». L’attuale momento «di notevole inquietudine politico- finanziaria» vie ne analizzato – alla luce dell’en ci clica Caritas in veritate – con un’attenzione particolare ai «costi umani» di una crisi i cui effetti «sorprendenti e spaventosi» sono disoccupazione, insicurezza, «crollo del – la fiducia nelle istituzioni» e disperazione. Di fronte al fallimento di un modello economico e culturale, consapevoli che non si uscirà dalla crisi senza promuovere una «cultura della speranza», i membri del Consiglio offrono un’alternativa ispirata ai valori evangelici e alla dottrina sociale cristiana nella quale, tenendo conto «delle variabili presenti in ogni equazione politica: efficienza economica, libertà individuale, tutela dell’ambiente e giustizia sociale», an che «il principio di gratuità e la logica del dono» trovano spazio tra i criteri che possono e devono regolare l’attività economica.
Consiglio per la giustizia e la pace – Conferenza vescovi cattolici irlandesi
Il testo dell’articolo è disponibile in formato pdf
![]() Visualizza il testo dell’articolo
Visualizza il testo dell’articolo
Da consultare
Un nuovo modello di leaderschip
Ettore Gotti Tedeschi
Gli errori di interpretazione e la sottovalutazione dell’attuale crisi economica sono stati gravi e perdurano. Sono state male interpretate le sue vere origini, cioè il crollo della natalità, e le conseguenze che hanno portato all’aumento delle tasse sul pil per assorbire i costi dell’invecchiamento della popolazione. E sono stati sottovalutati gli effetti delle decisioni prese per compensare questi fenomeni, soprattutto con la delocalizzazione produttiva e con i consumi a debito.
Non sono stati poi presi nella giusta considerazione l’urgenza di intervenire e i criteri da seguire per sgonfiare il debito prodotto. Non è stato quindi previsto il crollo di fiducia che ha condotto al ridimensionamento dei valori delle Borse e alla crisi del debito.
A questo punto le soluzioni non sono più tante. Per ridurre il debito totale – pubblico, delle banche, delle imprese, delle famiglie – e riportarlo ai livelli precedenti alla crisi, cioè a circa il 40 per cento in meno, è immaginabile, ma non raccomandabile, cancellarne una parte con una specie di concordato preventivo in base al quale i creditori vengano pagati al 60 per cento. È pensabile, ma si tratta di un’ipotesi senza prospettive, inventare qualche nuova bolla per compensare il debito con una crescita di valori mobiliari o immobiliari. È valutabile – ma speriamo sia solo una tentazione – una tassazione della ricchezza delle famiglie, sacrificando però una risorsa necessaria allo sviluppo e producendo allo stesso tempo un’ingiustizia. Si può anche ricercare una via di sviluppo rapido, grazie a una crescita di competitività, che nella crisi globale non è però facile generare. Non ci sono capitali da investire, le banche sono deboli, il problema demografico penalizza la domanda e gli investimenti. In questo contesto, inoltre, i consumi a debito non sono nemmeno immaginabili.
I Paesi occidentali sono costosi e per renderli economici in tempo breve si dovrebbe intervenire sul costo del lavoro. Interventi di stampo protezionistico per sostenere le imprese non competitive produrrebbero però svantaggi per i consumatori e ridurrebbero i consumi già in declino. Si potrebbe svalutare la moneta unica, ma questa iniziativa condurrebbe all’aumento dei prezzi di beni importati.
Qualcuno, per sgonfiare il debito, pensa anche all’inflazione. Ma l’inflazione non si accende se la crescita economica è pari a zero, se i salari sono fermi, se incombe l’ombra della disoccupazione e se diminuiscono persino i prezzi delle materie prime.
Si potrà affermare che la spirale inflazionistica non si avvia finché non c’è sfiducia nella propria moneta. La questione è che oggi non ci si può fidare di nessuna valuta: tutte, compresi euro e dollaro, sono deboli. L’inflazione non parte anche perché la liquidità non circola, ma soprattutto perché quella creata dalle banche centrali ha sostituito quella prodotta dai sistemi bancari per sostenere la crescita a debito.
Il primo problema oggi non è quindi l’inflazione ma la deflazione. I mercati stanno infatti privilegiando la liquidità. Questo perché in regime deflazionistico il valore della moneta cresce, mentre durante l’inflazione decresce. Far progredire l’economia oggi senza aumentare il debito pubblico significa correlare i tassi di interesse al pil. Nei Paesi con un debito pubblico superiore al 100 per cento del pil, è evidente che, per ottenere una crescita dell’1 per cento senza fare aumentare il debito, bisogna avere tassi non superiori all’1 per cento, penalizzando in questo modo i risparmi.
La soluzione è in mano ai Governi e alle banche centrali che devono realizzare un’azione strategica coordinata di reindustrializzazione, rafforzamento degli istituti di credito e sostegno dell’occupazione. Questo richiederà tempo, un tempo di austerità nel quale ricostituire i fondamentali della crescita economica. Ma soprattutto i Governi devono ridare fiducia ai cittadini e ai mercati attraverso una governance adatta ai tempi, che, oltre a garantire adeguatezza tecnica, sia anche un modello di leadership. Cioè uno strumento per raggiungere l’obiettivo del bene comune.
(©L’Osservatore Romano 4 novembre 2011)
Paolo Sorbi
Avvenire 3 novembre 2011
I meccanismi liberistici senza regole non funzionano. Si è iniziata una riflessione sui temi della produzione e dell’economia riecheggiando tematiche “interventiste” degli stati nazionali pensando di ricopiare alcuni modelli keynesiani degli anni Trenta. Ma la natura della crisi globale non è assimilabile a quella della prima grande crisi del 1929. Gli attuali processi di stagnazione internazionale non sono l’assemblaggio delle singole crisi dei sistemi nazionali. Inoltre l’attuale crisi generale (non solo economica, ma anche culturale ed antropologica) inizia a bloccare le forti crescite economiche classiche che avevano visto per protagonisti gli stati ed i grandi territori del Brasile, della Russia, dell’India e della Cina. Contemporaneamente, negli ultimi due anni, dati Fao, il numero di coloro che sono affamati non solo non è diminuito, ma è accresciuto: addirittura del 25%.
Dai grattacieli di Manhattan, ai deserti dell’Africa centrale è tutto il ciclo della globalizzazione “soft” – cioè quella prima ed iniziale fase di globalizzazione della finanza e delle tecnologie che aspiravano ad una crescita senza contraddizioni – ad aver ceduto. Sono i “cicli lunghi”, studiati dall’economista, Kondratieff, delle conflittualità sociali e popolari, ad aver indotto ristrutturazioni ed innovazioni di portata internazionale. Gli esiti economici, all’inizio del terzo millennio, sono stati grandi mutamenti “hard” per il volto feroce che hanno assunto verso centinaia di milioni di nuovi poveri. Un altro “volano” che ritengo decisivo, è determinato dalle dinamiche-sociodemografiche su scala globale.
È stato il crollo della natalità in Usa, Europa e Giappone, ad essere uno dei vettori dell’attuale crisi internazionale di stagnazione dello sviluppo. Sono le ricerche del maggior economista-demografo contemporaneo Alfred Sauvy, a dimostrare che nell’Occidente della crescita zero, la mancanza di innovazioni è correlata al “grande inverno” dell’invecchiamento delle popolazioni. Quelle ricerche dimostrano che tra popolazione giovane, sviluppo economico ed innovazioni istituzionali c’è una forte correlazione. Colpisce la decelerazione economica, ancora poco studiata, della Cina. Cresciuta in anni di boom economico straordinario in modo impressionante, in recenti surveys della società “Oxford Economic” emergono dati preoccupanti di un deleveraging, vale a dire di una rapida ed improvvisa decrescita che potrebbe raggiungere uno stop netto verso il 2014.
Gli investimenti in Cina si fermano, perché crescono contemporaneamente i tassi bancari ed il costo del lavoro per l’estesa diffusione di lotte operaie e popolari. La catena delle forniture in Asia colpisce il motore profondo della crescita economica ininterrotta e si aprono problemi di recessione e disoccupazione anche in quei territori. L’estensione rapidissima di lotte sociali è emersa anche in tutta la realtà del colosso brasiliano. Conflittualità sempre più apportatrici di fiducia tra fasce sociali estremamente povere di quelle aree che, per la prima volta nella loro storia, si autoidentificano come lavoratori portatori di rivendicazioni e saperi culturali solidali. Quello che sta accadendo, durante questi recenti anni di crisi internazionale, non a sufficienza monitorato dalla ricerca sociale, è un grande mutamento di ciclo economico.
La globalizzazione reale ha voluto dire un processo di costruzione e di decentramento produttivo in una sorte di corrente tecnologica “nord-sud” del mondo. Ora invece quella corrente si rovescia verso una tendenza “sud-nord”. Nell’attuale crisi, innumerevoli realtà imprenditoriali multinazionali, sia americane che europee, cominciano a comprendere che non conviene più l’outsourcing produttivo in molte aree dei cosiddetti paesi in sviluppo.
Un recente studio del “McKinsey Quarterly”, fine del 2010, evidenzia che in Cina i salari sono cresciuti del 15% all’anno, dal 2000 al 2009. Nei prossimi anni di rallentamento, anche in Cina, i salari cresceranno, comunque, tra il 20 ed il 30% in più. Gli utili stanno diminuendo, perché i costi della produzione stanno rapidamente aumentando.
Ad esempio, Barack Obama, all’inizio di quest’anno, nel suo discorso sullo stato dell’Unione ha enfatizzato l’importanza del “rientro in patria” degli ordini manifatturieri e tecnologici. In Inghilterra la crescita delle piccole e medie imprese dei segmenti della meccanica e del tessile, dopo oltre tre decenni di declino, ha subito una rapida ripresa riportando quei segmenti produttivi, all’inizio degli anni Novanta. Insomma l’Occidente finanziarizzato ha in buona parte perduto i criteri dell’economia reale che non può essere un semplice mondo di servizi e consumi.
“Ritorno della produzione” in Occidente vuol dire, secondo recenti ricerche di team di sociologi industriali, tra cui Francesco Garibaldo, che bisogna mettere mano ad una riorganizzazione sul territorio anche del sindacato e dei suoi modelli di partecipazione e democrazia. È ovvio che le nuove produzioni saranno sempre di più finalizzate ai mutamenti ecosistemici, decisivi per aprire concretamente nuove strade di crescita, ma anche per aprire nuove strade a modelli sociali differenti ed, in parte, anche oltre le logiche del puro profitto capitalistico.
Non è il ritorno meccanico ad una tradizionale forza-lavoro industriale, ma è certamente una crescita di lavori collegata a queste nuovi materiali e nuove produzioni, a dinamiche di mobilità sostenibili, a dinamiche di manutenzione del territorio, a dinamiche anche di grandi opere, ma di certe opere, orientate alla conversione strutturale ed ecosistemica delle vecchie strutture capitalistiche che non possono produrre “nuova crescita”.
ATRI CONTRIBUTI