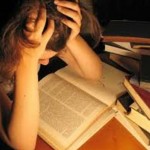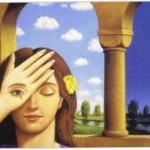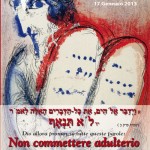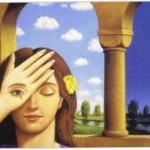
Il linguaggio su Dio è segnato naturalmente dalla sensibilità culturale del tempo. Molti sono i modi di dire Dio privilegiati nella tradizione. In ambito occidentale e cattolico è prevalso l’aspetto razionale. Specialmente il riferimento alla constatazione immediata della realtà sensibile – sensuconstat – è stato alla base di una rigorosa argomentazione – la prova – dell’esistenza di Dio.
L’orizzonte ermeneutico, che questi interventi privilegiano, sposta l’attenzione dalla dimostrazione razionale alla significatività esistenziale. A fondamento si questa impostazione sta un concetto di verità fortemente innovativo; tende a ripensare l’accesso stesso alla verità; a interpretarla in dimensione ermeneutica, come emergenza e manifestazione del reale.
In ambito religioso la stessa impostazione impone un’esplorazione attenta del vissuto credente. La riflessione tende cioè ad esplorare il rapporto con Dio in tutta la provocazione esistenziale che comporta: è meno preoccupata della fondazione razionale, del resto indispensabile, mostrandosi invece più sollecitata a misurare la novità appassionante di un rapporto che affiora nell’esistenza, la celebra e ne risulta a sua volta celebrato.
1.1. Il processo interpretativo nell’esperienza[1]
– Ho l’impressione che il mio orologio vada a rilento.
– Attendo che il campanile batta le ore e verifico.
– Sì, ritarda di alcuni minuti…
– Dovrò farlo regolare!
Ho constatato un piccolo disguido; ho preso coscienza che il mio orologio non funziona regolarmente. Ho deciso di farlo controllare. Un fatto semplicissimo, un’esperienza consueta che già consente di interpretare un processo normale in atto.
I casi sono di solito più complessi e coinvolgenti, magari rivelativi di situazioni drammatiche che incombono. Ancor più frequentemente si danno atteggiamenti esistenziali, banalizzati dalla consuetudine quotidiana. Prendiamo il caso della moglie che pensa al marito in termini di sicurezza economica: è colui che dispone di una somma notevole in banca o che al 27 del mese porta la busta… Può darsi che riflettendo con calma si renda conto di averlo ridotto ad una pura funzione materiale e sappia prendere coscienza che la sua presenza è fonte di sicurezza, ragione di dialogo, di comunicazione. Può anche darsi che la moglie arrivi finalmente a ricuperare il significato esistenziale pieno di lui come persona, scelta a compagno di vita, partecipe di un progetto magari ambizioso, che orienta l’esistenza reciproca. Questa donna va man mano scoprendo il significato autentico di una presenza che la routine rischia di semplificare eccessivamente. Può ricuperare la dimensione esistenzialmente appassionante di un rapporto umano restituito alla sua verità.
Questa ed altre possibili esemplificazioni tratte dalla consuetudine quotidiana lasciano affiorare l’impegno ad interpretare la vita concreta, le situazioni reali per quello che sottendono; orientano ad esplorare l’esperienza in tutto lo spessore che l’attraversa; consentono di avvertirne la risonanza esistenziale. Sollecitano una ricerca che tende a dare rilevanza autentica alla verità delle cose per tutto l’impatto che hanno sulla persona.
Rispetto alla riflessione tradizionale si è operato un cambiamento importante: la verità non è tanto adeguazione fra la cosa e la rappresentazione che la persona se ne fa; è piuttosto manifestazione, emergenza dello spessore che la situazione reale comporta, per tutto l’impatto che sottende all’esistenza.
L’esperienza si è rivelata portatrice di uno spessore singolare che le ricerche, soprattutto recenti sul linguaggio, hanno consentito di sondare.
1.2. La trascendenza presagita nel mistero
La singolare pienezza e novità in cui è percepita ed esplorata l’esistenza nella riflessione recente s’affaccia sull’orizzonte alternativo; evoca una presenza nascosta e fondante; fa appello alla trascendenza.
Un appello che tuttavia non è obbligante. Ciò che forse caratterizza l’incontro della riflessione recente – specialmente esistenziale e fenomenologica – con la trascendenza è una marcata connotazione di libertà. Non nel senso che risulti arbitrario affermarla o negarla; piuttosto perché il progetto stesso esistenziale è segnato dalla libertà: su questa base interpreta e si interpreta; si orienta e decide.
L’affermazione del fondamento non è logica conclusione di un ragionamento astratto: è esistenziale consapevolezza d’una presenza presagita e riconosciuta. L’uomo può sentirsi “gettato” nel mondo o “chiamato” all’esistenza. La trascendenza dell’essere è percepita in tutta la sua alterità: l’orma che di sé ha impresso nel mondo è ambivalente: lo rivela e lo nasconde. La ragione può trovarsi sconcertata dal nascondimento o sollecitata dalla rivelazione: denunciare l’assurdità e l’inconsistenza del progetto umano, dove non ne vede lo sbocco e ne misura lo scacco – essere per la morte – ; o presagirne il senso e la pienezza dove avverte di poterlo ancorare ad una presenza ultima e appagante – esistere per l’incontro –.
La prima condizione del linguaggio religioso è l’opzione per la trascendenza, come misteriosa presenza su cui il progetto dell’uomo può dispiegarsi in una vitalità che attinge a risorse inesauribili. Un’opzione tuttavia che non è mai affermazione astratta, ma percezione vissuta: garanzia di stabilità e di approdo.
Il linguaggio religioso esplora e comprende la realtà – anche quella materiale – animata e fermentata da una trascendenza che l’attraversa e la vivifica. “La natura è piena di dei”; il “logos” anima la realtà materiale già nell’originaria riflessione occidentale. «I cieli narrano la gloria di Dio e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento» nella più consapevole e perentoria attestazione biblica (Sal 19).
L’uomo può sentirsi “spaesato” in questa immensa dimora che lo accoglie; ma può anche sentirsi “ospitato” in una casa fatta sulla sua misura e che tuttavia non è opera delle sue mani. Perciò l’intera realtà è invito suadente a riconoscervi una presenza misteriosa e ad invocarla.
Il linguaggio religioso instaura dunque un rapporto nuovo con il mondo: l’uomo vi abita in attesa di un incontro, per prepararlo. Secondo l’immagine suggestiva che la Bibbia ci ha tramandato, l’uomo considera l’universo come un immenso giardino che gli è stato affidato, su cui ha piena signoria, per quanto la fatica di dissodarlo e di asservirlo non riempia la sua attesa, né le sue aspirazioni.
2. DIRE DIO NEL CONTESTO ATTUALE
2.1. Molteplicità delle manifestazioni di Dio
L’affermazione è data a partire da una doppia considerazione, che richiamiamo:
– la realtà, creata da Dio, ne porta il segno, è costitutivamente relazionata a Lui; cosicché la ricerca può legittimamente tentare di decifrare un rapporto già in atto;
– l’uomo è dotato di una risorsa capace di leggere in profondità le cose e svelarne la relazione con il creatore che le costituisce.
Dunque, presupposto fondamentale è l’atto creatore; l’intervento di Dio all’origine, di cui la realtà porta il segno.
Il presagio da cui muove la ricerca umana suppone quella traccia lasciata dal creatore sulla creatura al momento in cui l’ha costituita e continua ad alimentarne l’esistenza. Dire-Dio comporta quindi:
– che i segni della presenza creatrice siano impressi nella bellezza e nella maestà della natura, tanto da renderla potente e suggestivo richiamo ad una maestà definitiva;
– che la straordinaria forza evocativa di cui l’uomo dispone sia in grado di presagire e di chiamare per nome, insomma di rivelare la verità costitutiva della creazione.
La fede è depositaria di questo sguardo penetrante e rivelativo della verità delle cose: passa dai segni alla presenza; legge la verità della creazione nella misteriosa risorsa che la costituisce.
Il volto di Dio non corrisponde al volto dell’essere, ma è vero che il volto autentico dell’essere lo testimonia, lo lascia presagire. Cosicché la realtà anche materiale può segnalarlo ad una coscienza avvertita, capace di darvi risonanza.
Il ritorno all’interiorità, la chiara presa di coscienza del presagio che le cose sottendono, diventa traccia privilegiata all’incontro con Dio. Anche se va mantenuta la differenza fra ricerca filosofica e religiosa, in quanto l’una tende a darsi ragione e l’altra tende a vivere la pienezza dell’incontro. Anche se, e soprattutto, va salvaguardata la differenza fra essere e Dio.
La trascendenza di Dio – il suo essere totalmente altro dalla creazione – è la premessa per salvare la religione da ogni rischio di indebita identificazione di Dio con la realtà.
2.2. Presupposti dell’elaborazione esistenziale
– Il problema non è “la prova” ma “l’incontro”.
Per dire-Dio non è tanto questione di affermarne o dimostrarne l’esistenza, quanto di esplorare il rapporto sotteso, che vivifica e rende straordinario l’incontro.
La pista della razionalità rigorosa a base dell’affermazione dell’esistenza di Dio, per lunga tradizione perseguita con piena credibilità, lascia oggi margini di perplessità.
L’ambiguità sta nel termine stesso di “oggettività”. Sotteso, rischia di affiorare il sospetto di oggettività sensibile–verificabile. Il pregiudizio scientista di riportare ogni affermazione sensata alla verifica empirica o alla falsificabilità compromette radicalmente il discorso su Dio.
Assai più fidata e credibile, si è venuta impostando la ricerca esistenziale che ha saputo ancorarsi alla realtà e, di conseguenza, garantirsi la verità delle proprie conclusioni.
– Il pensiero e la realtà.
Il pensiero è di sua natura orientato alla realtà.[2] Che tuttavia non è affatto riducibile al dato sensibile, per quanto il dato sensibile stesso venga riconosciuto fondamentale per l’elaborazione del pensiero, nella sua prerogativa di spaziare su tutte le dimensioni della realtà, fino ad attingere il suo fondamento.
– L’esperienza del singolo a perno della riflessione.
Inoltre, nell’impostazione esistenziale l’esperienza del singolo assurge a perno della riflessione. Ma l’esperienza del singolo è iscritta in una storia di cui egli fa parte, che quindi l’individuo non può presumere di analizzare “oggettivamente”, con il distacco dello spettatore. Tanto più che nella considerazione dell’esperienza la storia risulta la “mia” storia, della quale faccio parte integrante, in cui sono coinvolto.
Allora ogni ricerca cessa di essere un problema che mi è estraneo; sono costretto a considerarlo un fatto che mi tocca da vicino, che non posso mai considerare oggettivo; cammina con me, si modifica man mano che mutano i miei punti di vista.
La realtà, che pure sono in grado di conoscere, assume uno spessore su cui il procedimento razionale anche rigoroso non ha presa: dovunque sono coinvolto, il problema si apre al mistero che fascia l’intera realtà. Di questo mi rendo conto proprio prendendo atto di me stesso.
– Il ridimensionamento dell’aspetto razionale.
Tanto più che, dovunque sono coinvolto, l’aspetto razionale risulta ridimensionato. Infatti, oltre lo sfondo della razionalità si impone la risonanza emotiva, si staglia netta e risolutiva l’esigenza della libertà. A livello esistenziale l’ultima parola sembra rivendicata non dalla chiarezza della comprensione ma dalla imprevedibilità della decisione.
Nel caso di Dio, la ragione conserva tutta la sua forza, ma non è risolutiva. L’argomentazione è importante, ma non obbligante. L’affermazione di Dio, con il peso enorme che sottende sulla vita del singolo, si gioca su un retroterra esistenziale di uno spessore straordinario. La responsabilità di ciascuno conserva margini di libertà decisivi.
2.3. Un volto alla trascendenza
Il tema della trascendenza resta da impostare in maniera esistenziale, cioè:
– come dato connaturale e costitutivo del vivere umano,
– insito nell’esistenza ed da questa emergente come presagio.
S’impone l’analisi di ciò che sono e dei richiami interiori da cui sono attraversato e che sono da esplorare e identificare.
Dentro questi potrò cogliere un richiamo che mi supera e che può trasfigurasi in appello e quindi in affermazione implicita di una presenza più intima a me di me stesso, cui sono sollecitato a rispondere.
Su questa pista l’affermazione di Dio assume un’altra logica.
Non è la ragione – il cosmo e l’argomentazione sul cosmo privilegiata dalle “vie” tradizionali – ma è la coscienza di quanto si vive, l’analisi dell’intuizione esistenziale che porta il richiamo di Dio e consente di affermarlo. Non il fatto di provarlo ma di “constatarlo” diventa decisivo; s’impone la correttezza dell’analisi soprattutto interiore, con i suoi apporti e i suoi limiti da evidenziare.
Dunque non è in gioco tanto una prova dell’esistenza di Dio, ma l’orma, il presagio della sua presenza da sondare, al cuore stesso della percezione del mistero.
È all’interno dell’analisi del mistero che la sua presenza può imporsi, nella libertà di accoglierlo o di negarlo. Si tratta dunque di una “prova” piuttosto singolare: si tratta di riconoscere il mistero nel quale sono immerso; di rendermi disponibile all’analisi delle condizioni reali di possibilità che vi danno consistenza.
Se l’uomo è immerso nel mistero ha ancora senso parlare di autonomia? Ha senso parlare di libertà: di accogliere o di rifiutate il mistero e colui che lo abita?
Emerge una libertà situata ed ancorata all’essere nel mistero. E tuttavia chiamata a deciderne il riconoscimento o il rifiuto; un atto che richiede la decisione di accogliere o di rifiutare e vi conferisce il suo significato esistenziale.
Non è la ragione che cerca Dio; è l’esistenza che anela all’incontro con Dio.
Donde la saggezza nel maestro dell’apologo orientale, dove si parla di un discepolo alla ricerca di Dio che domanda: «Come posso incontrare Dio?». Il maestro tace, nonostante la comprensibile insistenza del discepolo. «Andiamo al fiume», riprende finalmente il maestro. Si tuffano e mentre nuotano uno accanto all’altro, il maestro preme vigorosamente la testa del discepolo sott’acqua, vincendone la disperata resistenza. Tornati finalmente a riva il discepolo chiede sconcertato il significato del gesto. «Cosa cercavi disperatamente sott’acqua?», chiede il maestro. «L’aria», risponde pronto il discepolo. «Bene, così dovrai cercare Dio, se vuoi incontrarlo!», suona laconica ma perentoria la risposta del maestro.
3. UN LINGUAGGIO PER SONDARE IL MISTERO
3.1. Un volto al presagio
Al cuore della ricerca sta dunque l’esistenza, espressa in una molteplicità di situazioni, consapevole dello spessore che l’attraversa. In particolare segnata dal rapporto con la trascendenza, che la riflessione dichiara oscura e che la fede privilegia. Si impone la domanda: quale linguaggio interpreta la trascendenza stessa e la esprime; come accedervi?
3.2. Lo spessore dell’esperienza
Il singolo ha fame, cerca un’abitazione, desidera essere accolto… Il vissuto immediato ha uno spessore straordinario, che precede ogni riflessione: è esperito prima di essere capito e decifrato. E prima di venire decifrato ha già un senso esaustivo, nella gioia di vivere, di partecipare, di trovare soddisfazione ai bisogni più elementari e continui; tanto più se l’esperienza dischiude un rapporto di persone che si cercano e si amano.
Non è mai misurabile l’attesa e la speranza con cui due persone si aspettano e si incontrano. Com’è difficile descrivere il margine di delusione e di amarezza che segna un incontro, anche riuscito! Torna la verità di un’aspirazione interiore che la vita costantemente delude. Che può assurgere a grande allusione, a presagio di trascendenza, radice esistenziale ultima della ricerca religiosa.
Sfumature e spessore che si ribellano alla razionalizzazione disegnano uno spazio che il linguaggio tenta di interpretare; che comunque resta sempre insondabile.
La ricerca scientifica può facilmente definire il proprio ambito e identificare la propria demarcazione.[3] La chiave e il segreto della scienza, sta proprio nel definire con chiarezza un aspetto specifico da verificare, che risulti falsificabile.
La riflessione esistenziale, invece, si apre sull’intero orizzonte della vita. La sua demarcazione raccoglie e organizza aspetti molteplici, di cui la puntualizzazione razionale è solo l’iceberg; soggiacenti ci sono diramazioni e componenti illimitate e perciò indecifrabili. La ricerca scientifica può essere rigorosa; la riflessione esistenziale – che non prescinda dal vissuto – si rifiuta al rigore della razionalizzazione. L’esperienza empirica è verificabile; l’esperienza esistenziale è inverificabile.[4]
La scienza procede nell’ignoto; la filosofia, la religione, l’arte… si addentrano nel mistero. Esplorano ambiti diversi, si avvalgono di un linguaggio specifico, per lo più reciprocamente incomparabile.
Si tratta allora di mettere in atto un procedimento coerente e integrale: esplorare l’esperienza per sondarne tutti i richiami; anche quello specificamente religioso, dove emerge e si impone alla considerazione.
È un procedimento che potremmo definire “esistenziale”, senza volerlo ancorare obbligatoriamente a qualcuna delle scuole che hanno segnato recentemente questa riflessione. Il nodo della ricerca sta in un’esigenza di analisi aperta dell’esperienza, senza prevenzioni o strettoie, per raccogliere tutte le sollecitazioni che vi affiorano.
La prima sollecitazione riguarda la condizione stessa da cui la ricerca prende l’avvio. L’analisi dell’esperienza tiene conto che vi siamo coinvolti in prima persona: non può costituire una ricerca distaccata e oggettiva.
Inoltre, a sua volta, l’esperienza comporta una gamma innumerevole di rimandi, che le conferiscono uno spessore pressoché impenetrabile. Risalendo man mano i rimandi, di cui è intessuta, ci si affaccia ad un mondo che sconfina nel mistero.
Si può dire che ne portiamo l’intuizione profonda e suggestiva ad un tempo: riportata al suo asse si concentra sulla domanda: chi sono? Precisamente questo interrogativo induce a riconoscere che la mia esistenza resta avvolta di mistero: alla sua origine e soprattutto, in forma più conturbante, nel suo destino.
3.3. Il rifiuto della finitudine
La riflessione attorno a qualunque esperienza umana profonda avverte richiami penetranti e non eludibili. E questo, a partire dalle sensazioni più consuete:
– la salute che oggi si gode non è esente da una sottile trepidazione per il futuro immediato e lontano;
– l’amore come disponibilità e attesa non è mai garantito del tutto: l’indifferenza o il tradimento lo insidiano;
– le realizzazioni più ambiziose nell’ambito dell’essere come dell’avere lasciano sempre un margine inappagato.
Anche più profonda e tenace è l’insoddisfazione per la statura conseguita, per la sincerità e la trasparenza con cui si vive. Lo scarto fra la vita e la speranza, fra il desiderio e l’attuazione, fra l’attesa e la risposta sembrano dilatarsi man mano che l’esistenza avanza.
Buber l’ha rilevato con chiarezza: l’ha soprattutto attribuito alla situazione contemporanea – alla sensibilità tipica di un’epoca storica –, in cui l’uomo risulta privo di una “casa” che gli consenta stabilità. E certo ha colto nel segno dove ha voluto sottolineare che la nostra è epoca di transizione, che vede scompaginati i riferimenti tradizionali e sconcertate le prospettive.
E tuttavia la sua annotazione non si riduce al dato esteriore. Una casa, per quanto grande e spaziosa non è la risposta; anzi non è neppure la domanda: è solo un simbolo. Già il saggio antico ha visto bene, dove ha misurato l’irraggiungibilità di una condizione interiore finalmente placata e paga (Marco Aurelio).
Questa serenità definitiva è aspirazione che il saggio non sa tacitare. Attraversa l’esistenza e, forse più veramente, la fermenta. Rileva quel margine di inquietudine, di insoddisfazione che si apre sulla dignità dell’uomo: mai pago, più grande di qualunque statura conseguita, proprio perché non c’è statura che esaurisca la sua misura.
Nell’apologo così semplice e suggestivo posto a perno dell’interpretazione che Pico della Mirandola propone nel suo celebre discorso sull’uomo, resta adombrata la ragione definitiva dell’anelito inappagato.
Affidato dal Creatore alla propria completa responsabilità non gli è stato assegnato nessun limite come invalicabile: piuttosto gli è stata data una consegna di perfezione illimitata.[5] Il Vangelo lo ribadisce con perentoria chiarezza: «siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli» (Mt 5,48).
Un compito esigente e una consegna ambiziosa: segnano l’esistenza così profondamente che l’ultimo ritocco non è mai dato; perciò ogni realizzazione risulta parziale e insoddisfacente: lascia sempre un margine non raggiunto, eppure proposto e perciò ambito.
La riflessione credente ne ha fatto da sempre – non solo nel cristianesimo – il riferimento decisivo. Le parole di Agostino – «il nostro cuore è inquieto finché non si placa in Te» – hanno trasferito in linguaggio lucido e consapevole la sensazione che in termini indefiniti e vaghi attraversa l’esperienza di tutti.
4. UN MISTERO DA ESPLORARE
Il procedimento che si innesta è allora un percorso induttivo che prende sul serio l’esperienza umana e vi presagisce dimensioni molteplici; alcune delle quali si portano sul versante del mistero e della trascendenza.
Tale procedimento, affidato alla riflessione, può concludere legittimamente ad una presenza trascendente insita nell’esistenza. Il credente è colui che vi ha dato la propria adesione con un gesto gratuito e libero; che tuttavia potrebbe anche essere ripercorso con rigore e trovare piena legittimità razionale.
Per il credente c’è chi accoglie la sua invocazione: lo sa; anche se non sarà mai in grado di verificare scientificamente o di dimostrare razionalmente che il suo appello è stato recepito. Su questa consapevolezza poggia l’atteggiamento di fede: fonda un rapporto singolarissimo che legittima il dialogo religioso oltre i limiti della scienza e oltre le strettoie della filosofia.
Tutte le indagini che l’uomo fa sulla natura non s’imbatteranno mai nella constatazione di una presenza che per definizione è trascendente e quindi altra da ogni rilevamento empirico possibile. Così, tutte le ragioni che si adducono possono solo legittimare l’affermazione della trascendenza. Caso mai, quando questa venga postulata come orizzonte alternativo, le analisi scientifiche e le considerazioni razionali potranno darvi ulteriore conferma e comprensione. Come è chiaro che precisamente l’orizzonte di fede popola la natura e investe la ragione di un riferimento altrimenti inavvertito.[6]
4.1. Quale linguaggio per sondare il mistero?
Anche in queste annotazioni, il linguaggio si è progressivamente portato su aspetti specifici.
Si è innanzitutto trasferito dal confronto con la realtà esteriore, constatata nella sensazione, all’interiorità della persona, esplorata nelle intuizioni che la segnano e non trovano legittima spiegazione nella persona stessa; donde il passaggio razionalmente richiesto di portarsi su un versante alternativo, postulato più che constatato.
Dio non risulta tanto garantito dalla dimostrazione razionale; è richiesto piuttosto dall’esplorazione esistenziale. La trascendenza è chiamata in causa perché l’esistenza non si giustifica, né è in grado di spiegare se stessa.
E tuttavia è vero che questa realtà, cui sembra indispensabile fare appello non si può constatare, non si avverte direttamente. Appare avvolta di “mistero”. E impone la domanda se sia possibile identificarla, chiamarla per nome…
Comunque è chiaro che i nomi di cui disponiamo non le si addicono.
Il linguaggio è dunque sfidato su una dimensione specifica, sulla quale falliscono i procedimenti propri dell’indagine scientifica e dell’argomentazione razionale.
Il linguaggio religioso punta al… mistero e presume di poterne parlare in termini che abbiano senso.
Negativamente è chiamato in causa perché gli altri linguaggi risultano spuntati; l’esistenza è assillata da spiegazioni che i vari versanti della ricerca umana non sono in grado di soddisfare.
Più profondamente l’uomo è sollecitato da una presenza che resta avvolta di mistero; gli parla in maniera profonda e suadente, ma non lo costringe; gli si rivela in un richiamo ineludibile, proposto tuttavia alla sua vita; suscettibile di adesione e di rifiuto. L’orizzonte della ricerca religiosa si colloca così sul fronte del mistero; il suo compito resta quello di darvi volto e nome.
Le indicazioni forse più pertinenti ci vengono dalla riflessione religiosa recente.[7] Si tratta di chiamare per nome, di conferire volto ad una presenza che si impone come mistero in cui la vita è immersa.
La dimensione religiosa sembra affiorare dove l’uomo prende coscienza di una presenza arcana con cui è in una relazione radicale e ultima. Dove tale intuizione viene decifrata e si tenta di chiamarla per nome sembra potervi conferire volto personale e appagante; rappresentare il riferimento e custodire la risposta.
L’esperienza concreta che viviamo può essere ripercorsa sull’onda del richiamo interiore, come sulla traccia delle acquisizioni culturali di cui disponiamo.
4.2. La traccia privilegiata
L’atto religioso analizzato nella sua più profonda istanza è aspirazione al rapporto personale: è attesa di risposta definitiva.[8] Per lo più, esso soggiace all’esperienza consueta di incontro: anzi, dove il rapporto a tu per tu viene analizzato nelle sue sottese aspirazioni lì è presagita e invocata una presenza trascendente, una capacità di interpretazione e di risposta che nessun tu finito è in grado di dare. Di più: dove l’analisi si fa radicale e interpreta l’esistenza nella sua origine e nel suo destino ogni riferimento finito denuncia la propria insufficienza.
La riflessione si porta obbligatoriamente sul versante trascendente e ultimo. L’invocazione non trova risposta che in un Tu assoluto.
Cosicché l’esplorazione del rapporto religioso non può che percorrere la pista obbligata del rapporto interpersonale. Solo nell’esplorazione del rapporto corretto con un tu – e nel caso con un Tu assoluto – la religione parla in termini singolarmente nuovi e persuasivi.
Viene così identificato l’orientamento attuale della ricerca concentrata sull’analisi del rapporto interiore con una trascendenza personale, dialogante.
Il che apre anche la riflessione al problema della rivelazione. Dove la trascendenza assume carattere personale la possibilità di una rivelazione diretta e positiva è legittimata.
Si tratterà, allora, di evidenziare quali siano i connotati di un linguaggio relazionale e interpersonale, di caratterizzarli correttamente dove il rapporto è con il Tu assoluto. Il linguaggio dovrà quindi cercare l’impostazione corretta.
Rimane inoltre fondata anche la legittimità di una ricerca che avverta nella cultura la manifestazione esplicita del richiamo religioso, che potrebbe o addirittura dovrebbe essere anche segnato di impronta personale. La presenza del dato cristiano non è solo questione che tocca il credente. È un problema che la ricerca si pone e che è suo compito esplorare, come avremo modo di rilevare nei prossimi interventi.
[1] Il termine esperienza è generico; lo assumiamo in tutto lo spessore che comporta e che analisi puntuali e attente, anche recentemente, hanno rilevato. Richiamo in particolare le pp. di Gadamer dedicate a Il concetto di esperienza e l’essenza dell’esperienza ermeneutica, in G. Gadamer, Verità e metodo, Milano, Bompiani 1995, pp. 401ss.
[2] È la rivendicazione costante anche della riflessione esistenziale; cf, ad es. uno dei suoi pensatori più accreditati, G. Marcel, Giornale metafisico, Roma, Abete, 1976, p. 248.
[3] Popper ha identificato un criterio oggi sostanzialmente accettato: «Queste considerazioni suggeriscono che, come criterio di demarcazione, non si deve prendere la verificabilità, ma la falsificabilità di un sistema… un sistema empirico deve poter essere confutato dall’esperienza: K. Popper, Logica della scoperta scientifica, Torino, Einaudi 1970, p. 22.
[4] Prini ha giustamente definito la ricerca di Marcel metodologia dell’inverificabile: P. Prini, Gabriel Marcel e la metodologia dell’inverificabile, Roma, Studium 1968; ne ha con questo identificato l’aspetto qualificante, ma ha anche indicato un aspetto qualificante della stessa riflessione filosofica.
[5] “La natura illimitata degli altri è contenuta entro leggi da me prescritte.
Tu non costretto da nessuna barriera, la determinerai secondo il tuo arbitrio, alla cui potestà di consegnai. Ti posi nel mezzo del mondo perché di là meglio tu scorgessi ciò che è nel mondo. Non Ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso quasi libero e sovrano artefice, ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che avresti prescelto. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori che sono i bruti, tu potrai, secondo il tuo volere, rigenerarti nelle cose superiori che sono divine.” G. PICO DELLA MIRANDOLA, Discorso sulla dignità dell’uomo, Brescia, La Scuola, 1987, pp. 5-7:
[6] Sulla traccia di annotazioni come queste trovo irrilevanti talune discussioni sul rapporto fede-ragione. Mi sembrano perfettamente pertinenti le riflessioni di K. Popper, Dopo la società aperta, Roma, Armando 2009, p. 117.
[7] Sono stati valorizzati in questa ricerca proprio quegli Autori che hanno esplorato con singolare originalità l’esperienza religiosa.
[8] Cf M. Scheler, Vom Ewigen im Menschen, Bern, Franke 1968, pp. 364ss.