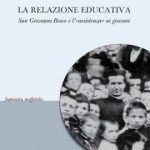
Categoria: Novità
La sezione Novità con le sue rubriche tiene aggiornati gli educatori sulle novità che: negli eventi, nell’editoria e nel cinema interessano l’educazione religiosa.
Presentazione del nuovo Direttorio per la Catechesi
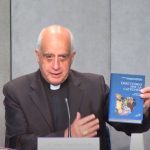
Alle ore 11.30 di ieri mattina, presso l’Aula “Giovanni Paolo II” della Sala Stampa della Santa Sede, in Via della Conciliazione 54, ha avuto luogo una Conferenza Stampa di presentazione del Direttorio per la Catechesi redatto dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.
Sono intervenuti: S.E. Mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione; S.E. Mons. Octavio Ruiz Arenas, Segretario del Pontificio Consiglio per la Promozione dellaNuova Evangelizzazione; S.E. Mons. Franz-Peter Tebartz-van Elst, Delegato per la Catechesi del medesimo Pontificio Consiglio.
Pubblichiamo il testo italiano:
Testo in lingua italiana
La pubblicazione di un Direttorio per la Catechesi rappresenta un felice evento per la vita della Chiesa. Per quanti sono dediti al grande impegno della catechesi, infatti, può segnare una provocazione positiva perché permette di sperimentare la dinamica del movimento catechetico che ha sempre avuto una presenza significativa nella vita della comunità cristiana. Il Direttorio per la Catechesi è un documento della Santa Sede affidato a tutta la Chiesa. Ha richiesto molto tempo e fatica, e giunge a conclusione di una vasta consultazione internazionale.
Oggi si presenta l’edizione ufficiale in lingua italiana. Sono già pronte, comunque, le traduzioni in spagnolo (edizione per l’America Latina e la Spagna), in portoghese (edizione per il Brasile e Portogallo), inglese (edizione per USA e Regno Unito), francese e polacco. È rivolto in primo luogo ai Vescovi, primi catechisti tra il popolo di Dio, perché primi responsabili della trasmissione della fede (cfr. n. 114). Insieme a loro sono coinvolte le Conferenze episcopali, con le rispettive Commissioni per la catechesi, per condividere ed elaborare un auspicato progetto nazionale che sostenga il cammino delle singole diocesi (cfr. n. 413). I più direttamente coinvolti nell’uso del Direttorio, comunque, rimangono i sacerdoti, i diaconi, le persone consacrate, e i milioni di catechisti e catechiste che quotidianamente offrono con gratuità, fatica e speranza il loro ministero nelle differenti comunità. La dedizione con cui operano, soprattutto in un momento di transizione culturale come questo, è il segno tangibile di quanto l’incontro con il Signore possa trasformare un catechista in un genuino evangelizzatore.
A partire dal Concilio Vaticano II questo che oggi presentiamo è il terzo Direttorio.
Il primo del 1971, Direttorio catechistico generale, e il secondo del 1997, Direttorio generale per la catechesi, hanno segnato questi ultimi cinquant’anni di storia della catechesi. Questi testi hanno svolto un ruolo primario. Sono stati un aiuto importante per far compiere un passo decisivo al cammino catechetico, soprattutto rinnovando la metodologia e l’istanza pedagogica. Il processo di inculturazione che caratterizza in particolare la catechesi e che soprattutto ai nostri giorni impone un’attenzione del tutto particolare ha richiesto la composizione di un nuovo Direttorio.
La Chiesa è dinanzi a una grande sfida che si concentra nella nuova cultura con la quale si viene a incontrare, quella digitale. Focalizzare l’attenzione su un fenomeno che si impone come globale, obbliga quanti hanno la responsabilità della formazione a non tergiversare. A differenza del passato, quando la cultura era limitata al contesto geografico, la cultura digitale ha una valenza che risente della globalizzazione in atto e ne determina lo sviluppo. Gli strumenti creati in questo decennio manifestano una radicale trasformazione dei comportamenti che incidono soprattutto nella formazione dell’identità personale e nei rapporti interpersonali. La velocità con cui si modifica il linguaggio, e con esso le relazioni comportamentali, lascia intravedere un nuovo modello di comunicazione e di formazione che tocca inevitabilmente anche la Chiesa nel complesso mondo dell’educazione. La presenza delle varie espressioni ecclesiali nel vasto mondo di internet è certamente un fatto positivo, ma la cultura digitale va ben oltre. Essa tocca in radice la questione antropologica decisiva in ogni contesto formativo, come quello della verità e della libertà. Già porre questa problematica impone di verificare l’adeguatezza della proposta formativa da qualunque parte provenga. Essa diventa, comunque, un confronto imprescindibile per la Chiesa in forza della sua “competenza” sull’uomo e la sua pretesa veritativa.
Forse, solo per questa premessa si rendeva necessario un nuovo Direttorio per la catechesi. Nell’epoca digitale, vent’anni sono paragonabili senza esagerazione ad almeno mezzo secolo. Da qui è derivata l’esigenza di redigere un Direttorio che prendesse in considerazione con grande realismo il nuovo che si affaccia, con il tentativo di proporne una lettura che coinvolgesse la catechesi. È per questo motivo che il Direttorio presenta non solo le problematiche inerenti la culturale digitale, ma suggerisce anche quali percorsi effettuare perché la catechesi diventi una proposta che trova l’interlocutore in grado di comprenderla e di vederne l’adeguatezza con il proprio mondo.
Esiste, comunque, una ragione più di ordine teologico ed ecclesiale che ha convinto a redigere questo Direttorio.
L’invito a vivere sempre più la dimensione sinodale non può far dimenticare gli ultimi Sinodi che la Chiesa ha vissuto. Nel 2005 quello sull’Eucaristia fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa; nel 2008 La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa; nel 2015 La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo; nel 2018 I giovani, la fede e il discernimento vocazionale.
Come si può osservare, ritornano delle costanti in tutte queste assemblee che toccano da vicino il tema dell’evangelizzazione e della catechesi come si può verificare dai documenti che ne hanno fatto seguito. Più in particolare è doveroso far riferimento a due scadenze che in maniera complementare segnano la storia di questo ultimo decennio per quanto riguarda la catechesi: il Sinodo sulla Nuova evangelizzazione e trasmissione della fede nel 2012, con la conseguente Esortazione apostolica di Papa Francesco Evangelii gaudium, e il venticinquesimo anniversario
della pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, ambedue toccano direttamente la competenza del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.
L’evangelizzazione occupa il posto primario nella vita della Chiesa e nel quotidiano insegnamento di papa Francesco. Non potrebbe essere altrimenti. L’evangelizzazione è il compito che il Signore Risorto ha affidato alla sua Chiesa per essere nel mondo di ogni tempo l’annuncio fedele del suo Vangelo. Prescindere da questo presupposto equivarrebbe a rendere la comunità cristiana una delle tante associazioni benemerite, forte dei suoi duemila anni di storia, ma non la Chiesa di Cristo. La prospettiva di Papa Francesco, tra l’altro, si pone in forte continuità con l’insegnamento di san Paolo VI nella Evangelii nuntiandi del 1975. Ambedue non fanno altro che riferirsi alla ricchezza scaturita dal Vaticano II che, per quanto riguarda la catechesi, ha trovato nella Catechesi tradendae (1979) di san Giovanni Paolo II il suo punto focale.
La catechesi, quindi, va intimamente unita all’opera di evangelizzazione e non può prescindere da essa. Ha bisogno di assumere in sé le caratteristiche stesse dell’evangelizzazione, senza cadere nella tentazione di diventarne un sostituito o di voler imporre all’evangelizzazione le proprie premesse pedagogiche.
In questo rapporto il primato spetta all’evangelizzazione non alla catechesi. Ciò permette di comprendere perché alla luce di Evangelii gaudium, questo Direttorio si qualifica per sostenere una “catechesi kerygmatica”. Cuore della catechesi è l’annuncio della persona di Gesù Cristo, che sorpassa i limiti di spazio e tempo per presentarsi ad ogni generazione come la novità offerta per raggiungere il senso della vita. In questa prospettiva, viene indicata una nota fondamentale che la catechesi deve fare propria: la misericordia. Il kerygma è annuncio della misericordia del Padre che va incontro al peccatore non più considerato come un escluso, ma un invitato privilegiato al banchetto della salvezza che consiste nel perdono dei peccati. Se si vuole, è in questo contesto che prende forza l’esperienza del catecumenato come esperienza del perdono offerto e della vita nuova di comunione con Dio che ne consegue.
La centralità del kerygma, comunque, deve essere recepita in senso qualitativo non temporale. Richiede, infatti, che sia presente in tutte le fasi della catechesi e di ogni catechesi. E’ il “primo annuncio” che sempre viene fatto perché Cristo è l’unico necessario. La fede non è qualcosa di ovvio che si recupera nei momenti del bisogno, ma un atto di libertà che impegna tutta la vita. Il Direttorio, quindi, fa sua la centralità del kerygma che si esprime in senso trinitario come impegno di tutta la Chiesa.
La catechesi come espressa dal Direttorio, si caratterizza per questa dimensione e per le implicanze che porta nella vita delle persone. Tutta la catechesi, in questo orizzonte, acquista una valenza peculiare che si esprime nell’approfondimento costante del messaggio evangelico. La catechesi, insomma, ha lo scopo di far raggiungere la conoscenza dell’amore cristiano che porta quanti l’hanno accolto a divenire discepoli evangelizzatori.
Il Direttorio si snoda toccando diverse tematiche che non fanno altro che rimandare all’obiettivo di fondo.
Una prima dimensione è la mistagogia che viene presentata attraverso due elementi complementari tra loro: anzitutto, una rinnovata valorizzazione dei segni liturgici dell’iniziazione cristiana; inoltre, la progressiva maturazione del processo formativo in cui tutta la comunità è coinvolta. La mistagogia è una via privilegiata da seguire, ma non è facoltativa nel percorso catechetico, rimane come un momento obbligato perché inserisce sempre più nel mistero che si crede e si celebra. È la consapevolezza del primato del mistero che porta la catechesi a non isolare il kerygma dal suo contesto naturale. L’annuncio della fede è pur sempre annuncio del mistero dell’amore di Dio che si fa uomo per la nostra salvezza. La risposta non può esulare dall’accogliere in sé il mistero di Cristo per permettere di fare luce sul mistero della propria esperienza personale (cfr. GS 22).
Un ulteriore tratto di novità del Direttorio è il legame tra evangelizzazione e catecumenato nelle sue varie accezioni (cfr. n.62). È urgente compiere la “conversione pastorale” per liberare la catechesi da alcuni lacci che ne impediscono l’efficacia. Il primo, lo si può identificare nello schema scolastico, secondo il quale la catechesi dell’Iniziazione cristiana è vissuta sul paradigma della scuola. La catechista sostituisce la maestra, all’aula della scuola subentra quella del catechismo, il calendario scolastico è identico a quello catechistico…
Il secondo, è la mentalità secondo la quale si fa la catechesi per ricevere un sacramento. È ovvio che una volta terminata l’Iniziazione si crei il vuoto per la catechesi. Un terzo, è la strumentalizzazione del sacramento a opera della pastorale, per cui i tempi del sacramento della Confermazione sono stabiliti dalla strategia pastorale di non perdere il piccolo gregge di giovani rimasto in parrocchia e non dal significato che il sacramento possiede in se stesso nell’economia della vita cristiana.
Papa Francesco ha scritto che “Annunciare Cristo significa mostrare che credere in Lui e seguirlo non è solamente una cosa vera e giusta, ma anche bella, capace di colmare la vita di un nuovo splendore e di una gioia profonda, anche in mezzo alle prove. In questa prospettiva, tutte le espressioni di autentica bellezza possono essere riconosciute come un sentiero che aiuta ad incontrarsi con il Signore Gesù… Si rende necessario che la formazione nella via pulchritudinis sia inserita nella trasmissione della fede” (Eg 167). Una nota di particolare valenza innovativa per la catechesi può essere espressa dalla via della bellezza soprattutto per permettere di conoscere il grande patrimonio di arte, letteratura e musica che ogni Chiesa locale possiede.
In questo senso, si comprende perché il Direttorio abbia posto la via della bellezza come una delle “fonti” della catechesi (cfr. nn. 106-109).
Un’ultima dimensione offerta dal Direttorio si ritrova nell’aiutare a inserirsi progressivamente nel mistero della fede. Questa connotazione non può essere delegata a una sola dimensione della fede o della catechesi. La teologia indaga con gli strumenti della ragione il mistero rivelato. La liturgia celebra ed evoca il mistero con la vita sacramentale. La carità riconosce il mistero del fratello che tende la mano. La catechesi, alla stessa stregua, introduce progressivamente ad accogliere e vivere globalmente il mistero nell’esistenza quotidiana.
Il Direttorio fa propria questa visione quando chiede di esprimere una catechesi che sappia farsi carico di mantenere unito il mistero pur articolandolo nelle diverse fasi di espressione. Il mistero quando è colto nella sua realtà profonda, richiede il silenzio. Una vera catechesi non sarà mai tentata di dire tutto sul mistero di Dio. Al contrario, essa dovrà introdurre alla via della contemplazione del mistero facendo del silenzio la sua conquista.
Il Direttorio, pertanto, presenta la catechesi kerygmatica non come una teoria astratta, piuttosto come uno strumento con una forte valenza esistenziale. Questa catechesi trova il suo punto di forza nell’incontro che permette di sperimentare la presenza di Dio nella vita di ognuno. Un Dio vicino che ama e che segue le vicende della nostra storia perché l’incarnazione del Figlio lo impegna in modo diretto.
La catechesi deve coinvolgereognuno, catechista e catechizzando, nell’esperire questa presenza e nel sentirsi coinvolto nell’opera di misericordia. Insomma, una catechesi di questo genere permette di scoprire che la fede è realmente l’incontro con una persona prima di essere una proposta morale, e che il cristianesimo non è una religione del passato, ma un evento del presente. Un’esperienza come questa favorisce la comprensione della libertà personale, perché risulta essere il frutto della scoperta di una verità che rende liberi (cfr. Gv 8,31).
La catechesi che dà il primato al kerygma si pone all’opposto di ogni imposizione, fosse anche quella di un’evidenza che non permette vie di fuga. La scelta di fede, infatti, prima di considerare i contenuti a cui aderire con il proprio assenso, è un atto di libertà perché si scopre di essere amati. In questo ambito, è bene considerare con attenzione quanto il Direttorio propone circa l’importanza dell’atto di fede nella sua duplice articolazione (cfr. n. 18). Per troppo tempo la catechesi ha focalizzato il suo impegno nel far conoscere i contenuti della fede e con quale pedagogia trasmetterli, tralasciando purtroppo il momento più determinante come l’atto di scegliere la fede e dare il proprio assenso.
Ci auguriamo che questo nuovo Direttorio per la Catechesi possa essere di vero aiuto e sostegno al rinnovamento della catechesi nell’unico processo di evangelizzazione che la Chiesa da duemila anni non si stanca di realizzare, perché il mondo possa incontrare Gesù di Nazareth, il figlio di Dio fatto uomo per la nostra
salvezza.
[Testo originale: Italiano]
Ne pubblichiamo di seguito tutti gli interventi:
presentazione del Direttorio per la Catechesi
Articoli correlati:
Vaticano. Nuovo Direttorio per la catechesi. Più attenzione al digitale e ai poveri
L’arcivescovo Fisichella ha presentato il documento, rimandarcandone i punti salienti. Non si fa catechesi solo in vista dei sacramenti, ma per inserirsi nella comunità cristiana
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/il-nuovo-direttorio
Mimmo Muolo giovedì 25 giugno 2020
Un nuovo «Direttorio per la Catechesi
Pubblicato dal Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2020-06/un-nuovo-direttorio-per-la-catechesi0.html
25 giugno 2020
Redatto dal Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, il nuovo «Direttorio per la Catechesi» è stato presentato in diretta streaming nella mattina di giovedì 25 giugno, presso la Sala stampa della Santa Sede. Nel link l’intervento dell’arcivescovo presidente.
Catechesi: un Direttorio molto atteso, “per far conoscere l’amore cristiano”
La presentazione del nuovo “Direttorio per la catechesi” in Sala Stampa vaticana, con l’arcivescovo Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, il vescovo segretario Ruiz Arenas e il vescovo delegato per la catechesi Tebartz-van Elst
Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano
Un documento molto atteso nella Chiesa, in tutti i continenti, che ha richiesto dodici bozze e più di 5 anni di lavoro, per il quale anche Papa Francesco ha chiesto, firmandolo, che “si suonino le campane a festa” in segno di gratitudine per l’impegno che ha richiesto. Così l’arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione e i suoi principali collaboratori nella preparazione del nuovo “Direttorio per la catechesi”, il segretario del dicastero monsignor Octavio Ruiz Arenas e il delegato per la catechesi monsignor Franz-Peter Tebartz-van Elst, presentano il documento di quasi 300 pagine ai giornalisti di tutto il mondo, in Sala Stampa vaticana. Oggi in italiano, ma già pronto in altre sei lingue e in 10 edizioni, dallo spagnolo per l’America Latina all’inglese per gli Stati Uniti.
Un nuovo Direttorio perché c’è una nuova cultura digitale
Serviva un nuovo Direttorio, chiarisce subito monsignor Fisichella, a quasi 50 anni dal primo, il Direttorio catechistico generale (1971), e a più di 20 dal secondo, il Direttorio generale per la catechesi (1997), perché la catechesi va inculturata, e la cultura in questi vent’anni è profondamente cambiata. La sfida è rappresentata dalla nuova cultura digitale, che coinvolge tutte le Chiese locali per effetto della globalizzazione. La tecnologia creata in questo ultimo decennio, spiega l’arcivescovo lombardo, trasforma i comportamenti “che incidono soprattutto nella formazione dell’identità personale e nei rapporti interpersonali”. La velocità con cui si modifica il linguaggio, e le relazioni, porta ad un “nuovo modello di comunicazione e di formazione che tocca inevitabilmente anche la Chiesa nel complesso mondo dell’educazione”.
25/06/2020
Nuovo Direttorio per la catechesi: rendere il Vangelo sempre attuale
Percorsi per far comprendere la proposta
La cultura digitale, sottolinea il presidente del dicastero per la Nuova evangelizzazione, tocca la questione decisiva “della verità e della libertà”, e non basta la presenza, pur molto positiva, di diverse espressioni ecclesiali nel web. Per questo il Direttorio non presenta solo la sfida del digitale, “ma suggerisce anche quali percorsi effettuare perché la catechesi diventi una proposta che trova l’interlocutore in grado di comprenderla” e di vederla adeguata al proprio mondo.
Rivolto ai vescovi ma anche a milioni di catechisti
Il Direttorio si rivolge ai vescovi, “primi catechisti tra il popolo di Dio”, alle conferenze episcopali che dovranno preparare i Direttòri per la Chiese locali, ma anche ai sacerdoti, ai diaconi, alle persone consacrate, “e ai milioni di catechisti e catechiste che quotidianamente offrono con gratuità, fatica e speranza il loro ministero nelle differenti comunità”. E giustifica la sua pubblicazione con le novità teologiche ed ecclesiali portate in questi vent’anni da cinque Sinodi dei vescovi, da quello sull’Eucaristia del 2005 fino all’assemblea sui giovani del 2018, passando per Parola di Dio e famiglia, ma soprattutto per il Sinodo sulla nuova evangelizzazione del 2012, con l’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Evangelii gaudium”.
Quando Benedetto XVI unì la catechesi all’evangelizzazione
Dopo quel Sinodo, Papa Benedetto XVI, come ricorda nel suo intervento monsignor Octavio Ruiz Arenas, ha trasferito la responsabilità della catechesi dalla Congregazione per il Clero al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, sottolineando così “l’importantissimo ruolo della catechesi nella realizzazione della missione fondamentale della Chiesa: l’evangelizzazione”. Ne aveva parlato alla fine dell’assemblea, e ha concretizzato l’intenzione nella lettera apostolica “Fides per Doctrinam”, del gennaio 2013, nella quale afferma che l’intelligenza della fede “richiede sempre che i suoi contenuti siano espressi con un linguaggio nuovo, capace di presentare la speranza presente nei credenti a tutti coloro che chiedono la loro ragione”.
25/06/2020
Fisichella: catechesi del primo annuncio, attenta al digitale e alla globalizzazione
Il primato spetta sempre all’evangelizzazione
L’evangelizzazione, ricorda ancora monsignor Fisichella, “occupa il posto primario nella vita della Chiesa e nel quotidiano insegnamento di Papa Francesco” che si pone in forte continuità con l’insegnamento di san Paolo VI nella “Evangelii nuntiandi” del 1975. I due documenti pontifici sono legati “alla ricchezza scaturita dal Vaticano II che, per quanto riguarda la catechesi, ha trovato nella ‘Catechesi tradendae’ (1979) di san Giovanni Paolo II il suo punto focale”. La catechesi, quindi, “va intimamente unita all’opera di evangelizzazione e non può prescindere da essa”, perché il primato “spetta all’evangelizzazione non alla catechesi”.
Kerygma: il cuore è l’annuncio della persona di Cristo
Questo spiega perché alla luce di “Evangelii gaudium”, il nuovo Direttorio “si qualifica per sostenere una ‘catechesi kerygmatica’. Cuore della catechesi è l’annuncio della persona di Gesù Cristo, che sorpassa i limiti di spazio e tempo per presentarsi ad ogni generazione come la novità offerta per raggiungere il senso della vita”. Il kerygma, chiarisce l’arcivescovo, “è annuncio della misericordia del Padre che va incontro al peccatore non più considerato come un escluso, ma un invitato privilegiato al banchetto della salvezza che consiste nel perdono dei peccati”. E’ il “primo annuncio” che sempre viene fatto perché Cristo è l’unico necessario. “La fede non è qualcosa di ovvio che si recupera nei momenti del bisogno, ma un atto di libertà che impegna tutta la vita”.
Accogliere l’annuncio, diventare discepoli evangelizzatori
La catechesi, insomma, sottolinea monsignor Fisichella, “ha lo scopo di far raggiungere la conoscenza dell’amore cristiano” che porta quelli che l’hanno accolto “a divenire discepoli evangelizzatori”. Tutte le tematiche del Direttorio portano a questo obiettivo, a partire dalla mistagogia, l’introduzione al mistero di Cristo, che viene presentata innanzitutto attraverso una “rinnovata valorizzazione dei segni liturgici dell’iniziazione cristiana”. L’annuncio della fede, ricorda il presidente del dicastero per la nuova evangelizzazione, “è pur sempre annuncio del mistero dell’amore di Dio che si fa uomo per la nostra salvezza”.
No allo schema scolastico e all’obiettivo-sacramento
Nel documento si invita poi a liberare la catechesi “da alcuni lacci che ne impediscono l’efficacia”, dallo “schema scolastico”, secondo il quale la catechesi dell’Iniziazione cristiana è vissuta sul paradigma della scuola, alla mentalità per la quale “si fa la catechesi per ricevere un sacramento”. Fisichella critica anche la “strumentalizzazione del sacramento a opera della pastorale, per cui i tempi del sacramento della Confermazione sono stabiliti dalla strategia pastorale di non perdere il piccolo gregge di giovani rimasto in parrocchia” e non dal significato che il sacramento nell’economia della vita cristiana.
La “via della bellezza”, una fonte della catechesi
Nella “Evangeli gaudium”, Papa Francesco chiede che “la formazione nella via pulchritudinis sia inserita nella trasmissione della fede”, e così l’arcivescovo sottolinea che valorizzare nella catechesi la “via della bellezza”, che il Direttorio pone come una delle “fonti” della catechesi stessa, potrà permettere “di conoscere il grande patrimonio di arte, letteratura e musica che ogni Chiesa locale possiede”.
La forza dell’incontro: Dio presente nella nostra vita
In conclusione, il Direttorio, “presenta la catechesi kerygmatica non come una teoria astratta, piuttosto come uno strumento con una forte valenza esistenziale”. La catechesi, infatti, “trova il suo punto di forza nell’incontro che permette di sperimentare la presenza di Dio nella vita di ognuno. Un Dio vicino che ama e che segue le vicende della nostra storia, perché l’incarnazione del Figlio lo impegna in modo diretto”. Una catechesi di questo genere, per Fisichella, “permette di scoprire che la fede è realmente l’incontro con una persona prima di essere una proposta morale, e che il cristianesimo non è una religione del passato, ma un evento del presente”. Anche per questo il documento sottolinea l’importanza dell’atto di fede compiuto in assoluta libertà. “Per troppo tempo – ricorda l’arcivescovo – la catechesi ha focalizzato il suo impegno nel far conoscere i contenuti della fede e con quale pedagogia trasmetterli, tralasciando purtroppo il momento più determinante come l’atto di scegliere la fede e dare il proprio assenso”.
«CATECHETICA ED EDUCAZIONE»
da oggi puoi scaricare il primo numero del 2020!!!

Editoriale
Dentro, «a confine» ed oltre…
INTERDISCIPLINARITÀ E TRANSDISCIPLINARITÀ
Confronto tra vari ambiti scientifici e punti di prospettiva
«Se alzi un muro pensa a tutto ciò che resta fuori. Anche per chi ha passato tutta la vita in mare, c’è un’età in cui si sbarca» (Italo CALVINO, Il barone rampante).
«Chiediamo anche noi oggi allo Spirito Santo di insegnarci a costruire ponti con la cultura, con chi non crede o con chi ha un credo diverso dal nostro. Sempre costruire ponti, sempre la mano tesa, niente aggressione. Chiediamogli la capacità di inculturare con delicatezza il messaggio della fede, ponendo su quanti sono nell’ignoranza di Cristo uno sguardo contemplativo, mosso da un amore che scaldi anche i cuori più induriti» (Papa FRANCESCO, Udienza del 6 dicembre 2019).
La rivista «CATECHETICA ED EDUCAZIONE» propone un tema che recentemente è tornato alla ribalta e ha interessato già altri Centri universitari, come testimonia l’articolo apparso su «Il Corriere della sera» del 7 maggio scorso (p. 28), dal titolo La sfida dell’innovazione negli Atenei del dopo-crisi, a firma dei proff. Elio Franzini, Giovanna Innantuoni e Francesco Svelto, Rettori degli Atenei rispettivamente di Milano, di Milano Bicocca e di Pavia. Volentieri ci affianchiamo a quanti indagano in campo scientifico con passione e impegno, seguendo coloro che sono pionieri e battistrada di nuove e umanizzanti conquiste scientifiche. Grazie alla disponibilità di studiosi e cultori di varie scienze che, nonostante gli innumerevoli e cogenti impegni, si sono lasciati coinvolgere, proponiamo una riflessione a più voci sull’interdisciplinarità e la transdisciplinarità, in un contesto inedito, qual è il nostro, segnato da trasformazioni e cambiamenti, non ultima la pandemia che ci ha trovati coinvolti in modo ineludibilmente inclusivo a livello planetario.
La scelta tematica è fortemente motivata, inoltre, da vari e differenti stimoli culturali che all’unisono, in questi ultimi anni, continuano ad esprimere l’esigenza di non fermarsi entro i confini della propria scienza, disciplina e competenza, ma di provare a spingersi “oltre” per approdare ad una visione che sia olistica, più aperta e possibilmente condivisa sul mistero della vita umana, in un crescendo di passione investigativa e di desiderio di benessere integrale che comporta il ben-pensare e il ben-sentire. La monografia è stata ispirata in particolar modo dal recente magistero di Papa Francesco e dal gruppo di scienziati che hanno elaborato e sottoscritto un manifesto sulla transdisciplinarità del 6 novembre 1994, di cui portavoce è il fisico teorico Basarab Nicolescu. Il paragrafo 4c del Proemio della Costituzione apostolica dell’attuale Pontefice, Veritatis gaudium (2018) riporta il terzo dei quattro criteri che dovrebbero orientare al rinnovamento e al rilancio degli studi universitari (compresi quelli ecclesiastici), «l’inter- e la trans-disciplinarità esercitate con sapienza e creatività nella luce della Rivelazione». Il richiamo è esplicito sull’«odierna riscoperta del principio dell’interdisciplinarità (EG 134): non tanto nella sua forma “debole” di semplice multidisciplinarità […] quanto piuttosto nella sua forma “forte” di transdisciplinarità, come collocazione e fermentazione di tutti i saperi entro lo spazio di Luce e di Vita offerto dalla Sapienza che promana dalla Rivelazione di Dio».
A partire da questo criterio e dall’avvertito bisogno di un supplemento di riflessione sull’interdisciplinarità e sulla “transdisciplinarità” (quest’ultima per tanti aspetti meno chiara e meno indagata), il cui emblema è costituito dal richiamato manifesto sottoscritto da Lima de Freitas, Edgar Morin e Basarab Nicolescu, il presente numero di «Catechetica ed educazione» intende sviluppare il tema sotto vari punti di vista, non tutti, ma quelli più rappresentativi dell’attuale panorama scientifico, secondo la seguente strutturazione:
1. Prefazione e avvio ai punti di prospettiva: prof. Mauro Mantovani
2. Punto di vista filosofico: prof. Sinsin Venance Mahougnon
3. Punto di vista pedagogico: prof.ssa Maria Teresa Moscato
4. Punto di vista psicologico: prof. Mario Becciu
5. Punto di vista sociologico: prof.ssa Cecilia Costa
6. Punto di vista giuridico: prof. Emanuele Bilotti
7. Punto di vista pragmatico-comunicativo: prof. Mario Morcellini
8. Punto di vista estetico: prof.ssa Claudia Caneva
9. Punto di vista teologico: prof. Antonio Escudero
10. Punto di vista catechetico: prof. Giuseppe Ruta
11. Postfazione e visione di sintesi: prof. José Luis Moral.
Alla prefazione e alla postfazione, oltre che ai sommari dei rispettivi contributi, si rimanda per un ragguaglio più particolareggiato.
Il numero si chiude con una dedica grata e doverosa al prof. JOSEPH GEVAERT (1930-2019), deceduto il 29 agosto scorso, che ha dato nei lunghi e intensi anni trascorsi presso la nostra Università Pontificia Salesiana di Roma, il suo qualificato contributo al dibattito epistemologico sulla inter- e trans-disciplinarità, oltre ad aver manifestato fine sensibilità e acuta perizia antropologica e culturale in vari campi scientifici da quello filosofico, a quello teologico e catechetico.
Oltre al profilo bio-bibliografico (prof. Cesare Bissoli) e ad una prima ricostruzione della bibliografia completa (a cura del prof. Corrado Pastore), viene anche offerto ai lettori un saggio che riconsidera la visione antropologica del professore estinto (prof. José Luis Moral).
Ci si augura che la riflessione multidisciplinare concertata in questo numero possa continuare e approfondirsi negli anni a venire, nel confronto interdisciplinare e nella collaborazione transdisciplinare su ambiti di vita e di pensiero, comuni e condivisi.
A quanti hanno reso possibile la pubblicazione di questa riflessione congiunta va un doveroso e sentito grazie.
I MEMBRI DELL’ISTITUTO DI CATECHETICA
catechetica@unisal.it
Revista de Educación Religiosa – Institute dell’Università Finis Terrae.
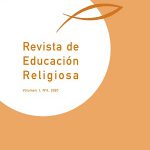
La Revista de Educación Religiosa è una pubblicazione accademica digitale e stampata, pubblicata ogni sei mesi (maggio e ottobre), dalla School of Faith Institute dell’Università Finis Terrae.
Presentazione:
Scarica il primo numero:
Patricio Jaramillo Fernández
Director Instituto Escuela de la Fe
Director Carrera Pedagogía en Religión
T_ +562 2420 7166
www.finisterrae.cl

Questa Pentecoste. Fare un altro mondo, essere davvero Chiesa
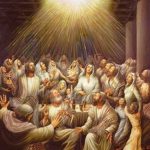
Il nostro mondo si è fermato: a memoria d’uomo, non avevamo mai fermato il mondo. Il nostro mondo si è fermato proprio a Pasqua. Il Signore risorto è arrivato anche per noi “a porte chiuse”, mentre eravamo chiusi in casa “per paura”. Non importa quale paura, la paura ti paralizza sempre, poco o tanto. I Discepoli non sono rimasti inerti, però, dopo l’incontro con il Signore risorto e prima dell’avvento dello Spirito che farà “uscire” la Chiesa.
Nel tempo degli incontri con il Risorto, i Discepoli riflettono insieme sugli eventi emozionanti e traumatici dell’avventura vissuta con Gesù e pregano Dio – insieme con la Madre – perché li custodisca in attesa della loro ora, che deve venire. Dopo cinquanta giorni, un rombo di tuono, un passaggio di vento, un lampo di fuoco. E i suoi “ragazzi” (così li chiamava il Signore, anche da Risorto, cfr. Vangelo di Giovanni, 21, 5) sono tutti fuori, a riaprire le promesse della vita “per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani” (Atti degli Apostoli, 2, 39).
Finiscono oggi, praticamente, anche i nostri cinquanta giorni. Vorrei prendere ispirazione dal significato di questa coincidenza della drammatica chiusura del tempo della pandemia, per illuminare l’appello che ci viene incontro: per noi e per tutti. Lo faccio, allusivamente, con due parole-chiave.
La prima è interiorità. Il lockdown ha imposto prepotentemente la forza vitale di questa risorsa, massacrata dalla società dei consumi e del godimento e dalla scuola delle competenze e delle prestazioni. Senza riserve di interiorità, ogni paura sconfina nell’angoscia e nello smarrimento totale. La nostra separazione forzata, l’isolamento, la perdita di esteriorità (pur necessaria) hanno messo alla prova le riserve dell’anima: la capacità di colloquio con sé stessi, l’attitudine a dare il giusto peso alle emozioni, il gusto di dare forma creativa ai pensieri e forza delicata alle relazioni, anche quando rimaniamo distanti. L’abitudine all’arricchimento della nostra interiorità è la riserva strategica della nostra resilienza alla forzata perdita di mondo. Questa riserva si apprende, si coltiva, si sviluppa affettivamente e culturalmente nell’intero tempo della scuola. (Nessun segno di conversione, su questo punto, è pervenuto: nonostante qualche accorato e motivato appello).
La seconda parola è delicatezza. Delicatezza è un modo di toccare i corpi che crea un contatto con la nostra anima. Lo abbiamo visto: la competenza e l’organizzazione affondano – e ci affondano – nei loro stessi apparati, senza interpreti generosi, all’altezza dell’umana capacità di toccare con delicatezza e maneggiare con cura l’umano. Una società manesca, una società dell’ammucchiata, una società delle tecniche, questa ricchezza dell’umanità la perde più velocemente della discesa del Pil. La delicatezza umana è virtù tipicamente familiare: la sua iniziazione nasce lì, non c’è altro inizio possibile. Il virus lo ha portato allo scoperto: la forma dei legami famigliari ha sopportato il peso maggiore, e retto nel modo più degno, all’aggressione. La grammatica delle relazioni famigliari è più istruttiva ed efficace di qualsiasi prontuario politicamente corretto delle buone maniere. Qualcuno ha intenzione di sostenere politicamente ed economicamente questo rovesciamento di prospettiva, nell’interesse delle giovani generazioni e della comunità tutta?
E la Chiesa? La Chiesa sapeva già da tempo che la parrocchia (Dio la benedica sempre) non è certamente più in grado di contenere neppure tutti i suoi figli battezzati: né tutti i credenti o tutti i lontani e gli estranei che il Signore chiamerebbe. L’opportunità di trarre dal segno apocalittico, che ha fermato il mondo per una buona “mezz’ora” (Apocalisse 8, 1), un cambio di passo ormai quasi obbligato, apre il verso per un tempo favorevole. Deve essere voluto, naturalmente. La piccola comunità eucaristica, ritrovata.
Pierangelo Sequeri
sabato 30 maggio 2020
Dalla pastorale del “campanile” a quella del “campanello”

“Lettera aperta alla parrocchia” di monsignor Gualtiero Sigismondi*– Parrocchia carissima, traendo spunto da don Primo Mazzolari, che nella prima metà del Novecento ha avuto la felice intuizione di scrivere una “Lettera” su di te, ti invio queste righe, che giro per conoscenza a quanti, opportune et importune, parlano della tua missione pastorale.
– C’è chi ne parla con profonda gratitudine, convinto della tua dimensione popolare di vicinanza alle case della gente, di porta d’accesso alla fede cristiana e all’esperienza ecclesiale, ma non del tutto consapevole della tua vocazione missionaria.
– C’è, pure, chi ne parla senza uscire dalla sacrestia o senza allontanarsi dall’ombra del campanile, ignorando la tua dipendenza strutturale dalla Chiesa particolare, a cui è intimamente legata
la tua appartenenza vitale alla Chiesa universale.
– C’è, persino, chi ne parla per conferirti la medaglia d’oro al “valore pastorale”, nella consapevolezza che hai “combattuto la buona battaglia” della salus animarum e hai portato a termine la tua lunga “corsa”, conservando la fede della Chiesa.
– C’è, addirittura, chi ne parla con diffidenza, ritenendoti, se non proprio un “rottame pastorale”, un “pezzo d’antiquariato” o, comunque, un “oggetto da museo”, indicato da questa laconica didascalia: “fontana del villaggio ormai sigillata”.
– C’è, anche, chi ne parla con troppa sicurezza, smaniando di versare “vino nuovo in otri vecchi”, anziché “vino nuovo in otri nuovi” (cf Lc 5,37-39), magari con il lodevole proposito di rinnovarti, ma con il risultato di incrinarti e di spaccarti.
– C’è, infine, chi ne parla con entusiasmo sincero, volendo seguire l’esempio dello scriba di evangelica memoria il quale, divenuto “discepolo del Regno”, «è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche» (Mt 13,52).
Come vedi, carissima parrocchia, sono in molti a tenere fisso lo sguardo su di te, forse con la nostalgia della simpatia, ma non sempre con la lungimiranza della profezia, che unisce alla pazienza dell’attesa l’intelligenza dei “segni dei tempi”.
Non temere né l’intraprendenza di chi ti ritiene inadeguata, né la reticenza di chi ti considera sorpassata e neppure la sufficienza di chi stenta a riconoscere la tua esperienza di lungo corso.
Non sostare nel vicolo cieco della “febbre degli eventi” o del “male della pietra” e non accontentarti di moltiplicare “iniziative prive di iniziativa”, che potrebbero dare l’impressione che tu sia un’azienda pastorale.
Non limitarti a presidiare i confini del tuo territorio, ma abbi l’audacia di presiederlo, riscoprendo la “grammatica di base” del “primo annuncio”. Ricordati che non è il territorio ad appartenere alla parrocchia, ma il contrario, nel duplice senso di farne parte e di prenderne le parti. Renditi conto che l’attenzione alla vita sociale non è separabile dall’impegno ecclesiale. Mi raccomando, prenditi cura dei poveri, “amici abituali della canonica”, e di coloro che si sono allontanati da te per “delusione d’innamorati”.
Parrocchia carissima, non dimenticare che la Parola convoca la comunità cristiana e l’eucaristia la fa essere un solo corpo. Tieni bene a mente che “la fede nasce dall’ascolto e si rafforza nell’annuncio”.
Esplora la “frontiera” della missione coltivando e dilatando gli strumenti e gli spazi della comunione, poiché “la concordia è il presupposto della Pentecoste”.
Valorizza gli organismi di partecipazione, ispirandoti non alla logica parlamentare della maggioranza bensì al criterio sinodale della convergenza. Riconosci la necessità e l’importanza delle unità o comunità pastorali, che non sono sovrastrutture amministrative, ma infrastrutture che contribuiscono a tradurre l’ecclesiologia di comunione del Vaticano II.
Non guardare con alterigia alla pietà popolare, autentico “sistema immunitario del corpo ecclesiale”, ma purificala da eventuali eccessi e rinnovala nei contenuti e nelle forme.
Affida all’oratorio il compito di rivelare il volto e la passione educativa della Chiesa per le nuove generazioni, coinvolgendo animatori, catechisti e genitori. Investi le migliori energie sulla famiglia, vera “miniatura” della Chiesa, altrimenti il tuo impegno pastorale sarà sempre una rincorsa affannosa.
Scommetti sull’Azione cattolica, riconoscendo il suo “carisma popolare” e la sua “passione formativa”, senza trascurare di accogliere il “genio missionario” delle nuove aggregazioni ecclesiali e degli istituti di vita consacrata, antichi e recenti, che assicurano un prezioso supporto di energie evangelizzatrici: guardati dalla tentazione di “spegnere lo Spirito”! (cf 1Ts 5,19).
Non rinunciare al suono delle campane, ma abbi il coraggio di passare dalla pastorale del “campanile” a quella del “campanello” – anche il tuo nome evoca l’idea di “vicinanza” (parà) riferita alla “casa” (oikìa) –, dalla pastorale “a pioggia” di mantenimento a quella “a goccia” di accompagnamento.
Parrocchia carissima, sei tanto venerabile quanto veneranda, e tuttavia tieni presente che “la bellezza di ogni creatura è nella sua capacità di rinnovarsi”.
*Vescovo di Orvieto-Todi e Assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana – articolo pubblicato sul mensile Vita pastorale (maggio/2020)
LA “MESSA” IN SCENA DIGITALE
Si può parlare di bellezza pastorale? O meglio esiste un’estetica dell’agire della
Chiesa?
L’interrogativo sul senso estetico della religione riemerge in modo prepotente, nei giorni dell’emergenza coronavirus, in conseguenza dell’esplosione di un fenomeno parareligioso: il proliferare della presenza di sacerdoti in rete.
Per provare a capire se si tratti di una sorta di nuova “via pulchritudinis” in salsa digitale oppure di una moda passeggera (in molti casi sgraziata), è necessaria una premessa che arricchisca la riflessione estetica con l’analisi sociale e con il pensiero religioso.
La destrutturazione dei tempi e degli spazi religiosi
La presenza online di pratiche religiose è una delle conseguenze dei vari decreti governativi che hanno imposto alla popolazione italiana (e non solo) di trascorrere l’intera giornata in casa. La criticità sanitaria non solo destabilizza certezze acquisite da generazioni, ma riprogramma inevitabilmente i formati dell’esistenza. A partire da due macro-categorie sociali come lo spazio e il tempo: si assiste a una dissoluzione inevitabile dell’agenda sociotemporale che crea un “tempo unico sospeso”, una sorta di calderone nel quale si mischiano e si indeboliscono sia i tempi sociali tradizionali (tempo del lavoro, tempo libero, tempo della formazione) che i cosiddetti interstizi temporali (l’attesa, fretta, la mobilità, la pianificazione del domani, la preghiera).
Stiamo vivendo, pertanto, uno scenario sociale inedito dove il primario e il
marginale non esistono più e nel quale avviene a una vera e propria disgregazione. Isolamenti e quarantene obbligano, quindi, l’individuo a riposizionare il proprio vissuto e (ri)generare pratiche usuali come, ad esempio, quelle ecclesiali. Pastori a ogni ora del giorno (e della notte) “trasferiscono” chiese, altari e tabernacoli in rete offendo celebrazioni, catechesi e momenti di preghiera. Questa trasposizione avviene attraverso dirette social (Facebook, Instagram), messaggi istantanei (WhatsApp, Telegram) o utilizzando una delle tante piattaforme di videoconferenza a disposizione. A queste esperienze pastorali vissute e strutturate online, si aggiunge la condivisione (sempre tramite web) di celebrazioni improvvisate sui terrazzi delle canoniche o di preghiere recitate in una macchina dal volenteroso prete che gira col megafono per le strade cittadine.
Al di là delle ragioni che muovono scelte di questo tipo (la principale è certamente la necessità di farsi presenti spiritualmente), una delle questioni che merita un approfondimento non riguarda la nobile intenzione ma la qualità (estetica e pastorale) della messa in scena di queste prassi.
La “messa” in scena
Un approfondimento di questo tipo non può prescindere da una piccola analisi dello scenario relativo al sacro nei media. Il riferimento principale è rappresentato dalla messa trasmessa in televisione che può essere considerata un vero e proprio format nato con l’inizio delle trasmissioni del piccolo schermo. Non a caso la prima volta andò in onda il 10 gennaio 1954 dalla basilica milanese di San Simpliciano, appena sette giorni dopo l’inizio ufficiale delle trasmissioni della Rai. Da quel momento, ogni domenica e in occasione delle festività religiose più importanti, il telespettatore ha potuto beneficiare di un prodotto costruito appositamente per la programmazione televisiva. Non si tratta infatti di semplici messe in tv ma di “video messe”, ovvero di riti mandati in onda secondo le logiche estetiche, spaziali e temporali del piccolo schermo.
La mediatizzazione del religioso ha,inoltre, una lunga tradizione. Basti citare due esempi abbastanza recenti. Il primo è la celebre ripresa dell’elicottero bianco con cui il dimissionario Papa Benedetto XVI lasciava il Vaticano il 29 febbraio 2013. La scena evocava l’inizio del capolavoro di Fellini La dolce vita, con il Cristo Redentore trasportato in elicottero nel cielo di Roma. Altro caso è rappresentato dalla suggestiva benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco del 27 marzo scorso in una piazza San Pietro per la prima volta vuota, sotto una pioggia battente e un cielo dai colori intensi. In entrambe le situazioni, lo spettatore ha potuto vivere due esperienze reali e autentiche che, grazie alla diretta televisiva, sono risultate dotate di un peculiare fascino narrativo. I due momenti, infatti, si sarebbero svolti comunque, ma la possibilità di trasmetterli in televisione li ha resi delle vere e proprie cerimonie mediali.
Sono diventati – secondo la definizione dei sociologi Dayan e Katz – dei “media events”, ossia delle trasmissioni contraddistinte dalla capacità di stimolare gli spettatori a interrompere la routine quotidiana per un appuntamento irripetibile. Chi li ha guardati ha potuto percepirne i dettagli da diverse prospettive, coglierne i significati profondi, esprimere un giudizio estetico e, infine, farne memoria.
La pastorale grassroots Oggi il concetto di “grande evento mediale” ha perso rilevanza a causa dell’aumento esponenziale degli spazi di partecipazione e dell’enorme disponibilità di strumenti tecnologici iperconnessi.
Ogni individuo, infatti, ha la possibilità di creare eventi personali, diffonderli a un proprio pubblico da cui potrà ricevere feedback immediati in termini di apprezzamento o disapprovazione.
È quello che sta succedendo con le innumerevoli esperienze online che, nelle ultime settimane, caratterizzano la quotidianità pastorale di molti ecclesiastici o religiosi. In molti casi, le narrazioni proposte risultano improvvisate e riflettono la radice amatoriale delle loro pratiche ovvero rientrano in quella che il sociologo francese Patrice Flichy chiama la “sacralizzazione dell’amatore” determinata dalla diffusione, dalla disponibilità e dal facile utilizzo delle tecnologie digitali. Flichy spiega come i media online hanno permesso a un gran numero di individui di vivere più intensamente le loro “passioni ordinarie” contribuendo notevolmente all’ascesa dei dilettanti sulle scene culturali, politiche e scientifiche. Nel nostro caso la dimensione dilettantistica non è riferita al ruolo intrinseco del prete che non è certamente né un professionista né un hobbista della religione, ma si configura come Alter Christus, come un “chiamato da Dio” per diffondere il suo Verbo.
Con il fenomeno “preti online”, emerso dalla necessità di continuare le
funzioni religiose ordinarie, si sta delineando una “pastorale dal basso”, le cui conseguenze in termini di resa estetica sono evidentemente discutibili. Esempi di tali storture sono le inquadrature traballanti, le riprese fuori campo, i primi piani esagerati.
Emblematico è il caso del sacerdote che attiva lo streaming della messa innescando inconsapevolmente i filtri dello smartphone e ritrovandosi, suo malgrado, in testa un casco da robot e il cappello e gli occhiali neri dei Blues Brothers. Lo scenario descritto rimanda, inoltre, a un concetto archetipico della cultura digitale, quello di “grassroots”, ovvero di una produzione mediale dal carattere spontaneo, autoprodotta da non professionisti ma in grado di creare larga partecipazione. La pastorale grassroots è indice di creatività perché permette al proprio specifico di diffondersi rapidamente e di essere accessibile a un gran numero di persone nello stesso momento e in uno stesso luogo (in questo periodo dalla propria abitazione attraverso un dispositivo connesso). Ma al di là degli evidenti benefici spirituali cela delle insidie. Tra queste: il rischio di dimenticare che “l’Eucaristia essendo un grande dono, il più prezioso, necessita di cure e attenzioni”. Sono parole contenute nel documento Celebrare la messa in Tv o in streaming proposto dall’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana. Si tratta di vademecum rivolto a tutti quei sacerdoti, religiosi e religiose e diaconi che hanno deciso (o decideranno) di cimentarsi (spesso con risultati disastrosi) nelle celebrazioni online a seguito della sospensione di quelle in presenza a causa del pericolo di contagio.
Concludendo: per una pastorale digitale
La nota della CEI è strutturata in tre parti. La prima, definita “indicazioni pratiche”, spiega in sette punti come rimodulare e adattare la liturgia durante la trasmissione online. Sono interessanti alcune espressioni scelte dalla Chiesa italiana; tra queste: “lentezza e meditazione” (nel proclamare la Parola di Dio), “dignità e preparazione” (degli spazi liturgici e delle vesti), “formazione” (a una presenza mediata), “diretta e non registrazione” (della celebrazione). La seconda parte include “alcune attenzioni di regia” e suggerisce la metodologia migliore per comporre un’inquadratura con lo smartphone, curare l’audio, le luci e garantire il decoro della celebrazione liturgica. L’ultima parte è una piccola proposta di azione pastorale negli spazi digitali attraverso la presentazione di quattro dimensioni costitutive della comunicazione in rete: la condivisione, l’engagement, l’hashtag e il target.
I suggerimenti della Conferenza Episcopale Italiana sono un utile prontuario
per gestire tecnicamente questo “tsunami spirituale” che ha travolto gli
account social di tanti fedeli orfani delle celebrazioni in presenza. Ma come tutte le guide pratiche rischia di essere recepita dai destinatari più come un tutorial che come un incentivo a conoscere, interpretare e interiorizzare i codici identitari della cultura digitale.
Questo vale sia per coloro che hanno battuto per la prima volta (e sovente con conseguenze tragicomiche) i territori del web sia per coloro che ne sono esperti e realizzano prodotti mediali apparentemente perfetti. È il caso del prete lombardo Alberto Ravagnani che ha scelto di aprire “W la fede”, un canale YouTube proprio il 14 marzo scorso per offrire riflessioni intorno al tema del Covid-19. E lo ha fatto nel migliore dei modi realizzando video pregevoli da un punto di vista tecnico: il suo eloquio è fluido e caratterizzato da tempi precisi, la libreria alle sue spalle ha il giusto livello di sfuocatura, il suo look è impeccabile.
Ma l’eccellenza formale se da un lato determina una fruizione soddisfacente, dall’altro non è sempre garanzia di qualità pastorale. Rischia, cioè, di ridurre l’esperienza religiosa – per citare Balthasar – a una mera “comunicazione di un sapere”, oscurando “la rivelazione dell’azione divina in continuità con la rappresentazione biblica del rapporto Dio-umanità”.
Ecco perché una prassi religiosa realizzata in rete, oltre a fare attenzione ai
particolari tecnico-formali, deve riflettere – usando ancora le parole del teologo svizzero – la “bellezza di Dio”; deve, cioè, superare la logica di un’asettica pastorale della tecnica comunicativa per proiettarsi in una prospettiva che metta al centro la bellezza del dato di fede e riesca a incarnarla nel contesto contemporaneo, caratterizzato dalla presenza e dallo sviluppo dei media digitali, dai fattori della convergenza e dell’interattività. Questo cambio di prospettiva può offrire una prima risposta alle domande poste all’inizio di questo scritto: bellezza pastorale può esistere soltanto se chi la fa è illuminato da un’autentica (e bella) pastoralità, ovvero – scriveva il teologo Sergio Lanza – “da quell’agire rispetto al contesto sociale che si configura come incarnazione dell’esperienza di fede evangelica”. È questo, infine, il presupposto di un’estetica del religioso nel macrocosmo della rete. Perché la bellezza più bella – spiegava in modo illuminante Carlo Maria Martini “non si dice (né si ostenta) ma si si percepisce a partire dalla pace dell’anima sotto lo splendore della luce divina. Per questo Gesù era straordinariamente bello e la sua bellezza si rifletteva sul volto di coloro che erano pronti a seguirlo”.
Massimiliano Padula
Massimiliano Padula è docente di Scienze della Comunicazione sociale alla Pontificia Università
Lateranense.
Perché tutto non sia come prima

Da più parti si comincia a pensare al “dopo”. È presto, ma è anche il modo di non rassegnarsi al presente, di guardare avanti, senza correre, “restando a casa” ma non semplicemente da prigionieri. Questo esercizio di immaginazione, per non essere una fuga, chiede di cominciare a pensare al dopo elaborando il presente, quello che ci sta succedendo.
Da parte mia, non sono certo in grado di prefigurare scenari per il mondo o per la Chiesa.[1] Provo a farlo dal punto di vista di una parrocchia, e delle sue pratiche pastorali che, in questa “sospensione”, sono state messe in discussione, chiedono e possono essere ripensate.
Dopo, che cosa succederà? Torneremo semplicemente a fare le cose di sempre, le liturgie di sempre, il catechismo ecc.? Già prima avevamo la percezione che si dovessero ripensare le pratiche pastorali in nome di un cambiamento d’epoca che stiamo vivendo e nella direzione di una Chiesa “in uscita” come piace dire a Francesco. Ma temo che l’inerzia sarà forte se non sorretta da un pensiero che non faccia passare inutilmente il tempo che stiamo vivendo.
Ho provato allora a fare un semplice esercizio: penso a che cosa è successo al mio ministero di prete in questo tempo sospeso, a come ho dovuto ripensare tutto e rinnovare il modo di accompagnare il cammino di fede della mia comunità. Lo faccio seguendo un ordine quasi cronologico, nel senso che sono le prime cose che mi sembrava mi chiamassero ad agire e a pensare.
L’evidenza della liturgia
La prima evidenza è stata la mancanza dell’eucaristia, in particolare delle celebrazioni domenicali. Come poteva resistere una parrocchia senza l’eucaristia? Che cosa potevo fare io come prete? E già questa è una indicazione preziosa: ci siamo accorti – lo sapevamo, ma forse non così fortemente – che «è l’eucarestia che fa la Chiesa» (secondo l’adagio di un mio saggio professore di teologia), che quel gesto di lasciarci radunare dal Signore è costitutivo, che la fede si vive e si trasmette celebrandola. Abbiamo percepito meglio l’evidenza che l’eucaristia non è una devozione individuale ma un atto comunitario.
Che cosa fare allora? Molti preti si sono buttati a pesce nella strada della trasmissione via streaming delle messe che continuavano a celebrare anche “in assenza di popolo”. Il mio istinto è stato diverso: se il popolo digiuna, digiuno anch’io. Imparo a vivere in attesa, perché senza l’assemblea presente con i corpi e i volti, la celebrazione è monca. Non che sia sbagliato celebrare senza popolo, e infatti, dopo un po’ di settimane, abbiamo deciso di celebrare una volta alla settimana per il popolo – intercedendo per tutti e a suffragio dei defunti – anche per non trasformare questa posizione in un assunto ideologico.
D’altra parte, ho fortemente evitato la trasmissione della messa in streaming. Cosa lecita, certo, e i preti che lo hanno fatto hanno le loro buone ragioni. Ma due cose mi hanno trattenuto: la prima è che mi sembrava sbagliato incrementare la pratica che alla messa si possa “assistere” (termine caro al rito tridentino) come ad uno spettacolo. Dove per altro il prete sembra cercare ancora un ruolo di protagonista che alimenta un certo clericalismo. Alla messa non si assiste, si celebra, si partecipa attivamente.
E poi: esiste solo la messa? Per questo – è la seconda ragione – ho pensato di investire le mie energie nell’aiutare i credenti a “celebrare” nelle case, preparando sussidi, fornendo anche qualche audio che facesse presente la voce della comunità in ogni casa, suggerendo magari di celebrare insieme con le piattaforme che oggi permettono di connettersi con più famiglie. È stato un vero e proprio lavoro, che ha chiesto a me una cura per la celebrazione – e non solo per l’omelia – che normalmente non mettevo in opera; e che ha chiesto ai credenti di attivarsi per celebrare: preparando il luogo, i segni, i tempi… Chi lo ha fatto credo sia cresciuto nel suo vissuto di fede.
Aggiungo un’osservazione circa la predicazione. Pensarla per chi celebra nelle case (con uno scritto e con un audio) mi ha aiutato a contestualizzare molto il commento alla Parola. Accorgendomi come questo tempo di prova è anche un tempo particolarmente intenso, e di come il vissuto della mia gente i loro racconti, le loro vicissitudini, fornissero quel materiale umano condiviso che permetteva di ascoltare in modo nuovo la Parola. Un solo esempio: difficile dire qualcosa su una pagina come la morte di Lazzaro, l’iniziale distanza di Gesù, senza pensare a tutti coloro che stavano vivendo la morte di persone care “a distanza”.
La vita, se la si ascolta e se ci si lascia ferire da essa, amplifica la Parola, dona carne viva alla sua presenza. Sono stato in questi giorni molto debitore alle parole che i racconti mi hanno affidato nelle prove della vita. Non dovrebbe essere sempre così? Non dovremmo preparare insieme la celebrazione di ogni domenica, celebrare insieme il mistero di Cristo dentro le nostre vite?
L’urgenza della carità
Subito si è contemporaneamente imposta una urgenza: che fare per i poveri? All’inizio, quando la sospensione sembrava temporanea, si è fermata la rete di aiuti per le famiglie in difficoltà. Ma non è stato possibile farlo a lungo. I poveri non aspettano, bussano, e sono spesso le persone che per prime pagano il prezzo di una crisi. Così, grazie all’iniziativa di un prete della parrocchia, la rete si è riattivata con nuove modalità: la disponibilità a fare la spesa per chi non poteva uscire di casa; un numero sempre attivo per il Centro di ascolto; l’arrivo di nuovi volontari; l’utilizzo dei social media per contattare e tenere in rete i bisogni; il legame con gli altri Centri di ascolto coordinandosi meglio…
Abbiamo scoperto nuovi modi di stare vicino alle persone in difficoltà e nuove risorse e disponibilità inaspettate di tante persone di buona volontà. La parrocchia si è nuovamente scoperta come un presidio sul territorio molto attento, anche più vicino delle istituzioni civili, al punto che queste, nel tempo di emergenza, fanno riferimento alla parrocchia per avere il polso della situazione reale. Un patrimonio che servirà tantissimo per il futuro. Tutto non sarà come prima.
La catechesi sospesa?
Un capitolo a parte riguarda la catechesi e tutti gli appuntamenti di formazione. Come giustamente qualcuno ha fatto osservare, l’impressione è che la catechesi sia stata semplicemente sospesa: «All’inizio la catechesi è stata quasi senza parole, la liturgia si è mossa prima (…) Per la catechesi, invece, la chiusura delle scuole ha significato la sua chiusura (…) Messaggi del tipo: “la catechesi è sospesa fino a quando la scuola è sospesa”».
È stato proprio così? Certo, le forme normale di catechesi sono state sospese, perché chiedevano il radunarsi di più persone in luoghi chiusi. Ma forse è nato inconsapevolmente un modo nuovo di formare un pensiero a partire dalla fede.
In questi giorni è nata l’esigenza di interpretare il tempo che stiamo vivendo. Una sete, un desiderio di riflessioni, pensieri, interpretazioni che, alla luce della fede, aiutassero a dare un senso, a trovare una saggezza, a tenere viva una speranza, a vivere da credenti il tempo perché diventasse un’occasione, un tempo di grazia.
Questo desiderio ha trovato nuove vie di comunicazione: sono circolate riflessioni, articoli, testimonianze, che poi le persone facevano circolare per mezzo dei social media. Ancora una volta la tecnologia insieme aiuta e rende tutto più difficile.
Nella rete circola anche molta spazzatura, anche molta spazzatura religiosa, forme di “devozionalismo selvaggio”. Abbiamo allora creato dei gruppi whatsApp – alcuni nati spontaneamente tra parrocchiani – che avessero cura di selezionare testi e riflessioni di qualità. Da qui sono nati pensieri e articoli che poi abbiamo raccolto nel giornale parrocchiale in due edizioni speciali nel tempo del Coronavirus. Anche in questo caso – come nella liturgia – la formazione non è stata più a senso unico (il prete parla e gli altri ascoltano) ma si è ingenerato un circolo dove i parrocchiani erano soggetti attivi.
Io stesso ho imparato a misurare i miei interventi (non troppo per non intasare e occupare tutto lo spazio) e mi sono preoccupato di fare una cernita mettendo in circolo il meglio di quello che leggevo (una sorta di ascesi del pensiero). A partire da questi spunti nasce anche il desiderio di confrontarsi, di incontrarsi – per ora via internet – per scambiare le impressioni e le riflessioni, insieme o a piccoli gruppi. Non è forse questa una forma di catechesi? Non potrebbe ispirare nuove modalità di formare un pensiero alla luce della fede? Tutto non potrà essere come prima.
Le relazioni come rete
La terza dimensione è quella comunitaria. Come tenere insieme una parrocchia nel tempo della dispersione? In realtà questo tempo rivela una verità già presente prima: il carattere fragile dell’appartenenza comunitaria. Eravamo già una comunità dispersa, ora lo sentiamo e lo comprendiamo meglio. Quindi, la prima risposta è quella di reggere la mancanza.
«Non possiamo pensare di sconfiggere l’assenza ignorandola, deridendola, scherzandoci, trasgredendola, surrogandola virtualmente. Possiamo solo riconoscerla e darle un significato: tu mi manchi davvero, ma io ti aspetto. Non potrebbe essere questa la consolazione che ci è regalata in questi giorni? La cosa più brutta che ci potrebbe succedere è quando una persona si sente in solitudine e sa che nessuno l’aspetta. La carità di questo periodo potrebbe esprimersi nello scambiarsi piccoli riti che ci ricordano che siamo soli, ma attesi».
Da questa mancanza è nato anche il desiderio di farsi vicini pur nella distanza. Non sono mai stato così tanto al telefono, e con conversazioni così intense, lontane dalla banalità, piene di vita. Sono stati giorni nei quali cercarsi: tra preti, con amici lontani e vicini, con i parrocchiani, sia con i collaboratori più stretti che con le persone anziane più bisognose di una parola, che con le persone che vivevano circostanze difficili (il contagio, la perdita di persone care). E questo è diventato uno stile condiviso.
Perché tutto non sia come prima
Ho chiesto che tutti facessero di questo un compito: farsi vicini, creare una rete di fraternità, far sentire a più persone che ci mancano e che le attendiamo. Anche in questo caso la fraternità non è più una preoccupazione dei soli preti, ma diventa una responsabilità di molti nella comunità. Diventa evidente ciò che è sempre vero: il senso di appartenenza, il legame fraterno in una parrocchia passa non solo dai preti, ma dalla qualità delle relazioni che ogni credente impara a costruire come responsabilità verso tutta la comunità.
Non so come riprenderemo il cammino al termine di questa pandemia. So che il dopo comincia adesso, che quello che stiamo imparando segna una traccia che ci insegnerà quali percorsi reinventare, che cosa potremo cambiare, che cosa non sarà necessario rifare, e che cosa dovremo riscrivere in modo nuovo. Il domani comincia oggi.
[1] Ho trovato molto stimolanti le riflessioni di alcuni e-book (iniziativa lodevole) di due case editrici che hanno con prontezza offerto chiavi di lettura: José Tolentino Mendonça, Il potere della speranza. Mani che sostengono l’anima del mondo, Vita e Pensiero. Tomáš Halík, Il segno delle chiese vuote. Per una ripartenza del cristianesimo, Vita e Pensiero; Centro Fede e Cultura “Alberto Hurtado”, Vedo la notte che accende le stelle. Sentieri in tempo di pandemia, EDB.
XXXV Giornata Mondiale della Gioventù: “Giovane, dico a te, alzati!”.

CITTÀ DEL VATICANO , 05 aprile, 2020 / 11:56 AM (ACI Stampa).-
“Dio ci ha salvato servendoci. In genere pensiamo di essere noi a servire Dio. No, è Lui che ci ha serviti gratuitamente, perché ci ha amati per primo. È difficile amare senza essere amati. Ed è ancora più difficile servire se non ci lasciamo servire da Dio”.
Papa Francesco lo ha detto nella riflessione proposta nella celebrazione della Domenica delle Palme.
Una celebrazione surreale nella basilica vaticana vuota e all’altare della Cattedra. La emergenza sanitaria ha indotto a questa scelta anche il Papa. Nel presbiterio sono stati collocati il Crocifisso di San Marcello e la Salus Populi Romani.
Il rito della Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme si è svolto ai piedi dell’Altare della Confessione, verso la Cattedra, dove è stato allestito un addobbo di palme e ulivi.
Francesco prosegue la sua riflessione: “Dio ci ha salvati lasciando che il nostro male si accanisse su di Lui. Senza reagire, solo con l’umiltà, la pazienza e l’obbedienza del servo, esclusivamente con la forza dell’amore”.
E le prove più dolorose sono quelle del tradimento e dell’abbandono, dice Papa Francesco. Un tradimento che sperimentiamo anche noi e “nasce in fondo al cuore una
delusione tale, per cui la vita sembra non avere più senso. Questo succede perché siamo nati per essere amati e per amare, e la cosa più dolorosa è venire traditi da chi ha promesso di esserci leale e vicino”.
Ma noi per primi dice il Papa, siamo traditori: “Se siamo sinceri con noi stessi, vedremo le nostre infedeltà. Quante falsità, ipocrisie e doppiezze! Quante buone intenzioni tradite! Quante promesse non mantenute! Quanti propositi lasciati svanire!”.
Ma il Signore ci conosce, e “ci ha guariti prendendo su di sé le nostre infedeltà, togliendoci i nostri tradimenti. Così che noi, anziché scoraggiarci per la paura di non farcela, possiamo alzare lo sguardo verso il Crocifisso, ricevere il suo abbraccio”.
E poi c’è l’abbandono: “Gesù aveva sofferto l’abbandono dei suoi, che erano fuggiti. Ma gli rimaneva il Padre”. E tutto questo dice il Papa lo ha fatto per noi “perché quando ci sentiamo con le
spalle al muro, quando ci troviamo in un vicolo cieco, senza luce e via di uscita, quando sembra che perfino Dio non risponda, ci ricordiamo di non essere soli”.
E allora anche oggi “nel dramma della pandemia, di fronte a tante certezze che si sgretolano, di fronte a tante aspettative tradite, nel senso di abbandono che ci stringe il cuore, Gesù dice a ciascuno: “Coraggio: apri il cuore al mio amore. Sentirai la consolazione di Dio, che ti sostiene”.
Allora quale deve essere la risposta dell’uomo ? “Possiamo non tradire quello per cui siamo stati creati, non abbandonare ciò che conta. Siamo al mondo per amare Lui e gli altri. Il resto passa, questo rimane. Il dramma che stiamo attraversando ci spinge a prendere sul serio quel che è serio, a non perderci in cose di poco conto; a riscoprire che la vita non serve se non si serve. Perché la vita si misura sull’amore. Allora, in questi giorni santi, a casa, stiamo davanti al Crocifisso, misura dell’amore di Dio per noi. Davanti a Dio che ci serve fino a dare la vita, chiediamo la grazia di vivere per servire. Cerchiamo di contattare chi soffre, chi è solo e bisognoso. Non pensiamo solo a quello che ci manca, ma al bene che possiamo fare”.
E il Papa conclude con un pensiero per i giovani, visto che oggi si celebra la XXXV Giornata Mondiale della Gioventù, quest’anno a livello diocesano, sul tema: “Giovane, dico a te, alzati!”.
“Certo, amare, pregare, perdonare, prendersi cura degli altri, in famiglia come nella società, può costare. Può sembrare una via crucis. Ma la via del servizio è la via vincente, che ci ha salvati e che ci salva la vita. Vorrei dirlo specialmente ai giovani, in questa Giornata che da 35 anni è dedicata a loro. Cari amici, guardate ai veri eroi, che in questi giorni vengono alla luce: non sono quelli che hanno fama, soldi e successo, ma quelli che danno sé stessi per servire gli altri.
Sentitevi chiamati a mettere in gioco la vita. Non abbiate paura di spenderla per Dio e per gli altri, ci guadagnerete! Perché la vita è un dono che si riceve donandosi. E perché la gioia più grande è dire sì all’amore, senza se e senza ma. Come Gesù per noi”.
Insieme sulla stessa barca
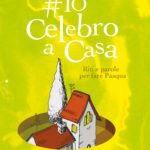
Uscire a seminare: questa l’idea di un gruppo di amici che in questo passaggio storico così difficile vuole offrire le sensibilità, le idee, le riflessioni di uno sguardo credente a chi voglia lasciarsi interrogare dallo stravolgimento determinato dalla pandemia del Covid-19.
Uscire a seminare: nei campi della coscienza e dell’intelligenza delle cose, per condividere il desiderio di scendere in profondità nei giorni che viviamo, guardandoli alla luce del Vangelo come esperienza, certo dolorosa ma autentica, dell’umano.
Uscire a seminare: una lettera, un sussidio per il Triduo pasquale, un instant-book, materiali che sono semplici suggerimenti per allargare e arricchire una riflessione sull’oggi che non può essere solitaria ma deve farsi costruzione del sentire del Popolo di Dio che si scopre parte dell’umanità e del pianeta di cui abbiamo la responsabilità.













