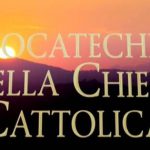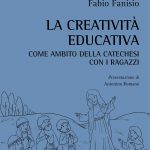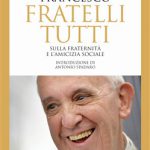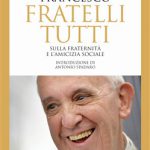
Fraternità e amicizia sociale sono le vie indicate dal Pontefice per costruire un mondo migliore, più giusto e pacifico, con l’impegno di tutti: popolo e istituzioni. Ribadito con forza il no alla guerra e alla globalizzazione dell’indifferenza
Isabella Piro – Città del Vaticano
Quali sono i grandi ideali ma anche le vie concretamente percorribili per chi vuole costruire un mondo più giusto e fraterno nelle proprie relazioni quotidiane, nel sociale, nella politica, nelle istituzioni? Questa la domanda a cui intende rispondere, principalmente, “Fratelli tutti”: il Papa la definisce una “Enciclica sociale” (6) che mutua il titolo dalle “Ammonizioni” di San Francesco d’Assisi, che usava quelle parole “per rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle e proporre loro una forma di vita dal sapore di Vangelo” (1).
Sulla tomba di san Francesco il Papa firma “Fratelli tutti”
Il Poverello “non faceva la guerra dialettica imponendo dottrine, ma comunicava l’amore di Dio”, scrive il Papa, ed “è stato un padre fecondo che ha suscitato il sogno di una società fraterna” (2-4). L’Enciclica mira a promuovere un’aspirazione mondiale alla fraternità e all’amicizia sociale. A partire dalla comune appartenenza alla famiglia umana, dal riconoscerci fratelli perché figli di un unico Creatore, tutti sulla stessa barca e dunque bisognosi di prendere coscienza che in un mondo globalizzato e interconnesso ci si può salvare solo insieme. Motivo ispiratore più volte citato è il Documento sulla fratellanza umana firmato da Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar nel febbraio 2019.
La fraternità è da promuovere non solo a parole, ma nei fatti. Fatti che si concretizzano nella “politica migliore”, quella non sottomessa agli interessi della finanza, ma al servizio del bene comune, in grado di porre al centro la dignità di ogni essere umano e di assicurare il lavoro a tutti, affinché ciascuno possa sviluppare le proprie capacità. Una politica che, lontana dai populismi, sappia trovare soluzioni a ciò che attenta contro i diritti umani fondamentali e che punti ad eliminare definitivamente la fame e la tratta. Al contempo, Papa Francesco sottolinea che un mondo più giusto si raggiunge promuovendo la pace, che non è soltanto assenza di guerra, ma una vera e propria opera “artigianale” che coinvolge tutti.
Guardare gli altri come fratelli e sorelle per salvare noi e il mondo
Legate alla verità, la pace e la riconciliazione devono essere “proattive”, puntare alla giustizia attraverso il dialogo, in nome dello sviluppo reciproco. Di qui deriva la condanna che il Pontefice fa della guerra, “negazione di tutti i diritti” e non più pensabile neanche in una ipotetica forma “giusta”, perché ormai le armi nucleari, chimiche e biologiche hanno ricadute enormi sui civili innocenti. Forte anche il rifiuto della pena di morte, definita “inammissibile”, e centrale il richiamo al perdono, connesso al concetto di memoria e di giustizia: perdonare non significa dimenticare, scrive il Pontefice, né rinunciare a difendere i propri diritti per custodire la propria dignità, dono di Dio. Sullo sfondo dell’Enciclica c’è la pandemia da Covid-19 che – rivela Francesco – “ha fatto irruzione in maniera inattesa proprio mentre stavo scrivendo questa lettera”. Ma l’emergenza sanitaria globale è servita a dimostrare che “nessuno si salva da solo” e che è giunta davvero l’ora di “sognare come un’unica umanità” in cui siamo “tutti fratelli” (7-8).
Problemi globali esigono azioni globali, no alla “cultura dei muri”
Aperta da una breve introduzione e articolata in otto capitoli, l’Enciclica raccoglie – come spiega il Papa stesso – molte delle sue riflessioni sulla fraternità e l’amicizia sociale, collocate però “in un contesto più ampio” e integrate da “numerosi documenti e lettere” inviate a Francesco da “tante persone e gruppi di tutto il mondo” (5). Nel primo capitolo, “Le ombre di un mondo chiuso”, il documento si sofferma sulle tante storture dell’epoca contemporanea: la manipolazione e la deformazione di concetti come democrazia, libertà, giustizia; la perdita del senso del sociale e della storia; l’egoismo e il disinteresse per il bene comune; la prevalenza di una logica di mercato fondata sul profitto e la cultura dello scarto; la disoccupazione, il razzismo, la povertà; la disparità dei diritti e le sue aberrazioni come la schiavitù, la tratta, le donne assoggettate e poi forzate ad abortire, il traffico di organi (10-24). Si tratta di problemi globali che esigono azioni globali, sottolinea il Papa, lanciando l’allarme anche contro una “cultura dei muri” che favorisce il proliferare delle mafie, alimentate da paura e solitudine (27-28). Inoltre, oggi si riscontra un deterioramento dell’etica (29) cui contribuiscono, in un certo qual modo, i mass-media che sgretolano il rispetto dell’altro ed eliminano ogni pudore, creando circoli virtuali isolati e autoreferenziali, nei quali la libertà è un’illusione e il dialogo non è costruttivo (42-50).
L’amore costruisce ponti: l’esempio del Buon Samaritano
A tante ombre, tuttavia, l’Enciclica risponde con un esempio luminoso, foriero di speranza: quello del Buon Samaritano. A questa figura è dedicato il secondo capitolo, “Un estraneo sulla strada”, in cui il Papa sottolinea che, in una società malata che volta le spalle al dolore e che è “analfabeta” nella cura dei deboli e dei fragili (64-65), tutti siamo chiamati – proprio come il buon samaritano – a farci prossimi all’altro (81), superando pregiudizi, interessi personali, barriere storiche o culturali. Tutti, infatti, siamo corresponsabili nella costruzione di una società che sappia includere, integrare e sollevare chi è caduto o è sofferente (77). L’amore costruisce ponti e noi “siamo fatti per l’amore” (88), aggiunge il Papa, esortando in particolare i cristiani a riconoscere Cristo nel volto di ogni escluso (85). Il principio della capacità di amare secondo “una dimensione universale” (83) è ripreso anche nel terzo capitolo, “Pensare e generare un mondo aperto”: in esso, Francesco ci esorta ad “uscire da noi stessi” per trovare negli altri “un accrescimento di essere” (88), aprendoci al prossimo secondo il dinamismo della carità che ci fa tendere verso la “comunione universale” (95). In fondo – ricorda l’Enciclica – la statura spirituale della vita umana è definita dall’amore che “è sempre al primo posto” e ci porta a cercare il meglio per la vita dell’altro, lontano da ogni egoismo (92-93).
I diritti non hanno frontiere, serve etica delle relazioni internazionali
Una società fraterna, dunque, sarà quella che promuove l’educazione al dialogo per sconfiggere “il virus dell’individualismo radicale” (105) e per permettere a tutti di dare il meglio di sé. A partire dalla tutela della famiglia e dal rispetto per la sua “missione educativa primaria e imprescindibile” (114). Due, in particolare, gli ‘strumenti’ per realizzare questo tipo di società: la benevolenza, ossia il volere concretamente il bene dell’altro (112), e la solidarietà che ha cura delle fragilità e si esprime nel servizio alle persone e non alle ideologie, lottando contro povertà e disuguaglianze (115). Il diritto a vivere con dignità non può essere negato a nessuno, afferma ancora il Papa, e poiché i diritti sono senza frontiere, nessuno può rimanere escluso, a prescindere da dove sia nato (121). In quest’ottica, il Pontefice richiama anche a pensare ad “un’etica delle relazioni internazionali” (126), perché ogni Paese è anche dello straniero ed i beni del territorio non si possono negare a chi ha bisogno e proviene da un altro luogo. Il diritto naturale alla proprietà privata sarà, quindi, secondario al principio della destinazione universale dei beni creati (120). Una sottolineatura specifica l’Enciclica la fa anche per la questione del debito estero: fermo restando il principio che esso va saldato, si auspica tuttavia che ciò non comprometta la crescita e la sussistenza dei Paesi più poveri (126).
Migranti: governance globale per progetti a lungo termine
Al tema delle migrazioni è, invece, dedicato in parte il secondo e l’intero quarto capitolo, “Un cuore aperto al mondo intero”: con le loro “vite lacerate” (37), in fuga da guerre, persecuzioni, catastrofi naturali, trafficanti senza scrupoli, strappati alle loro comunità di origine, i migranti vanno accolti, protetti, promossi ed integrati. Bisogna evitare le migrazioni non necessarie, afferma il Pontefice, creando nei Paesi di origine possibilità concrete di vivere con dignità. Ma al tempo stesso, bisogna rispettare il diritto a cercare altrove una vita migliore. Nei Paesi destinatari, il giusto equilibrio sarà quello tra la tutela dei diritti dei cittadini e la garanzia di accoglienza e assistenza per i migranti (38-40). Nello specifico, il Papa indica alcune “risposte indispensabili” soprattutto per chi fugge da “gravi crisi umanitarie”: incrementare e semplificare la concessione di visti; aprire corridoi umanitari; assicurare alloggi, sicurezza e servizi essenziali; offrire possibilità di lavoro e formazione; favorire i ricongiungimenti familiari; tutelare i minori; garantire la libertà religiosa e promuovere l’inserimento sociale. Dal Papa anche l’invito a stabilire, nella società, il concetto di “piena cittadinanza”, rinunciando all’uso discriminatorio del termine “minoranze” (129-131). Ciò che occorre soprattutto – si legge nel documento – è una governance globale, una collaborazione internazionale per le migrazioni che avvii progetti a lungo termine, andando oltre le singole emergenze (132), in nome di uno sviluppo solidale di tutti i popoli che sia basato sul principio della gratuità. In tal modo, i Paesi potranno pensare come “una famiglia umana” (139-141). L’altro diverso da noi è un dono ed un arricchimento per tutti, scrive Francesco, perché le differenze rappresentano una possibilità di crescita (133-135). Una cultura sana è una cultura accogliente che sa aprirsi all’altro, senza rinunciare a se stessa, offrendogli qualcosa di autentico. Come in un poliedro – immagine cara al Pontefice – il tutto è più delle singole parti, ma ognuna di esse è rispettata nel suo valore (145-146).
La politica, una delle forme più preziose della carità
Il tema del quinto capitolo è “La migliore politica”, ossia quella che rappresenta una delle forme più preziose della carità perché si pone al servizio del bene comune (180) e conosce l’importanza del popolo, inteso come categoria aperta, disponibile al confronto e al dialogo (160). Questo è, in un certo senso, il popolarismo indicato da Francesco, cui si contrappone quel “populismo” che ignora la legittimità della nozione di ‘popolo’, attraendo consensi per strumentalizzarlo al proprio servizio e fomentando egoismi per accrescere la propria popolarità (159). Ma la migliore politica è anche quella che tutela il lavoro, “dimensione irrinunciabile della vita sociale” e cerca di assicurare a tutti la possibilità di sviluppare le proprie capacità (162). L’aiuto migliore per un povero, spiega il Pontefice, non è solo il denaro, che è un rimedio provvisorio, bensì il consentirgli una vita degna mediante l’attività lavorativa. La vera strategia anti-povertà non mira semplicemente a contenere o a rendere inoffensivi gli indigenti, bensì a promuoverli nell’ottica della solidarietà e della sussidiarietà (187). Compito della politica, inoltre, è trovare una soluzione a tutto ciò che attenta contro i diritti umani fondamentali, come l’esclusione sociale; il traffico di organi, tessuti, armi e droga; lo sfruttamento sessuale; il lavoro schiavo; il terrorismo ed il crimine organizzato. Forte l’appello del Papa ad eliminare definitivamente la tratta, “vergogna per l’umanità”, e la fame, in quanto essa è “criminale” perché l’alimentazione è “un diritto inalienabile” (188-189).
Il mercato da solo non risolve tutto. Occorre riforma dell’ONU
La politica di cui c’è bisogno, sottolinea ancora Francesco, è quella che dice no alla corruzione, all’inefficienza, al cattivo uso del potere, alla mancanza di rispetto delle leggi (177). È una politica incentrata sulla dignità umana e non sottomessa alla finanza perché “il mercato da solo non risolve tutto”: le “stragi” provocate dalle speculazioni finanziarie lo hanno dimostrato (168). Assumono, quindi, particolare rilevanza i movimenti popolari: veri “poeti sociali” e “torrenti di energia morale”, essi devono essere coinvolti nella partecipazione sociale, politica ed economica, previo però un maggior coordinamento. In tal modo – afferma il Papa – si potrà passare da una politica “verso” i poveri ad una politica “con” e “dei” poveri (169). Un altro auspicio presente nell’Enciclica riguarda la riforma dell’Onu: di fronte al predominio della dimensione economica che annulla il potere del singolo Stato, infatti, il compito delle Nazioni Unite sarà quello di dare concretezza al concetto di “famiglia di nazioni” lavorando per il bene comune, lo sradicamento dell’indigenza e la tutela dei diritti umani. Ricorrendo instancabilmente “al negoziato, ai buoni uffici e all’arbitrato” – afferma il documento pontificio – l’Onu deve promuovere la forza del diritto sul diritto della forza, favorendo accordi multilaterali che tutelino al meglio anche gli Stati più deboli (173-175).
Il miracolo della gentilezza
Dal sesto capitolo, “Dialogo e amicizia sociale”, emerge inoltre il concetto di vita come “arte dell’incontro” con tutti, anche con le periferie del mondo e con i popoli originari, perché “da tutti si può imparare qualcosa e nessuno è inutile” (215). Il vero dialogo, infatti, è quello che permette di rispettare il punto di vista dell’altro, i suoi interessi legittimi e, soprattutto, la verità della dignità umana. Il relativismo non è una soluzione– si legge nell’Enciclica – perché senza principi universali e norme morali che proibiscono il male intrinseco, le leggi diventano solo imposizioni arbitrarie (206). In quest’ottica, un ruolo particolare spetta ai media che, senza sfruttare le debolezze umane o tirare fuori il peggio di noi, devono orientarsi all’incontro generoso e alla vicinanza agli ultimi, promuovendo la prossimità ed il senso di famiglia umana (205). Particolare, poi, il richiamo del Papa al “miracolo della gentilezza”, un’attitudine da recuperare perché è “una stella nell’oscurità” e una “liberazione dalla crudeltà, dall’ansietà e dall’urgenza distratta” che prevalgono in epoca contemporanea. Una persona gentile, scrive Francesco, crea una sana convivenza ed apre le strade là dove l’esasperazione distrugge i ponti (222-224).
L’artigianato della pace e l’importanza del perdono
Riflette sul valore e la promozione della pace, invece, il settimo capitolo, “Percorsi di un nuovo incontro”, in cui il Papa sottolinea che la pace è legata alla verità, alla giustizia ed alla misericordia. Lontana dal desiderio di vendetta, essa è “proattiva” e mira a formare una società basata sul servizio agli altri e sul perseguimento della riconciliazione e dello sviluppo reciproco (227-229). In una società, ognuno deve sentirsi “a casa” – scrive il Papa – Per questo, la pace è un “artigianato” che coinvolge e riguarda tutti e in cui ciascuno deve fare la sua parte. Il compito della pace non dà tregua e non ha mai fine, continua il Pontefice, ed occorre quindi porre al centro di ogni azione la persona umana, la sua dignità ed il bene comune (230-232). Legato alla pace c’è il perdono: bisogna amare tutti, senza eccezioni – si legge nell’Enciclica – ma amare un oppressore significa aiutarlo a cambiare e non permettergli di continuare ad opprimere il prossimo. Anzi: chi patisce un’ingiustizia deve difendere con forza i propri diritti per custodire la propria dignità, dono di Dio (241-242). Perdono non vuol dire impunità, bensì giustizia e memoria, perché perdonare non significa dimenticare, ma rinunciare alla forza distruttiva del male ed al desiderio di vendetta. Mai dimenticare “orrori” come la Shoah, i bombardamenti atomici a Hiroshima e Nagasaki, le persecuzioni ed i massacri etnici – esorta il Papa – Essi vanno ricordati sempre, nuovamente, per non anestetizzarci e mantenere viva la fiamma della coscienza collettiva. Altrettanto importante è fare memoria del bene, di chi ha scelto il perdono e la fraternità (246-252).
Mai più la guerra, fallimento dell’umanità!
Una parte del settimo capitolo si sofferma, poi, sulla guerra: essa non è “un fantasma del passato” – sottolinea Francesco – bensì “una minaccia costante” e rappresenta la “negazione di tutti i diritti”, “il fallimento della politica e dell’umanità”, “la resa vergognosa alle forze del male” ed al loro “abisso”. Inoltre, a causa delle armi nucleari, chimiche e biologiche che colpiscono molti civili innocenti, oggi non si può più pensare, come in passato, ad una possibile “guerra giusta”, ma bisogna riaffermare con forza “Mai più la guerra!” E considerando che viviamo “una terza guerra mondiale a pezzi”, perché tutti i conflitti sono connessi tra loro, l’eliminazione totale delle armi nucleari è “un imperativo morale ed umanitario”. Piuttosto – suggerisce il Papa – con il denaro che si investe negli armamenti, si costituisca un Fondo mondiale per eliminare la fame (255-262).
Pena di morte è inammissibile, abolirla in tutto il mondo
Una posizione altrettanto netta Francesco la esprime a proposito della pena di morte: è inammissibile e deve essere abolita in tutto il mondo. “L’omicida non perde la sua dignità personale – scrive il Papa – Dio ne è garante”. Di qui, due esortazioni: non vedere la pena come una vendetta, bensì come parte di un processo di guarigione e di reinserimento sociale, e migliorare le condizioni delle carceri, nel rispetto della dignità umana dei detenuti, pensando anche che l’ergastolo “è una pena di morte nascosta” (263-269). Viene ribadita la necessità di rispettare “la sacralità della vita” (283) laddove oggi “certe parti dell’umanità sembrano sacrificabili”, come i nascituri, i poveri, i disabili, gli anziani (18).
Garantire libertà religiosa, diritto umano fondamentale
Nell’ottavo e ultimo capitolo, il Pontefice si sofferma su “Le religioni al servizio della fraternità nel mondo” e ribadisce che la violenza non trova base alcuna nelle convinzioni religiose, bensì nelle loro deformazioni. Atti “esecrabili” come quelli terroristici, dunque, non sono dovuti alla religione, ma ad interpretazioni errate dei testi religiosi, nonché a politiche di fame, povertà, ingiustizia, oppressione. Il terrorismo non va sostenuto né con il denaro, né con le armi, né tanto meno con la copertura mediatica perché è un crimine internazionale contro la sicurezza e la pace mondiale e come tale va condannato (282-283). Al contempo, il Papa sottolinea che un cammino di pace tra le religioni è possibile e che è, dunque, necessario garantire la libertà religiosa, diritto umano fondamentale per tutti i credenti (279). Una riflessione, in particolare, l’Enciclica la fa sul ruolo della Chiesa: essa non relega la propria missione nel privato – afferma – non sta ai margini della società e, pur non facendo politica, tuttavia non rinuncia alla dimensione politica dell’esistenza. L’attenzione al bene comune e la preoccupazione allo sviluppo umano integrale, infatti, riguardano l’umanità e tutto ciò che è umano riguarda la Chiesa, secondo i principî evangelici (276-278). Infine, richiamando i leader religiosi al loro ruolo di “mediatori autentici” che si spendono per costruire la pace, Francesco cita il “Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza”, da lui stesso firmato il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi, insieme al Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib: da tale pietra miliare del dialogo interreligioso, il Pontefice riprende l’appello affinché, in nome della fratellanza umana, si adotti il dialogo come via, la collaborazione comune come condotta e la conoscenza reciproca come metodo e criterio (285).
Il Beato Charles de Foucauld, “il fratello universale”
L’Enciclica si conclude con il ricordo di Martin Luther King, Desmond Tutu, il Mahatma Gandhi e soprattutto il Beato Charles de Foucauld, un modello per tutti di cosa significhi identificarsi con gli ultimi per divenire “il fratello universale” (286-287). Le ultime righe del documento sono affidate a due preghiere: una “al Creatore” e l’altra “cristiana ecumenica”, affinché nel cuore degli uomini alberghi “uno spirito di fratelli”.
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-10/enciclica-fratelli-tutti-papa-francesco-sintesi-fraternita.html

SCARICA:
Fratelli tutti Lettera Enciclica Francesco
Conferenza sulla Lettera Enciclica Fratelli tutti