
dai membri dell’Istituto di Catechetica


La sezione Novità con le sue rubriche tiene aggiornati gli educatori sulle novità che: negli eventi, nell’editoria e nel cinema interessano l’educazione religiosa.

Lectio – Anno C
Prima lettura: Gen 3,9-15.20
| [Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frutto dell’albero,] il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici! Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. |
Essa contiene soprattutto l’annunzio di una prospettiva di salvezza per l’umanità rappresentata dalla prima coppia umana. L’annunzio è preceduto da un dialogo in cui Dio mette in evidenza l’effetto distruttore del peccato (la rottura del vincolo di dipendenza da Dio, suggerita dal serpente, che prometteva di far diventare gli uomini come Dio, se si fossero ribellati alle sue leggi): perdita del rapporto amicale con Dio, inizio della diffidenza reciproca tra l’uomo e la donna, ingresso della fatica e del dolore nella vita umana, necessità di lottare sempre contro l’insidia perenne del peccato.
L’annunzio apre la prospettiva che, nel futuro, il seme dell’uomo avrebbe sconfitto il seme del serpente. Il sentimento cristiano, guidato da una interpretazione libera di questo testo documentata dalla Volgata, ha capito che, in questa prospettiva di futura vittoria, un posto speciale spettava a Maria.
Seconda lettura: Ef 1,3-6.11-12
| Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà – a essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. |
Vangelo: Lc 1,26-38
| In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. |
Esegesi
Tra i testi del Nuovo Testamento che ci parlano di Maria, la madre del Salvatore, il racconto dell’Annunciazione di Gesù è certamente il più ricco di teologia, sicché ad esso si è sempre ispirato lo speciale settore dell’approfondimento teologico che è detto mariologia. Cerchiamo di cogliere questa ricchezza, partendo dall’analisi esegetica dei singoli versetti.
Nei vv. 26-27, l’evangelista stabilisce un rapporto di netta continuità tra il già descritto annuncio della nascita del precursore (Lc l,5ss) e la scena che si accinge a descrivere: ogni singolo avvenimento della storia della salvezza si inquadra perfettamente in un disegno generale concepito e realizzato da Dio. In questo disegno si fronteggiano la grandezza insondabile di Dio, che manda come suo messaggero l’angelo Gabriele (un personaggio a cui nel libro di Daniele era stata affidata una missione riguardante gli avvenimenti messianici), e la piccolezza apparentemente insignificante di Nazareth di Galilea e di una oscura fanciulla che si chiama Maria, promessa sposa di un certo Giuseppe (solo in quest’ultimo personaggio c’è un barlume di riconosciuta nobiltà, perché discende dalla cosa di Davide).
Di Maria è qui sottolineato per ben due volte lo stato di verginità. Per Giuseppe è richiamata la sua appartenenza alla cosa di Davide, da cui doveva venire il Messia.
— Nel v. 28, il saluto dell’angelo, chàire, non è un semplice sinonimo del comune shalom (pace), ma sembra voglia evocare l’accenno alla gioia messianica a cui nei profeti è invitata la figlia di Sion (che significa la nazione ebraica), nell’imminenza dei tempi messianici (Sof 3.14; Gl 2,21.23; Zac 9.9). Il titolo kecharitoméne, con cui Maria è gratificata dall’angelo, non ha certamente il senso di un gentile appellativo (equivalente a una bella fanciulla!), ma sembra si voglia riferire alla missione che a lei Dio vuole affidare e si può ben tradurre: trasformata dal favore divino; la traduzione della Volgata, piena di grazia, rende giustizia alla densità teologica del vocabolo e ha indotto il popolo cristiano a trovare qui incluso un accenno alla verità dell’immacolata concezione. A quella stessa missione sembra debba riferirsi la frase il Signore è con tè; era questa infatti la formula con cui si dava incoraggiamento, nei libri dell’Antico Testamento, ai personaggi scelti da Dio per una qualche missione speciale (Isacco, in Gn 26,3.24; Giacobbe in Gn 28,15; Mosè, in Es 3,12; Gedeone, in Gdc 6,12; ecc.).
— Nel v. 29, il turbamento di Maria, diversamente da quanto è detto per Zaccaria in 1,12, non deriva dalla visione dell’angelo, ma dal senso delle sue parole: Maria dimostra così la sua iniziale consapevolezza di trovarsi davanti a qualcosa di misterioso.
— Nei vv. 30-31, l’angelo, dopo averle rivolto un incoraggiamento, rivela a Maria la missione che Dio vuole affidarle: con parole che richiamano alla mente il testo di Is 7,14, le è detto che essa dovrà dare alla luce un figlio del quale Dio stesso ha già stabilito il nome. L’importanza di questo figlio è già oscuramente accennata nell’implicito riferimento al testo di Isaia e nel fatto che il suo nome è direttamente scelto da Dio.
— Nei vv. 32-33, è dichiarata apertamente la straordinaria identità del futuro figlio di Maria. Questo figlio è descritto con chiaro riferimento al testo di 2Sam 7,8-16: da lì sono presi i termini grande… figlio (di Dio) …cosa… regno (i Davide) …regno senza fine. Il figlio di Maria è qui qualificato come il Messia atteso dai Giudei, ma già il senso delle parole adoperate in ambiente giudaico sembra dilatarsi per accogliere la nuova prospettiva cristiana.
— I vv. 34-35 difficilmente potrebbero spiegarsi, se si intendessero come battute stenografiche di un dialogo tra l’angelo e Maria. Sono però chiarissimi nel trasmetterci il messaggio rivelato che il figlio di Maria è stato concepito verginalmente, cioè senza il contributo di un padre terreno, e che questo stesso figlio di Maria è propriamente figlio di Dio fin dalla sua origine, cioè non in conseguenza della sua elezione alla dignità messianica, ma, grazie alla potenza creatrice dello Spirito Santo, fin dal momento della sua prodigiosa concezione.
— Nei vv. 36-37, l’angelo conferma l’eccezionalità dell’avvenimento annunziato, fornendo un segno capace di renderlo credibile: rivela a Maria la notizia ancora sconosciuta da tutti, che la sterile Elisabetta è diventata feconda nella sua vecchiaia, a dimostrazione che nulla è impossibile a Dio.
— Nel v. 38, che conclude il racconto, l’evangelista ci fa capire che Maria ha pienamente inteso l’alta missione che le è stata affidata, al punto che mette sulle sue labbra parole evocanti alte personalità dell’Antica Alleanza (Abramo, Mosè, Davide, il misterioso Servo di JHWH), che avevano meritato il titolo onorifico di servi del Signore. Proclamandosi serva di Dio, Maria è ben lontana dall’esprimere una semplice rassegnazione a oscuri disegni divini, dichiara piuttosto di essere gioiosamente pronta a collaborare alla imminente salvezza del mondo portata dal suo figlio Gesù.
Dall’esame analitico dei singoli versetti emerge la conclusione che il racconto di Luca ha come scopo principale quello di rivelarci l’identità messianica del figlio di Maria, che però è anche, a titolo specialissimo, figlio di Dio sin dalla sua concezione. In secondo luogo, il racconto ci parla della missione affidata a Maria, sottolineando soprattutto due cose: che l’iniziativa di quanto dovrà accadere appartiene esclusivamente a Dio; che lo stesso Dio ha reso Maria idonea all’assolvimento del compito affidatele mediante la pienezza di grazia. In questa pienezza, il popolo cristiano ha sentito che doveva starci anche l’Immacolata Concezione.
Meditazione
La liturgia della Parola di questa festa ci consente di abbracciare in un solo sguardo il mistero della salvezza. Al centro delle letture c’è il testo tratto dalla lettera agli Efesini in cui Paolo medita quale sia il desiderio originario di Dio; la prima lettura, dalla Genesi, descrive la risposta umana, il peccato, che tuttavia non arresta il piano di Dio, ma lo trasforma in una promessa che attraversa la storia fino a compiersi nell’incarnazione del Figlio di Dio, come il racconto di Luca annuncia.
In Cristo il Padre «ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi» (Ef 1,4-5). Adamo ed Eva non sanno accogliere questa gratuita iniziativa di Dio. In loro opera l’inganno della tentazione che li induce a ritenere di dover conquistare, in modo autonomo e autosufficiente, ciò che Dio intende dare loro gratuitamente: l’essere per lui figli santi e immacolati. Dopo il peccato Adamo ed Eva sono ancora tentati di percorrere la via dell’autonomia, senza affidarsi alla misericordia del Padre. Si nascondono e, riconoscendosi nudi, intrecciano foglie di fico per farne cinture (cfr. Gen 3,7). È Dio invece a intrecciare per loro una storia di salvezza, rivestendoli di tuniche di pelle (cfr. Gen 3,21) e promettendo loro che, nella lotta contro quel male che sempre insidia la vita umana, un figlio di donna, stirpe della sua stirpe, conseguirà la vittoria.
«Dove sei?», domanda Dio all’uomo peccatore. La risposta che Adamo non sa dare la darà Dio stesso nell’incarnazione del Figlio: siamo in lui, nel Cristo. Essere in Cristo è uno dei temi più cari e ricorrenti in Paolo ed emerge anche nel brano della lettera agli Efesini. «In lui» – l’apostolo lo ripete continuamente – Dio ci ha benedetti, ci ha scelti, ci ha reso eredi… e sempre «in lui» si fonda la nostra speranza e sale al Padre la nostra benedizione e la nostra lode alla sua gloria. Dove sei? Siamo in Cristo.
Tale è anche il segreto della vita di Maria, colei che si lascia totalmente rivestire dalla gratuità di Dio per dare carne a questa grazia che in lei si fa persona e assume un volto umano: «Colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio» (Lc 1,35). Diversamente da Adamo ed Eva, che oppongono il loro progetto alla promessa di Dio, in Maria tutto è ascolto e recettività dell’agire divino. Si può rileggere il racconto di Luca facendo attenzione ai tre nomi con cui la vergine di Nàzaret viene chiamata. Il primo è quello con cui Gabriele la saluta: «piena di grazia», che traduce un’espressione greca più ricca di sfumature (kecharitoméne). Luca usa qui un participio perfetto di forma passiva. Un perfetto: in greco questo modo verbale indica un’azione passata che ha raggiunto la sua perfezione e perdura nel presente. Maria è stata e rimane oggetto del favore divino. Il participio è di forma passiva e ha come soggetto implicito Dio stesso: viene così posto l’accento sull’agire divino. Essere ricolma della grazia, prima che costituire una qualità di Maria, rivela l’atteggiarsi di Dio nei suoi confronti, il suo modo di guardarla e di incontrarla. Infine, il verbo indica una trasformazione. Non significa semplicemente guardare qualcuno con benevolenza, ma trasformare, in virtù di questo favore, l’oggetto del proprio sguardo, rendendolo amabile. Maria è l’amata da Dio e, in quanto amata, è totalmente rinnovata da questo amore. Il nome usato da Gabriele acquista così la sua pregnanza: da un lato sottolinea la gratuità dell’azione di Dio, dall’altro manifesta la recettività piena e cordiale da parte di Maria.
Solo dopo averla salutata con il nome che viene da Dio, Gabriele la chiama anche con il nome datele dagli uomini. La verità della vita di ciascuno di noi sta nel modo che Dio ha di guardarci e chiamarci. Il nome umano è Maria. Se confrontiamo questa scena con il precedente annuncio rivolto a Zaccaria (Lc 1,5-7.13) emerge una grande differenza. Di Maria non si dice nulla, ne della sua discendenza, ne delle sue qualità morali; nulla neppure di un suo desiderio di maternità. L’unica realtà ricordata è la sua verginità. Due volte, con insistenza, il testo afferma che Maria è vergine (vv. 27 e 28). Tale condizione segnala ancora una povertà: viene annunciata una gravidanza a una vergine, vale a dire a una persona che sembrerebbe del tutto impari rispetto al compito affidatele. Nello stesso tempo questa verginità sottolinea la radicale apertura e docilità di Maria verso l’agire di Dio. Tutto in lei è povertà che si apre ad accogliere la potenza di Colui al quale nulla è impossibile (cfr. v. 37).
Infine nel racconto risuona un terzo nome che Maria stessa si da in risposta al saluto dell’angelo: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (v. 38). Quello di Maria non è un semplice atto di obbedienza. E un modo peculiare di collocarsi davanti al Signore e di entrare nella giusta relazione con lui. L’angelo aveva salutato Maria annunciandole come Dio si relazionava con lei: il Signore è con te, tu sei la piena di grazia, colei che Dio ama e trasforma nel suo amore. Rispondendo, Maria afferma a sua volta come desidera che sia la sua relazione con Dio: sono la «schiava» del Signore. Colei che in tutto dipende dalla sua Parola. Quello di Maria è un atto di fede prima ancora che di obbedienza. Il suo atteggiamento mostra inoltre il legame che sussiste tra fede e umiltà. Non presume di sé; al contrario si domanda «com’è possibile? come posso io?»; di conseguenza si affida, facendo della propria povertà e inadeguatezza lo spazio nel quale il Signore può manifestare la sua potenza. Come canterà nel Magnificat, Dio ha potuto compiere in lei grandi cose, perché ha conosciuto l’umiltà, la piccolezza, il «niente» della sua serva. Dio agisce in lei non a misura della sua piccolezza, ma a misura della grandezza del proprio amore.
Possiamo comprendere il mistero dell’«Immacolata» alla luce di questi tre nomi, che tracciano anche per noi una via di santificazione personale.
Don Bosco commenta il Vangelo
Don Bosco, un innamorato della “Piena di grazia”
Tra i principali motivi di essere devoti di Maria, argomento con cui don Bosco apre il suo Mese di maggio consacrato a Maria SS. Immacolata, il primo corrisponde al sorprendente saluto indirizzato dall’angelo a Maria:
Nel Vangelo viene dall’angelo Gabriele chiamata piena di grazia, ave, gratia piena. Piena di grazia, ossia creata e formata nella grazia, il che vuol dire che Maria dal primo istante di sua esistenza fu senza macchia originale ed attuale, e senza macchia perseverò fino all’ultimo respiro di vita (OE10 307).
Essendo piena di grazia, Maria merita una venerazione speciale da parte nostra. Parlando del culto di Maria Vergine, anche perché non condiviso da tutti i cristiani, don Bosco nel volume Il cattolico provveduto per le pratiche di pietà,afferma con grande convinzione i veri motivi dell’onore singolare a lei dovuto:
Essa è la figlia prediletta dell’eterno Padre, la madre del figliuol di Dio, la sposa dello Spirito Santo e come tale essa risplende di una eccellenza infinita. Essa è l’unica che non sia stata macchiata dalla colpa originale, essa è l’unica che sia piena di grazia, essa è la benedetta fra tutte le donne. Gli altri santi sono servi ed amici del Signore, Maria n’è realmente la madre. Come adunque non onoreremo in modo singolare questa gran Vergine che venne elevata ad una dignità così alta da star infinitamente sopra agli stessi cherubini e serafini? (OE19 298s).
Le parole dell’angelo in onore di Maria risplendono in moltissime opere d’arte. Nel grande dipinto che sovrasta l’altare maggiore della nuova chiesa in onore di Maria Ausiliatrice, dalla parte superiore, scrive don Bosco nelle Meraviglie della Madre di Dio, “calano altri raggi dalla colomba, Spirito Santo, che vanno eziandio a posarsi sul capo di Maria con in mezzo le parole: Ave, gratia plena, Dioti salvi, o Maria, tu sei piena di grazia” (OE20 319s).
A Roma, sulla colonna eretta piazza di Spagna dopo la proclamazione dell’immacolata concezione di Maria, don Bosco ricorda nei Fatti ameni della vita di Pio IX, che “sono scolpiti i motti semplici ma sublimi dell’angelica salutazione: Salute, o piena di grazia” (OE23 96).
Ma dopo aver chiamato Maria “piena di grazia”, l’angelo Gabriele aggiunge: “Il Signore è con te”. Qui abbiamo un crescendo di lode che tocca don Bosco in modo profondo, come si percepisce in varie espressioni delle Meraviglie della Madre di Dio invocata sotto il titolo di Maria Ausiliatrice:
L’Arcangelo per confermare questa pienezza di grazia in Maria spiega ed amplifica le prime parole gratia plena aggiungendo Dominus tecum, il Signore è con te. Qui cade ogni dubbio di esagerazione sulle parole precedenti. Non è più solamente la grazia di Dio che viene in tutta la sua abbondanza in Maria, ma è Iddio medesimo che viene a riempirla di sé stesso e stabilire la sua dimora nel casto seno di lei facendone il suo tempio (OE20 213s).
Dopo il sorprendente saluto iniziale l’angelo aggiunge questa solenne dichiarazione: “Hai trovato grazia presso Dio”. Davanti a questa sovrabbondanza di grazia che Maria ha trovato presso Dio, noi possiamo e dobbiamo chiederle di condividere con noi questa grazia che lei ha trovato. Nelle Meraviglie della Madre di Dio don Bosco cita a questo punto il commentario di sant’Antonino, arcivescovo di Firenze:
Adamo col suo peccato perdette la grazia per sé e per tutti, e colla penitenza che ne fece dopo ricuperò solo la grazia per sé. Maria poi la trovò per tutti, perché per Maria tutti ebbero virtualmente la grazia, in quanto che per Maria avemmo Gesù che ci portò la grazia. Egli è dunque indubitabile quel che insegnano i santi Padri, cioè che Maria trovando questa grazia restituì agli uomini tanto di bene quanto di male ci aveva recato Eva col perdere la grazia (OE20 215s).
In conclusione, la cosa migliore da fare, secondo don Bosco, è chiedere e accogliere questa grazia che viene da Dio e ci raggiunge attraverso Maria.
(Morand Wirth)
Tra parentesi il lettore troverà i riferimenti principali dei testi citati nelle opere di o su don Bosco: – nei 38 volumi delle Opere edite di G. Bosco (OE1-38, a cura del Centro Studi Don Bosco dell’Università Pontificia Salesiana); – nei 19 volumi delle Memorie biografiche di don G. Bosco (MB1-19, a cura di G.B. Lemoyne, A. Amadei e E. Ceria); – nelle sue Memorie dell’Oratorio (MO, a cura di A. Giraudo); – nei 10 volumi del suo Epistolario (E1-10, a cura di F. Motto). La seconda cifra indica la pagina del volume.
L’immagine della domenica
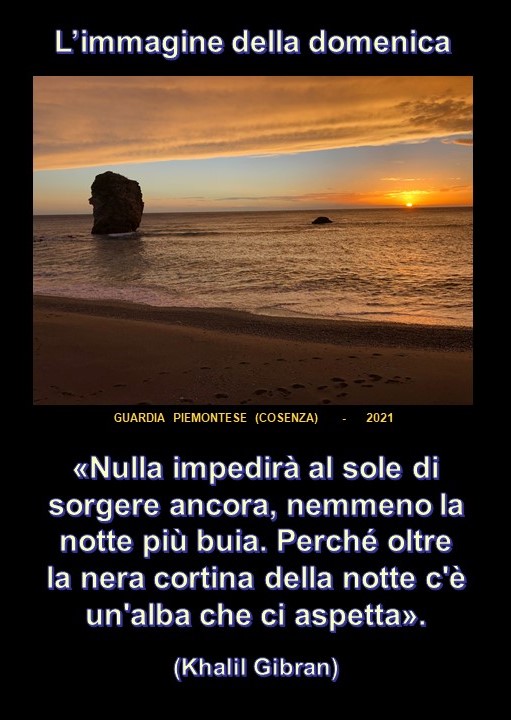
| GUARDIA PIEMONTESE (COSENZA) – 2021 |
«Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia. Perché oltre la nera cortina della notte c’è un’alba che ci aspetta».
(Khalil Gibran)
Preghiere e racconti
Se andiamo alla ricerca di un motivo esemplare che possa ispirare i nostri passi, e dare agilità alle cadenze del nostro cammino in questo periodo che ci separa dal Natale, dobbiamo assolutamente rifarci alla Madonna. Lei è la Vergine dell’attesa, la Vergine dell’Avvento, la Madre dell’attesa.
Lo sapete che nel Vangelo, prima ancora che ci venga detto il suo nome, viene riferito un fremito d’attesa che ardeva nella sua anima? San Luca, prima ancora di dirci che «il suo nome era Maria» (Lc 1, 26), ci dice un’altra cosa: «In quel tempo l’angelo Gabriele venne mandato ad una ragazza promessa sposa ad un uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide» (Lc 1, 26-27).
«Promessa sposa», cioè fidanzata! Noi sappiamo che la parola fidanzata viene vissuta da ogni donna come un preludio di tenerezze misteriose, di attese. Fidanzata è colei che attende. Anche Maria ha atteso; era in attesa, in ascolto: ma di chi? Di lui, di Giuseppe! Era in ascolto del frusciare dei suoi sandali sulla polvere, la sera, quando lui, profumato di vernice e di resina dei legni che trattava con le mani, andava da lei e le parlava dei suoi sogni.
Maria viene presentata come la donna che attende. Fidanzata, cioè. Solo dopo ci viene detto il suo nome. L’attesa è la prima pennellata con cui san Luca dipinge Maria, ma è anche l’ultima. E infatti sempre san Luca il pittore che, negli Atti degli apostoli, dipinge l’ultimo tratto con cui Maria si congeda dalla Scrittura. Anche qui Maria è in attesa, al piano superiore, insieme con gli apostoli; in attesa dello Spirito (At 1, 13-14); anche qui è in ascolto di lui, in attesa del suo frusciare: prima dei sandali di Giuseppe, adesso dell’ala dello Spirito Santo, profumato di santità e di sogni.
Attendeva che sarebbe sceso sugli apostoli, sulla chiesa nascente per indicarle il tracciato della sua missione.
Vedete allora che Maria, nel Vangelo, si presenta come la Vergine dell’attesa e si congeda dalla Scrittura come la Madre dell’attesa: si presenta in attesa di Giuseppe, si congeda in attesa dello Spirito. Vergine in attesa, all’inizio. Madre in attesa, alla fine. E nell’arcata sorretta da queste due trepidazioni, una così umana e l’altra cosi divina, cento altre attese struggenti. L’attesa di lui, per nove lunghissimi mesi. L’attesa di adempimenti legali festeggiati con frustoli di povertà e gaudi di parentele. L’attesa del giorno, l’unico che lei avrebbe voluto di volta in volta rimandare, in cui suo figlio sarebbe uscito di casa senza farvi ritorno mai più. L’attesa dell’«ora»: l’unica per la quale non avrebbe saputo frenare l’impazienza e di cui, prima del tempo, avrebbe fatto traboccare il carico di grazia sulla mensa degli uomini. L’attesa dell’ultimo rantolo dell’unigenito inchiodato sul legno. L’attesa del terzo giorno, vissuta in veglia solitaria, davanti alla roccia. Attendere: infinito del verbo amare. Anzi, nel vocabolario di Maria, amare all’infinito.
E noi oggi di che cosa parliamo se non di Avvento, di attesa? Voi promettete fede al Signore e con i vostri sospiri, con i vostri sentimenti, con le vostre attese, ricevete le tenerezze misteriose che vi riserva: vigilanti, così come si vive il periodo del fidanzamento, con il tripudio interiore.
Un giorno le nozze dell’Agnello le celebreremo tutti quanti. Saremo tutti invitati, tutti protagonisti. Verrà questo giorno!
Nei tempi gelidi che stiamo vivendo, nell’appannamento dei nostri entusiasmi e nella tristezza dei nostri peccati, non possiamo sentirci mancare il coraggio, al punto da non annunciarvi queste cose con forza, per quanto possano sembrare lontane, utopiche. No, non sono utopie, sono invece i luoghi dove noi realizzeremo veramente la nostra felicità, il nostro bene. Questo vi annunciamo oggi!
Le ragazze che sono davanti a me, sono anche un po’ l’icona di quello che dovremmo essere: con l’abito bianco, con la lampada accesa, in attesa; disponibili non soltanto a tenere la lampada accesa, ma anche a conservare una riserva sufficiente di olio nei recipienti, al punto che quando qualcuno ci rivolge quella preghiera così implorante e così umana che dice: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!», noi possiamo rispondere non come le vergini prudenti: «No, perché non basta ne a noi ne a voi» (Mt 25, 9), ma: «Sì, vogliamo correre il rischio che non basti ne a noi ne a voi».
A voi che oggi non fuggite per la tangente dell’irreale, ma fate una scelta di concretezza, vorrei dire: «Amate il mondo e siate disponibili a dare l’olio alle lampade del mondo, perché anche il mondo possa attendere e possa vivere l’attesa».
Oggi non si attende più. La vera tristezza non è quando ti ritiri a casa la sera e non sei atteso da nessuno, ma quando tu non attendi più nulla dalla vita. E la solitudine più nera la soffri non quando trovi il focolare spento, ma quando non lo vuoi accendere più: neppure per un eventuale ospite di passaggio. Quando pensi, insomma, che per te la musica è finita. E ormai i giochi sono fatti. E nessun’anima viva verrà a bussare alla tua porta. E non ci saranno più ne soprassalti di gioia per una buona notizia, ne trasalimenti di stupore per una improvvisata. E neppure fremiti di dolore per una tragedia umana: tanto, non ti resta più nessuno per il quale tu debba temere. La vita, allora, scorre piatta verso un epilogo che non arriva mai, come un nastro magnetico che ha finito troppo presto una canzone, e si srotola interminabile, senza dire più nulla, verso il suo ultimo stacco. Attendere: ovvero sperimentare il gusto di vivere. Hanno detto addirittura che la santità di una persona si commisura dallo spessore delle attese. E forse è vero.
Oggi abbiamo preso, invece, una direzione un tantino barbara: il nostro vissuto ci sta conducendo a non aspettare più, a non avere neppure il fremito di quelle attese che ci riempivano la vita un tempo: quando, non so, aspettavi profumi di mosti, o il cigolare dei frantoi o il grembo di tua madre che si incurvava sotto il peso di una nuova vita, o i profumi dei pampini, degli ulivi, o il profumo di spigo, di mele cotogne. Forse sto scappando anch’io per le tangenti del sogno, però – dite la verità – è così standardizzata la nostra vita, è così incastrata nei diagrammi cartesiani che c’imprigionano e ci stringono all’angolo, che non sappiamo più aspettare. Intuiamo tutti che abbiamo una vita prefabbricata, per cui ci lasciamo vivere, invece di vivere.
Oggi l’Avvento c’impegna invece a prendere la storia in mano, a mettere le mani sul timone della storia attraverso la preghiera, l’impegno e starei per dire anche l’indignazione: indignatevi un po’, fratelli e sorelle! Indignatevi, perché abbiamo perso questa capacità; anche noi sacerdoti, anche noi vescovi, non ci sappiamo più indignare per tanti soprusi, tante ingiustizie, tante violenze… Tutto quello che viviamo ora, qui, non è solo una simbologia. Vorrei dirvi, cari fratelli, che questi ragazzi, Antonio e Stefano e poi Barbara e Francesca e Lorella e Miriam, devono diventare per noi una provocazione, uno scrupolo, una spina di inappagamento, messa nel fianco della nostra vita, un’icona, una «pro-vocazione», una chiamata da parte di chi sta un po’ più avanti. Con i gesti anche paradossali delle scelte audaci, ci stimolano ad essere uomini dell’attesa come Maria; ci spingono a non diffidare mai dei sogni, per essere capaci sempre di annunciare al mondo rovesciamenti da troni e innalzamenti dello stereo, come Maria, donna dell’attesa, che ha aspettato questa ricollocazione sui troni della giustizia per tutti coloro che, invece, vivono nel fetore delle stalle e nel sopruso degli egemoni, che schiacciano sempre la gente.
Attesa, attesa, ma di che? Che cosa aspettiamo?
Aspettiamo prima di tutto un cambio per noi, per la nostra vita spirituale, interiore, e poi avvertiamo che stiamo camminando su speroni pericolosi, su rocce che possono farci ruzzolare da un momento all’altro. Forse abbiamo assunto un modo non proprio allineato alla logica delle beatitudini.
Attesa quindi di rinnovamento per noi, attesa di rinnovamento per la storia dell’umanità. Attesa di cambi interiori della nostra mentalità: non siamo ancora capaci di pronunciare una parola forte per dire che la guerra è iniqua, che ogni guerra è iniqua! Ancora ci stiamo trastullando con i concetti della guerra giusta o ingiusta, o della difesa…
Abbiamo nelle mani il Vangelo della non violenza attiva, il codice del perdono, ma siamo ancora cristiani irresoluti, che camminano secondo le logiche della prudenza carnale e non della prudenza dello Spirito. Siamo gente che riesce a dormire con molta tranquillità, pur sapendo che nel mondo ci sono tante sofferenze. Sopportiamo facilmente che, all’interno della nostra città, col freddo che fa, le stazioni siano assediate da terzomondiali o da persone che vivono allo sbando, che non hanno più progetti.
Macché fidanzamento, che sogni, che attese di sandali, che profumi di vernice o di santità! Molta gente odora soltanto della tristezza dei propri sudari.
Fratelli e sorelle, vergini fidanzate, provocate questa gente! Oggi ci sono tante fotografie per voi, tanti lampeggiamenti di flash; sarebbe molto bello che ognuno di voi, con il suo obiettivo allargato, imprimesse la provocazione di un’attesa di cieli nuovi e terre nuove. Anche tu, Stefano, che ti accingi ad entrare nel consesso presbiterale; e tu, Antonio, che ci sei già entrato, che sei già lettore e annunci la parola di Dio e da oggi tocchi anche le patene, le pissidi: tocchi quello che sarà il corpo vivente del Signore. Questo contatto con i vasi sacri, col grano fatto pane, con l’uva fatta vino, ti mette in rapporto con il cosmo, con questa realtà materiale, toccabile, perché il regno di Dio viene costruito non con i fumi delle nostre utopie ma con le pietre che vengono scavate nelle cave della storia, della terra. Scommetto che anche il pane che si mangia nel cielo è intriso delle acque della nostra terra e del grano che viene prodotto dai nostri campi!
Buona attesa, dunque. Il Signore ci dia la grazia di essere continuamente allerta, in attesa di qualcuno che arrivi, che irrompa nelle nostre case e ci dia da portare un lieto annuncio!
(Don Tonino Bello, Avvento e Natale. Oltre il futuro, Padova, Messaggero, 2007, 45-54).
Benedetta sei Tu, più grande del cielo, più bella della terra e più profonda di tutta la ragione, chi riesce a esprimere la Tua grandezza? Non c’è niente che sia uguale a Te, Vergine Maria. Ti glorificano gli angeli, Ti lodano i serafini, perché Colui che siede nella gloria è venuto a dimorare nel Tuo corpo. L’amico degli uomini ci ha innalzato fino a Sé, ha preso su di Sé la nostra morte, ci ha donato la vita Colui a cui appartiene onore e lode. Tu, Tu sola, nostra Signora, genitrice di Dio, sei madre della luce. Ti glorifichiamo con cantico di lode.
Sei il candelabro che porta la lampada sempre accesa, la luce del mondo, luce da luce senza inizio, Dio da Dio vero, che da Te prese senza mutamento la forma umana, che ci ha illuminati con la Sua venuta, noi che sedevamo nel buio e nell’ombra della morte, Luce che guida i nostri passi sulla via della pace per mezzo del mistero della Sua santa sapienza.
Rallegrati, benedetta vergine senza macchia, Tu vaso puro, Tu gloria del mondo, Tu luce intramontabile, Tu tempio indistruttibile, Tu bastone della fede, Tu solido sostegno dei santi. Prega per noi il Tuo figlio diletto, nostro redentore, perché abbia pietà di noi e sia misericordioso, e attraverso la Sua grazia ci siano perdonati i peccati per sempre.
Amen.
(Preghiera etiope)
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
—
– COMUNITÀ DI S. EGIDIO, La Parola e la storia,Milano, Vita e Pensiero, 2012.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– R. FERRIGATO (ed.), Avvento e Natale 2012. Sussidio liturgico-pastorale, Milano, San Paolo, 2012.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– Don TONINO BELLO, Avvento e Natale. Oltre il futuro, Padova, Messaggero, 2007.
—
– Immagine della domenica, a cura di García-Orsini-Pennesi.
PER L’APPROFONDIMENTO:

Testo integrale e integrato dell’Omelia pronunciata dal Direttore dell’Istituto di Catechetica, Don Giuseppe Ruta, durante la S. Messa in suffragio di Padre Rinaldo: Cappella Gesù Maestro, 13 novembre 2024, ore 12.20.
«Stanotte, ma verso mattina, all’ora dei sogni, ne ho fatto uno anch’io. Che cosa vi si svolgeva, non lo so più, ma era un qualche discorso; e se fosse fatto a me, o da me, anche questo non lo so più. Però vi si diceva che, quando un uomo nasce, gli viene consegnata una parola, ed era chiaro che cosa significasse: non era soltanto un carattere, ma una parola. Essa viene pronunziata all’interno dell’essenza dell’uomo, ed è come la parola d’ordine per quanto poi accade; è insieme forza e debolezza, è compito e promessa, è protezione e minaccia. Tutto ciò che avviene nel corso degli anni, è conseguenza di questa parola, è suo commento e adempimento. E avviene perciò che colui cui essa è stata detta, ogni uomo, poiché ad ognuno ne viene singolarmente detta una, la comprenda e con essa venga ad accordarsi. E sarà forse questa parola ad essere il fondamento di ciò che un giorno il Giudice gli dirà»[1].
L’espressione sapiente di Romano Guardini si attaglia alla vita e al mistero della persona di Rinaldo Paganelli, amico, allievo e docente della nostra Università Pontificia Salesiana di Roma.
Sacerdote dehoniano (SCJ), Padre Rinaldo nacque a Brembate (BG), il 24 febbraio 1955. Ha emesso la prima professione tra i Padri Dehoniani il 29 settembre 1976 ed è stato ordinato sacerdote il 19 settembre 1981. Attualmente appartenente alla Provincia dehoniana ITS, viveva a Roma presso la comunità, sita in Viale Mazzini, e prestava alcuni servizi pastorali presso la Parrocchia “Cristo Re” animata dai PP. Dehoniani.
Ha conseguito la licenza in catechetica e pastorale giovanile all’Università Pontificia Salesiana, nel 1985 con una tesi sul tema: Studio delle indicazioni pastorali risultanti dall’analisi dell’indagine sui preadolescenti italiani e il dottorato nel 2002 presso la medesima Università, con una tesi dal titolo: Formare i formatori dei catechisti. I valori sottesi al processo formativo.
Giornalista pubblicista (iscritto all’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna), è stato per tanti anni membro della Consulta dell’Ufficio Catechistico Nazionale, manifestando doti eccellenti sia nella riedizione dei Catechismi CEI, sia nella collaborazione delle riviste “Settimana” ed “Evangelizzare” di cui è stato direttore per diversi anni. Si può anche dire che sono poche le diocesi italiane che lo hanno visto assente con la ricchezza delle sue competenze: molte sono, infatti, le chiese locali che hanno beneficiato dei suoi suggerimenti e dei suoi orientamenti di rinnovamento.
Formare, accompagnare, sostenere gli annunciatori, i catechisti, i formatori/guide/animatori dei catechisti è stata la sua passione e missione che ha condiviso con sr. Giancarla Barbon e altri catecheti ed esperti. Tale passione ha trovato forma e si è concretizzata nella Scuola nazionale per formatori all’evangelizzazione e alla catechesi, prima a La Mendola (TN), poi a Malosco (TN), successivamente a Siusi (BZ) e attualmente ad Asolo (TV), con dei progetti e programmi formativi innovativi e “in forma di laboratorio”.
Ha svolto anche il servizio di docenza di Catechetica presso lo Studio Teologico Antoniano di Bologna (1991-2004). Chiamato all’insegnamento presso l’UPS, ha insegnato le seguenti discipline a partire dall’A.A. 2010/2011 fino a questo Anno, atteso da noi docenti e studenti, e in extremis sostituito per le due discipline assegnategli nel maggio scorso: Metodologia catechetica: Famiglia, infanzia e preadolescenza e Prospettive culturali e teologiche contemporanee:
Catechesi e impegno socio-politico (2010/11; 2011/2012); Pastorale giovanile, catechesi e impegno socio-politico (2013/2014; 2014/15; 2015/16); Primo annuncio e iniziazione cristiana (2018/19); Teologia dell’evangelizzazione (2014/2015; 2015/16; 2016/17; 2017/18; 2018/19); Formazione dei catechisti (2020/21); Dimensione ecologica e politica della pastorale e della catechetica (2018/19; 2020/21; 2022/23; 2023/24); Prospettive culturali e teologiche contemporanee (2020/21; 2021/22; 2022/23; 2023/24).
Recentemente, nel giugno 2023, era stato eletto nel Consiglio di Presidenza dell’Équipe Europea di Catechesi.
Dopo il riaffiorare del tumore che aveva già superato dieci anni prima e dopo un estremo tentativo di intervento chirurgico presso il “San Camillo” di Roma, è tornato alla Casa del Padre, il 19 ottobre 2024, dopo pochi giorni degenza e di terapia intensiva. Alla S. Messa esequiale, il 21 ottobre, alle ore 15, presso la Parrocchia “Cristo Re”, presieduta da S.E. Mons. Cesare Pagazzi, alla presenza di Superiori e Confratelli dehoniani, di colleghi docenti, allievi ed exallievi, di amici e amiche che hanno beneficiato del suo accompagnamento spirituale e catechistico, è stato elevato a Dio il “grazie” per il dono discreto e prezioso di Padre Rinaldo. Quasi un prolungamento del Deo gratias è la celebrazione odierna presieduta da Don Kevin Otieno Mwandha, Vicerettore dell’UPS, e concelebrata da P. Riccardo Regonesi, confratello e amico di padre Rinaldo, alla presenza di allievi, exallievi, amici e membri della famiglia dehoniana. A Padre Rinaldo è stata dedicata la Giornata del curriculum che docenti e allievi dell’Istituto hanno celebrato proprio il 13 novembre.
Anche noi riconosciamo che egli è stato un dono non solo per la congregazione di appartenenza e per l’UPS, ma anche per la Chiesa e per il mondo tanto amato da lui cordialmente, secondo l’originale carisma dehoniano. Il giorno dopo le esequie, è stato traslato al paese di Grignano (BG) per essere tumulato nella tomba di famiglia.
Ricordiamo il suo sorriso “delicato, gentile e sornione, ogni tanto accompagnato da un velo di tristezza” – così lo descrive il suo confratello Heiner Wilmer –; questo tratto lo rendeva immediatamente accessibile e accogliente. La sua presenza tra gli altri, poi, si prolungava sempre discreta e affabile.
Padre Wilmer così continua la sua testimonianza: «Mi ha colpito la passione con cui si chiedeva come fosse possibile annunciare il Vangelo al mondo di oggi. Come potessimo vivere in questo nostro tempo il fascino e la bellezza della lieta notizia che è il Dio di Gesù. Modulava questa domanda di fondo a seconda dei contesti in cui era attivo: la catechesi, la docenza all’Università salesiana, gli articoli scritti per SettimanaNews, il servizio alla Congregazione. Ognuno di questi ambiti chiedeva una declinazione particolare, attenta e sensibile, e Rinaldo era capace di farlo. Gli anni condivisi a Roma in Curia generale, mi hanno fatto apprezzare la sua capacità di lavorare in tempi stretti, con discrezione e precisione. Ma non solo questo. Il suo senso dell’umorismo era impareggiabile – talvolta sottile, ma riusciva a parteciparlo anche a un tedesco».
L’eredità che ci lascia è, per noi innanzitutto come Istituto, la testimonianza di una vita pienamente vissuta e a servizio della catechesi. Sr. Giancarla ha racchiuso in poche pagine non solo la condivisione pastorale decennale, iniziata quando entrambi erano studenti all’UPS, ma anche l’intensa e proficua collaborazione maturata negli anni, in particolare per la formazione dei catechisti e dei loro formatori. Nell’ultima attività di Susi, in questa trascorsa estate, le conclusioni da lui tratte e donate ai partecipanti hanno il sapore di un testamento spirituale. Siamo grati a sr. Giancarla di avercele condiviso:
«La percezione del proprio limite porta a considerare e a capire il limite degli altri. È solo attraverso le piccole cose che si scopre l’uomo, nella comprensione di ogni giorno, nel poter guardare in viso l’altro da sé e coglierne i segni del dolore visibili in un’espressione che sa di fine, mentre si chiede inutilmente perché ancora dolore. Una domanda che rimanda alla paura.
Non è possibile consolarsi se si è avvolti dal mondo impaurito. Occorre che ci sia un uomo vicino che ricordi che, anche dopo un temporale che ha sradicato un villaggio, uscirà il sole e risplenderà la luce, e che gli uccelli cinguetteranno e la vita continuerà. Questo è un uomo, questo forse è l’uomo. L’uomo del dolore, l’uomo della fragilità, l’uomo della comprensione, l’uomo della consolazione, colui che canta inni di speranza e giunge persino a pregare un Signore che forse non c’è ma che, se ci fosse, sarebbe bene delegargli la propria inconsistenza, la propria insufficienza, i propri limiti. L’uomo è un gigante che porta dentro di sé un bambino ed è bene che dica, che mostri che quella stazza gigantesca non deve intimorire poiché è piena di bontà, di voglia di essere amato, magari da un nano, da chi pensa di esser troppo piccolo per vivere, ma può diventare necessario a un gigante.
Nel nostro contesto è importante cercare un “dio” della fragilità, che sappia ascoltare e aspettare me che temo la solitudine e il dolore, nel mio deserto. Questo è Dio. La figura del Cristo, l’immagine di Dio che più si avvicina alla nostra paura e debolezza. Ha pianto, ha rimproverato il Dio che è nei cieli, ha sofferto sulla croce, è stato insultato, ha agito nell’impotenza e nella fragilità ed è morto di fragilità. Cristo, un grande uomo, Figlio di Dio. L’insieme di questi criteri chiarisce e rende complesso l’orientamento di proposte di percorsi catechistici. Occorrerà molta cura nell’intreccio delle diverse iniziative per orientare sulle questioni pratiche».
Autore di numerosi testi di carattere formativo per la pastorale e la catechesi, la produzione bibliografica di Padre Rinaldo è poliedrica: una prima sezione raccoglie saggi di carattere più fondativo e teorico; altri, in netta maggioranza, di carattere metodologico e pratico, si tratta di una serie di sussidi solidi, significativi ed efficaci; altri compongono la sezione più divulgativa e pubblicistica: si tratta di articoli apparsi in varie riviste e settimanali (in particolare settimananews con ben trenta articoli), dove affiora la capacità di Rinaldo Paganelli di cogliere gli argomenti di attualità ecclesiale e socio-culturale per farne un breve bilancio e offrire puntualizzazioni pertinenti e indicazioni sapienti. Il suo interesse era più sul versante della sperimentazione, più che su quello della speculazione, si è sempre mosso più sul versante della prasseologia che sul terreno epistemologico. Gli stava a cuore l’ascolto della problematica e delle sfide, a cui tentare in tutti i modi di dare risposte o almeno di offrire affiancamento e accompagnamento nonostante tutto, nonostante gli esiti incerti di un’epoca in continuo cambiamento.
Indimenticabile rimane per noi dell’ICa la Giornata del curriculum tenuta un anno fa, sul tema della sinodalità il cui relatore è stato proprio Padre Rinaldo, lasciando in tutti un’ottima impressione per la ricchezza di contenuti, per sinteticità e chiarezza nel riportare punti fermi e punti problematici del percorso sinodale.
Aveva rilasciato alcuni mesi fa un’intervista confluita nella pubblicazione in preparazione al Simposio internazionale di catechetica (8-9 novembre 2024) che per noi costituisce un messaggio e quasi il passaggio di testimone alle nuove generazioni di catecheti nel mondo. Per noi dell’ICa è una consegna preziosa.
Tra le opere segnaliamo le principali disposte in ordine cronologico, con l’auspicio che possa pubblicare prossimamente la lista completa delle opere di Padre Paganelli:
(insieme a Giancarla Barbon), Cammino per la formazione dei catechisti (1992).
(insieme a Giorgio Vincenzo), Il catechista incontra la Bibbia (1994).
Con Cristo dalla testa ai piedi. Via crucis ispirata agli scritti di mons. Tonino Bello (1994).
(insieme a Giancarla Barbon), Annunciare a partire dal cuore. Una spiritualità di catechisti (1998).
Formare i formatori dei catechisti. Valori e itinerari sottesi al processo formativo (2002).
(insieme a Giancarla Barbon), Gustate e vedete come è buono il Signore. 7 alimenti biblici per educare ed evangelizzare (2007).
(insieme a Giancarla Barbon), Si seppe che Gesù era in casa. 7 luoghi della casa per educare ed evangelizzare (2007).
(insieme a Giancarla Barbon), Sono con voi tutti i giorni. 7 momenti della giornata per educare ed evangelizzare (2009). Malato, mi hai visitato (2010).
(insieme a Giancarla Barbon), Li pose in un giardino. 7 azioni pazienti per educare ed evangelizzare (2011).
(insieme a Enza Annunziata), Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico (2012).
(insieme a Giancarla Barbon), Pensare e attuare la formazione (2016).
(insieme a Giancarla Barbon), Provando si impara. Il tirocinio e l’équipe nella formazione dei catechisti (2020).(Ed.), Immagina puoi. “Una porta aperta nel cielo” (2021).
[1] R. Guardini, Appunti per un’autobiografia, Morcelliana, Brescia 1986, 20.

L’evento è gratuito ed è previsto il collegamento online
Attenzione: anche per chi segue il Simposio online è necessario compilare la scheda d’iscrizione
8 – 9 novembre 2024 in Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 – 00139 Roma (RM) Italia
L’Istituto di Catechetica (ICa), la cui nascita risale all’A.A. 1953/54, festeggia il suo 70° di vita. Nel 2023, tra le tante iniziative ordinarie e straordinarie, la rivista on line “Catechetica ed Educazione” ha pubblicato diversi contributi che nel loro insieme fanno memoria dei settant’anni di vita e di attività dell’ICa, in particolare dell’ultimo ventennio.
Richiamando il Convegno in occasione del 60° (15-16 maggio 2015) imperniato sul tema della catechesi come comunicazione nell’era digitale e del conseguente “cambio di paradigma”, il Simposio dell’8-9 novembre 2024 intende soffermare l’attenzione sulla dimensione educativa della catechesi.
Alcune informazioni importanti:
La scadenza delle prenotazioni al Simposio è prorogata fino alla fine del mese corrente
L’eventuale rimborso dei costi avverrà al termine dell’evento
Per ulteriori informazioni chiamare al: 375.6427896
Scarica il dépliant:
Notizie del Simposio

Condividiamo un bollettino che annuncia le novità bibliografiche sugli IR e gli Studi Religiosi dei 5 continenti.
September – October 2024 ● vol. 3, issue 5, pages 1- 44
An International Bibliographic Bulletin on Religious Education & Religious Studies around the World
by Flavio Pajer , ed

Lectio – Anno B
Prima lettura: 1Re 17,10-16
| In quei giorni, il profeta Elia si alzò e andò a Sarèpta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: «Prendimi un po’ d’acqua in un vaso, perché io possa bere». Mentre quella andava a prenderla, le gridò: «Per favore, prendimi anche un pezzo di pane». Quella rispose: «Per la vita del Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po’ d’olio nell’orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio: la mangeremo e poi moriremo». Elia le disse: «Non temere; va’ a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela; quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio d’Israele: “La farina della giara non si esaurirà e l’orcio dell’olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra”». Quella andò e fece come aveva detto Elia; poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l’orcio dell’olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. |
Nell’antico vicino oriente le vedove erano riconoscibili per l’abito da lutto che esse indossavano, segno permanente della loro incompletezza dopo la perdita dello sposo (cf. Gn 38,13; Gdt 10,3). Entrato in città, Elia ne scorge una che raccoglie la legna destinata a cuocere le ultime poche risorse che sono rimaste per lei e suo figlio: un pugno di farina e una goccia d’olio. La vedova a cui Elia è inviato è sul lastrico, rassegnata ormai alla morte e alla cui alternativa non vede esonerato neanche il proprio figlio.
La donna esaudisce prontamente il desiderio di Elia in merito alla sete, come del resto prevede il grande senso di ospitalità orientale, ma recrimina per la richiesta di cibo. Il fatto che la donna invochi JHWH nella sua risposta ad Elia può dipendere dal fatto di avere riconosciuto in lui un ebreo sia per l’abbigliamento che per la pronuncia. Secondo l’uso orientale la donna giura per la divinità dell’ospite. Il giuramento rivela che quanto viene asserito dalla donna è vero ed importante.
Alla comprensibile protesta della donna Elia risponde non trascurando i suoi legittimi bisogni, ma invitandola a farli precedere da un atto di fede attraverso l’oracolo che egli pronuncia. Il contenuto delle parole di Elia non sono semplicemente un rovesciamento di prospettiva di futuro che aveva la vedova, la quale si sentiva ormai alla fine, ma anche una indicazione chiara di colui che offrirà la soluzione. L’oracolo profetico è chiaramente forgiato sulla fede monoteista israelitica secondo la quale JHWH è l’unico Signore del creato dal quale la pioggia dipende. Vi è qui un chiaro atteggiamento polemico verso il culto forestiero di cui Gezabele era promotrice e che riconosceva in Baal il dio della fecondità, manifestata appunto nei riguardi della terra con la pioggia.
Colui che regola i cicli naturali, che detiene il controllo delle riserve celesti (Gb 38,22-30) ha certamente potere anche sulla dispensa della vedova. Essa si fida della parola di Elia e il miracolo si compie. Attraverso il suo profeta Dio stesso si è presentato a quella diseredata non per toglierle il poco che le era rimasto, ma per aggiungere vita e speranza.
A causa di questo episodio Elia viene considerato nella pietà giudaica il patrono dei casi impossibili.
Seconda lettura: Ebrei 9,24-28
| Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui: in questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l’aspettano per la loro salvezza. |
Ritornando alla liturgia dello jom kippur, cioè del giorno della espiazione, Gesù viene paragonato al sommo sacerdote, ma per istituire un contrasto. Mentre il primo doveva annualmente «comparire», in modo solenne per indicare l’entrata del gran sacerdote nella parte più sacra del tempio, il santo dei santi, per Gesù non è così. Egli non ha bisogno di reiterare la sua offerta, perché per la purificazione dal peccato non si serve del sangue di terzi, che nel caso del sommo sacerdote era addirittura di animale, sangue di cui idealmente veniva rivestito e dal quale veniva protetto nel suo accesso al Santo dei santi; sangue che non era in grado di purificare dai peccati. Per questo il sacrificio, anche se svolto con la maggiore solennità, aveva una scadenza annuale che già in se stessa era dichiarazione di limitatezza.
Il v. 26 si apre con un ragionamento che procede per assurdo, per condurre alla comprensione della efficacia di quanto è stato compiuto da Cristo. Se fossero valsi per Lui i criteri che regolavano l’espiazione nell’antico culto, egli avrebbe dovuto accompagnare tutta la storia umana, fin dalle sue origini, con il sacrificio. Infatti la storia degli uomini è storia di peccatori e di miserie. Al contrario, una sola volta, nella pienezza dei tempi, cioè nel momento stabilito dal Padre, Gesù è «apparso» prima nel tempo, dimensione in cui si commettono i peccati, e, dopo aver consumato in esso il sacrificio di se stesso, è «apparso» nel santuario celeste rivestito del proprio sangue che lo qualifica come efficace espiatore ed intercessore. È pertanto sul sangue stesso di Gesù che si basa l’assoluta validità del suo sacrificio e dunque la sua non reiterabilità.
Nei vv. 27-28 vi è un nuovo confronto tra Gesù e l’esperienza umana. Per l’uomo dopo la morte viene il giudizio, per Gesù invece vi sarà una seconda «apparizione». Il tratto più interessante di questi versetti è il modo in cui viene presentata la parusia, perché certamente di essa parla l’autore quando dice che Cristo «apparirà una seconda volta». Il ritorno finale viene descritto rifacendosi ancora alla liturgia del giorno della espiazione. Quando il sommo sacerdote entrava nel Santo dei Santi tutto il popolo rimaneva fuori in attesa di lui che uscendo avrebbe portato il perdono divino. Così nel suo ritorno finale Cristo uscirà come vero sommo ed eterno sacerdote dal santuario celeste per portare la salvezza a coloro che lo attendono. Prevale qui un aspetto positivo della venuta finale descritta come il compimento dell’attesa della sospirata, completa assoluzione.
Vangelo: Marco 12,38-44
| In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». |
Esegesi
Il brano evangelico è diviso in due sezioni. La prima è costituita dai vv. 38-40 che contengono l’ultimo insegnamento impartito da Gesù nel capitolo 12 di Marco. La seconda, introdotta da un cambiamento di luogo, occupa i vv. 41-44 con la vedova additata ad esempio di vera pietà.
Uno sguardo d’insieme alla tradizione sinottica ci avvertirebbe che l’atteggiamento polemico di Gesù verso gli scribi fu forte e non raro; basterebbe ricordare il capitolo 23 di Matteo. La comunità primitiva si preoccupò subito di conservare memoria degli insegnamenti di Gesù in questa materia per ricavare anche da essi uno stile nuovo di vita al suo interno. Il vangelo di Marco ha conservato poco materiale a questo proposito, e la parte che ci tocca leggere in questa domenica è la più polemica. Gli scribi vengono presi di mira a causa della loro preoccupazione per l’esteriorità. Probabilmente la loro condizione di studiosi e di esperti del testo sacro era manifestata nell’abbigliamento da un mantello apposito che essi si ponevano sulle spalle. Altri segni di distinzione ai quali erano particolarmente attaccati erano gli atti di omaggio e di riguardo che venivano loro riservati in pubblico, innanzitutto nelle piazze, dove un gran numero di persone potevano assistere agli atti di deferenza che ricevevano. Anche nelle case private, in occasione di banchetti, e persino nei luoghi di culto, le sinagoghe, desideravano essere in rilievo occupando i primi posti. L’ultima apostrofe che Gesù riserva loro riguarda la vita di pietà vissuta in pubblico come atto di esibizionismo religioso.
Staccata dal piano esteriore è la loro avidità che prende di mira le persone meno tutelate: le vedove. Professionalmente gli scribi offrivano la loro consulenza in materia legale, il che equivaleva in una società e cultura come quella giudaica, ad una competenza religiosa perché tutto veniva regolato alla luce della Torâ. Essi però erano esosi per le loro prestazioni persino con i meno abbienti. Le parole con le quali Gesù conclude le considerazioni a loro riguardo sono assai dure. All’affermazione alla quale essi tanto tengono per il presente farà seguito una condanna più pesante di quella riservata al popolo. Forse si può notare qui una fine ironia: a queste persone esasperatamente preoccupate di primeggiare sarà data loro la possibilità di farlo persino nella dimensione definitiva, ma in un modo negativo.
La seconda sessione del nostro brano (vv. 41-44) narra un episodio che si svolge in un ambiente specifico del grande complesso del tempio. Si tratta di un corridoio dell’atrio, luogo in cui anche le donne potevano recarsi. In questo corridoio vi erano tredici urne nelle quali venivano deposte le offerte dei devoti. Ad introdurre il denaro nel contenitore era un sacerdote al quale l’offerente indicava lo scopo di quanto consegnava. Le urne si distinguevano proprio anche per la speciale destinazione data all’offerta e dunque all’uso che ne sarebbe stato fatto. Anche in questo ambiente non manca l’ostentazione che fa da legame narrativo con la sezione precedente: i ricchi gettano molto danaro. Proprio questo filo conduttore ci porta a scoprire che la pericope liturgica si gioca sul contrasto.
All’esteriorità e all’avidità di cui si è parlato si contrappone la generosità e la pochezza della vedova. Di proposito viene detto che la somma in suo possesso è costituita da due unità monetarie, le più piccole allora conosciute nel sistema numismatico della Giudea. Rimaneva così alla vedova la possibilità di un’equa, ragionevole divisione delle sue risorse con Dio. Non è stato questo il suo criterio di scelta. Completamente dimentica di sé ha affidato tutte le sue sostanze, quindi praticamente la sua vita a Dio.
Sulla linea del contrasto il messaggio evangelico potrebbe dunque essere questo: Dio non è una possibilità da sfruttare per la propria affermazione, ma una persona alla quale umilmente e fiduciosamente abbandonare se stessi.
Meditazione
La scena evangelica si apre con una singolare notazione: «la folla numerosa lo ascoltava volentieri». Perché? Gesù toccava il cuore della gente perché l’amava a tal punto da dare la sua stessa vita per loro. Ascoltare il Vangelo, e ascoltarlo volentieri, era decisivo per la salvezza. Già l’antico libro del Siracide esortava l’uomo saggio ad «ascoltare volentieri la parola divina» (6,35).
Siamo al termine del viaggio di Gesù verso Gerusalemme e il contrasto con gli scribi e i farisei ha raggiunto il suo culmine. L’evangelista Marco sottolinea la diversità tra l’atteggiamento della folla e quello della gerarchia religiosa. Non è una differenza di appartenenza. Il Vangelo di domenica scorsa parlava, ad esempio, di uno scriba che «non era lontano dal regno dei cieli». Il nodo del problema sta nel cuore dell’uomo, ossia se sente il bisogno di essere salvato. Gesù ascolta le domande della folla che lo segue e non vuole disattenderne il bisogno e tanto meno abbandonarla al suo destino. Il rifiuto o la disattenzione a quel grido avrebbe significato riconsegnare quella folla nelle mani degli scribi e dei farisei, cattivi pastori, che avrebbero lasciato tutti nella disperazione. L’indifferenza non è mai neutra; è molto di più, è abbandono dei più deboli in balìa degli «scribi». E ogni tempo ha i suoi «scribi» che si aggirano con lunghe vesti, che occupano i primi seggi nelle assemblee e nelle agorà della politica e della cultura, che ricevono i saluti e l’ossequio della maggioranza. Scribi e farisei sono coloro che dettano cosa sia la felicità o l’infelicità; sono coloro che governano le coscienze e i gusti, che ci indirizzano con un’autorità che spesso non cogliamo ma alla quale soggiaciamo. Sono dei veri «maestri» di vita. Hanno a disposizione potenti mezzi, come potenti e forti erano gli scribi al tempo di Gesù. Egli, allora come oggi, con la povertà della predicazione evangelica, vuole scalzarli dal loro ruolo di guida perché non impongano più pesi gravi e inutili sulle spalle della gente disperata. Gesù, solo lui, è il vero buon pastore.
Gesù non si arresta nella sua requisitoria e aggiunge: «Essi divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere». Le case delle vedove sono quelle di chi non ha nessuno che li difenda. Ancora oggi sono molte le case di vedove e di orfani non difesi, a volte si tratta di paesi interi. Sì, ci sono tante vedove come quella di Sarepta, di cui abbiamo ascoltato dal primo libro dei Re. Al tempo di Elia e di Gesù le vedove, assieme a orfani e stranieri, erano considerate tra i poveri. Infatti essere vedova (e, essendo numerose le guerre, era facile trovarsi in quella condizione) voleva dire perdere i propri diritti, ma soprattutto la possibilità di avere il necessario per vivere. Quanti sono costretti a dichiarare anche oggi: «Non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po’ d’olio nell’orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio: la mangeremo e moriremo»! In tante case e in tante terre non c’è da mangiare per il domani. Non c’è futuro. Chi guarderà queste vedove? Chi si prenderà cura di loro? Chi volgerà loro almeno uno sguardo?
Gesù le guarda. Le guarda come oggi ha fissato i suoi occhi sulla vedova che dava la sua offerta per il tempio. Gesù la vede mentre pone nelle mani del sacerdote due soli spiccioli. Nessuno, ovviamente, vi fa caso. Non è di famiglia nobile o di casa reale per attirare l’attenzione; non appartiene al mondo delle persone ricche o famose per essere notata. Non conta nulla. Se qualcuno dei passanti l’ha vista, l’avrà anche giudicata male. Cosa ha dato? Solo due spiccioli! Nulla, rispetto alle sostanziose offerte che i ricchi ostentavano. Ma quella donna, insignificante agli occhi dei più e magari anche disprezzata, è guardata con affetto e ammirazione da Gesù. Solo da lui. Neppure i discepoli si accorgono di lei. Possiamo immaginare Gesù che al vedere la scena chiama gli amici perché rivolgano l’attenzione a quella vedova. Ai discepoli, distratti o attenti solo a ciò che fa impressione, Gesù insegna a guardare con amore e attenzione anche le cose più piccole. È lo stesso sguardo di Dio, che con sollecitudine si prende cura dei poveri, come abbiamo cantato nel Salmo 145, una vera icona dell’amore di Dio per i poveri. Con la solennità dei momenti importanti – ben diverso è il giudizio degli uomini! – Gesù dice: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». Non ha trattenuto per sé neppure uno dei due spiccioli. Ella, a differenza degli altri e di tutti noi, ha amato Dio con tutta la sua anima e tutte le sue forze, sino a dare tutto quello che aveva. In una società che insegna a trattenere per se stessi, il dono della vedova e le parole di Gesù – perché si ha sempre bisogno delle parole del Signore per capire anche le cose semplici – ci indicano quanto siano vere le parole di Gesù riportate negli Atti degli Apostoli: «Sì è più beati nel dare che nel ricevere» (20,35).
Non è un caso che un episodio così insignificante e comunque così poco appariscente sia posto dall’evangelista a conclusione della vita pubblica di Gesù e del suo insegnamento nel tempio di Gerusalemme. Al contrario del giovane ricco che «se ne andò triste» perché aveva molti beni e volle conservarli per sé (Mc 10,22), questa povera vedova, donando tutto, ci insegna come amare Dio e il Vangelo. Ella si allontanò felice. Non era in verità vedova. Agli occhi degli uomini appariva tale. Su di lei si erano posati gli occhi d’amore di Gesù. La stessa felicità gusteremo noi se, come lei, sapremo dare il nostro povero cuore interamente al Signore.
Torniamo brevemente sull’episodio di Elia. La vicenda di Elia si apre nel capitolo 17 del Primo Libro dei Re proprio con il racconto dell’incontro del profeta con la vedova di Sarepta. Siamo innanzitutto in un territorio pagano, quindi la vedova non appartiene al popolo di Israele, non crede nel Dio di Elia. Eppure ella accoglie Elia e lo ascolta. Gesù stesso, rispondendo all’incredulità degli abitanti di Nazareth, citerà proprio questo episodio: «C’erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone» (Lc 4,25-26). La profezia di Elia, prima ancora di essere annuncio della parola di Dio, è incontro umano con una povera vedova, per la quale egli compie il miracolo del cibo e della vita ridonata al figlio. Fa parte del compito profetico, affidato ad ogni cristiano, comunicare la misericordia di Dio al mondo, a cominciare dai poveri. Ma anche i poveri, come quella vedova, hanno bisogno di ascoltare la parola del profeta, anzi hanno diritto di ascoltarla, perché solo essa può cambiare nel profondo la loro condizione avvicinandoli a Dio. Gesù, proprio nella sinagoga di Nazareth, fa proprio il compito profetico di Is 61: «Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio» (Lc 4,18). L’annuncio del Vangelo non è mai disgiunto dalla preoccupazione umana di fronte al bisogno materiale di coloro che incontriamo, ma guai se non tenessimo insieme questi due aspetti della vita cristiana.
L’immagine della domenica
| CANNETO (RIETI) – 2021 |

«A volte le parole non bastano.
E allora servono i colori.
E le forme.
E le note.
E le emozioni».
(Alessandro Baricco)
Preghiere e racconti
La generosità di cui parla il papa è una conseguenza della fede, intesa come “l’atteggiamento interiore di chi fonda la propria vita su Dio, sulla sua Parola, e confida totalmente in Lui”.
Riferendosi alla liturgia della 32ma domenica durante l’anno (B) il pontefice presenta la figura di due vedove, quella di Sarepta di Sidone, nel Primo Libro dei Re (17,10-16), e quella che offre due spiccioli al tesoro del tempio, nell’episodio narrato dal vangelo di Marco (12,41-44).
“Entrambe queste donne – spiega il Papa – sono molto povere, e proprio in tale loro condizione dimostrano una grande fede in Dio. La prima compare nel ciclo dei racconti sul profeta Elia. Costui, durante un tempo di carestia, riceve dal Signore l’ordine di recarsi nei pressi di Sidone, dunque fuori d’Israele, in territorio pagano. Là incontra questa vedova e le chiede dell’acqua da bere e un po’ di pane. La donna replica che le resta solo un pugno di farina e un goccio d’olio, ma, poiché il profeta insiste e le promette che, se lo ascolterà, farina e olio non mancheranno, lo esaudisce e viene ricompensata. La seconda vedova, quella del Vangelo, viene notata da Gesù nel tempio di Gerusalemme, precisamente presso il tesoro, dove la gente metteva le offerte. Gesù vede che questa donna getta nel tesoro due monetine; allora chiama i discepoli e spiega che il suo obolo è maggiore di quello dei ricchi, perché, mentre questi danno del loro superfluo, la vedova ha offerto ‘tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere’ (Mc 12,44)”.
“Quella della vedova, nell’antichità, – continua – costituiva di per sé una condizione di grave bisogno. Per questo, nella Bibbia, le vedove e gli orfani sono persone di cui Dio si prende cura in modo speciale: hanno perso l’appoggio terreno, ma Dio rimane il loro Sposo, il loro Genitore. Tuttavia la Scrittura dice che la condizione oggettiva di bisogno, in questo caso il fatto di essere vedova, non è sufficiente: Dio chiede sempre la nostra libera adesione di fede, che si esprime nell’amore per Lui e per il prossimo. Nessuno è così povero da non poter donare qualcosa. E infatti entrambe le nostre vedove di oggi dimostrano la loro fede compiendo un gesto di carità: l’una verso il profeta e l’altra facendo l’elemosina. Così attestano l’unità inscindibile tra fede e carità, come pure tra l’amore di Dio e l’amore del prossimo – come ci ricordava il Vangelo di domenica scorsa.
“Il Papa San Leone Magno – continua – di cui ieri abbiamo celebrato la memoria, così afferma: ‘Sulla bilancia della giustizia divina non si pesa la quantità dei doni, bensì il peso dei cuori. La vedova del Vangelo depositò nel tesoro del tempio due spiccioli e superò i doni di tutti i ricchi. Nessun gesto di bontà è privo di senso davanti a Dio, nessuna misericordia resta senza frutto (Sermo de jejunio dec. mens., 90, 3)”.
“La Vergine Maria – conclude – è esempio perfetto di chi offre tutto se stesso confidando in Dio; con questa fede ella disse all’Angelo il suo «Eccomi» e accolse la volontà del Signore. Maria aiuti anche ciascuno di noi, in questo Anno della fede, a rafforzare la fiducia in Dio e nella sua Parola”.
(Benedetto XVI)
Trascorremmo quella notte in un delizioso alberghetto sulla riva di un lago circondato da un fitto bosco. L’edificio era costruito in pietra e legno e dotato di caminetti in cui crepitava un bel fuoco. I motivi disegnati sulla carta da parati si ispiravano al nome di ogni stanza. La nostra si chiamava La prateria: era di color verde chiaro e le pareti erano piene di piante e fiori silvestri. Le regole della casa costrinsero Ali a dormire solo quella notte, in una piccola ma confortevole cuccetta, ma era chiaro che il mio amico avrebbe fatto una gran fatica a separarsi fisicamente ed emotivamente dal suo cucciolo.
Quando scendemmo per la cena non fu una gran sorpresa incontrare la stessa famiglia chiassosa che avevamo già notato all’ora di pranzo, visto che in quella zona gli hotel non sono certo numerosi. Com’era ovvio, la nostra entrata provocò lo stesso trambusto di poche ore prima, a dimostrazione del detto: “Qualunque cosa farai, non riuscirai mai ad accontentare tutti”. Tuttavia, con il passare dei minuti, forse per colpa della stanchezza di bambini e adulti, l’atmosfera al loro tavolo si fece così sgradevole che cominciammo a sentirci a disagio per l’evidente aggressività e violenza trattenuta a stento che si respirava in quella sala. Il figlio più piccolo piangeva disperato. Un altro era in punizione senza cena. Un terzo era costretto a finire una porzione di pesce che evidentemente non gli piaceva. Gli altre due tenevano gli occhi fissi sul piatto, senza il coraggio di aprire la bocca. Il mio giovane amico, poco avvezzo ai litigi familiari, rimase profondamente colpito dalla scena, fin quasi a perdere l’appetito. E fu allora che compì il secondo miracolo d’amore del nostro viaggio: si alzò da tavola, andò a prendere Ali e, portandolo in braccio come un soffice bebè bianco, lo offrì in regalo ai bambini. Loro, con gli occhi che sprizzavano gioia, allungarono le mani per accarezzarlo. Il gesto e l’atteggiamento del giovane principe furono così commoventi che i genitori non seppero cosa dire. Quando alla fine si decisero a reagire e cercarono di rifiutare il dono, Ali faceva già parte delle loro vite. […] Da quel momento la felicità tornò a regnare nella sala da pranzo e il mio giovane amico si godette la sua cena, interrotta di continuo dai saluti e dalle risate dei bambini, oltre che dai latrati di gioia di Ali, che a quel punto aveva ben cinque amici pronti a giocare con lui e a soddisfare ogni sua necessità.
“È stato proprio un bel gesto, soprattutto perché stamattina quei bambini ti avevano preso in giro” commentai per vedere come avrebbe reagito. Ma per tutta risposta lui disse: “Sei stato tu a farmi capire che li avevo provocati con il mio aspetto strano, ed è normale che i bambini reagiscano in maniera spontanea. E poi, non ne potevo più di quella tensione, e ho seguito l’impulso da fare qualcosa per allentarla. Ali mi è stato accanto, portandomi felicità quando più ne avevo bisogno. Mi fa piacere che adesso possa illuminare altri cuori”.
Con questa gratificante esperienza volgeva al termine la seconda giornata del nostro viaggio. Una volta ancora, ebbi l’impressione che il giovane principe avesse superarto con un solo gesto tutte le mie prolisse spiegazioni.
(A.G. ROEMMERS, Il ritorno del giovane principe, Corbaccio, Milano, 2012, 85-87)
Nell’attesa dell’ora, il Figlio dell’uomo non agisce quasi più. Si limita a guardar passare la gente: gli scribi in lunghe vesti riveriti per tutto in grazia delle loro interminabili preghiere, i fedeli che gettano i loro doni nella cassa delle offerte. Appoggiato a una colonna, nel recinto del Tempio, Gesù si inquieta, si fa beffe dei Farisei, e al tempo stesso s’intenerisce per una vedova che offre a Dio la sua stessa indigenza. Che vale un’elemosina che non ci priva di nulla? Forse, noi non abbiamo mai dato nulla.
(F. MAURIAC, Vita di Gesù, Milano, Mondadori, 1950, 123-124).
Gli spiccioli della vedova e il tesoro in Cielo
Il Vangelo mette a confronto due magisteri: quello degli scribi, teologi e giuristi importanti, e quello di una vedova povera e sola; ci porta alla scuola di una donna senza più difese e la fa maestra di vita. Gli scribi sono identificati per tre comportamenti: per come appaiono (passeggiano in lunghe vesti) per la ricerca dei primi posti nella vita sociale, per l’avidità con cui acquisiscono beni: divorano le case delle vedove, insaziabili e spietati. Tre azioni descritte con i verbi che Gesù rifiuta: apparire, salire e comandare, avere. Sintomi di una malattia devastante, inguaribile, quella del narcisismo.
Sono di fatto gli inconvertibili: Narciso è più lontano da Dio di Caino. Gesù contrappone un Vangelo di verbi alternativi: essere, discendere, servire e donare. Lo fa portandoci in un luogo che è quanto di più estraneo al suo messaggio si possa immaginare: in faccia al tesoro del tempio; e lì, seduto come un maestro, osserva come la gente getta denaro nel tesoro: “come” non “quanto”.
Le bilance di Dio non sono quantitative, ma qualitative. I ricchi gettavano molte monete, Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine. Due spiccioli, un niente, ma pieno di cuore. Gesù se n’è accorto, unico; chiama a sé i discepoli, li convoca, erano con la testa altrove, e offre la sua lettura spiazzante e liberante: questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Gesù non bada alla quantità di denaro. Anzi afferma che l’evidenza della quantità è solo illusione. Conta quanto peso di vita c’è dentro, quanto cuore, quanto di lacrime, di speranza, di fede è dentro due spiccioli.
L’uomo per star bene deve dare. È la legge della vita, siamo progettati così. Questa capacità di dare, e dare come un povero non come un ricco, ha in sé qualcosa di divino! Tutto ciò che è fatto con tutto il cuore ci avvicina all’assoluto di Dio.
Il verbo salvifico che Gesù propone in contrapposizione al “divorare” degli scribi, è “gettare”, ripetuto sette volte nel brano, un dare generoso e senza ritorno. Lo sa bene la vedova, l’emblema della mancanza. La sua mano getta, dona con gesto largo, sicuro, generoso, convinto, anche se ciò che ha da donare è pochissimo. Ma non è la quantità che conta, conta sempre il cuore, conta l’investimento di vita. La fede della vedova è viva e la fa vivere. Non le dà privilegi né le riempie la borsa, ma le allarga il cuore e le dà la gioia di sentirsi figlia di Dio, così sicura dell’amore del Padre da donare tutto il poco che ha. Questa donna, che convive col vuoto e ne conosce l’angoscia, è fiduciosa come gli uccelli del cielo, come i gigli del campo. E il Vangelo torna a trasmettere il suo respiro di liberazione.
(Ermes Ronchi)
1. Il gesto dell’obolo della vedova, su cui soffermiamo l’attenzione, è episodio in assoluto decisivo per la comprensione dell’intero scritto di Marco. Ne è una chiave di lettura, non a caso collocata tra la conclusione delle controversie di Gesù al tempio e sul tempio (Mc 11,27-12,40) e la profezia sulla distruzione del tempio (Mc13), con la proclamazione del Cristo pietra scartata divenuta pietra d’angolo di una nuova costruzione.
Opera fatta dal Signore, meraviglia ai nostri occhi (Mc 12,1-12; Sal 118,22-23). Non dunque di prima intenzione un racconto morale sulla generosità-non generosità, ma una narrazione esemplificativa del destino di morte di Gesù e del senso di quella morte e della intera sua vita.
2. Tutto muove da un atto di osservazione di Gesù, il quale «seduto di fronte al tesoro», alla cassetta cioè che raccoglieva le elemosine fatte al tempio, guarda la folla che vi depone la propria offerta. Sostanziosa, molte monete, quella di tanti ricchi, una cifra pressoché insignificante quella di una povera vedova, due monetine che fanno un soldo (Mc 12,41-42). All’osservazione Gesù fa seguire la chiamata a sé dei discepoli e l’interpretazione di quanto ha visto: questa vedova ha gettato più di tutti, tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere, non il superfluo (Mc 12,43-44). Non ha gettato cioè qualcosa ma ha buttato la sua stessa vita, il tutto di sé, questa la sua offerta per un mondo, aspetto da sottolineare, rappresentato da un tempio che non dà frutti e da gente che conta che si distingue per divorare le case delle vedove (Mc 12,40), dei poveri. In breve per un mondo non meritevole di ogni luogo e tempo, a cominciare da ciascuno e dalle proprie Chiese.
Un gesto assurdo, al di là di ogni logica, da parte di una creatura unica, la sola ad agire così, e per una realtà umana in declino che continua a tagliare i suoi figli minori (Mc 12,1-8), eppure amata al punto da dare tutto il proprio corpo e tutto il proprio sangue per essa (Mc 14,22-25). Gesù nella vedova ha letto se stesso e la sua morte così assurda, così inutile e così altamente significativa: è da dono radicale di sé a chi radicalmente ti nega che qualcosa di nuovo può nascere sotto il sole, le lacrime segno di una guarigione (Lc 22,62) operata da queste piaghe d’amore (1Pt 2,24).
3. Marco apre finestre che costituiranno materia ininterrotta di riflessione nella Chiesa delle origini e di sempre, il significato folle e scandaloso (1Cor 1,23) di un evento, la Croce, evocato dall’episodio dell’obolo della vedova. Dio in Cristo si identifica con una creatura nella miseria la cui generosità senza limite senza riserve stà nel donare totalmente se stessa, per puro amore, a un mondo assurdo che la sfrutta. Icona dello spegnersi di Cristo per uomini di ogni dove senza frutti, senza qualità, sempre pronti a spegnerlo: io, tu, noi, loro senza eccezione alcuna, infastiditi dalla sua stessa presenza che costringe a rendersi conto del come siamo presenti al mondo. Ma ove tale dono di sé del Cristo viene accolto, e le vie al sì sono tante quante sono le creature umane, lì inizia a nascere l’uomo nuovo, la catena delle vedove che nella loro pochezza hanno appreso qual’è la vera ricchezza che dà senso al vivere e al morire aprendo scenari inediti di resurrezione, consumare se stessi per ciò che amabile non è.
Sulle orme di Dio in Cristo e in forza del suo sguardo al contempo lucido e tenero: vede la mia insipienza e ci muore per rendermi sapiente, vede la mia cattiveria e ci muore per rendermi buono, vede la mia meschina astuzia e ci muore per rendermi semplice. Vede la mia non qualità e mi sogna a sua altezza: «predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio» (Rm 8,29).
(Giancarlo Bruni)
Ognuno è chiamato ad essere dio. Ma essere dio non vuol dire avere tutto, servirsi di ogni cosa e di ogni uomo; non vuol dire essere un “potente” per opprimere gli altri. Essere dio vuol dire essere un potente che dona agli altri il suo potere; vuol dire dare un senso di eternità a ciò che ci circonda, dare speranza ai disperati, gioia a chi piange, luce a chi non vede…Vuol dire indicare Dio a chi crede che Dio non esista.
(O. OLIVIERO, L’amore ha già vinto. Pensieri e lettere spirituali (1977-2005), Milano 2005, 22).
Si racconta di un abate che, quando veniva criticato, era solito scrivere il nome del monaco su un foglietto e lo metteva nel cassetto. In tal modo si ricordava che doveva contraccambiare il giudizio poco benevolo con una cortesia.
Si narra ancora di un mendicante che un giorno s’imbattè nel re, seduto su un cocchio dorato. Con sua meraviglia e sorpresa, il re lo guardò e gli tese la mano, chiedendo l’elemosina. Meravigliato, il mendicante frugò nella sua bisaccia ed estrasse un chicco di riso, il più piccolo che era riuscito a trovare. Alla sera, quando svuotò la bisaccia trovò il piccolo chicco trasformato in pepita d’oro. Si rammaricò. Se avesse donato tutto il suo riso, sarebbe diventato ricco.
«Chi usa misericordia verso il povero, presta a interesse al Signore» (Pr 19,17). […] Colui che presta denaro ai poveri del Signore, attende dal Signore la ricompensa della vita eterna. Del resto, anche il beato apostolo Paolo nel suo insegnamento attesta che, tra le preoccupazioni di tutte le chiese, quella che lui ha per i poveri non è di certo la più piccola. Dice infatti: «Soltanto ricordiamoci dei poveri, cosa che mi sono preoccupato di fare» (Gal 2,10); e in un altro passo esclama: «Niente abbiamo portato venendo in questo mondo, e niente possiamo portar via» (1Tm 6,7); e ancora: «Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto?» (2Cor4,7). […] Ricordiamoci anche di quella vedova che, nella sua sollecitudine per i poveri, trascurando se stessa, si privò di tutto quello che aveva per vivere, memore soltanto della vita futura, come attesta il Giudice stesso, il quale dice che altri danno del loro superfluo, essa invece, che forse era più bisognosa di molti anche tra i poveri, pur possedendo solo due monete, fu in verità più ricca nell’animo di tutti quanti i ricchi, e rivolta ai soli doni della bontà divina, avara del solo tesoro celeste, donò tutto quello che possedeva, perché tutto ciò che si raccoglie sulla terra alla terra deve tornare. Essa gettò nel tesoro del tempio quello che aveva per possedere ciò che non aveva ancora visto; vi gettò i beni destinati alla corruzione per procurarsi quelli immortali. Quella povera donna non disprezzò il giudizio disposto e ordinato da Dio per essere accolti da lui quando ritornerà. Per questo colui che tutto dispone e il Giudice del mondo anticipò la sua sentenza e lodò nel Vangelo la donna che avrebbe incoronata nel giudizio. […] Rendiamo dunque al Signore i suoi doni; restituiamoli a lui che li riceve nella persona di ogni povero; diamoli, dico, con gioia per riceverli di nuovo da lui con esultanza, come egli stesso afferma.
(PAOLINO DA NOLA, Lettere 34,2-4, PL 61,345C.346A-C).
Qualche tempo fa, ho ricevuto un articolo non firmato intitolato Le persone sono doni. Vorrei parafrasarne alcuni passi come segue:
«Le persone sono doni di Dio che mi vengono fatti. Sono già avvolti in una carta a volte bella, a volte meno attraente. Alcuni vengono strapazzati durante l’invio postale; altri, invece, sono recapitati con riguardo per espresso; alcuni sono avvolti alla bell’ e meglio e sono facili da aprire, altri sono chiusi saldamente.
Ma il dono non è l’involucro ed è importante rendersene conto. È così facile sbagliarsi al riguardo, e giudicare il contenuto dall’involucro esteriore.
Talvolta, il dono si apre con grande facilità; altre volte, c’è bisogno dell’aiuto altrui. Forse ciò è dovuto al fatto che gli altri hanno paura; forse in precedenza sono stati feriti e non vogliono esserlo ancora; o, forse, in passato sono stati aperti e poi abbandonati. Può darsi che adesso si sentano più una “cosa” che “persone”.
Io sono una persona: come chiunque altro, anch’io sono un dono. Dio ha infuso in me una bontà che è solo mia. E tuttavia, a volte, ho paura di guardare dentro il mio involucro: forse temo di essere deluso; forse non mi fido del mio contenuto; o forse non ho mai accettato veramente il dono che io stesso costituisco.
Ogni incontro e ogni condivisione con le persone è uno scambio di doni. Il mio dono sono io; il tuo dono sei tu. Siamo doni vicendevoli».
(J. POWELL, Parlami di te. So ascoltare il tuo Cuore, Milano, Gribaudi, 2005, 24-25).
“I valorosi sono sempre tenaci?”. Dal cielo, il Signore sorride contento, perché era ciò che Egli voleva: che ciascuno avesse nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. In fin dei conti aveva dato ai propri figli il più grande di tutti i doni: la capacità di scegliere e di decidere i propri atti. Soltanto gli uomini e le donne segnati nel cuore dalla fiamma sacra avevano coraggio di affrontarLo. E soltanto questi conoscevano il cammino per tornare al Suo amore, giacché capivano finalmente che la tragedia non era una punizione, ma una sfida.
Elia rivide a uno a uno tutti i suoi passi: dal momento in cui aveva lasciato la falegnameria, aveva accettato la propria missione senza discutere. Anche se fosse stata vera, e lui pensava che lo fosse, Elia non aveva mai avuto l’opportunità di vedere che cosa accadeva nei cammini che aveva rifiutato di percorrere. Perché aveva paura di perdere la fede, la dedizione, la volontà. Riteneva che fosse molto rischioso sperimentare il cammino delle persone comuni: alla fine avrebbe potuto anche abituarsi e amare ciò che vedeva. Non capiva che anche lui era una persona come tutte le altre, anche se udiva gli angeli e riceveva di tanto in tanto qualche ordine da Dio: era talmente convinto di sapere ciò che voleva da essersi comportato proprio come coloro che non avevano mai preso una decisione importante nella vita.
Era sfuggito al dubbio. Alla sconfitta. Ai momenti di indecisione. Ma il Signore era generoso, e lo aveva condotto nell’abisso dell’inevitabile per dimostrargli che l’uomo deve scegliere, e non accettare, il proprio destino.
(Paulo COELHO, Monte Cinque, Bompiani, Milano, 1998, 206-207).
Signore Gesù,
che da ricco che eri ti sei fatto povero per arricchirci con la tua povertà,
aumenta la nostra fede!
È sempre molto poco ciò che abbiamo da offrirti,
ma tu aiutaci a consegnarlo senza esitazione nelle tue mani.
Tu sei il Tesoro del Padre e il Tesoro dell’umanità:
in te si riversa la pienezza della divinità,
eppure tu attendi ancora, da noi, l’obolo di ciò che siamo,
perfino del nostro peccato.
Crediamo che tu puoi trasformare la nostra miseria in beatitudine per molti,
ma tu insegnaci la generosità e l’abbandono confidente dei poveri in spirito!
Vogliamo accettare la sfida della tua parola e donarti tutto,
anche il necessario per l’oggi e il domani: tu stesso fin d’ora sei la Vita per noi.
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
—
– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2002-2003; 2005-2006- .
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. II: Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.
– E. BIANCHI et al., Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche. Anno B, Milano, Vita e Pensiero, 2008.
– COMUNITÀ DI S. EGIDIO, La Parola e la storia, Milano, Vita e Pensiero, 2011.
– J.M. NOUWEN, Un ricordo che guida, in ID., Mostrami il cammino. Meditazioni per il tempo di Quaresima, Brescia, Queriniana, 2003.
—
– Immagine della domenica, a cura di García-Orsini-Pennesi

Carissimi Colleghi, Allieve e Allievi,
vi raggiungo per darvi la notizia della morte di Padre Rinaldo Paganelli (1955-2024), dehoniano e nostro docente di Catechetica.
Dopo aver subito un delicato intervento chirurgico la settimana scorsa a motivo di un tumore, Padre Rinaldo è ritornato alla Casa del Padre, stamattina 19 ottobre, dopo un faticoso decorso post-operatorio.
Lo ricordiamo nella preghiera per la sua serenità e fraternità, per la sua competenza e passione nelle varie discipline catechetiche da lui impartite presso la nostra Facoltà di Scienze dell’Educazione.
Nel sito dell’Istituto posteremo un breve profilo e l’ultima intervista da lui rilasciata in prossimità del Simposio di novembre. Avremo modo di ricordarlo e mostrargli la nostra gratitudine come ICa.
L’eucaristia di saluto sarà celebrata a Roma, presso la Parrocchia Cristo Re (Viale Mazzini, adiacente alla Sede RAI) lunedì 21 ottobre alle ore 15.
Martedì p.v. per desiderio dei fratelli, sarà traslato a Grignano di Brembate (BG) per essere ivi tumulato.
Vi chiedo la cortesia di informare quanti hanno conosciuto Padre Rinaldo e i responsabili delle Vostre Comunità, Istituti e Collegi.
Lo affidiamo alla misericordia di Dio Padre e alla tenerezza di Maria SS. madre di Cristo e nostra.
Fraternamente
don Giuseppe Ruta

Lectio – Anno B
Prima lettura: Isaia 53,10-11
| Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza; il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. |
Il v. 2, letto per intero, contiene questa parte, omessa nel brano liturgico: «Non ha né apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare in lui diletto». In linea con questa descrizione, il Servo del Signore è paragonato ad una pianta che a motivo dell’aridità del suolo presenta l’aspetto non bello di un arbusto spuntato in mezzo al deserto.
—Ecco perché è «reietto», tenuto lontano e in poco conto da parte degli uomini (v. 3), e lui stesso è «uomo dei dolori», soffrendo in mezzo al disprezzo, all’aridità, alla solitudine.
— I vv. 10-11 formano una strofa del carme, nella quale vengono evidenziate due dimensioni: da una parte l’espiazione, nel senso che il Servo soffre per gli altri, per i loro peccati (v. 110); dall’altra l’esaltazione, nel senso che Dio gli darà gloria perché ha preso su di sé tale sofferenza per gli altri. I due versi costituiscono un prezioso commento o spiegazione della parola sul riscatto pagato dal Figlio dell’uomo, alla fine del Vangelo di oggi (Mc 10,15).
Seconda lettura: Ebrei 4,14-16
| Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. |
Gesù, attraverso la risurrezione e la glorificazione «è passato attraverso i cieli» (v. 14), vale a dire è entrato nel tempio celeste, come il sommo sacerdote entra in quello terreno nel giorno dell’espiazione. Questa è la nostra confessione (homologia), corrisponde cioè alla sostanza di quello che decidiamo di credere.
— «Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze...» (v. 15). A questo punto la Lett. agli Ebrei tocca il mysterium compassionis: l’incarnazione è, fondamentalmente, la com-passione, il soffrire di Dio con noi. Il nostro sommo sacerdote ha voluto soffrire con noi ed essere messo alla prova insieme a noi.
— «Accostiamoci…al trono della grazia» (v. 16). Il Santo dei santi nasconde il «trono della grazia», chiamato in ebraico kapporet (cf. Rm 3,25: «hylasterion», propiziatorio), vale a dire il coperchio di oro che si trova sull’arca dell’Alleanza con i Cherubini, sui quali Dio è presente come re assiso sul trono. La presenza di Dio è soprattutto presenza di grazia. Per questo noi possiamo avvicinarci a tale trono pieni di gioia.
Vangelo: Marco 10,35-45
| In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora [Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».] |
Esegesi
Gesù ha annunziato per la terza volta la sua passione e morte ai Dodici in disparte (Mc 10,32-34), usando toni molto duri e realistici: lo condanneranno a morte, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo uccideranno. Nel vangelo odierno, ad immediato seguito di quelle dichiarazioni, i due figli di Zebedeo avanzano a Gesù un’ambiziosa domanda (vv. 35 ss): questa gli dà l’occasione di approfondire ed esplicitare il tema della passione, associando ad essa la sorte dei suoi discepoli.
«Nella tua gloria» (v. 37). Giacomo e Giovanni, che furono tra i primi ad accettare la chiamata del Maestro, sono persuasi di avere un titolo in più per occupare i primi posti in quel regno messianico glorioso che, secondo la comune convinzione dei discepoli, Gesù va ad inaugurare a Gerusalemme. Nonostante i ripetuti annunci di Gesù, coltivano ancora questa aspettativa terrena di gloria e vogliono accaparrarsene i posti di onore (a destra e a sinistra del re). Non è da escludere che nell’atteggiamento dei figli di Zebedeo si riflettano anche tensioni della chiesa nascente.
— Il calice, il battesimo (v. 38). In molti testi dell’Antico Testamento e del giudaismo il «calice» era metafora delle «vertigini» e sofferenze che Dio faceva provare ai peccatori (cf. Ger 25,15; Sal 11,6: 65,9 ecc.): Nella sua preghiera al Getsemani Gesù userà la medesima immagine (14,36). Lo stesso senso evoca la parola «battesimo», ossia immersione nelle onde della sofferenza (cf. Lc 12,50). Gesù coinvolge i discepoli nella sua missione di sofferenza.
— «Per coloro per i quali è stato preparato» (v. 40). Alla risposta affermativa dei due discepoli (dovuta sempre alla loro intenzione di partecipare alla gloria, anche se attraverso le prove), il Maestro replica che essi sono sì chiamati a partecipare alla sua intronizzazione messianica, ma non in base a diritti di umana precedenza, bensì per libera e gratuita iniziativa del Padre: il verbo preparare al passivo rimanda, come spesso nei testi biblici, alla sovrana volontà di Dio.
— «Dare la propria vita in riscatto per molti» (v. 45). Gesù prende spunto dalla «indignazione» umana degli altri discepoli (v. 41), per dichiarare lo statuto fondamentale che deve regolare i rapporti della comunità ecclesiale. Egli contesta radicalmente il modello di autorità dispotico che vige tra le genti, nel mondo pagano; e propone paradossalmente come modello di autorità due figure che sono agli antipodi: il servitore e lo schiavo. Queste due immagini, però, non sono generiche. Rappresentano concretamente la scelta di Gesù: per lui «servire» vuol dire essere fino in fondo obbediente e fedele alla volontà del Padre, sulla stessa linea del «servo del Signore» di Isaia (vedi I Lett.), che si fa solidale col peccato degli uomini. Dicendo che è venuto «per dare la sua vita in riscatto» per molti, il Cristo dichiara il carattere soteriologico della sua morte: la parola «riscatto» (in greco lytron, «mezzo per sciogliere») indicava, tra le altre realtà, il prezzo pagato per liberare uno schiavo. Accettando la sua morte come atto di amore e liberazione degli uomini dalla schiavitù del peccato, Gesù consegna alla comunità dei discepoli un modello di amore supremo, che essa è chiamata a inverare e prolungare nella vita.
Meditazione
La tentazione del potere. Così potremmo riassumere il tema del brano evangelico di questa ventinovesima domenica. Marco riferisce un dialogo tra Gesù e i due figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni. Siamo ancora sulla strada verso Gerusalemme e, per la terza volta, Gesù confida ai discepoli il destino di morte che lo aspetta al termine del cammino. I due discepoli, per nulla toccati dalle tragiche parole del maestro, e con una notevole durezza di cuore di fronte a Gesù si fanno avanti per chiedergli i primi posti accanto a lui quando instaurerà il regno. Dopo la confessione di Pietro a Cesarea e la discussione su chi tra loro fosse il primo, probabilmente è cresciuto un clima di rivalità tra i discepoli; e questo forse spiega l’ambizione dei due fratelli nel rivendicare i primi posti. Quanto è difficile per Gesù toccare i cuori di quei dodici che pure si era scelti e curati! I discepoli sono esperti nel sottrarsi alle esigenze dell’amore. E con un tratto di astuzia, che conosciamo bene anche noi quando si tratta di prendersi cura dei nostri affari, i due chiedono a Gesù: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». La verità è che sono davvero distanti dal pensiero e dalle preoccupazioni di Gesù, e non riescono a sintonizzarsi con lui. Non basta, infatti, stargli fisicamente vicino per comprenderlo (potremmo tradurre: non è sufficiente semplicemente frequentare la chiesa per comprendere Gesù e il suo Vangelo). È necessario ascoltarlo e obbedire giorno dopo giorno alla sua parola; e quindi seguirlo in un vero e proprio itinerario di crescita interiore. Quante volte, invece, dobbiamo constatare la nostra povertà spirituale, la nostra scarsa sapienza evangelica! E di fronte a tante nostre pretese, anche noi potremmo sentirci dire da Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete». Spesso la distanza da Gesù non ci fa comprendere le profondità del mistero del Signore e neppure le esigenze del suo amore.
Gesù, rivolto ai due, chiede: «Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». E cerca di spiegarglielo usando due simboli, il calice e il battesimo, ben noti a chi come loro frequentavano le Sante Scritture. Ambedue i simboli sono interpretati da Gesù in rapporto alla sua morte. Il calice è il segno dell’ira di Dio, come scrive Isaia: «Svegliati, svegliati, alzati, Gerusalemme, che hai bevuto dalla mano del Signore il calice della sua ira» (Is 51,17); e Geremia dice: «Prendi dalla mia mano questa coppa di vino della mia ira e falla bere a tutte le nazioni alle quali ti invio» (Ger 25,15). Per Gesù è una metafora con la quale indica che egli prende su di sé il giudizio di Dio per il male compiuto nel mondo, anche a costo della morte. La stessa cosa vale per il simbolo del battesimo: «Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati» (Sl 42,8). Le due immagini mostrano che il cammino di Gesù non è una folgorante e oleata carriera verso il potere. Semmai è il cammino dell’assunzione su di sé del male degli uomini, come disse il Battista: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!» (Gv 1,29). I due discepoli probabilmente neppure ascoltano le parole del maestro e tanto meno ne comprendono il senso. Del resto la Parola evangelica, per essere ascoltata e compresa, richiede un atteggiamento di ascolto e di preghiera. Ai due apostoli, come spesso anche a noi, non importa comprendere la Parola evangelica; quel che interessa è l’assicurazione del posto. E con sciocca semplificazione, i due rispondono: «Lo possiamo!». È la stessa superficiale faciloneria con cui risponderanno a Gesù al termine dell’ultima cena, mentre si avviano con lui verso l’orto degli Ulivi (Mt 26,35). Basta solo qualche ora, ed eccoli, assieme agli altri, abbandonare di corsa il Maestro per paura e lasciarlo nelle mani dei servi dei sommi sacerdoti.
La richiesta dei due figli di Zebedeo era ovvio che scatenasse l’invidia e la gelosia degli altri discepoli («cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni», nota l’evangelista). Gesù allora li chiamò ancora una volta tutti attorno a sé per una nuova lezione evangelica. Ogni volta che i discepoli non ascoltano le parole di Gesù e si lasciano guidare dai loro ragionamenti, si discostano dalla via evangelica e provocano liti e dissidi al loro stesso interno. È istintiva nei discepoli, come del resto in ogni persona, la tendenza a fare da maestri a se stessi, a divenire «adulti», ossia indipendenti e autosufficienti, sino al punto da fare a meno di tutti, persino di Gesù. È lo stile di questo mondo, che tutti conosciamo molto bene poiché lo pratichiamo con frequenza. Per il Vangelo è vero l’esatto contrario: il discepolo resta sempre alla scuola del maestro, rimane sempre uno che ascolta le parole evangeliche. Il discepolo di Gesù, anche se dovesse occupare posti di responsabilità, sia nella Chiesa che nella vita civile, resta sempre figlio del Signore, ossia discepolo che sta ai piedi di Gesù. Ecco perché Gesù raduna nuovamente i Dodici attorno a sé e li ammaestra: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così». L’istinto del potere — sembra dire Gesù — è ben radicato nel cuore degli uomini, anche in quello di chi spergiura di non esserne sfiorato. Nessuno, neppure all’interno della comunità cristiana, è immune da tale tentazione (si potrebbe dire che lo stesso Gesù subì la tentazione del potere, quando fu condotto dallo Spirito nel deserto). Non importa che si tratti del «grande» o del «piccolo» potere; tutti ne subiamo il fascino. È normale fare considerazioni severe su coloro che hanno il potere politico, economico, culturale; e talora è anche necessario farlo. Forse però è più facile fare l’esame di coscienza agli altri che a se stessi, in genere uomini e donne dal «piccolo potere». Non dovremmo tutti chiederci quanto spesso usiamo in modo egoistico e arrogante quella piccola fetta di potere che ci siamo ritagliati in famiglia, o a scuola, o in ufficio, o dietro uno sportello, o per la strada, o nelle istituzioni ecclesiali, o comunque altrove? La scarsa riflessione in questo campo è spesso fonte di amarezze, di lotte, di invidie, di opposizioni, di crudeltà. Ai suoi discepoli Gesù continua a dire: «Tra voi però non è così» (forse sarebbe più corretto dire: «Non sia così»). Non si tratta di una crociata contro il potere, per favorire un facile umilismo che può anche essere solo indifferenza. Gesù ha avuto potere («insegnava come uno che ha autorità», scrive Matteo 7,29), e lo ha concesso anche ai discepoli («Diede loro potere sugli spiriti impuri», si legge in Marco 6,7). Il problema è di quale potere si parla, e comunque di come lo si esercita. È il potere dell’amore. Gesù lo spiega non solo con le parole quando afferma: «Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore», ma con la sua stessa vita. Dice di se stesso che «non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Così deve essere per ogni suo discepolo.
Sia la prima che la seconda lettura ci spiegano come il potere di Gesù sia quello di un uomo che ha preso «parte alle nostre debolezze», lui che «è stato prostrato con dolori» e ci ha salvato con il dono della sua vita. È lui il Sommo Sacerdote, che ci permette di entrare in comunione con Dio e di imparare da lui la via del servizio: «Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno».
L’immagine della domenica
| ALIANO (MATERA-BASILICATA) – 2006 |

«La vera autenticità non sta nell’essere come si è, ma nel riuscire a somigliare il più possibile al sogno che si ha di se stessi».
(dal libro di Daniela Collu, Volevo solo camminare, p. 48).
Preghiere e racconti
«La Chiesa si sente spinta non solo a formare i suoi figli, ma a lasciarsi formare essa stessa vivendo al suo interno secondo modelli e relazioni fondate sul vangelo, secondo quelle modalità che sono capaci di esprimere una comunità alternativa. Cioè una comunità che, in una società connotata da relazioni fragili, conflittuali e di tipo consumistico, esprima la possibilità di relazioni gratuite, forti e durature, cementante dalla mutua accettazione e dal perdono reciproco».
(Card. C.M. Martini)
Ti offro, Signore, il mio servizio
lo affronto serenamente con il Tuo aiuto,
per la Tua gloria, come collaborazione
all’opera creatrice del Padre
per il benessere di tutti.
Cristo, insegnami a pensare al mio servizio,
non soltanto come una fatica,
ma come occasione
per servire amando il mio prossimo
e così incontrare Te,
che mi hai redento e vegli su di me.
Spirito Santo,
aiutami a rendere l’ambiente del servizio
più umano e cristiano perché aiuti
tutti a ritrovarci fratelli.
(Card. Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI).
Signore, mettici al servizio dei nostri fratelli
che vivono e muoiono nella povertà e nella fame di tutto il mondo.
Affidali a noi oggi;
dà loro il pane quotidiano
insieme al nostro amore pieno di comprensione, di pace, di gioia.
Signore, fa di me uno strumento della tua pace,
affinché io possa portare l’amore dove c’è l’odio,
lo spirito del perdono dove c’è l’ingiustizia,
l’armonia dove c’è la discordia,
la verità dove c’è l’errore,
la fede dove c’è il dubbio,
la speranza dove c’è la disperazione,
la luce dove ci sono ombre,
e la gioia dove c’è la tristezza.
Signore, fa che io cerchi di confortare e di non essere confortata,
di capire, e non di essere capita,
e di amare e non di essere amata,
perché dimenticando se stessi ci si ritrova,
perdonando si viene perdonati
e morendo ci si risveglia alla vita eterna.
(Madre Teresa di Calcutta)
Non biasimare altri per la tua sorte, perché tu e soltanto tu hai preso la decisione di vivere la vita che volevi. La vita non ti appartiene, e se, per qualche ragione, ti sfida, non dimenticare che il dolore e la sofferenza sono la base della crescita spirituale. Il vero successo, per gli uomini, inizia dagli errori e dalle esperienze del passato. Le circostanze in cui ti trovi possono essere a tuo favore o contro, ma è il tuo atteggiamento verso ciò che ti capita quello che ti darà la forza di essere chiunque tu voglia essere, se comprendi la lezione. Impara a trasformare una situazione difficile in un’arma a tuo favore. Non sentirti sopraffatto dalla pena per la tua salute o per le situazioni in cui ti getta la vita: queste non sono altro che sfide, ed è il tuo atteggiamento verso queste sfide che fa la differenza. Impara a rinascere ancora una volta dalle ceneri del tuo dolore, a essere superiore al più grande degli ostacoli in cui tu possa mai imbatterti per gli scherzi del destino. Dentro di te c’è un essere capace di ogni cosa. Guardati allo specchio. Riconosci il tuo coraggio e i tuoi sogni, e non asserragliarti dietro alle tue debolezze per giustificare le tue sfortune. Se impari a conoscerti, se alla fine hai imparato chi tu sei veramente, diventerai libero e forte, e non sarai mai più un burattino nelle mani di altri. Tu sei il tuo destino, e nessuno può cambiarlo, se tu non lo consenti. Lascia che il tuo spirito si risvegli, cammina, lotta, prendi delle decisioni, e raggiungerai le mete che ti sei prefissato in vita tua. Sei parte della forza della vita stessa. Perché quando nella tua esistenza c’è una ragione per andare avanti, le difficoltà che la vita ti pone possono essere oggetto di conquista personale, non importa quali esse siano. Ricordati queste parole: “Lo scopo della fede è l’amore, lo scopo dell’amore è il servizio”.
(Sergio BAMBARÉN, La musica del silenzio, Sperling & Kupfer, 2006, 114-116).
Marco afferma che soltanto Giacomo e Giovanni si avvicinarono al Signore e lo pregarono, perché vede che erano soprattutto loro che volevano porre quella domanda al Signore e sa che essi avevano spinto la madre a chiedere. Bisogna credere che l’affetto femminile della madre e l’animo ancora carnale dei discepoli siano stati spinti a domandare, soprattutto perché essi ricordavano le parole del Signore: «Quando il Figlio dell’uomo sederà nel luogo della sua maestà, anche voi sederete sui dodici troni per giudicare le dodici tribù di Israele» (Mt 19,28) e sapevano di essere amati in modo speciale dal Signore a confronto con gli altri discepoli, e più volte, insieme con Pietro, erano stati fatti partecipi di misteri che agli altri rimanevano nascosti, come ricorda il vangelo. Per questo, infatti, anche a loro, come a Pietro, era stato imposto un nome nuovo; come Pietro, che prima si chiamava Simone, per la fortezza e la stabilità della fede inespugnabile meritò il nome di Pietro, così essi furono chiamati Boanerghés, cioè figli del tuono (cfr. Mc 3,16-17), perché avevano udito insieme con Pietro la voce gloriosa del Padre che scendeva sul Signore (cfr. Mt 17,5), conoscevano i segreti dei misteri più che gli altri discepoli e, cosa più essenziale, sentivano di aderire con cuore integro al Signore e di amarlo col più grande affetto. Perciò credevano che sarebbe stato possibile per loro sedergli più da vicino nel Regno, soprattutto perché vedevano che Giovanni per la singolare purezza di cuore e di corpo era tanto amato da lui da posare il capo sul suo petto durante la cena (cfr. Gv 13,23).
[…] Non sapevano che cosa chiedevano perché pensavano che ciascuno potesse scegliere a proprio arbitrio quale posto e quale ricompensa avrebbe ottenuto in dono nella vita futura e non pregavano invece il Signore di condurre a buon fine, ben meritandolo, la fiducia e la speranza che avevano, consapevoli che qualsiasi cosa di buono avessero fatto, egli li avrebbe ricompensati in misura infinitamente più grande. Certo è lodevole la loro semplicità, per cui con devota fiducia chiedevano di sedere nel Regno vicino al Signore, ma molto sarà lodata la sapiente umiltà di chi, consapevole della propria fragilità, diceva: «Ho scelto di essere disprezzato nella casa di Dio piuttosto che abitare sotto le tende dei peccatori» (Sal 83 [84],11). Non sapevano quel che chiedevano essi che domandavano al Signore i pre-mi sublimi piuttosto che la perfezione delle opere. Ma il maestro celeste, indicando che cosa anzitutto dovevano chiedere, li richiama alla via della fatica con la quale avrebbero conseguito il premio della ricompensa. Dice: «Potete voi bere il calice che io sto per bere?» (Mc 10,38). […] Che tutti i fedeli debbano seguire quest’ordine nella vita lo insegna l’Apostolo quando dice: «Se siamo diventati come una medesima pianta con lui in conformità alla sua morte, così lo saremo anche per conformità alla sua resurrezione» (Rm 6,5).
(BEDA IL VENERABILE, Omelie sui vangeli 2,21, CCL 122, pp. 336-338).
Come Gesù chi vuol essere grande sia servitore
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo (…). «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete (…). Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti (…)».
Giovanni, non un apostolo qualunque ma il preferito, il più vicino, il più intuitivo, chiede per sé e per suo fratello i primi posti. E l’intero gruppo dei dieci immediatamente si ribella, unanime nella gelosia. È come se finora Gesù avesse parlato a vuoto: «Non sapete quello che chiedete!». Non sapete quali argini abbattete con questa fame di primeggiare, non capite la forza oscura che nasce da queste ubriacature di potere, che povero cuore ne esce. Ed ecco le parole con cui Gesù spalanca la differenza cristiana: «tra voi non sia così». I grandi della terra dominano sugli altri… Tra voi non è così! Credono di governare con la forza… non così tra voi! Chi vuole diventare grande tra voi. Una volontà di grandezza è innata nell’uomo: il non accontentarsi, il “morso del più”, il cuore inquieto.
Gesù non condanna tutto questo, non vuole nel suo regno uomini e donne incompiuti e sbiaditi, ma pienamente fioriti, regali, nobili, fieri, liberi. La santità non è una passione spenta, ma una passione convertita: chi vuole essere grande sia servitore. Si converta da “primo” a “servo”. Cosa per niente facile, perché temiamo che il servizio sia nemico della felicità, che esiga un capitale di coraggio di cui siamo privi, che sia il nome difficile, troppo difficile, dell’amore. Eppure il termine servo è la più sorprendente di tutte le autodefinizioni di Gesù: «Non sono venuto per farmi servire, ma per essere servo». Parole che ci consegnano una vertigine: servo allora è un nome di Dio; Dio è mio servitore! Vanno a pezzi le vecchie idee su Dio e sull’uomo: Dio non è il Padrone dell’universo, il Signore dei signori, il Re dei re: è il Servo di tutti! Non tiene il mondo ai suoi piedi, è inginocchiato lui ai piedi delle sue creature; non ha troni, ma cinge un asciugamano.
Come sarebbe l’umanità se ognuno avesse verso l’altro la premura umile e fattiva di Dio? Se ognuno si inchinasse non davanti al potente ma all’ultimo? Noi non abbiamo ancora pensato abbastanza a cosa significhi avere un Dio nostro servitore. Il padrone fa paura, il servo no. Cristo ci libera dalla paura delle paure: quella di Dio. Il padrone giudica e punisce, il servo non lo farà mai; non spezza la canna incrinata ma la fascia come fosse un cuore ferito. Non finisce di spegnere lo stoppino dalla fiamma smorta, ma lo lavora finché ne sgorghi di nuovo il fuoco.
Dio non pretende che siamo già luminosi, opera in noi e con noi perché lo diventiamo. Se Dio è nostro servitore, chi sarà nostro padrone? Il cristiano non ha nessun padrone, eppure è il servitore di ogni frammento di vita. E questo non come riserva di viltà, ma come prodigio di coraggio, quello di Dio in noi, di Dio tutto in tutti.
(Ermes Ronchi)
L’accostamento del testo di Isaia a quello di Marco ha come esito la rivelazione che Gesù è il Servo del Signore. Ovvero, l’obbediente alla volontà del Signore che ha donato se stesso per gli uomini vivendo la sua esistenza facendosi loro servo. La domanda di Giacomo e Giovanni (“Noi vogliamo che tu ci faccia ciò che ti chiederemo”) esprime la distorsione più frequente della preghiera cristiana: se la preghiera, come appare dal Padre nostro, porta il discepolo a fare la volontà del Signore (“sia fatta la tua volontà”: Mt 6,10), la domanda dei due discepoli va nel senso contrario. Si chiede che Dio faccia ciò che noi vogliamo. La preghiera allora non è più dialogo tra due libertà, ma imposizione umana a un Dio che non è più il Signore, ma un idolo.
Occorre che il cristiano impari a domandare, perché la domanda esaudita è quella che chiede “nel nome del Signore”: “Tutto ciò che dobbiamo chiedere a Dio e dobbiamo attendere da lui si trova in Gesù Cristo. Occorre cercare di introdurci nella vita, nelle parole, negli atti, nelle sofferenze, nella morte di Gesù, per riconoscere ciò che Dio ha promesso e realizza sempre per noi. Dio infatti non realizza tutti i nostri desideri, ma realizza le sue promesse” (Dietrich Bonhoeffer).
Con la loro incosciente richiesta, i due figli di Zebedeo dimostrano, da un lato, la loro incomprensione delle parole che Gesù ha appena pronunciato sul suo futuro di sofferenza e morte (cf. Mc 10,32-34) e, dall’altro, rivelano di vivere la comunità come finalizzata alla loro personale riuscita: essi devono ancora operare il passaggio da “la comunità per me” (“per noi”: Mc 10,35) a “io per la comunità”, e devono ancora imparare che non la comunità in quanto tale può essere il fine cui tendono, ma il Regno che va oltre la comunità stessa. La scorretta o parziale comprensione di Cristo diviene distorsione ecclesiologica. Il richiamo di Gesù alla coppa da bere e all’immersione da ricevere, cioè alla morte cruenta che lo attende, corregge la comprensione che essi hanno di lui, ma ricorda anche che la chiesa vive del suo innesto nella morte vivificante di Cristo grazie al battesimo e all’eucaristia. Innesto che le conferisce una forma altra rispetto alle istituzioni mondane: non il potere, ma il servizio è la sua logica interna.
Da Gesù Servo nasce una chiesa serva. L’iniziativa dei due fratelli suscita un conflitto all’interno della comunità: “gli altri dieci si sdegnarono con loro” (Mc 10,41). Concorrenzialità e clericalismo ante litteram sono già presenti nel gruppo dei Dodici, tanto che Gesù li convoca e li istruisce sulla logica che deve abitare le comunità cristiane, opposta a quella che vige nei poteri di questo mondo.
“Tra voi non è così”: questa parola di Gesù pone un criterio discriminante tra chiesa e non-chiesa. La prima testimonianza politica della chiesa consiste nella sua strutturazione interna, nell’organizzazione delle sue strutture di autorità e nel modo di vivere l’autorità, che dev’essere conforme a quanto vissuto da Cristo e da lui richiesto ai discepoli.
La parola di Gesù stigmatizza le logiche dei poteri mondani, ma soprattutto si rivolge alla chiesa: alla tentazione della mimesi dei meccanismi mondani, Gesù oppone la differenza cristiana fondata sul farsi servi gli uni degli altri. Se la chiesa è la testimone di Cristo Servo nella storia tra la croce e la parusia, allora la sua forma la mostra quale comunità non omologata, né asservita. Insomma, con una battuta, la chiesa non è uno Stato: “Tra voi, non è così”. Essa invece è, secondo le belle parole del Card. Carlo Maria Martini, “comunità alternativa”: “La chiesa si sente spinta non solo a formare i suoi figli, ma a lasciarsi formare essa stessa vivendo al suo interno secondo modellini relazioni fondate sul vangelo, secondo quelle modalità che sono capaci di esprimere una comunità alternativa. Cioè una comunità che, in una società connotata da relazioni fragili, conflittuali e di tipo consumistico, esprima la possibilità di relazioni gratuite, forti e durature, cementate dalla mutua accettazione e dal perdono reciproco”.
(Luciano Manicardi)
Signore Gesù, come Giacomo e Giovanni anche noi spesso «vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiediamo». Non siamo infatti migliori dei due discepoli. Come loro abbiamo però ascoltato il tuo insegnamento e vorremmo ricevere da te la forza per attuarlo; quella forza che ha poi condotto i figli di Zebedeo a testimoniarti con la vita.
Gesù, aiutaci a comprendere l’amore che ti ha spinto a bere il calice della sofferenza al nostro posto, a immergerti nei flutti del dolore e della morte per strappare dalla morte eterna noi, peccatori. Aiutaci a contemplare nel tuo estremo abbassamento l’umiltà di Dio.
Liberaci dalla stolta presunzione di asservire gli altri a noi stessi e infondici nel cuore la carità vera, che ci farà lieti di servire ogni fratello con il dono della nostra vita.
Mite Servo sofferente, che con il tuo sacrificio di espiazione sei divenuto il vero sommo sacerdote misericordioso, tu ben conosci le infermità del nostro spirito e le pesanti catene dei nostri peccati: tu che per noi hai versato il tuo sangue, purificaci da ogni colpa. Tu che ora siedi alla destra del Padre, rendici umili servi di tutti!
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
—
– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2002-2003; 2005-2006- .
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. II: Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.
– E. BIANCHI et al., Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche. Anno B, Milano, Vita e Pensiero, 2008.
– COMUNITÀ DI S. EGIDIO, La Parola e la storia, Milano, Vita e Pensiero, 2011.
– J.M. NOUWEN, Un ricordo che guida, in ID., Mostrami il cammino. Meditazioni per il tempo di Quaresima, Brescia, Queriniana, 2003.
—
– Immagine della domenica, a cura di García-Orsini-Pennesi

Lunedì 25 novembre 2024 è in programma a Pescara, presso la sede della TUA S.p.A. (Via San Luigi Orione, 4), il 3° Seminario di studio su disabilità e lavoro organizzato da questo Servizio Nazionale per la pastorale delle persone con disabilità, in coedizione con l’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro, dal titolo “Un altro punto di vista: la forza delle reti comunitarie”.
In allegato siamo lieti di pubblicare la locandina contenente il programma dell’evento e il link per effettuare l’iscrizione.
L’iscrizione, obbligatoria per poter partecipare, deve essere effettuata entro e non oltre il 17 novembre 2024, e fino ad esaurimento camere per chi desidera pernottare, tramite il seguente link d’iscrizione:
https://iniziative.chiesacattolica.it/SeminarioPescara25.11.2024
L’eventuale pagamento delle quote di partecipazione indicate nel format d’iscrizione può essere effettuato, oltre che sullo stesso portale tramite carta di credito, anche tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
– Bonifico bancario presso Banca Etica, intestato a:
Conferenza Episcopale Italiana
IBAN: IT 98 J 05018 03200 000010500502
Causale di versamento: Iniziativa 22795, Nome e Cognome
Una volta effettuato il versamento, copia dello stesso deve essere inviata all’indirizzo email di questo Servizio Nazionale (pastoraledisabili@chiesacattolica.it).
Per ulteriori eventuali info:
pastoraledisabili@chiesacattolica.it
unpsl@chiesacattolica.it

Lectio – Anno B
Prima lettura: Isaia 50,5-9a
| Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia: chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste: chi mi dichiarerà colpevole? |
Già qualche profeta (per es. Geremia) aveva svolto una missione contrassegnata da sofferenze e persecuzioni, ora l’intera nazione, dispersa e disorientata, sta sopportando prove e disagi di ogni genere. Invece di ribellarsi o di reagire insensatamente contro Dio, era più saggio prendere dal Signore il «castigo» e prepararsi a ricevere, se a lui piace, il perdono e la riabilitazione.
Il «Servo di JHWH» non è un individuo né una pura idealizzazione. È il simbolo dell’Israele migliore, di quelli che erano in grado innanzitutto di mettersi in ascolto di quanto era in procinto di dire Iddio al suo popolo. Non è facile dialogare con lui nella disgrazia. Nella circostanza si è portati a chiudersi in se stessi o a imprecare, ma il Servo reagisce e ascolta ciò che gli dice il Signore.
Forse quando l’autore compone i «Carmi» l’esilio era anche passato, ma la situazione è quella precedente; gli uomini sono ancora sotto l’abbattimento, la stanchezza morale e fisica. La sfiducia può prendere anche il profeta, chiamato a rincuorare i fratelli, ma pensa il Signore a tenerlo sveglio.
Il servo è un personaggio e più ancora una personificazione. In lui tutta la nazione rievoca le sofferenze e le umiliazioni subite nella deportazione e che continuano nella restaurazione poiché sono ancora sotto un dominatore. I colpi dei flagelli, lo strappo della barba sono i segni del dileggio morale e fisico a cui gli uomini sono sottoposti. Ma Israele nella sua afflizione ha un consolatore a cui fare affidamento: è JHWH. Il suo Dio è l’unico Signore, viene ripetuto nello Shema. Egli è ora a suo fianco anche in questo estremo frangente e lo aiuterà.
Le prove possono fiaccare, ma sapute accettare dalla mano del Signore, irrobustiscono la fede, rendono più saldo il rapporto con Dio. Se JHWH è vicino, dalla parte delle vittime c’è sempre una speranza che la nazione possa sopravvivere. «Chi di voi teme il Signore, ascolti la voce del suo servo» (v. 10). È il senso di tutto il carme.
Seconda lettura: Giacomo 2,14-18
| A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io ho le opere; mostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede». |
Non si può dire che sia un comportamento cristiano il discriminare negli incontri comunitari un fratello dall’altro, privilegiare il ricco e umiliare il povero. «Avvilire l’indigente» non è agire come Dio agisce, né come Gesù ha esortato a fare. Il credere non serve a nulla se non è suffragato dalle opere che la fede propone. Sarebbe come il dire a degli ignudi e a degli affamati «riscaldatevi e saziatevi» senza dargli né una veste, né un pane.
La dottrina su Dio sarà sempre utile a instaurare rettamente i propri comportamenti quotidiani, ma se questi non vengono influenzati, modificati, riordinati dalla fede, non vengono conformati alla proposta di Dio (comandamenti) e alla testimonianza di Cristo, in altre parole, se non hanno nessuna risonanza pratica nella vita, servono ad aumentare la responsabilità e la condanna del credente.
Se la fede non rifluisce nei comportamenti, non agisce nella vita, è «morta» (v. 17). È come non averla.
Il v. 18 è misterioso. Sembra farsi avanti un interlocutore fittizio che contesta la tesi dell’inutilità della fede senza le opere (2,14). Certo la fede può precedere le opere e trovarsi anche senza di esse, ma alla fine rimane sempre vero che sono le opere a darle conferma. Talmente che se uno ha solo la fede senza le opere, la sua realtà può rimanere sempre insicura, mentre in chi compie la volontà di Dio, cerca di ripercorrere la testimonianza di Cristo anche se non ha fede esplicita, cioè non sa esattamente e senza colpa chi egli è, è egualmente un implicito credente. Le opere danno un’identità sicura, le parole da sole danno un’identità sempre dubbia.
Vangelo: Marco 8,27-35
| In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà». |
Esegesi
Il brano di Mc 8,27-35 segna una svolta radicale nel vangelo di Marco. Chiude il ministero galilaico accompagnato da una solenne autorevole manifestazione di Gesù, che non è consentito capire e della quale non è neppure lecito parlare. Gesù preferisce passare in silenzio se non proprio in incognito. Fa tutti i suoi pronunciamenti, compie grandi prodigi che suscitano entusiasmo nella folla: 1,27 («che è questo?») 4,12 («Non abbiamo mai visto nulla di simile»), 4,47 («Chi è dunque costui?») 7,37 («Stupivano») e nello stesso tempo reazioni negative presso gli scribi e farisei: 2,7 («Perché costui fa queste cose? Bestemmia»), 3,36 («Ha uno spirito immondo»), 3,6 («tengono consiglio per farlo perire»). L’agire di Gesù sorprende anche le autorità che parlano per bocca di Erode Antipa, il tetrarca della Gallica (6,14).
Gesù non solo non scopre il suo «segreto» ma proibisce a coloro che possono averlo intuito di parlarne. Tali sono gli ordini impartiti ai demoni (1,34; 3,12) e ai miracolati (1,44; 5,19; 5,43; 6.45; 7.36). L’evangelista afferma che a «quelli che erano attorno a lui», spiegava «in disparte» ogni cosa (4,38), ma il mistero rimaneva nascosto anche a loro.
La tensione che domina la prima parte del vangelo di Marco si chiude con l’interrogatorio di Cesarea di Filippo, fuori della Galilea. Infatti dopo la guarigione del cieco di Betsaida (8,22-26) la comitiva si incammina verso «i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo», la capitale della Traconitide a due giorni di viaggio dal Lago di Tiberiade. È una meta reale e simbolica. L’evangelista vuole sottolineare che la prima manifestazione di Gesù avviene in terra pagana.
La tradizione evangelica ricorda una confessione messianica di Pietro. Giovanni la colloca dopo il discorso sul pane della vita (6,68-69), i sinottici a Cesarea di Filippo. La ricostruzione della scena è più didattica che storica; deve appurare chi è Gesù. Ed è lui che ha proposto e quindi voluto questa «rivelazione». In genere i maestri sono interpellati dagli alunni; qui è Gesù che pone non le domande, ma la domanda che serpeggia in tutto il vangelo. E proprio per non introdurre exabrupto nella questione comincia da un’interrogazione sull’opinione della folla che serve solo a richiamare l’attenzione sulla vera risposta che viene dai discepoli («Ma voi, chi dite»).
Alla luce del linguaggio veterotestamentario, cioè delle profezie messianiche dell’Antico Testamento, Gesù non poteva essere che una figura profetica, del tipo di Giovanni Battista o di Elia del quale si attendeva per di più il «ritorno» all’aprirsi dell’era escatologica (cf. Mal 3,23-24; Mt 11,14). Ma in tutti i modi le categorie dell’A.T. non sono idonee per spiegare chi è Gesù. Occorre una risposta che venga dall’esperienza di coloro che lo hanno conosciuto, che sono stati a suo fianco, alla sua scuola. Ed essi hanno capito che il loro maestro è più che un profeta, «è il Cristo». L’espressione «il Cristo», quando l’evangelista scrive, è la stessa che la Chiesa adopera per designare Gesù di Nazaret che è pur sempre un «grande profeta» (cf. Lc 7,16), ma anche il «messo» di Dio per eccellenza, il messia. In altre parole è il personaggio promesso per la fine dei tempi; allo scopo di imprimere alla storia della salvezza l’orientazione voluta dal creatore. Egli è colui che avrebbe ristabilito tutte le cose. Quindi era il fiduciario e il plenipotenziario di Dio; il salvatore, il «redentore», verrà aggiunto più tardi nella predicazione cristiana.
Se l’espressione si limitasse alle intenzioni di Pietro forse il significato sarebbe stato più ristretto e supererebbe di poco l’espressione «figlio di David» (10,47-48) o «restauratore del regno davidico» (11,18), ma l’evangelista ripete più la fede della Chiesa che quella del primo apostolo. Essa sarà ribadita poco dopo nella «confessione» di Gesù davanti al Sinedrio (14,61).
Ormai i discepoli conoscono colui a cui hanno dato la parola, di cui si sono messi al seguito, ma Gesù ha altre cose da aggiungere alla confessione dell’apostolo per questo è costretto a chiedere ancora di «non parlare» su tale dichiarazione (v. 30). E la «parola» nuova, inattesa da dire è quasi più importante della prima perché ne costituisce il presupposto (v. 32).
Se pertanto la «confessione» chiude la prima parte del vangelo, la dichiarazione di Gesù apre la seconda, quella riguardante la «croce» e il «cammino» che porta verso di essa, in concreto verso Gerusalemme, il Golgota, e del «cammino» che si impone a quanti sono al seguito di colui che, pur essendo «il Cristo», è finito sul patibolo.
I versetti 8,27.30 sono veramente al centro di tutto il vangelo. Gesù adesso non ha più veli nel parlare, non è sfuggente, né misterioso. Annunzia «apertamente» (parresiai) «la parola» (ton logon). Il testo è chiamato abitualmente la prima profezia della passione e della risurrezione, ma nell’attuale versione si è verificata una contaminazione tra i racconti del tragico avvenimento e la dichiarazione di Gesù al riguardo. Alcuni particolari sono passati da un quadro all’altro senza creare confusione, ma dando alla profezia più il colore di una narrazione che di un oracolo.
L’essenziale dell’avvertimento di Gesù è che il Cristo, ma è chiamato più vagamente «il figlio dell’uomo», una designazione che richiama Dn 7,14, deve «molto patire» ed «essere rigettato». In altre parole, il messia non sarà accolto dal suo popolo, fino a condannarlo a morte, ma la morte non sarà la sua fine bensì l’inizio della sua vittoria (risurrezione). «Dopo tre giorni» è un’espressione ebraica per dire «dopo breve tempo», dopo «un corto intervallo».
Il comportamento di Pietro, i «rimproveri» che fa a Gesù, sono verosimilmente storici, ma sono anche emblematici, esprimono non tanto il pensiero dell’apostolo, ma di ogni benpensante, di qualsiasi uomo che stenta sempre a capire come l’affermazione del bene, della verità abbia condizionamenti così irrazionali a cui non c’è alternativa. Si può accettare o rifiutare, non cambiare.
La terza parte della pericope, vv. 34-35, è un’esplicitazione della seconda. Il vangelo (logos) della croce non riguarda solo Gesù, ma tutti i suoi discepoli, indistintamente. A tal proposito è convocata, non si sa da dove, anche «la folla» (ochlos). Se il programma del cristiano è quello di «seguire Gesù» (opiso mou elthein; akolouthein) si tratta di un cammino che non può arrestarsi a metà strada. Non può escludere la «croce» come non ha potuto escluderla Gesù. Per arrivare a ciò bisogna cominciare dalla dimenticanza di se stessi, dalla abnegazione. Occorre la forza d’animo, il coraggio di non prendere troppo in considerazione i propri interessi, i propri beni, la stessa vita. «Rinnegare» significa anche riconoscere i propri limiti. E non si tratta di farne un’offerta a Dio, ma ai propri simili ai quali si è in grado di accordare una più larga, generosa collaborazione.
La «croce» che si è esortati a prendere fa prevedere che il prezzo della sequela di Cristo può equivalere alla perdita della vita, ma può non arrivare a questi estremi. Se la croce è il simbolo di qualsiasi sofferenza può designare ogni rinunzia che si impone al credente per tener fede ai suoi impegni.
La massima conclusiva ribadisce (v. 35) in termini parenetici il messaggio di tutto il discorso tenuto da Gesù ai suoi. Il seguire Cristo non è un consiglio qualsiasi che può lasciare indifferenti l’ascoltatore. La «vita» (psyche) di cui parla Gesù non è né la semplice vita spirituale (anima), né la sola vita fisica (corporea). È l’una e l’altra insieme, cioè l’intera esistenza che comincia nel tempo e si protrae nell’eternità. Non solo non è indifferente il credere e il non credere, ma da esso dipende la felicità nel tempo e oltre il tempo.
Meditazione
La pagina evangelica di questa domenica occupa un posto cruciale nel racconto di Marco. La professione di fede di Pietro, con il successivo «primo annunzio della passione», è infatti collocata al centro del libro e segna una svolta decisiva nel ministero di Gesù. D’ora innanzi il suo cammino prenderà una nuova ‘piega’, una nuova direzione, dirigendosi decisamente verso il luogo del compimento del suo pellegrinaggio terreno. Da Cesarea di Filippo (all’estremo nord del territorio palestinese) Gesù inizia il suo ultimo viaggio verso Gerusalemme, in una marcia di avvicinamento che proseguirà a ritmo incalzante, senza ripensamenti e senza incertezze, fino allo scontro definitivo con i suoi avversari (la prima lettura ci presenta, in parallelo, la misteriosa figura del «servo del Signore» che con coraggio e determinazione va per la sua strada, noncurante delle minacce e dell’opposizione violenta, ma confidando solo nell’assistenza di Dio).
«E per strada interrogava i suoi discepoli» (v. 27). Il Gesù di Marco è uno che interroga spesso, che fa sempre molte domande. I discepoli sono continuamente sollecitati a riflettere sul senso della loro esistenza, sulle ragioni della loro sequela e, soprattutto, sul mistero della persona che hanno davanti. «Ma voi, chi dite che io sia?» (v. 29a). È questa la domanda che, più di ogni altra, interessa a Gesù. La gente può dire tante cose, anche giuste e pertinenti, ma l’identità di Gesù non la si può ‘afferrare’ da lontano: solo una frequentazione assidua e quotidiana, solo una prossimità vitale può mettere nelle condizioni di accedere a una conoscenza non superficiale di lui. Si percepisce bene qui tutta l’attesa di Gesù per la risposta dei suoi discepoli. Ed ecco irrompere sulla scena Pietro che, facendosi il portavoce del gruppo, dà la sua bella risposta, chiara e sintetica: «Tu sei il Cristo» (v. 29b). È la prima volta che Pietro prende personalmente la parola nel vangelo di Marco e possiamo dire che lo fa in modo più che appropriato (non sappiamo come sia arrivato a formulare questa stupenda professione di fede; forse l’esperienza dello ‘stare con Gesù’ per lungo tempo avrà sortito qualche buon effetto…). Dal canto suo, Gesù non commenta la risposta di Pietro, anche se, in qualche modo, sembra approvarla. Gli preme solo che, per il momento, essa non venga divulgata: «E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno» (v. 30).
Gesù comincia allora a impartire il suo insegnamento, un insegnamento di capitale importanza poiché, per la prima volta, verte sulla sua sorte di passione e risurrezione. Egli è sì «il Cristo», ma i tratti che lo contraddistinguono sono alquanto inattesi e, comunque, assai diversi da quelli immaginati dai suoi discepoli. In una progressione impressionante, quattro verbi scandiscono il destino di sofferenza e di gloria che attende il «Figlio dell’uomo»: soffrire molto, essere rifiutato, venire ucciso, risorgere (v. 31). Nel momento stesso in cui i discepoli credono finalmente di aver compreso qualcosa intorno al loro singolare Maestro, ecco che si vedono ‘scaricare’ addosso parole scioccanti e incomprensibili: un Messia che deve passare per la sofferenza e la morte (senza dimenticare l’aspetto del rifiuto, della «riprovazione», non meno scandaloso). È questa necessità che i discepoli proprio non riescono a ‘digerire’: perché «deve»? Non potrebbe passare per un’altra via il destino del ‘loro’ Messia? Ed è proprio attorno a questo punto fatidico che esplode fortissimo il contrasto tra Gesù e i suoi. Ancora una volta è Pietro a farsi avanti, reagendo in modo deciso e disapprovando senza mezzi termini le parole di Gesù (addirittura si mette «a rimproverarlo»). Ma Gesù, con altrettanta energia, «rimprovera» Pietro bollando il suo atteggiamento come ‘satanico’ (v. 33). In nessun altro passo del vangelo è riportato un dissenso e uno scontro così violento tra i due! Pietro sembra trovarsi sotto l’influsso di uno ‘spirito cattivo’, tanto che Gesù si comporta con lui come un indemoniato (il verbo qui usato per indicare il «rimprovero» di Gesù, epitimá, è lo stesso generalmente adoperato per le scene di espulsione degli spiriti impuri: cfr. 1,25; 3,12; 9,25). Colui che aveva appena chiamato Gesù «il Cristo», si vede ora apostrofare con un titolo terribile e durissimo: «Satana»! Chi non pensa «secondo Dio», chi non riesce a sentire e a vedere le ‘cose’ di Dio lasciandosi guidare soltanto dai suoi istinti carnali, dai suoi desideri puramente umani, da tutto ciò, appunto, che è «secondo gli uomini», non può far altro che il gioco di Satana, il gioco dell’avversario di Dio per antonomasia. Invece di seguire Gesù, di lasciarsi condurre da lui sulla via di Dio, Pietro si mette davanti, ostacolando il cammino di Gesù e frapponendosi tra lui e il Padre suo (proprio come cercava di fare il Tentatore nel deserto!). Ma subito Gesù, in tono perentorio, ricolloca Pietro al posto che gli spetta: «Va’ dietro a me!». Così Pietro è di nuovo invitato a obbedire a quella voce udita al tempo della sua prima chiamata lungo il mare di Galilea quando, insieme a suo fratello Andrea, si sentì dire: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini» (1,17). Il posto del discepolo è sempre «dietro» – come rimarca ancora una volta Gesù nei due detti conclusivi (vv. 34-35) -; ma non solo: se non si osservano alcune condizioni basilari non si può, neanche lontanamente, cercare di seguire Gesù, di conoscerlo, di aderire a lui. Si tratta di imparare a dire di «no» a se stessi per dire di «sì» a un altro; si tratta di entrare nella logica paradossale del vangelo che implica il percorrere la via della croce, la stessa seguita da Gesù; si tratta, in ultima istanza, di spossessarsi persino della propria vita per riceverla nuova e ‘salvata’ dalle mani di Dio.
Immagine della domenica

Lagos de Covadonga (Asturias) – 2021
«Una ligera niebla,
un cielo pálido
y muchos deseos».
(Ivo Andric)
Preghiere e racconti
La rinuncia a se stessi
Quando una situazione umana ci chiede una totale rinuncia a noi stessi, istintivamente cerchiamo il compromesso o semplicemente imbocchiamo la strada della fuga, ci accomuniamo agli apostoli, che anch’essi sono fuggiti di fronte al realismo della Passione di Gesù. A tanti livelli e su tanti piani dobbiamo cercare di smascherare le forme di fuga che caratterizzano il nostro preteso “servizio agli altri”. Quante volte a livello della famiglia, ci lasciamo andare alla ricerca soltanto della gratificazione dell’affermazione di noi stessi e non accettiamo le persone che ci sono vicine così come sono nella loro realtà, le vorremmo sempre diverse e ci arrovelliamo? Quante volte nell’ambito professionale ci lasciamo trascinare solo dall’interesse e non cerchiamo di rendere un servizio fino in fondo, servizio che ci chiede di uscire da noi stessi di prendere parte in qualche modo alla croce e di partecipare alla sua forza rivelatrice? Quante volte di fronte alle richieste che i nostri fratelli avanzano, noi manifestiamo disagio, stizza, rifiuto: tante realtà semplici della nostra vita quotidiana in cui Gesù dalla croce ci chiede di operare una profonda conversione, di metterci davvero in ginocchio davanti alla croce per coglierne il realismo e la fedeltà che cambiano la vita..
Innanzitutto, si rimane colpiti dal fatto che, nel Vangelo di Marco, la descrizione dei miracoli compiuti da Cristo sfuma, fino a scomparire del tutto, quanto più ci si avvicina alla Croce: è qui, dove Gesù non salva se stesso, che anche i miracoli muoiono. Se i miracoli sono i segni tangibili della potenza di Dio, la Croce ci dice in modo chiaro che questa potenza si manifesta soprattutto nell’amore e nel dono che Cristo fa di sé. Per Marco, il vero discepolo è colui che sa riconoscere il Figlio di Dio inchiodato sulla croce per la nostra salvezza (15,39).
«La croce è diventata la suprema cattedra per la rivelazione della sua nascosta e imprevedibile identità; il volto dell’amore che si dona e che salva l’uomo condividendone in tutto la condizione, escluso il peccato (Ebrei 4,15). La Chiesa non lo dovrà mai dimenticare: sarà questa la sua strada a servizio dell’amore e della rivelazione di Dio agli uomini» (CVMC 14).
Se anche tu fossi
così sottile e sapiente
da possedere ogni scienza
e interpretare ogni lingua
e scrutare i segreti del cielo,
di tutto ciò non potresti gloriarti,
perché un dèmone, da solo,
seppe delle cose celesti,
e ora sa delle terrene,
più di tutti gli uomini.
E se anche tu fossi il più bello
e il più ricco tra tutti gli uomini
e facessi cose mirabili,
come mettere in fuga i dèmoni,
tutto ciò non ti appartiene,
e non puoi affatto gloriartene.
Solo delle nostre infermità,
di questo solo possiamo gloriarci,
portando ogni giorno
la santa croce del nostro Signore Gesù Cristo.
(San Francesco D’Assisi)
La croce non è solo un bell’oggetto artistico per decorare i salotti e i ristoranti di Friburgo, ma è anche il segno della trasformazione più radicale nel nostro modo di pensare, sentire e vivere. La morte di Gesù in croce ha cambiato tutto. Qual è la reazione umana più spontanea davanti alla sofferenza e alla morte?
Per conto mio, sarei portato istintivamente a impedire, evitare, negare, fuggire, star lontano e ignorare il soffrire e il morire. È una reazione che indica che queste due realtà non si accordano col nostro programma di vita. Per la maggior parte della gente, sono proprio questi i due nemici principali della vita. Ci sembra davvero ingiusto che esistano, e ci sentiamo obbligati a cercare in un modo o nell’altro di tenerli sotto controllo come meglio possiamo; se poi non ci riusciamo subito, vuol dire che ci sforzeremo di fare meglio un’altra volta.
Ci sono dei malati che capiscono ben poco la loro malattia, e spesso muoiono senza mai aver pensato sul serio alla morte. L’anno scorso un mio amico morì di cancro. Sei mesi prima di morire era già evidente che non gli restava molto da vivere. Gli facevano tante iniezioni, fleboclisi e cose del genere che si aveva l’impressione che lo si volesse tenere in vita a ogni costo. Non voglio dire che si facesse male a cercare di guarirlo: voglio dire piuttosto che s’impiegava tanto tempo a tenerlo in vita che non ne restava più per prepararlo alla morte.
Il risultato logico di questa situazione è che ci curiamo ben poco dei defunti. Non facciamo molto per ricordarli, cioè per associarli alla nostra vita interiore.
Ben diverso era l’atteggiamento di Gesù verso la sofferenza e la morte. Egli infatti guardava queste realtà bene in faccia e a occhi aperti. Anzi, la sua vita intera fu una consapevole preparazione alla morte. Gesù non esalta la sofferenza e la morte come cose che dobbiamo desiderare, ma ne parla come di cose che non dobbiamo rigettare, evitare o ignorare.
(H.J.M. NOUWEN, Lettere a un giovane sulla vita spirituale, Brescia, Queriniana, 72008, 26-29).
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno.
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini» (…).
Gesù interroga i suoi, quasi in un sondaggio d’opinione: La gente chi dice che io sia? E l’opinione della gente è bella e incompleta: Dicono che sei un profeta, uno dei più grandi! Ma Gesù non è semplicemente un profeta del passato che ritorna, fosse pure il più grande di tutti. Bisogna cercare ancora: Ma voi, chi dite che io sia?
Non chiede una definizione astratta, ma il coinvolgimento personale di ciascuno: “ma voi…”. Come dicesse: non voglio cose per sentito dire, ma una esperienza di vita: che cosa ti è successo, quando mi hai incontrato? E qui ognuno è chiamato a dare la sua risposta. Ognuno dovrebbe chiudere tutti i libri e i catechismi, e aprire la vita.
Gesù insegnava con le domande, con esse educava alla fede, fin dalle sue prime parole: che cosa cercate? (Gv 1,38). Le domande, parole così umane, che aprono sentieri e non chiudono in recinti, parole di bambini, forse le nostre prime parole, sono la bocca assetata e affamata attraverso cui le nostre vite esprimono desideri, respirano, mangiano, baciano.
Ma voi chi dite che io sia? Gesù stimolava la mente delle persone per spingerle a camminare dentro di sé e a trasformare la loro vita. Era un maestro dell’esistenza, e voleva che i suoi fossero pensatori e poeti della vita. Pietro risponde: Tu sei il Cristo. E qui c’è il punto di svolta del racconto: ordinò loro di non parlare di lui ad alcuno. Perché ancora non hanno visto la cosa decisiva. Infatti: cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere.
Volete sapere davvero qualcosa di me e di voi? Vi do un appuntamento: un uomo in croce. Prima ancora, l’appuntamento di Cristo sarà un altro: uno che si china a lavare i piedi ai suoi. Chi è il Cristo? Il mio “lavapiedi”. In ginocchio davanti a me. Le sue mani sui miei piedi. Davvero, come a Pietro, ci viene da dire: ma un messia non può fare così.
E Lui: sono come lo schiavo che ti aspetta, e al tuo ritorno ti lava i piedi. Ha ragione Paolo: il cristianesimo è scandalo e follia. Adesso capiamo chi è Gesù: è bacio a chi lo tradisce; non spezza nessuno, spezza se stesso; non versa il sangue di nessuno, versa il proprio sangue. E poi l’appuntamento di Pasqua. Quando ci cattura tutti dentro il suo risorgere, trascinandoci in alto.
Tu, cosa dici di me? Faccio anch’io la mia professione di fede, con le parole più belle che ho: tu sei stato l’affare migliore della mia vita. Sei per me quello che la primavera è per i fiori, quello che il vento è per l’aquilone. Sei venuto e hai fatto risplendere la vita. Impossibile amarti e non tentare di assomigliarti, in te mutato / come seme in fiore. (G. Centore).
(Ermes Ronchi)
È facilissimo dare a Gesù un’identità secondo i nostri desideri ed è anche facile giungere a dire chi lui è, ma è molto più difficile accettare che sia lui a spiegare e a dire la propria identità. Il brano evangelico di questa domenica vuole proprio interrogarci sulla nostra fede-adesione conoscitiva a Gesù. Ascoltiamolo dunque.
Gesù nel suo ministero, con la sua parola autorevole, con il suo comportamento e con le azioni di liberazione dal male che compiva, destava domande sulla sua identità: “Che è mai questo?” (Mc 1,27); “Chi è mai costui?” (Mc 4,41); “Da dove gli vengono queste cose? E che tipo di sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria?” (Mc 6,2-3).
Vi erano giudizi su di lui: veniva definito bestemmiatore (cf. Mc 2,7), “pazzo, fuori di sé” (Mc 3,21), posseduto dal demonio (cf. Mc 3,22). Vi erano, infine, anche urla di demoni che, scacciati da Gesù, gli gridavano: “Tu sei il Santo di Dio” (Mc 1,24), “il Figlio del Dio Altissimo” (Mc 5,7).
Sono dunque i demoni che sanno esprimere la vera identità di Gesù, con la loro conoscenza sovrumana, mentre gli uomini non sanno o sanno poco. Al massimo arrivano a pensare che sia un profeta mandato da Dio (cf. Mc 6,15), perché compie i segni di Elia e di Eliseo, perché parla come gli antichi profeti, con la loro franchezza e autorevolezza, dovuta al fatto che dice quello che pensa e che vive, senza ipocrisie e senza vantare autorità acquisite per qualità sacerdotale o professionale.
Queste si acquisivano per appartenenza a una discendenza o per aver frequentato una scuola rabbinica, come quelle di Gerusalemme o di Tiberiade. Ma Gesù non può vantare nulla di tutto ciò: dunque, chi è in verità?
Egli approfitta di un viaggio insieme alla sua comunità fuori della terra santa, in una regione sirofenicia e pagana, alle pendici dell’Hermon, presso le sorgenti del Giordano, per chiedere ai discepoli la loro opinione su di lui. È Gesù stesso a interrogarli, nei dintorni di Cesarea di Filippo (la città che porta il nome di Cesare, il potente dominatore di questo mondo!), innanzitutto chiedendo che cosa la gente dice di lui.
Essi lo sanno, perché quanti non osavano avvicinare Gesù potevano parlare con loro, manifestando opinioni sul loro rabbi. I discepoli, in risposta, riferiscono a Gesù l’opinione più diffusa: la gente pensa che egli sia un uomo autorevole, un profeta, così simile al Battista suo maestro ucciso da Erode (cf. Mc 6,17-29), al punto da pensare che quest’ultimo fosse risuscitato dai morti (cr. Mc 6,16); oppure lo paragonano a Elia, il profeta degli ultimi tempi. In ogni caso, è percepito come un profeta.
Gesù però non si ferma a questa prima domanda, e pone loro quella seria e decisiva: “E voi, ciascuno di voi, chi dite che io sia?”. Questa domanda esige che i discepoli si chiedano se anche loro seguono l’opinione comune, ciò che quasi tutti pensano, oppure se hanno un proprio pensiero. Certamente tra i discepoli gli stessi Dodici non la pensavano tutti allo stesso modo.
Per Marco è però importante la dichiarazione di Pietro, colui che tra i Dodici teneva il primo posto. È lui – e non a nome di tutti, o come portavoce, ma personalmente – a proclamare: “Tu sei il Cristo, il Messia!”. Pietro dice che Gesù è più di un profeta, è l’inviato di Dio, unto dal Signore per stabilire il regno di Dio. Quella di Pietro è una vera confessione di fede, nella sua espressione teologica, perché Gesù è veramente il Cristo, il Messia (come appare fin dal primo versetto del vangelo secondo Marco), e questo sarà il suo titolo più importante per i giudei, per Israele.
E tuttavia l’evangelista non mette in bocca a Gesù parole che confermino tale confessione, che dicano un “amen” un “sì” a Pietro (come invece in Mt 16,17-19). Nel vangelo più antico questa confessione è accolta da Gesù nel silenzio e con l’imposizione del silenzio, perché era vera, ma poteva essere insufficiente, dunque doveva essere messa alla prova.
Ed è ciò che puntualmente avviene subito dopo. Non appena Pietro ha confessato la sua fede di giudeo credente, in attesa del compimento della promessa di Dio, ecco che Gesù può iniziare un insegnamento nuovo rispetto a quello della tradizione. Per questo “incominciò” (érxato) a dire che egli, Messia sì, ma – come amava definirsi – Figlio dell’uomo, “doveva soffrire molte cose, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere”.
Ecco l’insegnamento nuovo e scandaloso, ma fatto apertamente da Gesù. E allora Pietro che, insieme agli altri Undici, stava dietro a lui (opíso autoû), secondo l’usanza dei discepoli nei confronti del loro rabbi, accelera il passo, gli si pone davanti, lo precede e lo rimprovera. Per Pietro è impossibile un Messia che non trionfi, che non sia vittorioso sui nemici, un Messia rigettato dalle autorità legittime della comunità dei credenti di Israele, un Messia che subisca una morte violenta. E poi, cosa significa questo rialzarsi il terzo giorno?
Gesù allora può solo rispondergli: “Passa dietro a me (opíso mou), alla mia sequela, al tuo posto di discepolo”, e lo definisce “Satana”, cioè oppositore, avversario: a Pietro viene dato il nome del demonio! È facile dire a Gesù che egli è il Cristo, il Messia, ma è impossibile accettare un “Messia al contrario”, un Messia sofferente sconfitto; si tratta davvero di un insegnamento nuovo, e Pietro non è pronto ad accoglierlo…
Mosè era morto “sulla bocca di Dio” (Dt 34,5), Elia era stato da Dio assunto in cielo (cf. 2Re 2,1-18), e invece proprio il Messia deve subire violenza, condanna, rifiuto? Non può essere, pensa Pietro… E invece è così – dice Gesù – e in effetti così è stato.
Un abisso separa il piano, la volontà di Dio dai pensieri degli umani (cf. Is 55,8-9), anche dai nostri, dai miei! In verità è tanto facile acclamare Gesù come Cristo, cantarlo e invocarlo; ma accettarne la fine ignominiosa, il fallimento della missione, è scandalo, inciampo, è quasi impossibile per le nostre attese religiose.
E poi, al pensiero che dietro a un tale Messia, maestro e profeta si è coinvolti nella sua vicenda, allora siamo presi da paura e preferiamo non credere, non conoscere la vera identità di Gesù. E così siamo cristiani non del Vangelo, ma del campanile; cristiani culturalmente, non perché seguiamo Gesù; cristiani pii e devoti, ma lontani dall’ombra della croce.
(Enzo Bianchi)
Che cosa significano le parole: «Se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua»? (Mt 16,24). Comprendiamo che cosa vuol dire: «Prenda la sua croce»; significa: «Sopporti la sua tribolazione»; prenda equivale a porti, sopporti. Vuol dire: «Riceva pazientemente tutto ciò che soffre a causa mia. «E mi segua». Dove? Dove sappiamo che se ne è andato lui dopo la risurrezione. Ascese al cielo e siede alla destra del Padre. Qui farà stare anche noi. […]
«Rinneghi se stesso».
In che modo si rinnega chi si ama? Questa è una domanda ragionevole, ma umana. L’uomo chiede: «In che modo rinnega se stesso chi ama se stesso?» Ma Dio risponde all’uomo: «Rinnega se stesso chi ama se stesso». Con l’amore di sé, infatti, ci si perde; rinnegandosi, ci si trova. Dice il Signore: «Chi ama la sua vita la perderà» (Gv 12,25). Chi da questo comando sa che cosa chiede, perché sa deliberare colui che sa istruire e sa risanare colui che ha voluto creare. Chi ama, perda. È doloroso perdere ciò che ami, ma anche l’agricoltore perde per un tempo ciò che semina. Trae fuori, sparge, getta a terra, ricopre. Di che cosa ti stupisci? Costui che disprezza il seme, che lo perde è un avaro mietitore. L’inverno e l’estate hanno provato che cosa sia accaduto; la gioia del mietitore ti dimostra l’intento del seminatore.
Dunque chi ama la propria vita, la perderà. Chi cerca che essa dia frutto la semini. Questo è il rinnegamento di sé, per evitare di andare in perdizione a causa di un amore distorto. Non esiste nessuno che non si ami, ma bisogna cercare un amore retto ed evitare quello distorto. Chiunque, abbandonato Dio, avrà amato se stesso e per amore di sé avrà abbandonato Dio, non dimora in sé, ma esce da se stesso. […] Abbandonando Dio e preoccupandoti di te stesso, ti sei allontanato anche da te e stimi ciò che è fuori di te più di te stesso. Torna a te e poi di nuovo, rientrato in te, volgiti verso l’alto, non rimanere in te. Prima ritorna a te dalle cose che sono fuori di sé e poi restituisci te stesso a colui che ti ha fatto e che ti ha cercato quando ti sei perduto, ti ha trovato quando sei fuggito, ti ha convertito a sé quando gli volgevi le spalle. Torna a te, dunque, e va’ a colui che ti ha fatto.
(AGOSTINO DI IPPONA, Discorsi 330,2-3 NBA XXXIII, pp. 818-822).
Sulle grandi arterie, oltre alle frecce giganti collocate agl’incroci, ce ne sono altre, più piccole, che indicano snodi secondari. Ora, per noi che corriamo distratti sulle corsie preferenziali di un cristianesimo troppo accomodante e troppo poco coerente, quali sono le frecce stradali che invitano a imboccare l’unica carreggiata credibile, quella che conduce sulla vetta del Golgota? Ve ne indico tre.
La freccia dell’accoglienza. E una deviazione difficile, ma che porta diritto al cuore del Crocifisso. Accogliere il fratello come un dono, con tutti i suoi bagagli, compreso il bagaglio più difficile da far passare alla dogana del nostro egoismo: la sua carta d’identità! Sì, perché non ci vuole molto ad accettare il prossimo senza nome, o senza contorni, o senza fisionomia. Ma occorre una gran fatica per accettare quello che abita di fronte a casa mia. Il cristianesimo è la religione dei nomi propri, dei volti concreti, del prossimo in carne e ossa con cui confrontarsi, non delle astrazioni volontaristiche.
La freccia della riconciliazione. Ci indica il cavalcavia sul quale sono fermi, a fare autostop, i nostri nemici. E noi dobbiamo assolutamente frenare. Per dare un passaggio al fratello che abbiamo ostracizzato dai nostri affetti. Per stringere la mano alla gente con cui abbiamo rotto il dialogo. Per porgere aiuto al prossimo col quale abbiamo categoricamente deciso di archiviare ogni tipo di rapporto. E sulla rampa del perdono che vengono collaudati il motore e la carrozzeria della nostra esistenza cristiana.
La freccia della comunione. Al Golgota si va in corteo, come ci andò Gesù. Non da soli. Pregando, lottando, soffrendo con gli altri. Non con arrampicate solitarie, ma solidarizzando con gli altri che, proprio per avanzare insieme, si danno delle norme, dei progetti, delle regole precise, a cui bisogna sottostare da parte di tutti. Se no, si rompe il tessuto di una comunione che, una volta lacerata, richiederà tempi lunghi per pazienti ricuciture.
(Don Tonino Bello)
Ama la croce, luce e pace,
e per essa, ormai,
Cristo sia il tuo signore!
Tracciala su di te con la mano:
essa ti tiene e tu la tieni
con tutto il tuo essere.
Il cuore in croce, la croce nel cuore,
liberato da ogni bruttura,
calmo e sereno;
che ben forte la croce amatissima
dalle tue labbra sia proclamata:
lodata senza fine.
Nel riposo, nella fatica,
quando ridi e quando piangi,
conserva ben stretta
– quando vai, quando vieni,
nelle gioie, nei dolori –
la croce nel cuore!
(San Bonaventura)
Sono un figlio del secolo, un figlio della mancanza di fede e del dubbio quotidiani e lo sono fino al midollo. Quanti crudeli tormenti mi è costato e mi costa tuttora quel desiderio della fede che nell’anima mi è tanto più forte quanto sono presenti in me motivazioni contrarie! Tuttavia Dio talvolta mi manda momenti nei quali mi sento assolutamente in pace. In tali momenti, io ho dato forma in me ad un simbolo di fede nel quale tutto è per me chiaro e santo. Questo simbolo è molto semplice, eccolo: credere che non c’è nulla di più bello, di più profondo, di più ragionevole, di più coraggioso e di più perfetto di Cristo e con fervido amore ripetermi che non solo non c’è, ma non può esserci. Di più: se qualcuno mi dimostrasse che Cristo è fuori della verità, mi dimostrasse che veramente la verità non è in Cristo, beh, io preferirei lo stesso restare con Cristo piuttosto che con la verità.
(F. Dostoevskij)
Concedimi, Gesù benignissimo, la tua grazia,
la quale sia con me e con me lavori e con me sino alla fine perseveri.
Dammi di desiderare e volere solo quello che è a te più accetto e più caramente piace a te.
Fa’ che la tua volontà sia la mia, e la mia volontà segua sempre la tua e concordi con essa a perfezione.
Che io abbia un unico volere e non volere con te; e che possa volere o non volere se non ciò che tu vuoi o non vuoi.
Dammi di morire a tutte le cose che sono nel mondo, e per te d’essere sprezzato e ignorato in questa vita.
Dammi sopra ogni cosa desiderata, di riposare in te e pacificare in te il mio cuore.
Te, vera pace del cuore, solo riposo, fuor di te ogni cosa è dura e inquieta.
In questa pace – cioè in te solo, sommo, eterno bene – dormirò e riposerò. Così sia.
(L’imitazione di Cristo, III, 15).
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
—
– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2002-2003; 2005-2006- .
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. II: Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.
– E. BIANCHI et al., Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche. Anno B, Milano, Vita e Pensiero, 2008.
– COMUNITÀ DI S. EGIDIO, La Parola e la storia, Milano, Vita e Pensiero, 2011.
– J.M. NOUWEN, Un ricordo che guida, in ID., Mostrami il cammino. Meditazioni per il tempo di Quaresima, Brescia, Queriniana, 2003.
—
– Immagine della domenica, a cura di García-Orsini-Pennesi-Serrano
PER L’APPROFONDIMENTO: