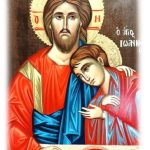
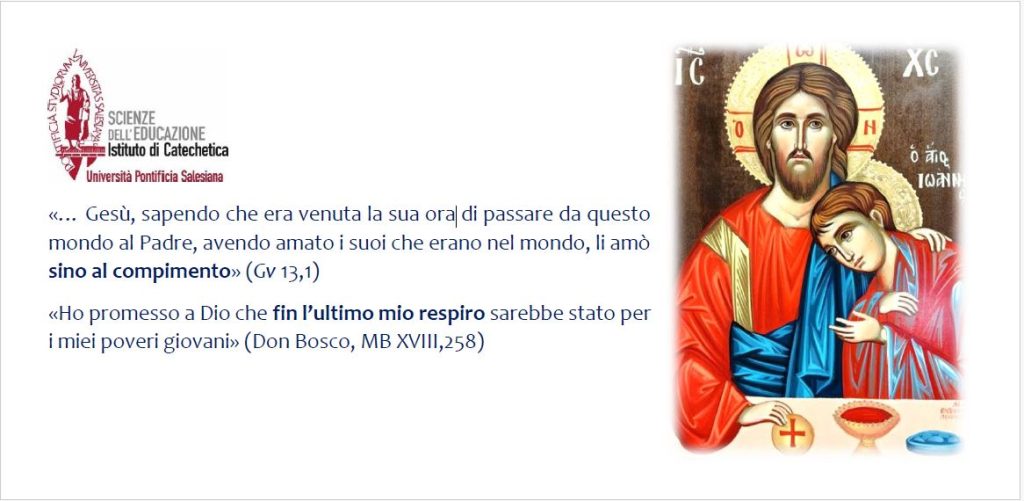
L’ISTITUTO DI CATECHETICA VI AUGURA UNA BUONA PASQUA DI RISURREZIONE!
La sezione Novità con le sue rubriche tiene aggiornati gli educatori sulle novità che: negli eventi, nell’editoria e nel cinema interessano l’educazione religiosa.
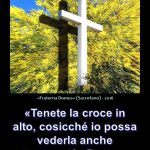
Lectio – Anno C
Prima lettura: Isaia 50,4-7
| Il Signore Dio mi ha dato una lingua da iniziati, perché io sappia indirizzare allo sfiduciato una parola. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come gli iniziati. Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. |
Dapprima il Servo ricorda, in modo appassionato, la missione ricevuta di sostenere gli sfiduciati, quali erano i rimpatriati dall’esilio babilonese, alla fine del VI secolo a.C., in mezzo a tante difficoltà e ostilità. Poi proclama come l’ha vissuta, grazie ai doni del Signore di una lingua e di un orecchio «da iniziati», cioè degli introdotti e pienamente dediti all’ascolto e alla proclamazione della parola di Dio. Ciò implica un impegno profondo e costante anche suo. Anzi, ha richiesto la più dura testimonianza della vita, per le persecuzioni, espresse col piegare il dorso ai flagellatori, e per le umiliazioni subite, che si possono prendere alla lettera, fatte di insulti, sputi in faccia e depilazioni infamanti.
Di fronte a tutto questo, il Servo riafferma i suoi più profondi sentimenti. Non si tira indietro, ma affronta con coraggio le prove. È sicuro che Dio lo assiste, per questo non ha confusioni e incertezze, ma rende la faccia dura e impavida come roccia.
La lettura si ferma qui, forse per restare a quanto è più consono ai sentimenti di Cristo nella passione che segue. Nei versetti che completano il carme, il Servo sfida pure gli avversari sulla giustezza delle sue posizioni ed è sicuro che saranno confusi da Dio e logorati come veste intaccata dalle tarme. Non sono sentimenti teneri ma neppure estranei a Cristo. Forse i cristiani d’oggi dovrebbero riscoprire il modo e il coraggio di ripeterli.
Seconda lettura: Filippesi 2,6-11
| Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. |
Può darsi che Paolo stesso sia l’autore di questa composizione ritmata. Ma più probabilmente l’ha presa dalla liturgia preesistente e l’ha adattata ai suoi intendimenti. È chiaro lo schema in due parti simmetriche, una discendente nella kènosys e l’altra ascendente nella esaltazione.
Con la kènosys, svuotamento (vv. 6-8), Cristo scende dal trono più alto all’abisso più profondo, per gradini vertiginosi. Al contrario di Adamo, presuntuoso di essere come Dio, egli passa dalla reale «uguaglianza con Dio» alla «condizione di servo»; quindi da regnante supremo a servo obbediente; in una obbedienza non ordinaria, ma fino alla morte; e una morte non qualunque, ma in croce, come si usava per gli schiavi e per i delinquenti peggiori…
Con la esaltazione (vv. 9-11), Dio gli fa risalire tutti i gradini. Vi sono coinvolte tutte le creature ed è conseguente, anzi intrinseca, all’annientamento. A Cristo da, anzitutto un Nome, cioè una realtà e missione al di sopra di ogni altro; quindi sottomette a lui tutti gli esseri buoni e cattivi, nei cieli, sulla terra e sotto terra; e, nel riconoscimento della signoria universale di lui, da ad ogni persona la possibilità di ritrovare e di vivere la gloria della paternità divina.
Di seguito, Paolo indica ai Filippesi alcune conseguenze pratiche da tirare, che valgono anche per noi se le attualizziamo, rapportandole alla vita nella società e nella Chiesa di oggi.
Vangelo: Luca 22,14-23,56
| C Quando fu l’ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: + “Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, poiché vi dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio”. C E preso un calice, rese grazie e disse: + “Prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finche non venga il regno di Dio”. Fate questo in memoria di me C Poi preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: + “Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me”. C Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: + “Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi”. Guai a quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo è tradito “Ma ecco, la mano di chi mi tradisce è con me, sulla tavola. Il Figlio dell’uomo se ne va, secondo quanto è stabilito; ma guai a quell’uomo dal quale è tradito!”. C Allora essi cominciarono a domandarsi a vicenda chi di essi avrebbe fatto ciò. Io sto in mezzo a voi come colui che serve Sorse anche una discussione, chi di loro poteva essere considerato il più grande. Egli disse: + “I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così; ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Infatti chi è il più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove; e io preparo per voi un regno, come il Padre l’ha preparato per me, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno e siederete in trono a giudicare le dodici tribù di Israele. Tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli Simone, Simone, ecco satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano; ma io ho pregato per te, che non venga meno la tua fede; e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli”. C E Pietro gli disse: P “Signore, con te sono pronto ad andare in prigione e alla morte”. C Gli rispose: + “Pietro, io ti dico: non canterà oggi il gallo prima che tu per tre volte avrai negato di conoscermi”. Deve compiersi in me questa parola della Scrittura C Poi disse: + “Quando vi ho mandato senza borsa, né bisaccia, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?”. C Risposero: P “Nulla”. C Ed egli soggiunse: + “Ma ora, chi ha una borsa la prenda, e così una bisaccia; chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Perché vi dico: deve compiersi in me questa parola della Scrittura: ‘‘E fu annoverato tra i malfattori’’. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo termine”. C Ed essi dissero: P “Signore, ecco qui due spade”. C Ma egli rispose: + “Basta!”. In preda all’angoscia, pregava più intensamente C Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: + “Pregate, per non entrare in tentazione”. C Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e, inginocchiatosi, pregava: + “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà”. C Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda all’angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: + “Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione”. Giuda, con un bacio tradisci il Figlio dell’uomo? C Mentre egli ancora parlava, ecco una turba di gente; li precedeva colui che si chiamava Giuda, uno dei Dodici, e si accostò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: + “Giuda, con un bacio tradisci il Figlio dell’uomo?”. C Allora quelli che eran con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: P “Signore, dobbiamo colpire con la spada?”. C E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l’orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: + “Lasciate, basta così!”. C E toccandogli l’orecchio, lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che gli eran venuti contro, sommi sacerdoti, capi delle guardie del tempio e anziani: + “Siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante? Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete steso le mani contro di me; ma questa è la vostra ora, è l’impero delle tenebre”. Uscito, Pietro pianse amaramente C Dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno, anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Vedutolo seduto presso la fiamma, una serva fissandolo disse: P “Anche questi era con lui”. C Ma egli negò dicendo: P “Donna, non lo conosco!”. C Poco dopo un altro lo vide e disse: P “Anche tu sei di loro!”. C Ma Pietro rispose: P “No, non lo sono!”. C Passata circa un’ora, un altro insisteva: P “In verità anche questo era con lui; è anche lui un Galileo”. C Ma Pietro disse: P “O uomo, non so quello che dici”. C E in quell’istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: “Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte”. E uscito, pianse amaramente. Indovina: chi ti ha colpito? Frattanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo schernivano e lo percuotevano, lo bendavano e gli dicevano: P “Indovina: chi ti ha colpito?”. C E molti altri insulti dicevano contro di lui. Lo condussero davanti al sinedrio Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo, con i sommi sacerdoti e gli scribi; lo condussero davanti al sinedrio e gli dissero: P “Se tu sei il Cristo, diccelo”. C Gesù rispose: + “Anche se ve lo dico, non mi crederete; se vi interrogo, non mi risponderete. Ma da questo momento starà il Figlio dell’uomo seduto alla destra della potenza di Dio”. C Allora tutti esclamarono: P “Tu dunque sei il Figlio di Dio?”. C Ed egli disse loro: + “Lo dite voi stessi: io lo sono”. C Risposero: P “Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L’abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca”. Non trovo nessuna colpa in quest’uomo C [Tutta l’assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo: P “Abbiamo trovato costui che sobillava il nostro popolo, impediva di dare tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo re”. C Pilato lo interrogò: P “Sei tu il re dei Giudei?”. C Ed egli rispose: + “Tu lo dici”. C Pilato disse ai sommi sacerdoti e alla folla: P “Non trovo nessuna colpa in quest’uomo”. C Ma essi insistevano: P “Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui”. C Udito ciò, Pilato domandò se era Galileo e, saputo che apparteneva alla giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode che in quei giorni si trovava anch’egli a Gerusalemme. Erode con i suoi soldati insulta Gesù Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto, perché da molto tempo desiderava vederlo per averne sentito parlare e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò con molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. C’erano là anche i sommi sacerdoti e gli scribi, e lo accusavano con insistenza. Allora Erode, con i suoi soldati, lo insultò e lo schernì, poi lo rivestì di una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici; prima infatti c’era stata inimicizia tra loro. Pilato abbandona Gesù alla loro volontà Pilato, riuniti i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo, disse: P “Mi avete portato quest’uomo come sobillatore del popolo; ecco, l’ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna colpa di quelle di cui lo accusate; e neanche Erode, infatti ce l’ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò dopo averlo severamente castigato, lo rilascerò”. C Ma essi si misero a gridare tutti insieme: P “A morte costui! Dacci libero Barabba!”. C Questi era stato messo in carcere per una sommossa scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, volendo rilasciare Gesù. Ma essi urlavano: P “Crocifiggilo, crocifiggilo!”. C Ed egli, per la terza volta, disse loro: P “Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Lo castigherò severamente e poi lo rilascerò”. C Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso; e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta fosse eseguita. Rilasciò colui che era stato messo in carcere per sommossa e omicidio e che essi richiedevano, e abbandonò Gesù alla loro volontà. Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: + “Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: Beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: Cadete su di noi! E ai colli: Copriteci! Perché, se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?”. C Venivano condotti insieme con lui anche due malfattori per essere giustiziati. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: + “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno”. C Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte. Questi è il re dei Giudei Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: P “Ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto”. C Anche i soldati lo schernivano, e gli si accostavano per porgergli dell’aceto, e dicevano: P “Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso”. C C’era anche una scritta, sopra il suo capo: Questi è il re dei Giudei. Oggi sarai con me nel paradiso Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: P “Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!”. C Ma l’altro lo rimproverava: P “Neanche tu hai timore di Dio, benché condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male”. C E aggiunse: P “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. C Gli rispose: + “In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso”. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito C Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: + “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. C Detto questo spirò. Qui si genuflette e si fa una breve pausa. Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio: P “Veramente quest’uomo era giusto”. C Anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornavano percuotendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano e così le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea, osservando questi avvenimenti.] Giuseppe pone il corpo di Gesù in una tomba scavata nella roccia C’era un uomo di nome Giuseppe, membro del sinedrio, persona buona e giusta. Non aveva aderito alla decisione e all’operato degli altri. Egli era di Arimatea, una città dei Giudei, e aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo calò dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roccia, nella quale nessuno era stato ancora deposto. Era il giorno della Parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe; esse osservarono la tomba e come era stato deposto il corpo di Gesù, poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo, secondo il comandamento. |
Esegesi
Essendo qui impossibile l’analisi esegetica dell’intero racconto della passione, che è sostanzialmente conforme a quello degli altri evangelisti, ci limitiamo a segnalare alcune particolarità di questo racconto, che ci consentono di capire i principali messaggi religiosi ad esso collegati da Luca. Si tratta soprattutto di omissioni e di aggiunte, rispetto al testo di Marco, da cui certamente il racconto di Luca dipende. Sottolineeremo soltanto le variazioni più significative e di più facile interpretazione.
Tra le variazioni apportate al racconto marciano della passione, si deve considerare quello che contiene l’insegnamento di Gesù su chi sia il più grande tra i suoi discepoli, che Luca sposta qui, nella cornice dell’ultima cena: 22,24-27.
Questo testo Marco lo riporta in 10,41-45 e Matteo in 20,24-28. Lo spostamento serve a Luca per sottolineare l’idea che la passione e morte di Gesù non si deve considerare affatto come una sconfitta, ma è un elemento integrante della via della salvezza.
Elemento aggiuntivo è il brano detto delle due spade: 22,35-38. In esso Gesù annunzia con molta chiarezza ai discepoli che, con la passione del loro maestro, comincia anche per loro il tempo delle difficoltà e dei contrasti. Per dare maggior forza alle sue parole, Gesù stabilisce una contrapposizione tra la missione in Galilea, descritta in Lc 9,1-6 («non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né bisaccia, … né denaro,…»), e la missione che essi dovranno svolgere nel futuro: «…ora chi ha una borsa la prenda, e così una bisaccia; chi non ha una spada, venda il mantello e ne compri una». Gli apostoli non capiscono il senso metaforico dell’accenno alla spada e ne mettono due a disposizione del maestro. Ma Gesù interrompe il discorso con un basta! Il brano è servito a Luca per ricordare che anche la condizione della sua Chiesa sarà caratterizzata da contrasto e persecuzione.
Il racconto dell’agonia nell’orto degli ulivi (22,39-45), sostanzialmente conforme a quello di Marco e Matteo, se ne differenzia per elementi omessi e per altri aggiunti. Mentre non si attenua in nulla l’angoscia sofferta da Gesù durante la sua preghiera, arrivando essa addirittura a un sudore come gocce di sangue (v. 44); nulla è detto del bisogno di Gesù di sentire vicini a sé i discepoli oranti; egli prega solo, lontano dai suoi e, alla fine, «Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo» (v. 43). Con queste variazioni, risplende maggiormente, pur nella sofferenza intensa, la maestà solitaria di Gesù.
Notevoli variazioni, rispetto al testo di Marco-Matteo, ci sono in Luca nella descrizione del comportamento di Pilato. Di costui l’evangelista sembra voler sottolineare una certa dignità e compostezza. Udite le molte e confuse accuse mosse contro Gesù dalla folla, egli si limita a porre una lapidaria domanda all’accusato: «Sei tu il re dei Giudei?» (23,3). La risposta ricevuta gli basta per decretare l’inconsistenza di quelle accuse e dichiara senz’altro:
«Non trovo nessuna colpa in quest’uomo» (23,5-7). Messa poi in evidenza la inconsistente fatuità di erode, Luca ritorna a parlare di Pilato, ribadendo la sua correttezza di magistrato romano, che vuol chiudere il caso con una dichiarazione solenne dell’innocenza di Gesù, appoggiato anche all’opinione di Erode. Pensa di rabbonire quei forsennati dicendo loro: «Perciò dopo averlo severamente castigato, lo rilascerò» (23,13-16). Alla fine, Luca non può negare che Pilato cedette alla richiesta dei nemici di Gesù, ma gli risparmia l’umiliante scena del lavarsi le mani, riportata in Mt 27,24. Questo comportamento di Luca sembra sia determinato dalla sua volontà di attenuare i motivi di tensione tra la comunità cristiana e le autorità romane.
Questo stesso motivo ha forse indotto l’evangelista a omettere di riferire la flagellazione e i maltrattamenti dei soldati, nel corso della sua detenzione (Mc 15,15-20 e Mt 27,26-31). Questa omissione cambia il senso dell’episodio di Cireneo (Lc 23,26): esso non è più motivato dallo spossamento di Gesù (così in Marco e Matteo) e l’uomo che porta la croce per Gesù appare qui piuttosto come uno scudiero che segue il suo cavaliere.
Nel viaggio verso il Calvario, secondo Luca Gesù cammina dritto davanti alla folla con la consueta maestà, tanto che è in grado di parlare alle donne con accento profetico, rifiutando la loro compassione e annunziando che ben più miseranda è la condizione di chi lo rifiuta. Questo episodio (23,27-31) è tra quelli che Luca aggiunge al racconto della passione, in armonia con la sua volontà di non sminuire mai l’atteggiamento maestoso di Gesù.
Luca non smette di sottolineare il comportamento maestoso e regale di Gesù anche quando egli è inchiodato e innalzato sulla croce. La sua regale maestà l’evangelista la esprime soprattutto con le parole di lui.
Luca omette di riferirci il grido angoscioso del crocifisso «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mc 15,34 e Mt 27,46), mentre riporta tre sue frasi piene di maestà. La prima frase è quella con cui Gesù invoca il perdono per tutti quelli che lo hanno respinto e condotto alla croce, perché «non sanno quello che fanno» (23,34). La seconda è la risposta al ladrone crocifisso con lui, che si ravvede all’ultimo momento e gli si affida: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso» (23,42). La terza è quella con cui Gesù esprime, gridando «a gran voce», il suo totale abbandono nel Padre: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (23,46).
Alle parole pronunziate da Gesù sulla croce sembra che Luca abbia voluto affidare il significato ultimo di quella crocifissione e dell’intero suo vangelo.
Nelle parole con cui Gesù prega perché il Padre perdoni. Luca afferma che tutti quelli che lo hanno respinto e condannato sono responsabili di una vera colpa, che ha bisogno del perdono divino, ma contemporaneamente afferma che quella colpa non coincide con un giudizio di condanna definitiva. Tutti quelli che, con diversa gradazione di responsabilità, lo hanno condotto in croce possono prendere parte, a condizione che si convertano, ai frutti della salvezza portata da lui, tanto i pagani quanto i figli dell’antico Israele. Inoltre, la preghiera di Gesù per i suoi nemici manifesta l’amore di Dio per i peccatori (quale è espresso da Luca nelle tre parabole della misericordia del c. 15) e presenta insieme, in concreto, un modello di comportamento per tutti i cristiani (quale è enunciato in Lc 6,27-35).
Le parole con cui Gesù risponde al ladrone convertito contengono un messaggio correttivo dell’attesa giudaica del Messia. «Gesù, ricordati di me quando entrerai (o verrai) nel tuo regno», dice il ladrone, esprimendosi con puro linguaggio biblico e pensando, come tutti i giudei del suo tempo, che il regno messianico si sarebbe realizzato solo alla fine dei tempi. La risposta di Gesù, che riconosce possibile la conversione e la salvezza per tutti i peccatori fino all’ultimo respiro, afferma che il regno di Dio e la salvezza non sono eventi dell’indeterminato futuro, ma cominciano oggi. Questa parola era già risuonata sulla bocca degli angeli annunzianti la buona novella ai pastori di Betlemme («Oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore»: Lc 2,11) e sulla bocca dello stesso Gesù all’inizio del suo ministero pubblico nella sinagoga di Nazaret («Oggi si è adempiuta questa scrittura»: Lc 4,21).
L’ultima frase che Luca attribuisce a Gesù sulla croce mette il sigillo sulla sua presentazione generale della persona del redentore, che soffre e muore senza mai sminuire od offuscare la sua maestà regale. Volutamente sembra che Luca abbia sostituito le parole attribuite a Gesù da Marco e Matteo: mentre questi gli pongono sulle labbra il versetto iniziale del Salmo 22, Luca deriva il suo testo dal Salmo 30 versetto 6, dove non c’è ombra di abbandono da parte di Dio ed è anzi espressa la certezza della sua vicinanza. In tal modo, Gesù è presentato come il supremo modello del giusto, che gli uomini maltrattano e offendono, ma sperimenta sempre la protezione divina. Nelle ultime parole del crocifisso, ai lettori del terzo vangelo è offerto il motivo ispiratore di un comportamento simile a quello del protomartire Stefano, che morì dicendo queste stesse parole (At 7,59-60).
Meditazione
Nel racconto della passione secondo san Luca compare un personaggio, che non incontriamo negli altri racconti evangelici, il quale può offrire il giusto angolo prospettico dal quale guardare a quello che l’evangelista definisce lo ‘spettacolo’ della Croce (cfr. Lc 23,48). È il cosiddetto ‘buon ladrone’, con il quale Gesù ha un ultimo intenso dialogo proprio nell’imminenza della morte. Il terzo vangelo, peraltro, sottolinea con insistenza che Gesù è crocifisso tra due malfattori. Soltanto Luca parla della loro presenza durante la via che sale al Calvario: «insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori» (23,32). Nel versetto successivo insiste precisando: «quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra». Egli vede realizzarsi in questo evento il versetto di Isaia che Gesù ha citato durante l’ultima cena applicandolo a sé e al destino che lo attendeva: «e fu annoverato tra gli empi» (Lc 22,37; cfr. Is 53,12d). Crocifisso in mezzo a due malfattori, Gesù ora viene davvero annoverato tra gli iniqui. Luca, tuttavia, non intende solo mostrare il realizzarsi della profezia; gli preme soprattutto mettere in luce il suo significato salvifico. Il dialogo con il buon ladrone ha proprio questo intento teologico: rivelare il senso salvifico che questo modo di morire in mezzo a due peccatori possiede. Assume perciò, nel contesto del racconto della passione, un valore sintetico e interpretativo di come l’evangelista comprenda e descriva tutto l’evento pasquale.
A introdurre il dialogo è il buon ladrone stesso, che per prima cosa si rivolge non a Gesù, ma al suo compagno per rimproverarlo di non avere il giusto atteggiamento di fronte a Dio, che ora egli inizia ad assumere. Anche questo ‘buon ladrone’ non ha avuto finora timore degli uomini, al punto da compiere azioni gravi che lo conducono a subire la condanna capitale, ma in questo momento giunge ad avere timore di Dio. Ovviamente ‘timore’ non va inteso nel senso di ‘paura’ o ‘terrore’ (ad esempio della morte, o del giudizio), ma nel suo significato squisitamente biblico: avere il giusto senso di Dio, in particolare della sua giustizia. Rimanendo davanti a Dio con ‘timore’ egli riconosce da un lato la propria colpevolezza e il proprio peccato – noi siamo condannati giustamente (cfr. v. 41) – dall’altro l’innocenza e la giustizia di Gesù. Questi due aspetti vanno insieme e non possono essere separati: contemplare la giustizia di Gesù illumina la nostra vita e ci porta a riconoscere il nostro peccato; d’altro lato, circolarmente, la consapevolezza del nostro peccato fa risaltare la giustizia di Gesù in cui si manifesta la giustizia stessa del Padre. Avere timore di Dio significa vivere insieme questi due atteggiamenti, consentendo all’uno di illuminare e rendere possibile l’altro. Si apre così per questo personaggio la via verso un pentimento che si esprime poi in un’invocazione molto breve e molto ricca nella sua essenzialità: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno» (v. 42). Gesù: è l’unica ricorrenza in tutto il Nuovo Testamento in cui leggiamo il nome di Gesù al vocativo, senza che venga aggiunto qualche altro titolo. Nessun altro personaggio si rivolge a Gesù con la stessa familiarità di questo ladrone, accomunato a lui dalla medesima terribile pena. Non è però soltanto la confidenza a farlo parlare in questo modo. Gesù significa ‘Dio salva’ e negli Atti degli Apostoli Luca afferma che questo è il solo nome in cui si può trovare salvezza. Il buon ladrone, anziché oltraggiare, schernire, bestemmiare, invoca in Gesù la salvezza di Dio, e lo fa proprio mentre Gesù non sta salvando se stesso, e rimane insieme a lui sul medesimo patibolo infame.
Quanti altri personaggi del vangelo di Luca si sono accostati al profeta itinerante in Galilea, potente in parole e opere, con la fede che chiedeva una liberazione dal male? Gesù li aveva accolti rispondendo ‘la tua fede ti ha salvato’. Ma ora questo ladrone rivolge la sua invocazione a un Gesù che sembra impossibilitato a salvare persino se stesso. Il racconto di Luca suscita così una domanda fondamentale: da dove e come nasce questa fede? In Luca la voce in cui si ricapitola e si esprime la pienezza della fede è proprio quella del buon ladrone. C’è quindi una differenza rispetto al racconto di Marco, in cui la pienezza della fede risuona piuttosto nelle parole del centurione, il quale «avendolo visto spirare in quel modo, disse: “Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!”» (Mc 15,39). Per Marco la fede matura risuona nelle parole di un centurione romano, vale a dire di un pagano. In Luca in un peccatore, in modo coerente con l’intero suo vangelo che ha cura di rimarcare come durante la sua vita Gesù abbia mangiato con i peccatori e sia stato accolto dalla loro fede. Pensiamo ad esempio alla peccatrice che gli cosparge di olio e di lacrime i piedi nella casa di Simone il fariseo (cfr. Lc 7,36-50), o a Zaccheo, il pubblicano di Gerico, che in Gesù accoglie la salvezza di Dio mentre tutti mormorano: «è entrato in casa di un peccatore!» (cfr. Lc 19,1-10). Zaccheo è proprio l’ultimo personaggio che Gesù incontra nel suo cammino verso Gerusalemme: un peccatore che viene cercato e salvato da Gesù. «Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto» (19,10), dichiara Gesù nella sua casa. Il significato di queste parole diviene chiaro sulla croce: Gesù è venuto a cercare e a salvare anche questo ladrone, e con lui ciascuno di noi. Ci ha cercati non solo fino a entrare nella casa di un pubblicano – il che era vietato a un pio e osservante giudeo – ma fino a salire con noi, lui l’unico giusto, sulla croce del nostro ostinato peccato. Ecco perché Gesù non risponde alla triplice sfida che gli viene lanciata di salvare se stesso. O meglio, lo fa con le parole che rivolge al buon ladrone. Non salva se stesso perché è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto, e lo ha fatto fino al punto di perdere se stesso, fino a non salvare se stesso dalla croce e dalla morte.
Rimane però aperta la domanda iniziale. Come può questo ladrone giungere a questa fede? Cosa significa riconoscere in Gesù la salvezza? Che tipo di salvezza è quella che si manifesta in un giusto crocifisso? Per rispondere a tali interrogativi dobbiamo ricordare ancora la citazione di Isaia 53: «e fu annoverato tra gli empi». La fede del buon ladrone rivela il significato salvifico di questo accettare la morte insieme agli iniqui. Gesù, condividendo il destino dei peccatori, prende su di sé il loro peccato per donare loro la sua giustizia. Anche per questo motivo in Luca il centurione romano esclama, diversamente dal racconto di Marco: «veramente quest’uomo era giusto». Giusto perché ci rende giusti, assumendo il nostro peccato per comunicarci la sua giustizia. La salvezza consiste nel riconoscere questa misericordia che ci giustifica raggiungendoci nel nostro peccato e facendosi solidale con il nostro destino di peccatori. La fede del ladrone, che per Luca rappresenta la figura esemplare della fede di ogni discepolo, riconosce la salvezza di Dio proprio nella misericordia con cui Gesù accetta liberamente di morire come lui e insieme a lui.
Nel racconto di Luca la vita di Gesù è interamente abbracciata da un oggi, che per la prima volta risuona nel racconto della nascita e per l’ultima volta in quello della morte. È interessante notare il gioco delle preposizioni che risuona nei due testi. Nella nascita gli angeli annunciano: «oggi è nato per voi un salvatore» (cfr. Lc 2,7). Nella morte Gesù promette: «oggi sarai con me». La vita di Gesù segna questo passaggio: dal per voi al con me. Egli nasce per noi perché noi possiamo essere definitivamente con lui. Ecco l’oggi della salvezza!
Vita est enim esse cum Christo, quia ubi Christus ibi regnum. «La vita è essere con Cristo, perché dove c’è Cristo, lì c’è il regno» (Ambrogio di Milano).
Don Bosco commenta il Vangelo
Domenica delle Palme
Pietro era seduto in mezzo al cortile, e diceva di non conoscere il Nazareno. Un gallo cantò. “Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto” (Lc 22,61s).
Don Bosco ha notato con attenzione lo sguardo di Gesù fisso su Pietro che solo l’evangelista Luca menziona.
Nel terzo giorno dell’Esercizio di divozione alla misericordia di Dio, dedicato ai “particolari tratti di misericordia usati dal divin Salvatore nella sua passione ai peccatori”, don Bosco cita il caso di Pietro:
“Pietro lo nega per tre volte, egli lo mira con uno sguardo di compassione, lo fa rientrare in sé stesso, e lo riceve di nuovo nella sua grazia” (OE2 137s).
Più avanti nello stesso libretto don Bosco dichiara: “Forse ci atterrirà l’abuso delle grazie da Dio fatteci per il passato? […] San Pietro era stato ricolmo di segnalatissimi favori, ciò non ostante per tre volte lo nega; ma come si pente, tosto ne riceve il perdono. Ci spaventerà la gravezza dei nostri peccati?” (OE2 141s).
Anche nella Storia sacra si legge: “Udito il gallo per ben due volte a cantare, rammentossi di quanto gli aveva detto il Redentore, ed in seguito ad un amoroso sguardo di lui si pentì di cuore, e subito uscito pianse amaramente il suo peccato” (OE3 193).
Alla domanda: “Quali osservazioni fate sulla passione di Gesù?”, si legge questa risposta:
Fra le molte virtù che egli fece luminosamente risplendere nella sua passione fu segnalata la sua costanza, con cui soffrì tanti dolori senza proferir parola di risentimento o di lamento, e più ancora l’amore che dimostrò per li peccatori. […] Pietro lo nega, ed egli con uno sguardo amoroso lo fa ravvedere. […] Carità fu questa che non può essere se non di un Dio, e che animar deve tutti i cristiani a patire per lui, e perdonare generosamente agli offensori (OE3 199).
Nella Vita di san Pietro don Bosco mostra come lo sguardo di Gesù ha reso Pietro un modello di contrizione e di penitenza:
A questa rimembranza si turba, sentesi tutto amareggiato il cuore, e girando l’occhio verso l’offeso Gesù, lo sguardo di lui s’incontra col suo. Questa occhiata di Cristo fu un atto muto, ma un colpo di grazia che a guisa di strale acutissimo lo andò a ferire nel cuore, non per dargli la morte ma per restituirgli la vita. A quel tratto di bontà e di misericordia Pietro scosso come da un profondo sonno si sentì gonfiare il cuore e provocare le lagrime pel dolore. Per dare libero sfogo al pianto uscì da quel malaugurato luogo e andò a piangere il suo fatto e invocare dalla divina misericordia il perdono. Il Vangelo ci dice solamente che: Et egressus Petrus flevit amare. Pietro uscì fuori e pianse amaramente. Di questa caduta Pietro ne portò rimorso tutta la vita e si può dire che da quell’ora fino alla morte non fece che piangere il suo peccato facendone aspra penitenza. Si dice che egli avesse sempre accanto un pannolino per asciugarsi le lagrime, e che ogni qual volta sentiva il gallo a cantare, trasaliva e tremava, richiamandogli tuttora alla memoria il doloroso momento di sua caduta. (OE8 342ss).
Nella circolare “Dei castighi da infliggersi nelle case salesiane”, don Bosco propone Gesù come modello dell’educatore che corregge l’allievo soprattutto con il suo sguardo di carità:
Bisogna evitare l’affanno e il timore inspirato dalla correzione e mettere una parola di conforto. Dimenticare e far dimenticare i tristi giorni dei suoi errori è arte suprema di buon educatore. […] Con somma e paterna delicatezza [Gesù] fece confessare e purgarsi san Pietro nella sua debolezza. Anche il fanciullo vuol essere persuaso che il suo superiore ha buona speranza della sua emendazione, e così sentirsi di nuovo messo dalla sua mano caritatevole per la via della virtù.
Si otterrà più con uno sguardo di carità, con una parola dì incoraggiamento che dia fiducia al suo cuore, che con molti rimproveri (MB16 444s).
(Morand Wirth)
Tra parentesi il lettore troverà i riferimenti principali dei testi citati nelle opere di o su don Bosco: – nei 38 volumi delle Opere edite di G. Bosco (OE1-38, a cura del Centro Studi Don Bosco dell’Università Pontificia Salesiana); – nei 19 volumi delle Memorie biografiche di don G. Bosco (MB1-19, a cura di G.B. Lemoyne, A. Amadei e E. Ceria); – nelle sue Memorie dell’Oratorio (MO, a cura di A. Giraudo); – nei 10 volumi del suo Epistolario (E1-10, a cura di F. Motto). La seconda cifra indica la pagina del volume.
L’immagine della domenica
| «Fraterna Domus» (Sacrofano) – 2016 |
«Tenete la croce in alto,
cosicché io possa vederla anche attraverso le fiamme».
(Giovanna D’Arco)
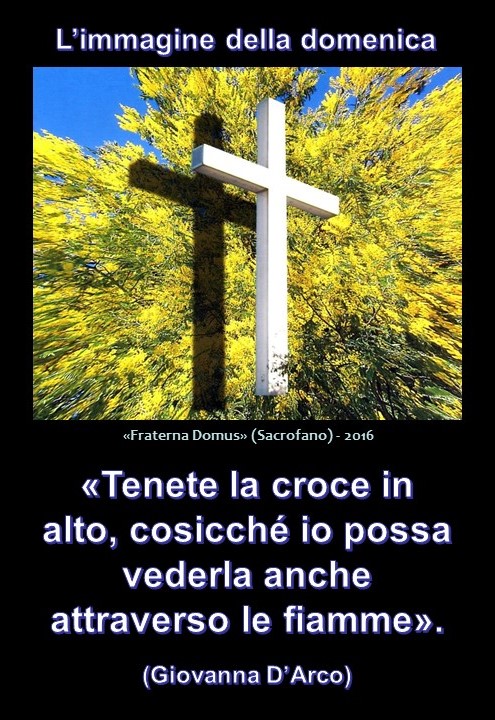
Preghiere e racconti
«Io vorrei che tutti, dopo questi giorni di grazia, avessimo il coraggio di camminare in presenza del Signore, con la Croce del Signore; di edificare la Chiesa sul sangue del Signore, che è versato sulla Croce; e di confessare l’unica gloria: Cristo Crocifisso. E così la Chiesa andrà avanti.»
(Papa Francesco, omelia del 14 marzo 2013).
Postato in General il 14 marzo, 2013
Nello stemma episcopale di papa Jorge Mario Bergoglio ci sono tre parole latine di non immediata comprensione: “Miserando atque eligendo”.
Ma se si va a vedere da dove sono riprese si scoprono tratti importanti del programma di vita e di ministero di papa Francesco.
In questa piccola caccia al tesoro è d’aiuto una nota del dotto teologo Inos Biffi su “L’Osservatore Romano” del 15 marzo.
Il motto proviene da un’omelia di san Beda il Venerabile (672-735), monaco di Wearmouth e di Jarrow, autore di opere esegetiche, omiletiche e storiche, tra cui la “Historia ecclesiastica gentis Anglorum”, per cui è chiamato il “Padre della storia inglese”.
Nell’omelia, la ventunesima di quelle che ci sono giunte, Beda commenta il passo del Vangelo che racconta la vocazione ad apostolo di Matteo, pubblico peccatore.
Nel brano da cui è ricavato il motto si legge:
“Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: ‘Seguimi’ (Matteo, 9, 9). Vide non tanto con lo sguardo degli occhi del corpo, quanto con quello della bontà interiore. Vide un pubblicano e, siccome lo guardò con amore misericordioso in vista della sua elezione, gli disse: ‘Seguimi’. Gli disse ‘Seguimi’, cioè imitami. ‘Seguimi’, disse, non tanto col movimento dei piedi, quanto con la pratica della vita. Infatti ‘chi dice di dimorare in Cristo, deve comportarsi come lui si è comportato’ (1 Giovanni, 2, 6)”.
In latino, il brano inizia così:
“Vidit ergo Iesus publicanum, et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi, Sequere me. Sequere autem dixit imitare. Sequere dixit non tam incessu pedum, quam exsecutione morum”.
Includere nello stemma il motto “Miserando atque eligendo” significa dunque mettersi al posto di Matteo, da Gesù guardato con misericordia e chiamato, nonostante i suoi peccati.
Ma l’importante è il seguito del passo citato. Dove Beda spiega cosa comporta seguire ed imitare Gesù:
“Non ambire le cose terrene; non ricercare i guadagni effimeri; fuggire gli onori meschini; abbracciare volentieri tutto il disprezzo del mondo per la gloria celeste; essere di giovamento a tutti; amare le ingiurie e non recarne a nessuno; sopportare con pazienza quelle ricevute; ricercare sempre la gloria del Creatore e non mai la propria. Praticare queste cose e altre simili vuol dire seguire le orme di Cristo”.
Conclude Inos Biffi:
“È il programma di san Francesco d’Assisi, iscritto nello stemma di papa Francesco. E intuiamo che sarà il programma del suo ministero, come vescovo di Roma e pastore della Chiesa universale”.
La benedizione delle palme, da cui questa domenica prende il nome, e la processione che ne è seguita vogliono evocare l’ingresso in Gerusalemme di Gesù e la folla che gli va incontro festosa e acclamante.
Forse la nostra processione appare un po’ povera rispetto a ciò che dovrebbe rievocare. L’importante, tuttavia, non è prendere in mano le palme e gli ulivi e compiere qualche pas-so, ma esprimere la volontà di iniziare un cammino. Questa scena infatti, che vorrebbe essere di entusiasmo, non ha valore in sé: assume piuttosto il suo significato nell’insieme degli eventi successivi che culmineranno nella morte e nella risurrezione di Gesù. Contiene perciò una domanda che è anche un invito: vuoi tu muovere i passi entrando con Gesù a Gerusalemme fino al calvario? Vuoi vedere dove finiscono i passi del tuo Dio, vuoi essere con lui là dove lui è? Solo così sarà tua la gioia di Pasqua.
Entriamo dunque con la domenica delle Palme nella Settimana santa, chiamata anche “autentica” o “grande”. Grande perché, come dice san Giovanni Crisostomo, «in essa si sono verificati per noi beni infallibili: si è conclusa la lunga guerra, è stata estinta la morte, cancellata la maledizione, rimossa ogni barriera, soppressa la schiavitù del peccato. In essa il Dio della pace ha pacificato ogni cosa, sia in cielo che in terra».
Sarà dunque una settimana nella quale pregheremo in particolare per la pace a Gerusalemme e ci interrogheremo pure sulle condizioni profonde per attuare una reale pace a Gerusalemme e nel resto del mondo.
La liturgia odierna è quindi un preludio alla Pasqua del Signore. L’entrata in Gerusalemme dà il via all’ora storica di Cristo, l’ora verso la quale tende tutta la sua vita, l’ora che è al centro della storia del mondo. Gesù stesso lo dirà poco dopo ai greci che, avendo saputo della sua presenza in città, chiedono di vederlo: «È venuta l’ora in cui sarà glorificato il Figlio dell’uomo» (Gv 12,23). Gloria che risplenderà quando dalla croce attirerà tutti a sé.
(Carlo Maria MARTINI, Incontro al Signore risorto, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2009, 159-160).
Mi rallegrai quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore».
E ora i nostri piedi
sono nell’interno delle tue porte,
Gerusalemme!
Gerusalemme costruita come città,
in sé ben compatta!
Là salivano le tribù, le tribù del Signore,
secondo il precetto dato a Israele
di lodarvi il nome del Signore.
Sì, là s’ergevano i seggi del giudizio,
i seggi della casa di Davide.
Augurate la pace a Gerusalemme:
vivano in prosperità quanti ti amano!
Sia pace fra le tue mura,
prosperità fra i tuoi palazzi.
Per amore dei miei fratelli e amici
dirò: Sia pace in te!
Per amore della casa del Signore, nostro Dio,
chiederò: Sia bene per te!
(Salmo 121)
Dopo la risurrezione di Lazzaro, morto da quattro giorni, il Signore trovò un asinello che era stato preparato dai discepoli, come racconta l’evangelista Matteo (cfr. Mt 21,1-11), montò su di esso ed entrò in Gerusalemme secondo la profezia di Zaccaria, che aveva predetto: «Non temere, figlia di Sion! Ecco, giunge a te il tuo re, re di giustizia e di salvezza; mite cavalca il piccolo di un’asina» (Zc 9,9). Attraverso queste parole il profeta voleva indicare che Cristo è il re profetizzato, l’unico vero re di Israele. Il tuo re — dice – non mette paura a quelli che lo vedono, non è duro né malvagio, non conduce con sé soldati armati di scudo o guardie del corpo, né una quantità di fanti e di cavalieri, superbo, pronto a riscuotere imposte e tasse, a imporre schiavitù e servitù ignobili e dannose, ma sue insegne, invece, sono l’umiltà, la povertà, la sobrietà. Montato su un asino, infatti, faceva il suo ingresso senza ostentare alcuno sfarzo mondano. Per questo egli è il solo re giusto, che salva nella giustizia, mansueto perché la mansuetudine è l’attributo che più gli è proprio. Ed è lo stesso Signore che dice di sé: «Imparate da me, che sono mite e umile di cuore». Colui dunque che risuscitò Lazzaro dai morti, re montato su un asino, entrava allora in Gerusalemme e subito tutta la gente, bambini, uomini, adulti e vecchi, stesero per terra i loro mantelli e, presi dei rami di palma, simbolo di vittoria, gli andavano incontro come all’autore della vita e al vincitore della morte, gli si prostravano davanti, lo scortavano e non solo all’esterno, ma anche dentro il recinto del tempio, e a una sola voce cantavano: «Osanna al figlio di David! Osanna nel più alto dei cieli!» (Mt 21,9). «Osanna» è un inno che si eleva a Dio; infatti tradotto significa: «Salvaci, Signore!»; e la parte che segue «nell’alto dei cieli» significa che l’inno è cantato non solo sulla terra, non solo dagli uomini, ma anche nell’alto dei cieli dagli angeli del cielo.
(GREGORIO PALAMAS, Omelie 15, PC 151,184B-185).
Signore Gesù Cristo, nell’oscurità della morte
Tu hai fatto che sorgesse una luce;
nell’abisso della solitudine più profonda
abita ormai per sempre la protezione potente
del tuo amore;
in mezzo al tuo nascondimento
possiamo cantare l’Alleluja dei salvati.
Concedici l’umile semplicità della fede,
che non si lascia fuorviare
quando tu chiami nelle ore del buio, dell’abbandono,
quando tutto sembra apparire problematico;
concedi in questo tempo nel quale attorno a te si combatte una lotta mortale,
luce sufficiente per non perderti;
luce sufficiente perché noi possiamo darne
a quanti ne hanno ancora più bisogno.
Fai brillare il mistero della tua gioia pasquale,
come aurora del mattino, nei nostri giorni,
concedici di poter essere veramente uomini pasquali
in mezzo al sabato della storia.
Concedici che attraverso i giorni luminosi ed oscuri
di questo tempo
possiamo sempre con animo lieto
trovarci in cammino verso la Tua gloria futura.
Amen.
(J. Ratzinger)
Il tuo volto, Signore Gesù, è il volto del Dio dell’umiltà che ci ama fino a spogliarsi, fino a rendersi povero in mezzo a noi. Il tuo volto è il volto del nostro dolore, della nostra solitudine, della nostra angoscia, della nostra morte che tu hai voluto assumere perché non fossimo più soli e disperati.
Fa’ che impariamo a riconoscere questa sconcertante rivelazione della tua onnipotenza, l’onnipotenza di chi ama fino a condividere la sofferenza, fino a lasciarsi crocifiggere per nostro amore. Insegnaci che cosa significa amare come tu ci ami, per accettare in silenzio di partecipare al tuo mistero di passione e morte e gustare con te e in te la gioia della vittoria piena e totale sulla divisione, sul peccato e sulla morte.
5-12 aprile
5. (S. Vincenzo Ferrer) – Questo santo pregava così: “O Signor Gesù Cristo, […] vi prego […] che nell’ora della morte mi concediate […] una viva fede, una ferma speranza, ed un’ardente carità” (OE19 193s).
6. “Procureremo di evitare fra noi qualunque minimo dispiacere, sopportando con pazienza i compagni e le altre persone moleste” (MB5 480).
7. (S. Giovanni Battista de la Salle) – Dopo aver distribuito il suo patrimonio ai poveri, “si pose ad istruire i ragazzi fondando un istituto, che ha di mira l’istruzione morale e civile della gioventù” (OE1 491).
8. La confidenza è “la chiave di tutto” (MB11 354).
9. “Chi non può prestarsi per li detenuti, si presti per gli schiavi del demonio animando e consigliando altri a lasciare il peccato e porsi in grazia di Dio” (OE3 274).
10. “Ricordatevi che scienza senza coscienza non è che la rovina dell’anima” (MB8 166).
11. (S. Stanislao) – “Credesi che questo santo vescovo fosse stato mandato dalla Vergine in aiuto ai Polacchi” (OE20 261).
12. “La temperanza e il lavoro sono i migliori custodi della virtù” (E7 480).
(Morand Wirth)
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
—
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– M. FERRARI, monaco di Camaldoli, «Oggi di è adempiuta questa scrittura». Tempo di Quaresima e Tempo di Pasqua, Milano, Vita e Pensiero, 2013.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.
– C.M. MARTINI, Incontro al Signore risorto. Il cuore dello spirito cristiano, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009.
– J.M. NOUWEN, Un ricordo che guida, in ID., Mostrami il cammino. Meditazioni per il tempo di Quaresima, Brescia, Queriniana, 2003.
—
– Immagine della domenica, a cura di García-Orsini-Pennesi.

L’Istituto di Catechetica dell’Università Pontificia Salesiana intende riprendere la tradizione delle attività di formazione residenziale per Insegnanti di Religione Cattolica (IdR) con un Corso che avrà luogo dal 1 al 3 luglio 2025 a Sacrofano (Roma) sul tema: Il sapere religioso nel tempo del dialogo.
Programma del corso
Il sapere religioso nel tempo del dialogo
1° luglio, pomeriggio: dimensione pedagogica
Relatore: prof. Pierpaolo Triani, ordinario di Pedagogia, Università Cattolica di Milano,
Discussant: prof. Carlo Macale, docente di Pedagogia del lavoro, UPS.
Seguirà il laboratorio didattico.
2 luglio, mattina: dimensione teologica
Relatore: prof. Giuseppe Lorizio, ordinario di Teologia, Pontificia Università Lateranense,
Discussant: prof. Komlanvi Samuel Amaglo, docente di Teologia delle religioni, UPS.
Seguirà il laboratorio didattico.
2 luglio, pomeriggio: dimensione filosofica
Relatore: prof. Adriano Fabris, ordinario di Filosofia morale, Università di Pisa,
Discussant: prof. Tiziano Conti, docente di Filosofia dell’educazione, UPS.
Seguirà il laboratorio didattico.
3 luglio, mattina: dimensione sociologica
Relatore: prof.ssa Cecilia Costa, ordinaria di Sociologia, Università di RomaTre,
Discussant: prof.ssa Maria Paola Piccini, docente di Metodologia della ricerca sociale, UPS.
Seguirà il laboratorio didattico.
Note logistiche
Il Corso si svolgerà presso la Fraterna Domus di Sacrofano, Via Sacrofanese 25, 00188 Roma, con arrivo entro le ore 14.00 del 1° luglio e partenza dopo il pranzo del 3 luglio.
La Sede si trova a pochi chilometri da Roma ed è facilmente raggiungibile:
Costi
Soggiorno con trattamento di pensione completa in camera singola, dalla cena del 1° luglio al pranzo del 3 luglio: € 190 (IVA compresa).
Spese di partecipazione al corso: € 160 (IVA compresa).
Costo di un singolo pasto: € 20 (IVA compresa).
Chi non intende pernottare in sede verserà solo la quota di partecipazione e dei singoli pasti prenotati.
Eventuali soggiorni di familiari in camere multiple o prolungamenti del soggiorno per fermarsi a Roma nei giorni successivi saranno concordati direttamente dagli interessati con Fraterna Domus (info@fraternadomus.it; tel. 06-330821).
Iscrizione e scadenze
Indirizzo mail unico di comunicazione sarà rpr@unisal.it (salvo diverse disposizioni)
L’iscrizione va comunicata entro il 31/03/2025 inviando una mail a rpr@unisal.it, indicando nell’oggetto Corso IRC 2025 – Cognome e Nome e allegando la scheda di iscrizione debitamente compilata e la ricevuta del bonifico attestante il pagamento della quota di partecipazione (€ 160) a titolo di caparra. La caparra verrà restituita solo in caso di annullamento del Corso; non sarà restituita in caso di ritiro dell’iscrizione da parte dell’interessato/a.
Il pagamento è da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate:
IBAN: IT62W0569603219000001000X18
Beneficiario: PONTIFICIO ATENEO SALESIANO – Piazza Ateneo Salesiano, 1 – 00139 ROMA
Causale: IDR25 – Cognome e Nome di chi si iscrive al Corso
La conferma della partecipazione e il pagamento delle spese di soggiorno avverranno con modalità analoghe entro il 20/05/2025.

Giovedì 10 aprile 2025 dalle 16 alle 17, online presentazione del convegno AICa 2025
Link zoom: https://bit.ly/aica2025 – passcode: aica
Nella complessità che stiamo vivendo ci chiediamo quale sia lo specifico della catechesi e quali arricchimenti possa trarre dalla relazione con i diversi soggetti che incontra nell’azione pastorale.
Il primo anno del convegno ci ha messo in ascolto di esperienze, luoghi e periferie esistenziali che ci hanno invitato a ripensare la vita pastorale odierna e la proposta della catechesi. In particolare siamo stati provocati dal cambiamento della spiritualità e della forma di Chiesa che si stanno delineando.
In questo secondo anno, ci lasciamo provocare dalla ricerca di spiritualità dei giovani che tocca anche i genitori dei ragazzi dell’iniziazione cristiana, per rinnovare il nostro modo di incontrarli e di accompagnare gli itinerari proposti.
Quando: dal pomeriggio di martedì 2 a dopo pranzo di giovedì 4 settembre 2025.
Dove: Casa don Bosco – Valdocco, via Maria Ausiliatrice, 32, Torino.
Come arrivare: La stazione Ferroviaria più vicina è Porta Susa: da qui si può prendere il taxi o il bus numero 10 N direzione Rondò Della Forca.
Martedì 2 settembre 2025:
● 16.00: Accoglienza e presentazione del convegno
● 16.30: Ascolto della ricerca su giovani e spiritualità – Paola Bignardi e d. Claudio Margaria
● 18.30: Celebrazione eucaristica
Mercoledì 3 settembre 2025
● 9.00: In ascolto dei genitori e della loro ricerca di spiritualità nell’esperienza della diocesi di Torino (d. Michele Roselli)
● Pranzo
● 15.00: Approfondimento del significato e lavoro con la griglia di lettura della realtà attuale (d.
Rolando Covi). Lavoro in gruppo
● 18.30: Celebrazione eucaristica
● Cena sociale
Giovedì 4 settembre
● 9.00: condivisione in assemblea e rilettura del percorso
● 12.00: Conclusione convegno
● 12.30: Pranzo
Iscrizioni: è possibile iscriversi al Convegno entro il 30 giugno 2025 compilando il google form
Per informazioni
Don Stefano Borghi (segretario AICa)
segreteria@catechetica.it
Quota di partecipazione è di 230€
Comprensiva di:
vitto e alloggio: 150€ (dalla cena del 2 al pranzo del 4)
iscrizione al convegno 40€
quota associativa 2025: 40€
Per coloro che hanno già versato la quota associativa 2025 il costo è di 190€
Per coloro che partecipano in forma non residenziale il costo è di 80€ (comprensivo di quota associativa 2025) più supplemento di eventuali pasti (15€ ciascuno).
La quota di partecipazione deve essere versata per mezzo di Bonifico Bancario sul c.c.:
IBAN: IT49S0306909606100000182921
Intestato a: Associazione Italiana del Catecheti
Causale: Cognome e Nome – Partecipazione Convegno AICa 2025

Webinar IRC – 28 marzo 2025 – 17:00 – 19:00
Per richiedere l’attestato di partecipazione si prega di mandare una mail a: rpr@unisal.it con i seguenti dati (nome, cognome, data e luogo di nascita) e di farlo contestualmente all’evento.

Il 6 febbraio 2025 è venuto a mancare il professore Józef Stala, Vicerettore per il potenziale scientifico e la cooperazione internazionale della Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia nel 2014-2020.
È con grande tristezza che abbiamo appreso la notizia della morte di P. Józef Stal, sacerdote della diocesi di Tarnów, professore di scienze teologiche, docente di catechesi presso la Facoltà di Teologia, sezione di Tarnów della Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia, vicepreside per la scienza, lo sviluppo e la cooperazione internazionale negli anni 2010-2014, capo del dipartimento di scienze pedagogiche e catechistiche (attualmente: dipartimento di teologia pratica, diritto canonico e pedagogia) presso la Facoltà di Teologia, sezione di Tarnów (WTST), vicerettore per il potenziale scientifico e la cooperazione internazionale dell’UPJPII negli anni 2014-2020.
Il reverendo professor Józef Stala da diversi anni lottava contro una malattia insidiosa che, nonostante ripetute guarigioni, non era riuscito a sconfiggere. Non si è arreso fino alla fine e non ha smesso di lavorare per la Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia.
Tutta la comunità accademica, con il Rettore e il Senato, chiede a Dio misericordioso la luce e il riposo eterno per il defunto Reverendo professor Józef Stal.

Dal 1985 al 1991 Stala ha studiato Filosofia e Teologia , nel 1985 e nel 1986 al Seminario Gościkowo -Paradyż e dal 1986 al 1991 a Tarnów . Il 31 maggio 1991 ha terminato gli studi con Magister of Theology presso la Pontificia Accademia di Cracovia (ora: Pontificia Università Giovanni Paolo II ). Dopo gli studi presso l’Accademia Teologica di Varsavia (oggi Università Cardinale Stefan Wyszyński di Varsavia), il 15 maggio 1995 ha conseguito la Licenza , l’8 giugno 1998 il Dottorato e nel 2005 l’ Abilitazione con il libro: “Katecheza o małżeństwie i rodzinie w Polsce po Soborze Watykańskim II.” ( L’insegnamento della religione nelle famiglie in Polonia dopo il Concilio Vaticano II ) presso la Pontificia Università Giovanni Paolo II .
Dal 2013 Stala, sacerdote della diocesi di Tarnów, è stato professore associato di Catechesi e vicepreside per la ricerca, lo sviluppo e la cooperazione e direttore della Sezione di ricerca di studi pedagogici e catechetici presso la Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia (UPJPII), Facoltà di Teologia, Sezione di Tarnów (WTST), coordinatore del programma Erasmus presso la WTST e caporedattore della rivista scientifica internazionale The Person and the Challenges .
Stala è stato eletto nel senato accademico come prorettore per la scienza e la cooperazione internazionale della Pontificia Università di Cracovia per il periodo dal 2014 al 2018.
Libri
E. Osewska, J. Stala: Die katholische Schule zu Beginn des XXI. Jahrhunderts am Beispiel Polens und Englands UKSW, Warszawa 2015, ISBN 978-83-65224-83-5 Importa titolo nel progetto Citavi in base a questo ISBN(stampato), ISBN 978-83-65224-84-2
Importa titolo nel progetto Citavi in base a questo ISBN(online)
J. Stala, E. Osewska. Anders erziehen in Polonia. Der Erziehungs- und Bildungsbegriff im Contest eines sich ständig verändernden Europas des XXI. Jahrhunderts. Polihymnia, Tarnów 2009, ISBN 978-83-7270-765-9 Importa titolo nel progetto Citavi in base a questo ISBN.
J.Stala. Familienkatechese in Polen um die Jahrhundertwende. Probleme und Herausforderungen. Biblos, Tarnów 2008, ISBN 978-83-7332-674-3 Importa titolo nel progetto Citavi in base a questo ISBN.
J.Stala. Dzisiejsza młodzież powiedziała, że… : problemy i wyzwania , Kielce 2006, wyd. Jedność, ISBN 8374423552 Importa titolo nel progetto Citavi in base a questo ISBN.
J.Stala. Katecheza o małżeństwie i rodzinie w Polsce po Soborze Watykańskim II: próba oceny , Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. Tarnów: “Biblos”, poliziotto. 2004. ISBN 8373322248 Importa titolo nel progetto Citavi in base a questo ISBN
J.Stala. Katecheza rodzinna w nauczaniu Kościoła od Soboru Watykańskiego II , Tarnów; Lublino: Wydawnictwo Polihymnia, 2009. ISBN 9.788.372,707703Importa titolo nel progetto Citavi in base a questo ISBN
J. Stala, Weronika Dryl. Kocham Cię, Jezu: propozycje katechez przedszkolnych dla pięciolatków Tarnów: “Biblos”, 2001. ISBN 8373320032 Importa titolo nel progetto Citavi in base a questo ISBN
J. Stala, Anna Kawa. Miłuję Chrystusa: pomoce do katechez i homilii: ewangelie roku B Kraków: Wydaw. Księży Sercanów, poliziotto. 2002. ISBN 8388465686 Importa titolo nel progetto Citavi in base a questo ISBN
J. Stala, Anna Kawa. Naśladuję Chrystusa : pomoce do katechez i homilii – Ewangelie roku C Kraków : Wydaw. Księży Sercanów, 2003. ISBN 838846597X Importa titolo nel progetto Citavi in base a questo ISBN
J. Stala, Anna Kawa. Poznaję Chrystusa: pomoce do katechez i homilii – Ewangelie roku A Kraków: “SCJ”, 2001. ISBN 8388465368 Importa titolo nel progetto Citavi in base a questo ISBN
J.Stala. Ręce mego ojca i usta mojej matki powiedziały mi najwięcej o Bogu : biskupa Piotra Bednarczyka ujęcie katechezy rodzinnej Tarnów ; Lublino: Wydawnictwo Polihymnia, 2011. ISBN 9.788.372,709523Importa titolo nel progetto Citavi in base a questo ISBN
J.Stala. W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie : (próba refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II w kontekście polskich uwarunkowań) Tarnów ; Lublino: Wydawnictwo Polihymnia, 2010. ISBN 9.788.372,708014Importa titolo nel progetto Citavi in base a questo ISBN
J.Stala. Z Ewangelią w trzecie tysiąclecie: Piesza Pielgrzymka Tarnowska, Tarnów – 2001 Tarnów: “Biblos”, cop. 2001. ISBN 8387952664 Importa titolo nel progetto Citavi in base a questo ISBN
J. Stala, Anna Kawa. Z Jezusem szczęśliwi codziennie : Ewangelie dni powszednich. T. 2, Wielki Post i Wielkanoc Kraków: Dom Wydawniczy “Rafael”, poliziotto. 2004. ISBN 8389431351 Importa titolo nel progetto Citavi in base a questo ISBN
J. Stala, Anna Kawa. Z Jezusem szczęśliwi codziennie : Ewangelie dni powszednich. T. 4, Wielki Post i Wielkanoc Kraków: Dom Wydawniczy “Rafael”, poliziotto. 2004. ISBN 8389431564 Importa titolo nel progetto Citavi in base a questo ISBN
J. Stala, Anna Kawa. Z Jezusem szczęśliwi codziennie : Ewangelie dni powszednich. T. 5, Wielki Post i Wielkanoc Kraków: Dom Wydawniczy “Rafael”, poliziotto. 2004. ISBN 8389431599 Importa titolo nel progetto Citavi in base a questo ISBN
Articoli in inglese
J. Stala. Alla scoperta di Dio con i bambini con l’aiuto dei libri di religione in un contesto polacco. in Comunicazione simmetrica? Filosofia e teologia nelle aule di tutta Europa, red. F. Kraft, H. Roose, G. Büttner, Rehburg-Loccum 2011, p. 49-59.
E. Osewska, J. Stala. Esigenza etica di un’autentica fraternità radicata nella Bibbia. in Biblia a etika: etické dimenzie správania, rosso. D. Hanesová, Banská Bystrica 2011, gmg. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela w Banská Bystrica, p. 134-139.
J. Stala. Educazione religiosa / Catechesi in famiglia: una prospettiva psicologica ed ecclesiale di base. in Educazione religiosa / Catechesi in famiglia. Una prospettiva europea, red. E. Osewska, J. Stala, Warszawa 2010, wyd. UKSW, p. 49-57.
J. Stala, E. Osewska. Aspetti sociologici dell’educazione religiosa familiare in Polonia. in Educazione religiosa / Catechesi in famiglia. Una prospettiva europea, red. E. Osewska, J. Stala, Warszawa 2010, wyd. UKSW, p. 167-177.
E. Osewska, J. Stala: Educazione religiosa / Catechesi nella famiglia. Una prospettiva europea. UKSW, Warszawa 2010.
Lezioni di J. Stala in inglese
Charles University di Praga / Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, Katedra pastorálních oborů, Praga, 12 settembre 2012, conferenza scientifica internazionale The Powerful Learning Environments: Religious Education in the post-modern reality and Modern Family Catechesi
Facoltà di Pedagogia Università Mateja Bela w Banská Bystrica, 1 marzo 2011, Conferenza Internazionale: Bibbia ed Etica: Dimensioni Etiche del Comportamento: Bisogno Etico di una Fraternità Autentica radicata nella Bibbia
L’ Università Cattolica di Ružomberok /Katolícka Univerzita v Rużomberku, 28 febbraio 2011: Modelli di educazione moderna
Università Carlo di Praga/ Univerzita Karlova v Praze, 10 aprile 2010: Come possiamo trovare Dio con l’aiuto dei libri di educazione religiosa?
Charles University di Praga/ Univerzita Karlova v Praze, 8 aprile 2010: Formazione cristiana moderna
Univerza v Ljubljani / Università di Lubiana , 25 marzo 2010: Problemi selezionati della gioventù moderna: con particolare attenzione alla formazione del gruppo
Univerza v Ljubljani / Università di Lubiana, 25 marzo 2010, Conferenza internazionale: Educazione religiosa e catechesi in Europa con particolare attenzione a Polonia, Inghilterra e Slovenia: Educazione religiosa e catechesi in Polonia
L’Università Cattolica di Ružomberok/Katolícka Univerzita v Rużomberku, 23 marzo 2010: Accompagnare i giovani nel processo della loro formazione
L’Università Cattolica di Ružomberok/Katolícka Univerzita v Rużomberku, 22 marzo 2010: Modelli di educazione moderna
Rehburg – Loccum (nei pressi di Hannover), Germania, 6-9 settembre 2009, Conferenza internazionale: Teologizzare con i bambini: come troviamo Dio con i bambini con l’aiuto del programma di educazione religiosa?
Articoli in tedesco
J.Stala. Der Mensch als Person: Die bestimmende Grundlage für Johannes Paul II. in seinem Bild von der Familie in “La persona e le sfide” 2 (2012) n. 2, p. 41-59.
J.Stala. Die Transzendenz als bestimmendes Merkmal der Person in der Anthropologie und der Pädagogik Johannes Pauls II. in “La persona e le sfide” 2 (2012) n. 1, p. 61-75.
J.Stala. Die personalistische Grundlage für Erziehung und Bildung in der katholischen Schule in “Angelicum” 88 (2011), p. 997-1007.
J.Stala. Ausgewählte Aspekte von Erziehung und Bildung an der katholischen Schule in “Angelicum” 88 (2011), p. 751-761.
J.Stala. Impulso Giovanni Paolo II. zur Religionserziehung in der Familie in „Studia Bobolanum“ 4 (2011), p. 153-163.
J.Stala. Die Religionserziehung in der Familie im Kontext der Gegebenheiten in Polen in „Biuletyn Edukacji Medialnej” (2011) No. 1, p. 173-183.
J.Stala. Wie schön ist es, in der Reichweite des Wortes Gottes und der Eucaristia zu leben. Eine Betrachtung zur eucharistischen Bildung der jungen Menschen in „Theologica” 46 (2011) 2, p. 311-322.
J. Stala. Internet – Chiesa – Comunicazione in „Studia Pastoralne” (2011) n. 7, p. 566-574.
J.Stala. Aspekte der Aktivitäten der akademischen Mitarbeiter an der Theologischen Fakultät, Sektion Tarnów, im Dienst der Wissenschaft. in “La persona e le sfide” 1 (2011) n. 2, p. 11-19.
J.Stala. Die Person und die Herausforderungen der Gegenwart im Licht der Nachfolge und der Lehre des Heiligen Vaters Johannes Pauls II “La persona e le sfide” – ein internationales wissenschaftliches Periodikum. in “La persona e le sfide” 1 (2011) n. 1, p. 13-23.
J.Stala. Grundlagen der Religionserziehung in der Familie im Kontext zu den Gegebenheiten der heutigen Zeit. “Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” (2010) n. 30, p. 263-272.
J.Stala. Implicazioni pedagogiche-catechetiche aus den Anregungen Johannes Pauls II. per la formazione sacrale. Riforma del ginnasio Zehn Jahre in Polonia. “Studia Bobolanum” (2010) n. 4, p. 155-167.
J.Stala. Lehrpläne und Schulbücher für den Religionsunterricht an den Staatlichen Grundschulen in Polen. “Bogoslovni vestnik” 70 (2010) n. 3, pag. 405-414.
J.Stala. Last uns voller Hoffnung vorwärts gehen. Pädagogisch-katechetische Aspekte, wie der Christ die Zeichen der Zeit in der gegenwärtigen Welt aufnimmt. „Roczniki liturgiczne“ 1 (56) (2009), p. 435-447.
Altri argomenti su Alchetron
Riferimenti
Wikipedia di Józef Stala
(Testo) CC BY-SA
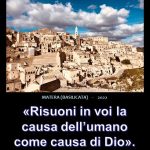
Lectio – Anno C
Prima lettura: Geremia 17,5-8
| Così dice il Signore: «Maledetto l’uomo che confida nell’uomo, e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un tamarisco nella steppa; non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. Benedetto l’uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d’acqua, verso la corrente stende le radici; non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell’anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti». |
La sua salvezza è la sua fede in un Dio giusto giudice (12,1), che punisce il male e premia il bene. È l’assioma che si trova alla base della teologia deuteronomistica (cioè presente nel libro del Deuteronomio) di cui Geremia è un esponente. Tuttavia l’«uomo che confida nell’uomo» non è chiunque fa ricorso all’aiuto del proprio simile, ma l’israelita che vuole risolvere i suoi problemi nazionali e militari appoggiandosi agli stranieri invece che a JHWH.
Le alleanze con i popoli vicini, assiri, babilonesi, egiziani, non sono mai state ben viste dai profeti, quindi neanche da Geremia, perché sottindendevano una carenza di fede nel Dio dei padri, colui che li aveva sottratti, con braccio potente, dalla schiavitù egiziana e aveva messi nelle loro mani i cananei.
Il discorso si fa più ampio nella contrapposizione tra l’agire secondo la carne e l’agire secondo lo spirito. La «carne» nella tradizione biblica designa la fragilità creaturale dell’uomo. Vivere o agire secondo la carne significa seguire gli istinti dell’egoismo o dell’orgoglio più che la voce di Dio e la sua volontà. In altre parole è dare spazio alle scelte più facili, di comodo, che soddisfano più la passione che la ragione.
Se l’«uomo» non sa lasciarsi guidare dallo Spirito di Dio, sono le conseguenze del suo agire carnale che dovrebbero portarlo al ravvedimento, i castighi che l’hanno colpito o stanno per colpirlo. I buoni suggerimenti, le riflessioni sapienziali non valgono sempre a cambiare l’uomo, ma il bene e il male che consegue il suo agire dovrebbero portarlo a resipiscenza. È quanto il profeta si augura.
Il richiamo alle conseguenze del ricordo e della dimenticanza di Dio può essere opportuno ma non gli si può dare un peso sicuro, poiché molte volte la «maledizione» non cade sempre sugl’iniqui, né la «benedizione» raggiunge solo i buoni. La fede non è un calcolo matematico.
Seconda lettura: 1Corinzi 15,12.16-20
| Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto; ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. |
L’apostolo si è appellato alle prove storiche, ai testimoni cioè della risurrezione di Gesù (vv. 3-11), ora fa ricorso anche alle ragioni teologiche. La risurrezione è la garanzia unica ed esclusiva non tanto della credibilità di Gesù Cristo, quanto della validità della sua missione ovvero della sua azione redentiva. Se egli non fosse risorto non solo non avrebbe dato la giusta prova di quello che aveva predicato, ma non avrebbe dimostrato e avviato il processo di rigenerazione e di rinascita di quelli che muoiono. Se ciò fosse vero non c’è futuro, non c’è speranza di una vita nuova in quelli che hanno chiuso l’esperienza terrestre.
L’argomentazione di Paolo è tuttavia più complessa poiché concepisce la morte di Cristo come un sacrificio di espiazione per i peccati dell’umanità. Egli è il capro che porta su di sé i peccati di tutti (cf. Rm 3,21-28) come Giovanni dice che è l’agnello che toglie i peccati del mondo (1,29).
La risurrezione prova che Gesù è entrato nel mondo di Dio, quindi ha offerto al Padre il risarcimento che aspettava dagli uomini e da lì ora attende quelli che hanno creduto in lui. È evidente che se non fosse risorto, né lui né i suoi seguaci sarebbero mai entrati nel regno della vita, non sarebbero quindi salvi.
La risurrezione è, si può dire, un termine convenzionale, equivalente a continuità nell’esistenza. Gesù risorto significa che egli vive, non è nel regno dei morti, ma dei vivi. Solo che è un trapasso senza prove, senza verifiche; si può accettare affidandosi alla parola di Dio trasmessa da Gesù Cristo.
Gesù è la primizia dei dormienti (v. 20), il primogenito tra molti fratelli (Rom 8,29), ma se non si è verificato in lui il trapasso nella nuova vita, non si verificherà in nessuno, nemmeno in quelli che vivono con tale fede in lui. Anzi questi che coltivano tali illusioni, accanto a privazioni e sacrifici di ogni genere, sono alla fine da compiangere più degli altri. L’apostolo nemmeno accetta queste supposizioni e chiude ogni possibile riserva riaffermando categoricamente la sua fede nella risurrezione (v. 20).
Vangelo: Luca 6,17.20-26
| In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne. Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti». |
Esegesi
Il brano di Lc 6,20-26 è parallelo a Mt 5,1-12. Si tratta in entrambi i casi di un grande discorso programmatico di Gesù, solo che nel primo caso esso è tenuto «in un luogo pianeggiante», nel secondo «su un monte». In Matteo Gesù apre la sua predicazione, per Luca invece l’ha aperta nella sinagoga di Nazaret (4,18-22), ma con un annunzio che è identico a quello del discorso della montagna o in pianura. Anzi è più esplicito e forse più genuino.
«Lo Spirito di Dio è su di me» per questo mi ha inviato ad evangelizzare i poveri, a liberare i carcerati, gli oppressi, a guarire i ciechi, a proclamare l’anno di grazia del Signore (cf. Is 61,1-2; Lc 4,18-22).
La «buona notizia» che i poveri attendono è che la loro infelice condizione abbia a finire, non in un giorno che nessuno sa quale, ma presto, subito, si può aggiungere. «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che avete udito», dichiara Gesù ai suoi concittadini che l’ascoltano sbigottiti e offesi (4,20,28).
La povertà non è un bene che Dio ha contemplato nel suo disegno creativo; è addirittura un male, una carenza, come tale è la malattia e qualsiasi altro ostacolo che intralcia il cammino dell’uomo, destinata a scomparire. L’era messianica doveva segnare l’avvio di una siffatta realizzazione, insieme a un rinnovamento dei rapporti dell’uomo con Dio.
Il giardino delle origini (Gen 2) era per Gesù il regno dei cieli o di Dio di cui era arrivata la realizzazione.
Il programma di Gesù guarda a tutto l’uomo, al suo corpo come al suo spirito, ai rapporti con Dio ma anche con i propri simili; abbraccia tutto e tutti senza escludere nessuno, ma le sue attenzioni, quasi le sue preferenze, vanno agli umili, ai piccoli, agli indigenti, ai malati, in una parola ai «poveri», perché ne hanno più bisogno.
Anche i messi del Battista gli chiedono di qualificarsi: «Sei tu colui che deve venire o un altro?». Egli non fa che rispondere appellandosi alle stesse parole del profeta Isaia (61,1-2;26,19;29,18;35,5) e anche qui la risposta è: «I poveri sono evangelizzati» e accanto ad essi sono i ciechi, i lebbrosi, gli storpi, i sordi. In questo senso Gesù si proclama il salvatore degli uomini più che dei propri connazionali. I figli di Abramo attendono prima di tutto l’affrancamento dal giogo straniero che pesa sulle loro spalle da circa sei secoli (dal 587 a. C.), ma Gesù guarda alle aspirazioni e aspettative di tutti gli uomini: tutti egualmente figli dello stesso comune padre.
Egli è un israelita, ma la sua missione supera i confini d’Israele, come materialmente li sta superando nel corso della sua predicazione. Il suo sogno è arrivare a una convivenza tra ebrei, samaritani, fenici, greci e romani, in un regno di piena, perfetta giustizia e pace.
Il «primato» d’Israele o di qualsiasi altro popolo, come di un uomo sull’altro, è sempre satanico perché nasce dal desiderio di sopraffazione non dallo Spirito di Dio di cui egli si sente ricolmo (Lc 4,18; 1,35:3,22).
Gesù è un profeta non un dottore della legge e meno ancora uno stratega; egli cerca di aiutare gli uomini a scoprire i disegni di Dio nascosti nelle profondità del loro cuore o che si esplicano nel corso della storia.
Il messaggio che ha lasciato ai suoi ascoltatori è troppo insolito, ardito per essere subito capito ed accettato dai suoi stessi seguaci, per questo con il passare del tempo ne tentano una loro reinterpretazione. I vangeli registrano quella delle chiese di Marco e Matteo, di Luca e Giovanni.
I «poveri» da evangelizzare per Matteo sono i poveri in spirito». Essi non sono da beatificare, ma sono già beati. Nella comunità cristiana per vivere in pace, felici, occorre essere umili, spogliare «lo spirito», ossia il proprio io, da eventuali rivendicazioni, dagli stessi personali diritti. Bisogna saper tacere, anche subire; è questa la miglior medicina per risol-vere le conflittualità comunitarie, per convivere con gli altri, soprattutto con i prepotenti, i facinorosi, gli ottusi: i ricchi di spirito.
Luca invece rilegge il messaggio dell’evangelizzazione dei poveri in chiave, più che ecclesiale, cristiana. Gesù ha aperto il discorso in pianura davanti a una «gran moltitudine di gente» (v. 17), ma quando deve cominciare il proclama inaugurale restringe la sua prospettiva. «Alzati gli occhi verso i suoi discepoli» (v. 20) e «diceva» (ivi). L’imperfetto («diceva») non è casuale; vuol sottolineare che si tratta di un discorso ripetuto più di una volta, con una certa intenzionalità e insistenza. Si trattava di una proposta di Luca più che di Gesù che ai suoi ascoltatori non appariva troppo evidente.
Il messaggio originario di Gesù ha subito in Luca due gravi modifiche. I «poveri», senza distinzione, a cui si riferiva Isaia e di cui si parlava nel programma di Nazaret (4,18-22) e nella risposta ai messi del Battista, sono diventati i poveri discepoli di Gesù, in una parola i cristiani che sono oggetto di persecuzioni, confisca di beni, esilio; per questo hanno fame, soffrono, piangono.
Le promesse di Gesù non solo non si erano attuate, ma avevano provocato ai fedeli disagi e sofferenze. A questi credenti che sono in crisi per la loro fede Luca offre una rilettura del messaggio delle beatitudini spostandone la realizzazione.
Gesù nella sinagoga di Nazaret parlava di «oggi»; Luca crede forse ancora a questa perentorietà, ma preferisce spostare l’obiettivo in un tempo successivo e, alla fine, nel mondo dell’al di là.
Nella mente di Gesù il «regno dei cieli» era la realizzazione delle promesse messianiche e, come il progetto originario, prendeva avvio fin da questa terra. L’evangelista sembra saltare la fase terrestre, come farà Matteo nel discorso escatologico (25,31-46) e si porta senz’altro a quella del cielo.
Il contrasto non è tra il ieri e l’oggi, il passato e il presente, ma tra l’oggi e il domani, tra il presente e il futuro, tra il mondo attuale e quello avvenire. «Ora» avete fame, ora piangete, siete messi al bando, ma un giorno o in quel giorno, in definitiva «nei cieli», sarete saziati, riderete, vi rallegrerete, esulterete.
La vita terrestre, anche quella del cristiano, soprattutto quella del cristiano, è segnata, oltre che dalla povertà, da ingiustizie, persecuzioni, sofferenze, e la risposta che l’evangelista propone è la pazienza, la rassegnazione, nell’attesa di vedere rivalutati i diritti conculcati, in un giorno che nessuno sa qual è e nessuno sa quando verrà, ma la fede assicura che
verrà certamente.
Se poi potesse essere di conforto ai perseguitati, l’evangelista Luca, solo lui, si affretta a delineare il rovesciamento che subirà la sorte dei persecutori. E riporta quattro «Vae» (guai) o maledizioni, poste in bocca a Gesù, contro i ricchi, i sazi, quelli che ridono, che sono beati.
La storia si rovescerà; gli infelici saranno felici e i gaudenti saranno afflitti. È il mutamento che prevede il Magnificat, anch’esso un brano del Vangelo di Luca (1,46-56). La stessa cosa avverrà secondo Matteo, nel «giudizio universale»: i «benedetti» finiranno nel regno del padre, i «maledetti» nel fuoco eterno (25,34,42).
La legge del taglione vale anche nel mondo di Dio e ad applicarla è lo stesso Padre che, secondo le parole di Gesù, è capace di perdonare somme spropositate (Mt 18,27) ed è sulla soglia di casa ad aspettare ansioso il ritorno del figlio che si era smarrito (Lc 15,20).
Meditazione
La Liturgia della parola ci introduce in questa domenica nel capitolo sesto di Luca, dove incontriamo il cosiddetto Discorso della pianura, che nel terzo evangelo corrisponde, sia pure in un gioco di somiglianze e differenze, a quello che in Matteo è il Discorso della montagna. L’ambientazione è infatti diversa. Matteo fa parlare Gesù dall’alto di un monte, anzi del monte, perché non è un luogo generico, ma ben determinato, che simbolicamente evoca il Sinai, il monte su cui Mosè riceve le Dieci parole dell’Alleanza. Luca, invece, introduce il discorso precisando che Gesù, disceso con i Dodici, «si fermò in un luogo pianeggiante» (v. 17). I versetti precedenti di questo capitolo sesto, che il lezionario liturgico omette, narrano infatti che Gesù si era recato sul monte a pregare, e dopo aver passato tutta la notte in preghiera chiama a sé i discepoli scegliendone dodici, «ai quali diede anche il nome di apostoli» (v. 13). Il primo frutto della preghiera di Gesù sembra dunque essere la cosiddetta istituzione dei Dodici. Anche il Discorso della pianura pare, nella trama narrativa che l’evangelista intesse, affondare le sue radici in questa notte di preghiera solitaria. Gesù scende dal monte e inizia a parlare, aprendo il suo discorso con la grande proclamazione delle quattro beatitudini, alle quali rispondono i quattro guai.
Con questo simbolo spaziale della ‘discesa’, Luca sembra suggerirci che la pagina delle beatitudini che oggi ascoltiamo sono una parola che discende verso di noi, ci raggiunge e ci consola nei molti luoghi delle nostre povertà e delle nostre afflizioni, consentendoci di gustare quella gioia e quella pienezza di vita che provengono dall’alto, da Dio, che in Gesù è disceso verso di noi. Val la pena sottolinearlo: la proclamazione delle beatitudini germina e matura nell’intimità della relazione con il Padre che Gesù vive nella sua preghiera. Rimanendo in questo rapporto con il Padre, Gesù può comprendere più profondamente il suo modo di agire verso gli uomini, e specialmente verso i poveri, gli affamati, gli afflitti, i perseguitati.
È bene precisarlo subito: nella visione di Gesù, che tanto Matteo quanto Luca ci tramandano sia pure con accenti differenti, le beatitudini, prima ancora che essere una descrizione di come gli uomini debbano agire, verso Dio e verso gli altri, sono una rivelazione del modo di essere e di agire del Padre che è nei cieli. La struttura stessa delle beatitudini ce lo ricorda. È nel terzo elemento di ciascuna beatitudine, introdotto dal ‘perché’, che la gioia trova il suo fondamento e la sua ragion d’essere, e questo ‘perché’ fa sempre riferimento a un’azione di Dio, espressa con un verbo coniugato al passivo, che allude all’agire del Padre senza nominarlo esplicitamente. Ma è lui che dona il suo regno ai poveri, che sazia chi ha fame, che consente di ridere a chi piange, che offre nella gioia e nell’esultanza una ricompensa a chi ora è odiato, insultato, disprezzato a motivo della sua fede nel Figlio dell’uomo.
Quando Dio scende verso di noi, entra nella nostra storia, non rimane neutrale, prende posizione, e se certo il suo amore è universale, conosce comunque una predilezione, quella per i poveri e per tutti coloro che non hanno nessuno che si prenda cura della loro vita e del loro bisogno, che assuma la difesa del loro diritto ingiustamente conculcato, che offra consolazione alla loro afflizione. Se nessun altro lo fa, ecco Dio che si schiera dalla loro parte e dona una gioia che altrimenti sarebbe loro negata. Al contrario, coloro che cercano da soli, in modo autonomo e autosufficiente, una forma compiuta e felice per la propria vita, confidando nell’opera delle proprie mani, si espongono al rischio di rimanere delusi, di ritrovarsi a mani vuote. Ora ridono, confidando in se stessi, ma piangeranno, ora sono sazi, ma patiranno la fame. È questo il senso dei ‘guai’ che in Luca seguono immediatamente la proclamazione dei ‘beati’. Non vanno intesi alla stregua di una minaccia, di un giudizio o peggio di un castigo. Sono piuttosto un avvertimento profetico, attraverso il quale Gesù mette in guardia coloro ripongono la propria fiducia in se stessi. Geremia descrive questo loro atteggiamento nella prima lettura:
Maledetto l’uomo che confida nell’uomo,
e pone nella carne il suo sostegno,
allontanando il suo cuore dal Signore (Ger 17,5).
Al contrario,
Benedetto l’uomo che confida nel Signore
e il Signore è la sua fiducia (v. 7).
Come ricorda anche il Salmo 1, cantato quale responsorio, siamo posti di fronte a due vie, a due modi contrapposti di orientare la nostra esistenza: la possiamo fondare nell’attesa confidente di ciò che Dio farà per noi, realizzando la sua promessa; oppure possiamo fondarla su noi stessi e sulle nostre ricchezze. Questa è la differenza fondamentale tra i poveri, proclamati beati, e i ricchi, ai quali è indirizzato il primo ‘guai’. Più che giudicare o punire il loro atteggiamento, Gesù intende metterli in guardia circa il pericolo della ricchezza, che nella visione di Luca è sempre iniqua, disonesta. Lo è perché non mantiene la parola data; ci fa balenare davanti agli occhi una promessa di felicità che non riuscirà a realizzare. La fame che colpirà chi ora è sazio, o il pianto che affliggerà chi ora ride, non sono da intendersi alla stregua di una sorta di castigo divino, che piomberebbe su di loro dall’alto, improvvisamente; sono piuttosto l’esito del venir meno di una promessa infondata, illusoria, come accade all’uomo che costruisce la sua casa sulla terra, senza fondamenta, anziché fondarla sulla roccia (cfr. Lc 6,48-49): la casa crolla, e chi aveva riposto in essa tutta la propria gioia si ritroverà nel pianto, nell’afflizione, senza ricompensa e senza consolazione. È significativo che tanto in Matteo il Discorso della montagna, quanto in Luca il Discorso della pianura, si aprano con le beatitudini e si concludano con la parabola dei due costruttori. La beatitudine appartiene a chi costruisce la sua vita sulla roccia della confidenza nel Signore; i guai ammoniscono invece circa il pericolo che si corre costruendo la propria vita
sulla sabbia. Costruisce sulla sabbia di chi ripone in se stesso la propria fiducia e il proprio sostegno, «allontanando il suo cuore dal Signore» (cfr. Ger 17,5-7).
Don Bosco commenta il Vangelo
Sesta domenica del tempo ordinario
Don Bosco ammonisce i ricchi
Le parole del Vangelo contro i ricchi egoisti non hanno lasciato don Bosco indifferente. Le ha citato parecchie volte, specialmente quando parla del dovere dell’elemosina.
Nel racconto intitolato Angelina o l’orfanella degli Appennini, don Bosco riporta la domanda che Angela fece al padre amante della ricchezza: “Gli domandai come intendesse quelle altre parole del Vangelo: Guai ai ricchi”. Il padre rispose per giustificarsi: “Queste cose, egli disse, bisogna che si studino, si sappiano, ma non fermarcisi troppo sopra, altrimenti fanno perdere la pace del cuore, anzi farebbero dare la volta al cervello se uno di troppo se ne desse pensiero”.
Agitata dal pensiero delle difficoltà che ha un ricco per potersi salvare, Angelina si reca poi da un sacerdote che le spiega le parole di Gesù in questo modo:
Le ricchezze sono vere spine e sorgente infausta di pericoli nella via della salvezza, e ciò pel grande abuso che per lo più se ne fa: spese inutili, viaggi inopportuni, intemperanze, balli, giuochi, oppressione dei deboli, fraudazioni della mercede agli operai, appagamenti di passioni indegne, liti ingiuste, odio, rabbia e vendette, ecco il frutto che molti raccolgono dalle loro ricchezze. Per costoro le sostanze temporali sono un gran rischio di perversione spirituale, e di costoro appunto disse il Salvatore: Guai ai ricchi. […] Ma coloro che fanno buon uso delle ricchezze […] hanno un mezzo di salvezza nella loro sostanza temporale, e sanno cangiar le ricchezze, che sono vere spine, in fiori per l’eternità (OE22 44ss).
Quando don Bosco chiedeva l’elemosina, “più che le argomentazioni teologiche potevano in tema di elemosina gl’imperativi e le minacce del Vangelo contro i ricchi”. Diceva:
Vissi tra i poveri ed ebbi pure da frequentare i ricchi. In generale io ho visto che si fa poca elemosina, e che molti signori fanno poco buon uso delle loro ricchezze. Nessuno può immaginarsi come il Signore chiederà stretto conto di quanto ha loro dato, perché si adoperasse a benefizio dei poveri.
A queste parole il suo biografo annota che don Bosco “sapeva pure come in ogni caso l’aver il cuore attaccato ai beni della terra sia di per sé un gran male, che impedisce tanti favori celesti, a cui potrebbero essere connesse la preservazione dal peccato, la grazia del pentimento e la perseveranza finale. Onde quel suo amore per le anime, che gl’ispirava eroici sacrifizi a pro della gioventù materialmente e spiritualmente bisognosa, gl’infondeva anche il non sempre piacevole coraggio d’ammonire i ricchi che dessero con larghezza” (MB15 528).
Secondo il suo biografo don Bosco “non mai adulava i ricchi o quelli posti in dignità; anzi dava loro, a tempo e luogo, ammonizioni e consigli” (MB5 324). In un discorso ai cooperatori salesiani don Bosco denunciava con forza le conseguenze della mancanza di carità da parte di chi poteva aiutare i poveri:
Coll’avarizia, coll’interesse, colla spilorceria, colla durezza di cuore, mentre lasciano crescere tanti malfattori in mezzo alle vie, mentre lasciano languire tante famiglie nel fondo della miseria e le mettono come nella dura necessità di provvedersi per forza ciò, che vien loro negato per carità, si fanno eziandio mal volere e odiare e in un subbuglio saranno essi i primi a pagarla. E poi che avverrà? In un giorno, forse non lontano, si avvereranno anche quaggiù i guai pronunziati da Gesù Cristo […] contro i ricchi senza cuore: Guai a voi, o ricchi (MB15 792).
Nel suo Cattolico provveduto leggiamo questa preghiera di un ricco pubblico impiegato che cerca altrove la vera felicità:
Voi avete voluto nascere povero sulla terra, e vivere fra ogni sorta di umiliazioni, e se a voi non piacque che in questo io vi rassomigliassi, deh! fate almeno che io nutra al pari di voi sentimenti di disprezzo per le grandezze di quaggiù, e non sia pure contro di me pronunziata quella terribile sentenza: Infelici i ricchi! infelici quelli che hanno le loro gioie su questa terra! (OE19 649).
(Morand Wirth)
Tra parentesi il lettore troverà i riferimenti principali dei testi citati nelle opere di o su don Bosco: – nei 38 volumi delle Opere edite di G. Bosco (OE1-38, a cura del Centro Studi Don Bosco dell’Università Pontificia Salesiana); – nei 19 volumi delle Memorie biografiche di don G. Bosco (MB1-19, a cura di G.B. Lemoyne, A. Amadei e E. Ceria); – nelle sue Memorie dell’Oratorio (MO, a cura di A. Giraudo); – nei 10 volumi del suo Epistolario (E1-10, a cura di F. Motto). La seconda cifra indica la pagina del volume.
L’immagine della domenica
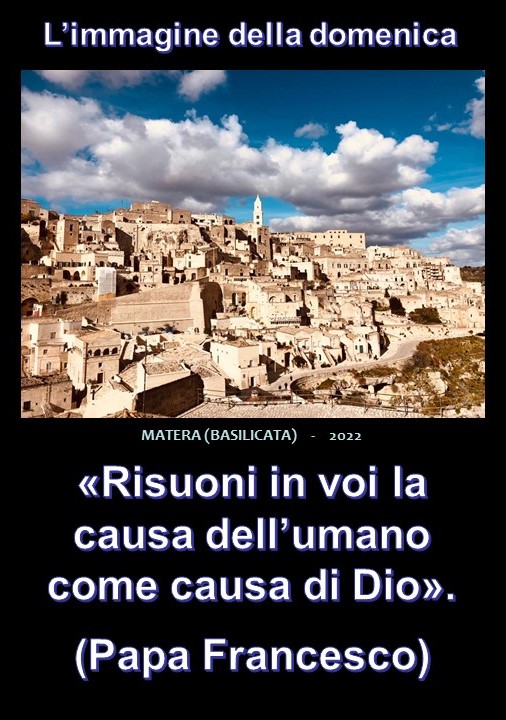
«Risuoni in voi
la causa dell’umano come causa di Dio».
(Papa Francesco)
Preghiere e Racconti
BEATI quelli che sanno ridere di se stessi:
non finiranno mai di divertirsi.
BEATI quelli che sanno distinguere
un ciottolo da una montagna:
eviteranno tanti fastidi.
BEATI quelli che sanno ascoltare e tacere:
impareranno molte cose nuove.
BEATI quelli che sono attenti
alle richieste degli altri:
saranno dispensatori di gioia.
BEATI sarete voi se saprete
guardare con attenzione le cose piccole
e serenamente quelle importanti:
andrete lontano nella vita.
BEATI voi se saprete apprezzare un sorriso
e dimenticare uno sgarbo:
il vostro cammino sarà sempre pieno di sole.
BEATI voi se saprete interpretare
con benevolenza gli atteggiamenti degli altri
anche contro le apparenze:
sarete giudicati ingenui,
ma questo è il prezzo dell’amore.
BEATI quelli che pensano prima di agire
e che pregano prima di pensare:
eviteranno certe stupidaggini.
BEATI soprattutto voi che sapete riconoscere
il Signore in tutti coloro che incontrate:
avete trovato la vera luce e la vera pace.
Il nostro campo è invaso dall’ingiustizia. Tutte le risposte del mondo all’ingiustizia sono violenza attiva o consentita. Opporvi la dolcezza del Cristo è scandalo.
Chi può misurare il coraggio richiesto a coloro che accettassero questo scandalo della mitezza? Ma c’è scandalo più grande – ed autentico, questo – dello scandalo dei cristiani che hanno lasciato a un Gandhi la responsabilità di levare nel mondo una massa di uomini che si affidavano alla forza incoercibile di quella mitezza?
E tuttavia, ancora una volta, non c’è scelta. Il Cristo “mite ed umile di cuore” è un fatto. Non possiamo né rettificarlo né adattarlo.
(Madeleine DELBRỆL, Noi delle strade, Milano, Gribaudi, 2008, 123).
Non si deve contrarre la misericordia secondo la moda del giorno. Bisogna che la presa di coscienza della infelicità economica delle masse non ci trascini a sprezzare altre forme di infelicità, a disinteressarci di queste.
La misericordia del Cristo per i poveri si inserisce in una misericordia tanto vasta quanto tutte le infelicità umane. È misericordia verso i peccatori, misericordia verso gli ammalati, misericordia verso tutti coloro che piangono i loro morti, misericordia verso i prigionieri, misericordia verso tutto ciò che è piccolo.
A motivo di una nozione materializzata della povertà si rischia assai spesso di dimenticare che vi sono altri poveri che non gli economicamente poveri, altri piccoli che non il proletariato. Vi sono ammalati morali o psicologici. Poveri di doni, di attrattive, di amore. Accanto alle classi oppresse vi sono gli “inclassificabili”.
I poveri e i piccoli non sono soltanto nel proletariato. Ed il proletariato stesso non è composto esclusivamente di militanti, quei militanti ricchi già di una speranza, di una ricchezza di cuore, di una formazione spirituale.
Il cuore del Cristo, neppure lui può essere rettificato: è di tutti, ed è a tutti che dobbiamo darlo.
Questo amore personale del Cristo “chiama ciascuno con il suo nome”, non chiama una categoria. Conosce ciascuno “come il Padre conosce il Figlio”.
Dobbiamo ritrovare quest’amore personale di qualcuno verso qualcuno. Quest’amore è mutilato dalle definizioni “sociali” che attacchiamo sui nostri fratelli ed in base a quella che diamo di noi stessi. Noi non sappiamo più incontrarci come un uomo incontra un uomo nella sua semplicità individuale. Non sappiamo più chiamarci per nome.
(Madeleine DELBRỆL, Noi delle strade, Milano, Gribaudi, 2008, 125-126).
«Il Mahatma Gandhi, padre dell’India moderna e apostolo della non-violenza, ricordando il suo primo incontro con il “discorso della montagna”, diceva che gli era andato dritto al cuore: “The Sermon on the Mount went straight to my heart…”. E aggiungeva: “È stato grazie a questo discorso che ho imparato ad amare Gesù”. Questa testimonianza mostra in maniera eloquente come la lettura dei capitoli 5-7del Vangelo di Matteo possa essere decisiva per l’incontro col Profeta galileo e il suo messaggio. Si può perfino dire che la storia delle interpretazioni del discorso della montagna è la storia delle diverse auto-comprensioni del cristianesimo».
(Mons. Bruno FORTE, Il discorso della montagna e il dialogo ebraico-cristiano, dialogo pubblico con il biblista ebreo americano Jacob Neusner, 18 GENNAIO 2010).
Fra i dieci gruppi in cui si possono distribuire e raccogliere le diverse beatitudini bibliche, uno solo riguarda il possesso dei beni materiali. È la beatitudine di un padre che, per merito della fecondità della moglie, si trova provvisto di un certo numero di figli, sani e robusti, e che, perciò, passa onorato e riverito tra la gente della sua città. Ma altre beatitudini di ordine materiale non esistono. Né i ricchi, né i potenti, dominatori, eroi, né, molto meno, i gaudenti, fecero parte, direttamente, per le beatitudini bibliche, del numero dei beati. Anche la ricchezza, certamente, rientrò nella visione biblica antico-testamentaria, tra i beni desiderabili per la vita di ogni uomo. La povertà e l’indigenza non ebbero mai buona accoglienza. A differenza, però, delle beatitudini sia egiziane che greche, le beatitudini bibliche non credettero mai che la ricchezza, da sola, bastasse a dare felicità. E neppure, quindi, la gloria, la potenza, il prestigio.
Anche questi, certamente, apparvero e furono stimati beni altamente desiderabili. Ma non vennero ritenuti affatto costitutivi della felicità umana. Furono cioè dei beni integrativi, ma non costitutivi.
Servendoci, quindi, di questa distinzione fra beni costitutivi e beni integrativi, l’unico grande bene costitutivo non fu, in realtà, secondo nove dei dieci gruppi di beatitudini, che Dio; ovvero, meglio, il possesso, da parte dell’uomo, di tutti gli atteggiamenti più genuini e autentici verso la realtà divina: la fede in un unico Dio (gruppo I); piena confidenza e speranza nella sua azione salvifica (II); rispetto profondo, timore e amore (III); umile confessione delle proprie colpe e desiderio di perdono (IV); stima e attiva partecipazione all’incremento del culto e la liturgia del tempio (V); attento sguardo sapienziale e attento ascolto alla presenza di Dio nel mondo e nella storia (VI); stima della Legge come riflesso e testimonianza della manifestazione dell’azione salvifica di Dio (VII); rispettoso comportamento verso l’ordine della giustizia (VIII); e, infine, umile accettazione anche di una qualche menomazione fisica, di uno stato di sofferenza (X).
Siamo, quindi, come si vede, di fronte a un complesso di atteggiamenti religiosi, per i quali l’uomo, consapevole delle sue incapacità, limitatezze, non si chiude orgogliosamente in se stesso, ma riconosce che solo in Dio trova la sua completezza.
(A. MATTIOLI, Beatitudini e felicità nella Bibbia d’Israele, Prato 1992,542s.).
«Cari amici, la Chiesa oggi guarda a voi con fiducia e attende che diventiate il popolo delle beatitudini”. “Beati voi, afferma il papa, se sarete come Gesù poveri in spirito, buoni e misericordiosi; se saprete cercare ciò che è giusto e retto; se sarete puri di cuore, operatori di pace, amanti e servitori dei poveri. Beati voi!”. E’ questo il cammino percorrendo il quale, dice il papa vecchio ma ancora giovane, si può conquistare la gioia, “quella vera!”, e trovare la felicità. Un cammino da percorrere ora, subito, con tutto l’entusiasmo che è tipico degli anni giovanili: “Non aspettate di avere più anni per avventurarvi sulla via della santità! La santità è sempre giovane, così come eterna è la giovinezza di Dio. Comunicate a tutti la bellezza dell’incontro con Dio che dà senso alla vostra vita. Nella ricerca della giustizia, nella promozione della pace, nell’impegno di fratellanza e di solidarietà non siate secondi a nessuno!”.
“Quello che voi erediterete”, continua il papa in quelle che sono parole sempre attuali, “è un mondo che ha un disperato bisogno di un rinnovato senso di fratellanza e di solidarietà umana. È un mondo che necessita di essere toccato e guarito dalla bellezza e dalla ricchezza dell’amore di Dio. Il mondo odierno ha bisogno di testimoni di quell’amore. Ha bisogno che voi siate il sale della terra e la luce del mondo. (…) Nei momenti difficili della storia della Chiesa il dovere della santità diviene ancor più urgente. E la santità non è questione di età. La santità è vivere nello Spirito Santo”.
Una scelta di vita, una scelta che dà senso, una scelta per vivere e testimoniare ciò che ogni cristiano sa: “Solo Cristo è la ‘pietra angolare’ su cui è possibile costruire saldamente l’edificio della propria esistenza. Solo Cristo, conosciuto, contemplato e amato, è l’amico fedele che non delude”.
(Giovanni Paolo II, a Toronto, nella GMG 2002).
Le beatitudini indicano il cammino della felicità. E, tuttavia, il loro messaggio suscita spesso perplessità. Gli Atti degli apostoli (20,35) riferiscono una frase di Gesù che non si trova nei vangeli. Agli anziani di Efeso Paolo raccomanda di «ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse: “Vi è più gioia nel dare che nel ricevere”». Da ciò si deve concludere che l’abnegazione sarebbe il segreto della felicità? Quando Gesù evoca ‘la felicità del dare’, parla in base a ciò che lui stesso fa. È proprio questa gioia – questa felicità sentita con esultanza – che Cristo offre di sperimentare a quelli che lo seguono. Il segreto della felicità dell’uomo sta dunque nel prender parte alla gioia di Dio. È associandosi alla sua ‘misericordia’, dando senza nulla aspettarsi in cambio, dimenticando se stessi, fino a perdersi, che si viene associali alla ‘gioia del cielo’. L’uomo non ‘trova se stesso’ se non perdendosi ‘per causa di Cristo’. Questo dono senza ritorno è la chiave di tutte le beatitudini. Cristo le vive in pienezza per consentirci di viverle a nostra volta e di ricevere da esse la felicità.
Resta tuttavia il fatto, per chi ascolta queste beatitudini, che deve fare i conti con una esitazione: quale felicità reale, concreta, tangibile viene offerta? Già gli apostoli chiedevano a Gesù: « E noi che abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che ricompensa avremo?» (Mt 19,27). Il regno dei cieli, la terra promessa, la consolazione, la pienezza della giustizia, la misericordia, vedere Dio, essere figli di Dio. In tutti questi doni promessi, e che costituiscono la nostra felicità, brilla una luce abbagliante, quella di Cristo risorto, nel quale risusciteremo. Se già fin d’ora, infatti, siamo figli di Dio, ciò che saremo non è stato ancora manifestato. Sappiamo che quando questa manifestazione avverrà, noi saremo simili a lui «perché lo vedremo così come egli è» (1 Gv 3,2).
(J.-M. LUSTIGER, Siate felici, Genova, 1998, 111-117 passim).
Signore Gesù Cristo,
custodisci questi giovani nel tuo amore.
Fa’ che odano la tua voce
e credano a ciò che tu dici,
poiché tu solo hai parole di vita eterna.
Insegna loro come professare la propria fede,
come donare il proprio amore,
come comunicare la propria speranza agli altri.
Rendili testimoni convincenti del tuo Vangelo,
in un mondo che ha tanto bisogno
della tua grazia che salva.
Fa’ di loro il nuovo popolo delle Beatitudini,
perché siano sale della terra e luce del mondo
all’inizio del terzo millennio cristiano.
Maria, Madre della Chiesa, proteggi e guida
questi giovani uomini e giovani donne
del ventunesimo secolo.
Tienili tutti stretti al tuo materno cuore. Amen.
(Preghiera del Papa, al termine della Giornata della Gioventù di Toronto).
9-15 febbraio
9. (B. Eusebia Palomino Yenes) – “Signor mio Gesù Cristo, per quelle cinque piaghe, che l’amore verso di noi vi fece in Croce, soccorrete ai vostri servi redenti col vostro preziosissimo Sangue” (OE2 319).
10. (S. Scolastica) – Una cugina di Don Bosco era “religiosa benedettina nella Badia di Pradines (Loire)” in Francia (MB17 893).
11. (B. Vergine Maria di Lourdes) – “In quest’anno [1858] un portentoso avvenimento aveva in tutto il mondo fatto risuonare la gloria e la bontà della celeste Madre e don Bosco l’aveva narrato più volte ai suoi giovani e più tardi ne consegnava alle stampe la relazione” (MB6 90).
12. “Vi sono, è vero, molte spine, ma tu con tante chiacchiere non sei buono a prendere il martello della pazienza e confidenza e romperne la punta?” (E5 235).
13. “Chi non si cura di acquistare questa eguaglianza e questa tranquillità di spirito non avrà mai con sé lo spirito del Signore” (OE3 325).
14. (Ss. Cirillo e Metodio) – “Abbiamo pranzato […] in compagnia di un vescovo slavo. […] Oh la carità cristiana lega in un sol vincolo le anime di tutto il mondo!” (MB8 699).
15. “Il cristiano deve trattare col suo prossimo, siccome trattava Gesù Cristo coi suoi seguaci: perciò i suoi trattenimenti devono essere edificanti, caritatevoli, pieni di gravità, di dolcezza e di semplicità” (OE8 21).
(Morand Wirth)
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
—
– COMUNITÀ DI S. EGIDIO, La Parola e la storia,Milano, Vita e Pensiero, 2012.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– M. FERRARI, «Oggi di è adempiuta questa scrittura». Avvento, Tempo di Natale e Tempo ordinario (prima parte), Milano, Vita e Pensiero, 2012.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.
—
– Immagine della domenica, a cura di García-Orsini-Pennesi.

Per la Domenica della Parola di Dio, che si celebra il 26 gennaio, l’Ufficio Catechistico, tramite il Servizio dell’Apostolato Biblico, l’Ufficio Liturgico, l’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro e l’Ufficio per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto hanno preparato un Sussidio per aiutare le comunità diocesane e parrocchiali a celebrare, riflettere e pregare su un tema che solo apparentemente riguarda il passato: il Giubileo.
L’obiettivo, sottolinea nella presentazione Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari e Segretario Generale della CEI, è “riscoprire nella meditazione della Parola di Dio il senso della libertà biblica e il fondamento solido della speranza che non delude”. “La parola d’ordine, che emerge anche dai testi di questo Sussidio, è libertà”, aggiunge Mons. Baturi evidenziando che “vari sono i soggetti che devono beneficiare di una rinnovata e forse insperata libertà nel tempo giubilare”. “Anzitutto – spiega – le persone: se qualcuno per varie ragioni è caduto in disgrazia ed è diventato schiavo, non deve restare tale per sempre. Viene il tempo in cui recuperare lo status di persona libera. Nessun errore o sciagura del passato sono da considerarsi definitivi. Ma anche la terra deve essere affrancata da ogni potenziale sfruttamento intensivo: astenersi periodicamente dalla semina significa allora ricordare ai proprietari terrieri che la terra è un dono di Dio e come tale va trattata”. Ecco allora che il Giubileo può essere “un tempo speciale, in cui porre gesti concreti di speranza per un futuro nuovo, rispettoso della dignità di tutte le creature di Dio, affrancato dalla schiavitù delle cose materiali e aperto al trascendente”.
Il Sussidio si compone di uno schema per l’animazione liturgica della Domenica della Parola, della proposta di testi biblici e di documenti magisteriali a cui si aggiungono testi teologici e opere d’arte che possono sostenere la riflessione e l’approfondimento.
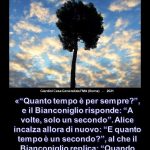
Lectio – Anno C
Prima lettura: Neemia 8,2-4.5-6.8-10
| In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all’assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci d’intendere; tutto il popolo tendeva l’orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno, che avevano costruito per l’occorrenza. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: «Amen, amen», alzando le mani; si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. I levìti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemìa, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: «Questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio; non fate lutto e non piangete!». Infatti tutto il popolo piangeva, mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemìa disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro; non vi ratristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza». |
8-9) presenta la promulgazione della legge giudaica a cui fa seguito la festa dei tabernacoli, la preghiera penitenziale e l’impegno assunto dalla comunità nei confronti della legge; la terza parte (cc. 10-13) contiene alcuni dati statistici e informa sulle ultime azioni di Neemia. Il brano della nostra lettura si trova nella seconda parte, di cui è un momento culminante.
Il tratto dà il quadro grandioso e solenne dell’avvenimento costitutivo della comunità giudaica, e cioè della promulgazione della legge. Esdra e i leviti leggono alcune parti della legge; è il giorno della nascita del giudaismo. L’assemblea del popolo ascolta in piedi la proclamazione della legge; il popolo viene direttamente interpellato e posto di fronte alle sue responsabilità e ai suoi doveri nei confronti di Dio quale comunità dell’alleanza. Avviene una liturgia vera e propria; Esdra benedice il Signore, i presenti rispondono: amen, compiendo il gesto rituale di alzare le mani; poi tutti si inginocchiano e adorano il Signore. Questi aspetti liturgici della descrizione sono molto simili alla celebrazione del culto giudaico nel periodo sinagogale.
Nella liturgia della Chiesa questo testo biblico che, nell’annuncio e nell’accoglienza della legge di Dio, pone l’atto di nascita della comunità del popolo eletto dopo l’esilio, assume il significato di indicare che nella presente celebrazione l’ascolto della parola di Dio e l’adesione ad essa nella fede crea e mantiene la comunità dei credenti in Cristo; attorno alla parola di Dio la chiesa viene costituita in assemblea liturgica cultuale. Si ha così una visualizzazione dell’insegnamento del concilio ecumenico Vaticano secondo: «Il popolo di Dio viene adunato anzitutto per mezzo della parola del Dio vivente (…), in virtù della parola salvatrice la fede si accende e si alimenta nel cuore dei credenti, e con la fede ha inizio e cresce la comunità dei credenti» (Presbyterorum Ordinis n. 4). L’evento raccontato nella lettura è anticipazione della costituzione della Chiesa viva e la Chiesa viva è compimento e realizzazione della prefigurazione profetica descritta nella lettura.
Seconda lettura: 1 Corinzi 12,12-30
| Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse: «Poiché non sono mano, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. E se l’orecchio dicesse: «Poiché non sono occhio, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato? Ora, invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; oppure la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». Anzi proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie; e le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? |
In questo tratto l’autore insiste sulla necessità che tutti, dotati di doni diversi, collaborino alla missione dell’unica Chiesa. Si serve dell’esempio delle membra e del corpo, esempio allora classico. Tutte le membra hanno una funzione indispensabile per il bene di tutto. In tale unità e solidarietà non c’è posto per i complessi di inferiorità o di superiorità, tutti portano un contributo tutti compiono una funzione. Ma la Chiesa unita e solidale a modo del corpo fisico forma realmente il corpo di Cristo, animato dalla vita dello Spirito Santo. È una delle grandi idee sul mistero della Chiesa. Essa non è una società nata dalle varie iniziative degli uomini, diretta da loro; esprime invece e attua una unità mistica che è Cristo nell’atto di riunire i credenti. Con il battesimo tutti i cristiani sono incorporati in Cristo per opera dello Spinto Santo; tutti fummo abbeverati di uno stesso Spirito, cioè ricevemmo l’abbondanza del suo dono. Dal battesimo sorgono le diverse funzioni elencate per il bene della chiesa. Il termine «apostoli» non comprende soltanto il gruppo dei Dodici, ma tutti i predicatori del vangelo, favoriti di carismi divini; i dottori sono coloro che con il dono della scienza e della sapienza istruiscono i fedeli nelle verità della religione; il dono di assistere è quello di compiere opere di misericordia soccorrere i poveri, i malati bisognosi. Il brano della lettura si conclude con l’esortazione ad aspirare ai carismi migliori; segue ad esso infatti l’elogio della carità.
Vangelo: Luca 1,1-4;4,14-21
| Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». |
Esegesi
Il vangelo di Luca dopo il prologo (1,1-4) si articola nel racconto dell’infanzia di Giovanni e di Gesù (1,5-2,52), nella descrizione del ministero di Gesù in Galilea (3,1-9,50), nella narrazione del grande viaggio verso Gerusalemme (9,51;19,28), nel ministero di Gesù a Gerusalemme (20-21) e nel mistero finale di morte e risurrezione (22-24). Il brano della lettura evangelica della terza domenica del tempo ordinario nel ciclo C congiunge due tratti evangelici staccati, e cioè l’inizio, il prologo (Lc 1,1-4) e la inaugurazione del ministero pubblico di Gesù in Galilea nella sinagoga di Nazaret (Lc 4).
Aspetti di esegesi
Prologo: Questo prologo di Luca al suo vangelo composto con arte e con armonia di parti, ha un’andatura classica e attesta il proposito dell’evangelista di comporre un’opera storica coscienziosa. Molti avevano già scritto intorno alla vita e agli insegnamenti di Gesù. Luca vuole servirsi di fonti scritte, interrogare le fonti orali più accreditate, cioè i testimoni oculari, specialmente gli apostoli. Dopo questa indagine accurata e universale l’evangelista scriverà tutto con ordine, disponendo i fatti in un vasto disegno e quadro storico e cronologico non trascurando la connessione logica. L’opera è dedicata a Teofilo, personaggio di famiglia elevata, appartenente alla nobiltà. Luca scrive infatti: «Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto» (Lc 1,1-4).
Inaugurazione del ministero di Gesù a Nazaret. All’inizio dell’attività di Gesù la scena qui descritta costituisce un momento programmatico. In un solo tratto Luca mette in evidenza le grandi idee dell’opera di Gesù; Gesù agisce mosso e guidato dallo Spirito: «In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode» (Lc 4,14-15); lo Spirito, che era disceso su Gesù nel battesimo ora agisce in lui ispirandolo, conducendolo, e rendendo efficace il suo ministero; lo Spirito e Cristo sono inseparabili; Gesù incomincia ad insegnare ed è ammirato e lodato dalle folle; il seguito del racconto infatti informa che «Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca» (Lc 4,22); l’affermazione secondo cui la sua fama si diffuse in tutta la regione è come un ritornello nel vangelo di Luca, che lo ripete dopo l’insegnamento a Cafarnao (Lc 4,37), dopo la guarigione del lebbroso (Lc 5,15) e dopo la risurrezione del figlio della donna di Naim (Lc 7,17).
In Gesù si compie la vocazione espressa nell’antico Testamento nel libro di Isaia nel testo profetico 61,1-2 che egli legge nella sinagoga di Nazaret ove inaugura il suo ministero: «Secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore» (Lc 4,16-19; Is 61,1-2).
Il testo descrive la chiamata e la missione del profeta come annuncio e messaggio di consolazione; Gesù applica a sé il testo profetico: «Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» (Lc 4,20-21). Gesù è unto da Dio Padre con lo Spirito Santo per la missione; il compito di tale missione consiste nell’annunziare il lieto messaggio ai poveri, nel proclamare la liberazione ai prigionieri, nel dare la vista ai ciechi, nel rimettere in libertà gli oppressi, nel predicare l’anno di grazia. Si tratta di una funzione che ha carattere profetico e insieme messianico; a tale compito egli è abilitato dallo Spirito Santo a lui donato da Dio Padre come unzione per la consacrazione. Il brano evangelico risulta così una presentazione che Gesù fa di se stesso inaugurando il suo ministero.
Meditazione
Erano stati il battesimo ricevuto al Giordano (cfr. Lc 3,21-22) e lo scontro con Satana nel deserto (cfr. Lc 4,1-13) a dargli quell’energia incontenibile. Il dono dello Spirito Santo e la vittoriosa lotta contro lo spirito del male gli avevano dato una carica e una lucidità profetica uniche. Gesù ormai girava insegnando tra le genti e queste «gli rendevano lode» (Lc 4,15). Assistiamo incantati allo sbocciare della vocazione travolgente di Gesù. La tradizione monastica definisce questo momento del cammino ‘fervore novizio’, dove ogni ostacolo è vinto dalla passione di un’ardente adesione all’evangelo.
Gesù torna al luogo delle sue origini, tra i suoi famigliari, a Nazaret. E anche qui, una volta ancora, pone al centro della sua vita e delle relazioni con i suoi conoscenti la parola di Dio, secondo una metodologia tanto antica – ce ne viene fatta una precisa descrizione nella prima lettura, tratta dal libro di Neemia – quanto attuale anche per noi, essendo quella che ancor oggi viene seguita nelle nostre liturgie: scelta una sezione dal Libro, questa viene proclamata con chiarezza e autorità, facendovi seguire un commento esplicativo e attualizzante, al fine di mostrare la pertinenza del testo con la vita di chi ascolta e provocare la meditazione, la conversione, la preghiera.
Il brano scelto da Gesù è uno dei più luminosi di tutto il Primo Testamento. Narra di un personaggio che, rinnovato dall’unzione dello Spirito Santo, viene incaricato dal Signore di recare una esaltante comunicazione: «mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore» (Lc 4,18-19).
Dopo la lettura, è certo che deve essere sceso un silenzio perfetto in quell’assemblea. Ancor oggi è forse il momento della celebrazione in cui l’attenzione è massima, perché ci si prepara ad ascoltare il commento che verrà tenuto (e a valutare il predicatore…). Se poi a svolgere questo incarico è un ragazzo del paese, di cui si sente dire un gran bene, è facile immaginare la scena: un’assemblea quasi in ‘apnea’, con gli occhi fissi su di un unico punto… (cfr. Lc 4,20).
Personalmente, sono intrigato dal tentativo di ipotizzare cosa potesse passare in quel frangente per il cuore e per la mente di Gesù. Il seguito del racconto, non riportato dal brano liturgico, ci fa sapere che il suo stato d’animo non era affatto assalito da vergogna, timidezza o da una qualche forma di soggezione verso i suoi conterranei (cfr. Lc 4,23-27). Ho invece il sospetto che Gesù stesse rapidamente rendendosi conto che, a partire da quanto aveva vissuto precedentemente e da quanto aveva appena letto, il misterioso personaggio, datore dell’universale messaggio di liberazione, potesse essere… lui stesso. Come ogni altro essere umano, seppur secondo una specialissima esperienza, Gesù è andato ricercando quale potesse essere il miglior modo per rendere onore a Dio, è andato ricercando segni storici per contribuire ad attuare il sogno di Dio.
Non sappiamo quanti secondi o minuti sia durato il silenzio in cui l’assemblea e Gesù erano immersi. Certo è che la prima parola risuonata dalla bocca del «figlio di Giuseppe» (Lc 4,22) ha proprio dell’incredibile: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» (Lc 4,21). In modo ancor più suggestivo, il testo originale greco afferma: «che si è compiuta nei vostri orecchi». Ora, non era la prima volta che le parole del profeta Isaia risuonavano in una sinagoga. Ma in Gesù si realizzano in modo assolutamente unico, perché in lui vanno a coincidere. Lui è la Parola, che realizza tutte le attese e le profezie. Tutta la sua esistenza sarebbe stata lo ‘svolgimento’ del messaggio di liberazione annunciato e atteso. Detto in altre parole, Gesù sta dicendo di essere il Messia e che avrebbe portato una svolta decisiva al Regno di Dio.
Non credo che noi potremo mai renderci conto di quello che devono aver provato gli ascoltatori presenti in quel luogo di culto. Forse tra costoro c’erano alcuni che sono poi diventati, secondo la testimonianza dell’evangelista Luca, «testimoni oculari» (Lc 1,2) della vicenda di Gesù. Comunque sia, non abbiamo da rimpiangere nulla: ogni volta che ascoltiamo e celebriamo la parola evangelica, possiamo entrare in relazione con il Signore Gesù in modo certamente più profondo ed esistenziale di quanto hanno potuto fare gli abitanti di Nazaret; anche perché siamo meglio a conoscenza del destino e della speranza che Gesù
ha inaugurato. Ascoltatori della Parola per vivere della Parola!
Don Bosco commenta il Vangelo
Don Bosco privilegia i giovani tra i poveri
Nella sinagoga di Nazareth Gesù aprì il rotolo e trovò il passo del profeta Isaia dove era scritto: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio” (Lc 4,18). Questo testo ha illuminato un santo come san Vincenzo de’ Paoli molto caro a don Bosco.
Prima di tutto, nell’opera pubblicata da don Bosco in italiano e intitolata Il cristiano guidato alla virtù ed alla civiltà secondo lo spirito di san Vincenzo de’ Paoli,si legge che questo santo si è lasciato illuminare dallo Spirito Santo: “Per bene apprezzare qual sia stato l’amore di san Vincenzo verso Dio, sarebbe mestieri conoscere tutta l’influenza dello Spirito Santo sul cuore di lui, e la fedele sua cooperazione ai lumi che ne riceveva” (OE3 250).
All’origine del suo amore per i poveri, spiega poi don Bosco, c’è la visione di fede di san Vincenzo, di cui tratta l’istruzione per il giorno decimosecondo del mese dedicato al santo:
Se io considero, diceva, un contadino o una povera donna secondo il suo esteriore e ciò che sembra proporzionato al loro spirito, appena troverei in loro la figura e lo spirito di esseri ragionevoli, tanto sono essi grossolani e materiali. Ma se gli osservo coi lumi della fede, vedrò che il Figlio di Dio, il quale volle essere povero, ci viene rappresentato da questi poveri. Vedrò che non aveva quasi più la figura d’uomo nella sua passione. Vedrò che dai Gentili riputavasi un insensato e consideravasi qual pietra di scandalo dai Giudei. Vedrò infine, che malgrado tutto ciò egli si qualifica il predicatore de’ poveri: Evangelizare pauperibus misit me (OE3 339s).
Ai suoi Preti della Missione san Vincenzo voleva inculcare che la loro missione è la santificazione dei poveri in vista della loro salvezza:
Dopo di aver dedotto dal testo evangelico: Evangelizare pauperibus misit me, che la santificazione dei poveri fu una delle principali funzioni del Salvatore, dimostra ai suoi preti quanto sarebbe per essi pericoloso il trascurare questi membri sì abbietti agli occhi degli uomini, ma sì preziosi a quelli di Dio […]. Un missionario deve tremare se a causa dell’età, o sotto pretesto d’infermità, si rallenta e dimentica che Dio riposa su di lui per la salvezza dei poveri, perché la salvezza dei poveri è un affare di cui si è incaricato presso Dio (OE3 464).
Sull’esempio di san Vincenzo, don Bosco ha voluto privilegiare i poveri in tutte le sue opere. Nel Regolamento dell’Oratorio di s. Francesco di Sales per gli esterni leggiamo:
Lo scopo di quest’Oratorio essendo di tener lontana la gioventù dall’ozio, e dalle cattive compagnie particolarmente nei giorni festivi, tutti vi possono essere accolti senza eccezione di grado o di condizione. Quelli però che sono poveri, più abbandonati, e più ignoranti sono di preferenza accolti e coltivati, perché hanno maggior bisogno di assistenza per tenersi nella via dell’eterna salute (OE29 59).
Nelle regole per le scuole elementari diurne e serali troviamo le stesse espressioni: “Sebbene queste scuole siano aperte a tutti, tuttavia nei casi di ristrettezza di posto, si preferiscono i più poveri ed abbandonati” (OE29 78).
Lo stesso orientamento infine si legge logicamente nelle Regole o Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales:
Il primo esercizio di carità sarà di raccogliere giovanetti poveri ed abbandonati per istruirli nella santa Cattolica religione, particolarmente nei giorni festivi. Avvenendo spesso che si incontrino giovani talmente abbandonati, che per loro riesce inutile ogni cura, se non sono ricoverati, perciò per quanto è possibile si apriranno case, nelle quali coi mezzi, elle la divina Provvidenza ci porrà tra le mani, verrà loro somministrato ricovero, vitto e vestito; e mentre si istruiranno nelle verità della cattolica fede, saranno eziandio avviati a qualche arte o mestiere (OE29 252).
(Morand Wirth)
Tra parentesi il lettore troverà i riferimenti principali dei testi citati nelle opere di o su don Bosco: – nei 38 volumi delle Opere edite di G. Bosco (OE1-38, a cura del Centro Studi Don Bosco dell’Università Pontificia Salesiana); – nei 19 volumi delle Memorie biografiche di don G. Bosco (MB1-19, a cura di G.B. Lemoyne, A. Amadei e E. Ceria); – nelle sue Memorie dell’Oratorio (MO, a cura di A. Giraudo); – nei 10 volumi del suo Epistolario (E1-10, a cura di F. Motto). La seconda cifra indica la pagina del volume.
L’immagine della domenica
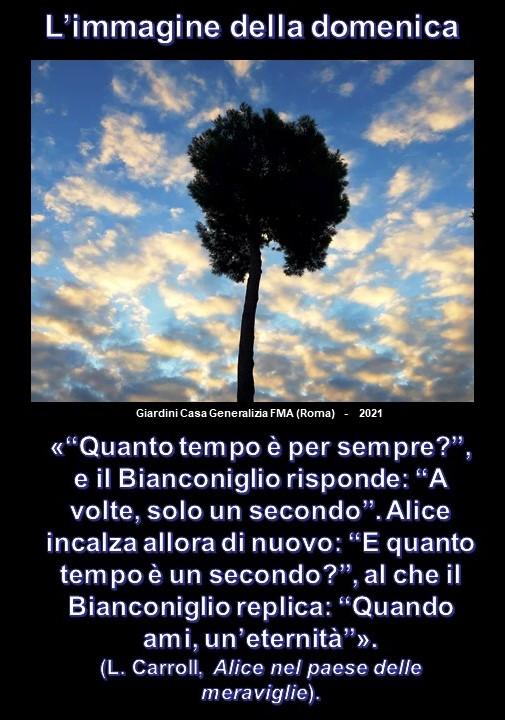
| Giardini Casa Generalizia FMA (Roma) – 2021 |
«“Quanto tempo è per sempre?”, e il Bianconiglio risponde: “A volte, solo un secondo”. Alice incalza allora di nuovo: “E quanto tempo è un secondo?”, al che il Bianconiglio replica: “Quando ami, un’eternità”».
(L. Carroll, Alice nel paese delle meraviglie).
Preghiere e racconti
C’è un profondo bisogno di amore in ciascuno di noi, così spesso prigionieri delle nostre solitudini. È il bisogno di una parola di vita che vinca le nostre paure e ci faccia sentire amati. Il profeta Amos descrive con efficacia questa situazione: “Ecco, verranno giorni oracolo del Signore Dio – in cui manderò la fame nel paese; non fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare le parole del Signore” (8,11). E sant’Agostino – che quella Parola ha incontrato, fino a farne la ragione di tutta la sua vita – così presenta la risposta del Dio vivente al nostro bisogno: “Da quella città il Padre nostro ci ha inviato delle lettere, ci ha fatto pervenire le Scritture, onde accendere in noi il desiderio di tornare a casa” (Commento ai Salmi, 64, 2-3).
Se si arriva a comprendere – come è capitato a tanti credenti di ieri e di oggi – che la Bibbia è questa “lettera di Dio”, che parla proprio al nostro cuore, allora ci si avvicinerà a essa con la trepidazione e il desiderio con cui un innamorato legge le parole della persona amata. Allora, Dio, che è insieme paterno e materno nel suo amore, parlerà proprio a ciascuno di noi e l’ascolto fedele, intelligente e umile di quanto egli dice sazierà poco a poco il nostro bisogno di luce, la tua sete d’amore. Imparare ad ascoltare la voce di Dio che parla nella Sacra Scrittura è imparare ad amare: perciò, l’ascolto delle Scritture è ascolto che libera e salva.
(Bruno FORTE, Lettera ai cercatori di Dio, EDB, Bologna, 2009, 63-64).
Luca, il migliore scrittore del Nuovo Testamento, sa creare una tensione, una aspettativa con questo magistrale racconto che si dipana come al rallentatore: Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. E seguono le prime parole ufficiali di Gesù: oggi l’antica profezia si fa storia. Gesù si inserisce nel solco dei profeti, li prende e li incarna in sé. E i profeti illuminano la sua vocazione, ispirano le sue scelte: Lo Spirito del Signore mi ha mandato ai poveri, ai prigionieri, ai ciechi, agli oppressi.
Adamo è diventato così, per questo Dio diventa Adamo. Da subito Gesù sgombra tutti i dubbi su ciò che è venuto a fare: è qui per togliere via dall’uomo tutto ciò che ne impedisce la fioritura, perché sia chiaro a tutti che cosa è il regno di Dio: vita in pienezza, qualcosa che porta gioia, che libera e dà luce, che rende la storia un luogo senza più disperati. E si schiera, non è imparziale il nostro Dio: sta dalla parte degli ultimi, mai con gli oppressori; viene come fonte di libere vite e mai causa di asservimenti.
Gesù non è venuto per riportare i lontani a Dio, ma per portare Dio ai lontani, a uomini e donne senza speranza, per aprirli a tutte le loro immense potenzialità di vita, di lavoro, di creatività, di relazione, di intelligenza, di amore. Il primo sguardo di Gesù non si posa mai sul peccato della persona, il suo primo sguardo va sempre sulla povertà e sul bisogno dell’uomo. Per questo nel Vangelo ricorre più spesso la parola poveri, che non la parola peccatori. Non è moralista il Vangelo, ma creatore di uomini liberi, veggenti, gioiosi, non più oppressi.
Scriveva padre Giovanni Vannucci: «Il cristianesimo non è una morale ma una sconvolgente liberazione». La lieta notizia del Vangelo non è l’offerta di una nuova morale, fosse pure la migliore, la più nobile o la più benefica per la storia. La buona notizia di Gesù non è neppure il perdono dei peccati. La buona notizia è che Dio è per l’uomo, mette la creatura al centro, e dimentica se stesso per lui. E schiera la sua potenza di liberazione contro tutte le oppressioni esterne, contro tutte le chiusure interne, perché la storia diventi “altra” da quello che è.
Un Dio sempre in favore dell’uomo e mai contro l’uomo. Infatti la parola chiave è “libertà-liberazione”. E senti dentro l’esplosione di potenzialità prima negate, energia che spinge in avanti, che sa di vento, di futuro e di spazi aperti. Nella sinagoga di Nazaret è allora l’umanità che si rialza e riprende il suo cammino verso il cuore della vita, il cui nome è gioia, libertà e pienezza (M. Marcolini). Nomi di Dio.
(Ermes Ronchi)
L’evangelo di oggi, che cuce insieme il prologo di Luca con l’esordio della predicazione di Gesù nella sinagoga di Nazaret, mostra fitte rispondenze con il brano della prima lettura, tratto dal profeta Neemia. In questo brano infatti ci viene rappresentata una vera e propria liturgia della parola ad opera del sacerdote Esdra (450 a. C.), che, ritto su una tribuna, declama le Scritture mentre “tutto il popolo tendeva l’orecchio al libro della legge”.
Secondo la consuetudine, ci racconta infatti Neemia, “i levìti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura”. Oltre 400 anni dopo, Gesù si colloca fermamente in questa tradizione rabbinica di primato della Parola e stavolta il popolo non tende solo l’orecchio, ma anche “gli occhi di tutti erano fissi su di lui”. Ancora da Neemia comprendiamo come la spiegazione del senso, l’interpretazione fornita dai sacerdoti, fa sì che la Parola da lettera morta diventi messaggio vivo ed efficace per il qui e ora di chi la ascolta, tanto da suscitare la commozione e il turbamento profondo del popolo (“Infatti tutto il popolo piangeva, mentre ascoltava le parole della legge”).
Tuttavia, rispetto allo scriba Esdra, la singolarità della lettura di Gesù sta nel fatto che egli sceglie con cura la pagina di Isaia per riadattarla a se stesso, espungendo tra l’altro un versetto “duro” (“per annunciare un giorno di vendetta” diceva l’antico profeta) e modificandone le parole: lo Spirito del Signore mi ha “chiamato” diventa mi ha “unto”. La Parola proclamata diventa così interpretazione essa stessa della figura storica di Gesù di Nazaret, ne spiega i gesti, ne illumina l’agire, ne traccia il ritratto di Messia mite e vicino agli uomini nei loro bisogni, rivelando a sua volta il volto di misericordia e di libertà del Padre. Gli occhi di tutti erano fissi su di lui perché Lui è la Parola, e infatti, esordisce Luca, ci sono “testimoni oculari” che si sono fatti servitori e mediatori di questa unica vicenda umana di Parola fattasi carne e sangue.
Tra questi, a “trafficare” con la Parola, come con i talenti, c’è lo stesso Luca, che con la sua attitudine scientifica vuole mettere ordine alla congerie di racconti che circolavano su Gesù, per mostrare al Teofilo (“amico di Dio”) di ogni tempo, lo spessore della Parola su cui poggia la sua Fede. Interessante peraltro l’uso del verbo catecheo, da cui la nostra “catechesi”, che però nella nostra lingua ha svoltato verso un senso di insegnamento morale, mentre qui, come si vede, è ancorato alla Parola (logos).Ma se gli avvenimenti si sono allora compiuti (pleròo), e in Gesù “la Scrittura si è compiuta” (ancora lo stesso verbo), grazie allo Spirito che apre le orecchie e toglie il velo ai nostri occhi, essa si compie ancora, ogni giorno, nelle gambe e nelle braccia, nel cuore e nella mente di ogni uomo che da questa Parola si lascia interpellare, e alla luce di questa Parola legge la propria vita intrecciandola nella relazione salvifica con gli altri compagni di strada.
(Valentina Chinnici – Pastorale della Cultura e dell’Educazione di Palermo).
«Quanto avrei voluto essere sacerdote per poter predicare sulla Madonna! Una sola volta sarebbe stata sufficiente per dire tutto quello che penso a questo proposito. Prima avrei fatto capire quanto poco conosciamo la sua vita. Non occorre dire cose inverosimili o che non sappiamo; per esempio che, da piccola, a tre anni, la Madonna ha offerto se stessa a Dio nel Tempio con sentimenti ardenti di amore e del tutto straordinari; mentre forse ci é andata semplicemente per obbedire ai suoi genitori… Perché una omelia sulla Madonna possa piacermi e farmi del bene, occorre che io veda la sua vita reale, non la sua vita supposta; e sono certa che la sua vita reale era molto semplice. Ce la mostrano inabbordabile, mentre bisognerebbe mostracela imitabile, fare vedere le sue virtù, dire che viveva di fede come noi, dare delle prove di questo per mezzo del Vangelo in cui leggiamo: «Non compresero le sue parole» (Lc 2,50). E questa parola molto misteriosa: «I suoi genitori si stupivano delle cose che si dicevano di lui» (Lc 2,33). Questo stupirsi suppone un certo meravigliarsi, non è vero? Sappiamo bene che la Madonna è Regina del Cielo e della terra, eppure è più madre che regina, e non occorre dire a motivo delle sue prerogative, che lei eclissi la gloria di tutti i santi, come il sole al suo sorgere fa scomparire le stelle. Mio Dio! quanto questo mi appare strano! Una madre che fa scomparire la gloria dei suoi figli! Io penso tutto il contrario, ritengo che essa farà crescere molto lo splendore degli eletti. È bene parlare delle sue prerogative, ma non occorre dire soltanto questo… Forse qualche anima andrà fino al punto di sentire allora una certa lontananza con una tale creatura talmente superiore e dirà : «Se le cose stanno così, ci accontenteremo di andare a brillare in un angolino».Ciò che la Madonna aveva in più rispetto a noi, era il fatto che non poteva peccare, che era esente dalla macchia originale, ma d’altra parte, è stata meno fortunata di noi, poiché non ha avuto la Madonna da amare, e questa è una tale dolcezza per noi».
(Santa Teresa del Bambino Gesù (1873-1897), carmelitana, dottore della Chiesa, in Ultimi colloqui, 21/08/1897).
«Chi non risponde alla Parola diventa sordo» (Martin Buber). L’accompagnamento non può che portare alla consapevolezza che, come ci ricorda NVNE, «tutta la vita è una risposta» (26/e) e, quindi, a saper scorgere le continue chiamate di Dio in ogni stagione della propria esistenza. È il faticoso passaggio dal cavallo al cammello.
Un cavallo va bene per la bellezza, la forza, la velocità e la razza, per godersi una cavalcata, gareggiare e vincere un premio. Tutto molto bello. Ma poi nella vita ci sono anche i deserti, e là il migliore dei cavalli è inutile e la velocità non serve. Il cavallo si spazientirà, diverrà irrequieto, gli zoccoli affonderanno nella sabbia. Il suo respiro brucerà nel calore e la bestia s’imbizzarrirà, cadrà e morirà nelle sabbie spietate. I cavalli non sono per il deserto.
I cammelli sì! Il cammello s’incamminerà e andrà avanti. Anche senza cibo, senz’acqua, senza redini, senza direzione, andrà avanti costantemente, fedelmente, sicuramente, manterrà la rotta, attraverserà il deserto, raggiungerà l’acqua e salverà se stesso e il suo cavaliere. La tenace perseveranza di mantenere fermamente la rotta nelle circostanze peggiori è una dote preziosa per sopravvivere in questo mondo. Noi tutti abbiamo bisogno di un cammello nelle nostre stalle.
(Antonio LADISA, La direzione spirituale oggi: perché?, in CENTRO REGIONALE VOCAZIONI (PIEMONTE-VALLE D’AOSTA), Corso di avvio all’accompagnamento spirituale. Atti, a cura di Gian Paolo Cassano, Casale Monferrato, Portalupi, 2007, 30).
La tua parola, Signore, mi porta a meditare,
perché è una parola dal senso inesauribile,
che non ha mai finito di offrire i suoi segreti
a colui che li cerca.
Più che alla riflessione, la tua parola m’invita
alla contemplazione, perché sei tu che mi parli
e mi fai scoprire la tua personalità,
in tutto quello che dici.
Leggendo il Vangelo per accogliere
tutta la verità che ci hai insegnato,
vorrei unirmi con più chiarezza
a tutto quello che sei.
Trasforma la mia lettura in uno sguardo profondo
che cerchi la tua presenza e raggiunga,
attraverso la tua parola, un volto d’amico
dal sorriso divino.
Arricchendosi di un testo che è vita,
il mio spirito e il mio cuore possano trovare in te
un riposo che li apra ad una conoscenza
carica d’amore.
(JEAN GALOT, Contemplazione, Benedettine, S. Agata sui due Golfi, 1987).
Nella sua Parola è Dio stesso a raggiungere e trasformare il cuore di chi crede: “La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore” (Ebrei 4,12). Affidiamoci, allora, alla Parola: essa è fedele in eterno, come il Dio che la dice e la abita. Perciò, chi accoglie con fede la Parola, non sarà mai solo: in vita, come in morte, entrerà attraverso di essa nel cuore di Dio: “Impara a conoscere il cuore di Dio nelle parole di Dio” (San Gregorio Magno).
Alla Parola del Signore corrisponde veramente chi accetta di entrare in quell’ascolto accogliente che è l’obbedienza della fede. Il Dio, che si comunica al nostro cuore, ci chiama ad offrirgli non qualcosa di nostro, ma noi stessi. Questo ascolto accogliente rende liberi: “Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Giovanni 8,31-32).
Per renderci capaci di accogliere fedelmente la Parola di Dio, il Signore Gesù ha voluto lasciarci – insieme con il dono dello Spirito – anche il dono della Chiesa, fondata sugli apostoli. Essi hanno accolto la parola di salvezza e l’hanno tramandata ai loro successori come un gioiello prezioso, custodito nello scrigno sicuro del popolo di Dio pellegrino nel tempo. La Chiesa è la casa della Parola, la comunità dell’interpretazione, garantita dalla guida dei pastori a cui Dio ha voluto affidare il suo gregge. La lettura fedele della Scrittura non è opera di navigatori solitari, ma va vissuta nella barca di Pietro.
(Bruno FORTE, Lettera ai cercatori di Dio, EDB, Bologna, 2009, 63-64).
O Gesù, ti sei presentato al tuo paese
per annunciare i tempi messianici,
per proclamare
ai poveri il lieto messaggio,
ai prigionieri la liberazione,
ai ciechi la vista,
agli oppressi la libertà,
per predicare un anno di grazia.
Grazie per tutti coloro che si adoperano per questo.
Grazie per quanti proclamano la tua Parola,
con la parola e con la vita,
con popolarità o nel silenzio.
Mandaci sempre uomini pazzi di te,
pronti a testimoniare con la vita.
Fino a quando la tua Parola viene proclamata,
è ancora tempo di speranza e di salvezza.
Solo chi si pare alla verità
e alla conoscenza della tua legge,
esperimenta gioia e riconoscenza.
(A. Merico)
19-25 gennaio 2025
19. “Volete levarvi di dosso questa melanconia? Venite da me e troveremo il mezzo per cacciarla e per rimediare” (MB6 321).
20. (Ss. Fabiano e Sebastiano) – “Erano raccolti per la elezione del nuovo Papa quando videro una colomba [che] si andò a posare sul capo di Fabiano” (OE30 27). – “Il Santo Pontefice ravvisando in questo giovine militare [Sebastiano] un cristiano pio, dotto, prudente, ed intrepido in mezzo a tutti i pericoli lo costituì difensore della Chiesa Romana” (OE14 384).
21. (S. Agnese) – “All’età di soli dodici anni ella fu in mille guise insultata, flagellata, minacciata […] e finalmente cinta della corona dei vergini e dei martiri” (OE15 53s).
22. (S. Vincenzo diacono) – (B. Laura Vicuña) “Per far del bene, era solito ripetere, bisogna avere un po’ di coraggio” (MB3 52).
23. “Se pregate, da due grani che voi seminate ne nasceranno quattro spighe; se non pregate, seminando quattro grani raccoglierete due sole spighe” (MB1 197).
24. (S. Francesco di Sales) – “Colle sole armi della dolcezza e carità si parte pel Chiablese”, “tutto s’accende di zelo”, “colla sua pazienza, colle prediche, cogli scritti, e con insigni miracoli acqueta ogni tumulto”; “quasi per forza creato Vescovo di Ginevra, […] raddoppiò il suo zelo non trasandando anche il più basso uffizio del suo ministero” (OE1 479s).
25. (Conversione di S. Paolo) – Dio “è padrone dei cuori”, e “può cangiare anche una tigre feroce in mansueto agnello” (OE24 28).
Questo piccolo “calendario salesiano” propone al lettore un pensiero di don Bosco per ogni giorno dell’anno.
Segue il calendario liturgico della Chiesa, nel quale inserisce il Proprio della Famiglia salesiana.
Per ogni giorno offre un pensiero del Santo possibilmente adattato al giorno corrispondente.
Come si può indovinare, questo piccolo calendario è destinato in modo speciale ai membri della Famiglia salesiana come nutrimento per il loro spirito salesiano.
Tra parentesi il lettore troverà i riferimenti principali dei testi citati nelle opere di o su don Bosco,
– soprattutto nei 38 volumi delle Opere edite di G. Bosco (OE1-38, a cura del Centro Studi Don Bosco dell’Università Pontificia Salesiana);
– nei 19 volumi delle Memorie biografiche (MB1-19, a cura di G.B. Lemoyne, A. Amadei e E. Ceria);
– nelle Memorie dell’Oratorio (MO, a cura di A. Giraudo);
– e nei 10 volumi del suo Epistolario (E1-10, a cura di F. Motto).
La seconda cifra indica la pagina del volume.
Le solennità sono in maiuscolo, le feste in maiuscoletto, le memorie obbligatorie in minuscolo tondo, e le memorie facoltative in minuscolo corsivo.
In pochi casi l’ortografia e la punteggiatura dei testi di don Bosco sono state modernizzate per facilitare la lettura.
(Morand Wirth)
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
—
– COMUNITÀ DI S. EGIDIO, La Parola e la storia,Milano, Vita e Pensiero, 2012.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– M. FERRARI, «Oggi di è adempiuta questa scrittura». Avvento, Tempo di Natale e Tempo ordinario (prima parte), Milano, Vita e Pensiero, 2012.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.
—
– Immagine della domenica, a cura di García-Orsini-Pennesi.

“2025: A.I. confini della comunicazione” è il titolo del Convegno organizzato dall’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, che si terrà dal 23 al 26 gennaio a Roma.
L’evento si aprirà con due sessioni tematiche specifiche per poi intersecarsi con il programma ufficiale del Giubileo del mondo della comunicazione. Si inizia giovedì alle 15.30 con il saluto di mons. Domenico Pompili, presidente della Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali, e l’introduzione di Vincenzo Corrado, Direttore dell’Ufficio. Alle 16 è prevista la riflessione di Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR, su “Intelligenza artificiale, informazione e comunicazione”, mentre alle 18 sarà Mariagrazia Fanchi, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore a soffermarsi su “Le sfide della comunicazione oggi”.
Venerdì 24 gennaio, alle 9.30 Alessandro Gisotti, vicedirettore della Direzione Editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, offrirà ai partecipanti una lettura del Magistero pontificio legato ai temi della comunicazione. Alle 10, Antonio Preziosi, direttore del Tg2, interverrà su “Il senso del limite”, mentre alle 10.30 Marco Ferrando, direttore delle testate del Master in giornalismo dell’Università di Torino, e Celeste Satta, del medesimo Ateneo, rifletteranno su “meno prodotti, più processi”. Alle 11.45 è in programma un dialogo con Marco Girardo, direttore di Avvenire, Vincenzo Morgante, direttore di Tv2000-inBlu2000, e Amerigo Vecchiarelli, direttore dell’Agenzia Sir.
Nel pomeriggio l’appuntamento è nella Basilica di San Giovanni in Laterano per la Messa internazionale in occasione della festa di San Francesco di Sales. La giornata di sabato 25 è dedicata al Pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro e all’incontro culturale in Aula Paolo VI con Maria Ressa e Colum McCann (moderato da Mario Calabresi), seguito dall’esibizione del Maestro Uto Ughi. Alle 12.30, gli operatori della comunicazione arrivati da tutto il mondo saranno ricevuti in udienza da Papa Francesco, sempre in Aula Paolo VI.
Alle 15, nell’ambito dei “Dialoghi con la città” organizzati per il Giubileo, il Card. Matteo Zuppi, Presidente della CEI, dialogherà con Ferruccio De Bortoli, giornalista e saggista, sul tema: “Comunicare speranza e pace” (Basilica di Santa Maria in Trastevere). Il tutto si concluderà il 26 gennaio con la Messa della Domenica della Parola presieduta dal Papa nella Basilica di San Pietro.
“Nel sentire comune, i confini vengono solitamente intesi come linee di delimitazione di un territorio, di una proprietà oppure della sovranità di uno Stato. Eppure, la radice etimologica della parola indica ben altre sfumature: cum e finis. Cioè, cum, che rimanda alla condivisione. E, poi, finis, che significa limite ma anche culmine di un’azione”, sottolinea Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali ricordando che “il rapporto con i confini si gioca proprio sul livello della relazione”. “È un punto di incontro, tra il vecchio e il nuovo. Ai (il riferimento è ai sistemi di intelligenza artificiale) confini ci si incontra per dirigersi verso il cuore della comunicazione. Questo percorso, certamente faticoso, restituisce il fascino dell’incontro, dell’ascolto e della parola. A noi – conclude – l’impegno di coglierne il messaggio e tradurlo in realtà”.