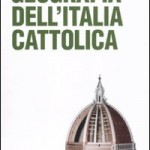Pierluigi Di Piazza, Fuori dal tempio. La Chiesa al servizio dell’umanità, Laterza, Bari 2011, pp. 125 , euro 12,00
Presentazione
«Mi sento laico, umile credente sempre in ricerca, prete per un servizio disponibile, disinteressato, gratuito nella comunità cristiana e nella società; anticlericale, cioè non appartenente ad una categoria; non funzionario della religione. Si può così intuire quale sia a livello di comunicazione l’effetto del cercare giustizia, verità, uguaglianza, pace, condivisione».
Parla don Pierluigi Di Piazza, fondatore del Centro di accoglienza per stranieri Ernesto Balducci di Zugliano, e racconta la sua storia di uomo e di prete, di insegnante e di animatore culturale, alle prese con i temi più discussi nelle comunità cristiane: le delicate posizioni dei separati e divorziati nella Chiesa, l’aborto, l’omosessualità, il celibato dei preti, il sacerdozio delle donne, la pedofilia, la malattia e il fine vita.
L’autore
Pierluigi Di Piazza,prete, parroco, laureato in Teologia, ha ricevuto nel 2006 la laurea ad honorem dell’Università degli Studi di Udine quale ‘imprenditore di solidarietà’. Insegnante per 30 anni, nel 1988 ha fondato il Centro di accoglienza per stranieri e di promozione culturale “Ernesto Balducci” di Zugliano (Udine) di cui è responsabile. Collabora con giornali e riviste. Tra le sue pubblicazioni, Nel cuore dell’umanità, storia di un percorso (2006) e Questo straordinario Gesù di Nazaret (2010).
La fede ha radici laiche
di Federico Vercellone
in “La Stampa” del 17 luglio 2011
Forse mai come oggi si è reso evidente che integralismo e laicismo sono una sorta di Giano bifronte, due volti dello stesso individuo. All’integralismo religioso e politico ha fatto compagnia in questi anni, anche con ottime motivazioni, un atteggiamento laico che ha voluto ridurre la religione a un fatto privato fornendo in questo modo legittimità alla fede solo quando rinunzi a essere
partecipe della sfera pubblica. Ma se la religione è come l’attesa degli Ufo, non si può poi pretendere che gli extraterrestri non vogliano invadere la Terra.
Il gioco di specchi tra laicisti e fondamentalisti in questo modo si rivela come un conflitto necessario. Si tratta, in fondo, una diatriba tra fratelli. In questo Paese siamo troppo spesso ancora figli di Peppone e di Don Camillo, mangiapreti amici-nemici dell’abito talare, religiosi pronti a fare ogni compromesso con il mondo quando ciò convenga alla maggior gloria di Dio.
A parlarci delle radici laiche della fede viene ora un sacerdote, Pierluigi Di Piazza, che ci rammenta l’essenza più pura del Vangelo, che coincide anche con la laicità cristiana. E con la libertà del mondo di aderire o di non aderire al messaggio di Gesù Cristo. Don Di Piazza ci ricorda con forza, in un piccolo libro quanto mai incisivo, Fuori dal tempio. La Chiesa al servizio dell’umanità (Laterza), che il cristianesimo è essenzialmente una religione profetica, è attesa di un nuovo Regno che è da coltivarsi con l’atteggiamento vigile della testimonianza. Questo comporta fare i conti con la cultura del momento e con le contingenze della storia scegliendo innanzi tutto l’accoglienza. Don Di Piazza, che ha fondato a Zugliano, in Friuli, il Centro di accoglienza per stranieri e di promozione culturale «Ernesto Balducci», ci conduce così in un appassionato itinerario nella laicità cristiana. È un cammino che si accompagna a una ferma condanna delle prese di posizione delle gerarchie cattoliche nei confronti del celibato dei preti, del divieto del sacerdozio femminile, del caso Englaro, delle compromissioni scandalose nei confronti del potere politico. Don Di Piazza ci insegna così che è doveroso essere laici per i credenti. E che è doveroso per tutti, credenti e non, essere in «buona fede».
L’intervista
Il libro è un sofferto e profondo excursus nella sua vita di uomo, prete, insegnante, animatore culturale, personaggio capace di assumere posizioni scomode, ma sempre sostenute con la forza della fede, del sentimento e del ragionamento, davanti a molti dei temi più delicati che agitano le anime dei cristiani: separati e divorziati, aborto, omosessualità, celibato dei preti, sacerdozio delle donne, pedofilia, malattia e fine vita. Il tutto in un impegno di fede e di sincerità.
Si tratta di un libro troppo ricco di spunti di riflessione per essere decentemente illustrato nel ristretto spazio della pagina di un giornale, ma qui tentiamo di tratteggiarne le linee fondamentali parlandone con lui.
– Il titolo del libro dice Fuori dal tempio. Questo implica che c’è una differenza sensibile tra il tempio e il mondo che ne resta fuori?
«Questo titolo esprime l’itinerario di riflessione che mi pare sia ispirato e suggerito dal Vangelo che costituisce il filo conduttore del libro. Quando Gesù di Nazaret muore sulla croce, il velo del tempio si squarcia perché Gesù viene ucciso dall’intreccio dei poteri culturale, legislativo, politico e religioso, nonché dal braccio armato militare dei romani. E questo pone una questione di drammaticità e contrasto, mette in evidenza una dialettica tra il Dio del tempio e il Dio che Gesù presenta nella sua vita, nelle sue parole, nei suoi gesti. È il contrasto che pone da una parte il Dio del tempio, gestito dai sacerdoti di una religione tradizionale che di fatto legittima le disattenzioni per i bambini, la discriminazione della donna, l’esclusione degli ammalati, la cacciata di coloro che sbagliano, dei peccatori, il disprezzo per la gente povera considerata ignorante dalla classe dirigente. Dall’altra parte Gesù pone una fede, non una religione; una fede incarnata della vita, nella storia e soprattutto nelle relazioni con le persone. Quindi il Dio del tempio e il Dio di Gesù di Nazaret entrano in un conflitto insanabile che costa a Gesù la crocifissione, ma che poi dona a chi partecipa di questa fede anche Gesù che vive oltre la morte, con una presenza misteriosa che sempre ci accompagna».
– Ma tutto questo non è riferito soltanto a quella storia, ma anche all’oggi…
«Il titolo, infatti, dice che, partendo da questo assunto, la Chiesa dovrebbe sempre ispirarsi al Vangelo di Gesù misurando il suo annuncio, la sua credibilità e la sua coerenza soprattutto fuori dal tempio anche se nel tempio, inteso come edificio religioso, ci si continua a incontrare per i momenti di preghiera, di riflessione, per la comunione nell’eucarestia. Ma guai se tutto questo, restando chiuso nella sacralità del tempio, è separazione e non diventa invece incarnazione del messaggio del Vangelo nella storia e nelle relazioni con le persone».
– All’inizio del volume è pubblicata la Lettera di Natale del 2009, quella in cui, in dieci sacerdoti di questa regione, avete specificato in quali definizioni di Dio credete e in quali non credete. Come mai è stato deciso di collocarla come introduzione al libro?
«A dire il vero questa è stata una decisione presa dagli editori che hanno pensato che questa lettera – che avevo mandato loro insieme ad alcuni altri scritti – poteva essere un prologo interessante e importante. Ovviamente in questa lettera noi non abbiamo alcuna presunzione di definire cos’è Dio: se lo facessimo sarebbe davvero una contraddizione clamorosa perché quando parliamo di Dio siamo sempre noi poveri esseri umani a parlarne dentro la contingenza di una cultura, di un linguaggio che è sempre parziale rispetto all’universalità e alla profondità. Quindi, come diceva padre Ernesto Balducci, al quale abbiamo intitolato il Centro di accoglienza e di promozione culturale di Zugliano, Dio è absconditus e sarebbe terribile identificarlo forzatamente con le nostre teologie e a pensarlo rinchiuso nelle nostre liturgie perché Dio è sempre da cercare, pur se intuito, creduto, pregato. Questa lettera, che credo sia sempre attuale, l’abbiamo scritta con l’intenzione di favorire una riflessione su quella specie di politeismo così presente anche nella nostra realtà, italiana e friulana. È davvero sconcertante, infatti, come nello stesso tempo si possa parlare di Dio e invocarlo come il Dio dei ricchi e dei poveri; come il Dio di chi si impegna per la pace e di chi legittima le guerre e i bombardamenti; come il Dio di che è razzista e utilizza una religione etnicizzata e chi in nome di questo Dio, che disse “Ero forestiero e mi avete accolto”, accoglie gli ultimi, i fuggitivi, i diseredati; come il Dio dei forti, dei potenti e dei prepotenti e il Dio dei deboli, dei fragili, degli ultimi; come il Dio di chi utilizza il suo nome per un potere – come avviene anche nel nostro Paese – assolutizzato, che pretende di essere ingiudicabile e il Dio che ci insegna che il potere va inteso come servizio. Quindi questo politeismo, questo relativismo riguardo a Dio è per me preoccupante».
– Quindi, a maggior ragione, non si potrebbe parlare di un Dio “al di sopra delle parti”, di un Dio indifferente alle sorti degli uomini e dell’umanità?
«Nel libro c’è un capitolo in cui descrivo il fascino che Gesù esercita sulla mia vita e il coinvolgimento che ne deriva, ma mi pare che Gesù riveli, e sia, un Dio chiaro ed esplicito nelle sue manifestazioni, il cui messaggio è rivolto a tutti, ma nello stesso tempo mi sembra un Dio schierato, un Dio che prende parte davanti alle ingiustizie del nostro mondo. Credo che su questo non ci possano essere dubbi».
– Se Dio è absconditus, è altrettanto vero che l’uomo è sempre drammaticamente palese. Però, visto che l’uomo è stato creato “a sua immagine e somiglianza”, proprio l’uomo dovrebbe essere il mezzo più giusto per onorare Dio attraverso il suo rispetto e la sua cura. Questo, invece, purtroppo non avviene sempre nella realtà, anche in quella di chi si dice vicino al mondo delle religioni…
«È vero. E questo mi colpisce ogni giorno anche perché richiede a me per primo una costante coerenza con quel Dio che in Gesù vive continuamente una grande “com-passione”, che interpella l’altro, che assume su di sé le vicende altrui dentro a situazioni di sofferenza, di malattia, di marginalità, di esclusione; le assume come un nuovo e completo impegno di liberazione intesa nella sua accezione più ampia e non soltanto fisica o spirituale. Io credo in una spiritualità che sempre innerva l’umanità, l’attraversa, la illumina, la fortifica, la irrobustisce, la rilancia, la libera nel senso più completo del termine».
– Ma alla base di tutto questo impegno deve esserci una scelta consapevole…
«Noi esseri umani viviamo l’ambivalenza di ogni giorno e quotidianamente siamo provocati a una scelta. Purtroppo tante volte finiamo per scegliere la minore umanità, o addirittura tratti di disumanità che poi possono avere conseguenze drammatiche. Ed è molto grave, poi, la presunzione, la pretesa, la prepotenza di utilizzare Dio, o almeno il suo nome, per giustificare molti atteggiamenti disumani dell’uomo. È un paradosso clamoroso. Credo che ogni religione viva questa dialettica, questo pericolo costante di incoerenza tra le ispirazioni e le proclamazioni, da una parte, e le attuazioni delle promesse dall’altra. Questo utilizzo di Dio per la prepotenza, il potere assolutizzato, le discriminazioni, addirittura per la violenza, la guerra, i privilegi, l’ingiustizia, è di una gravità veramente tragica».
– In questo senso prende vera concretezza il comandamento che prescrive “Non nominare il nome di Dio invano”…
«Credo che si potrebbe dire che Dio ci libera, ma che nel medesimo tempo ci coinvolge a liberare Lui stesso dall’utilizzo negativo del suo nome fatto troppo spesso da una parte dell’umanità. Ci chiede di impegnarci a far sì che non lo si imprigioni e non lo si usi in modo improprio e troppo frequentemente terribile».