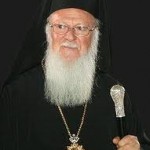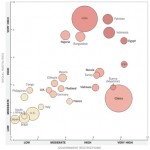Riprende la campagna mai sopita su Chiesa cattolica e tasse.
Riportiamo di seguito alcuni contributi per comprendere i dati della polemica e la rispota scaricabile pubblicata nel volume “La vera questua”
Campagna anticattolica
Da 4 anni le stesse bugie
Freezer e microonde sono il toccasana in tante cucine. E pure in certe redazioni. Proprio ieri un “settimanale di politica cultura economia” lanciava una roboante inchiesta dal titolo «La santa evasione», così riassunta: «I vescovi lanciano l’anatema contro chi non paga le tasse, ma i patrimoni della Chiesa vivono di agevolazioni ed esenzioni. Ecco la mappa di un tesoro che conta un quinto degli immobili italiani. E per legge sfugge alla manovra».
Nulla di nuovo. La fonte principale, se non unica, è una vecchia inchiesta di Curzio Maltese apparsa sulla “Repubblica” dal 28 settembre al 17 dicembre 2007, poi raccolta nel volume “La Questua”. A ogni puntata dell’inchiesta seguiva una pagina di Avvenire che confutava, dati alla mano, errori, verità dimezzate e omissioni, lavoro poi confluito nel libro “La vera questua” (scaricabile qui). “Repubblica” non rispose mai né mai corresse i suoi sbagli; ma Maltese ripulì il libro dagli errori più madornali, pur senza mai citare “Avvenire”, esempio perfetto di mobbing mediatico: ci sei ma non esisti.
Nient’altro di nuovo, se non un misterioso «altro libro» di Piergiorgio Odifreddi, che accuserebbe la Chiesa di un’evasione doppia, rispetto a quella denunciata da Maltese.
A sconcertare è l’assenza totale di fonti che i lettori possano controllare. Si citano vaghe «stime» e «calcoli», magari dei «Comuni». Tutto così generico da risultare inattendibile. Si dice, si ripete, si ridice che «la Chiesa non paga l’Ici», ma da quattro anni non facciamo che ripetere la verità: la Chiesa paga l’Ici per tutti gli immobili di sua proprietà che danno reddito, a cominciare dagli appartamenti (vedi la lettera del parroco romano) e dai cinema con caratteristiche commerciali. E se qualcuno non paga ma dovrebbe pagare, sbaglia e va fatto pagare. Ma chi?
L’inchiesta, se così la si può definire, non lo dice. Sbrina e riscalda. E insinua. Afferma che a Roma gli immobili del Vaticano sono grandi evasori. Ma non si prende la briga di chiedere all’Agenzia delle Entrate della capitale l’elenco degli enti non commerciali contribuenti. Comprensibile: se fosse una vera inchiesta, dovrebbe spiegare che Apsa (Amministrazione del patrimonio della Sede apostolica) e Propaganda Fide sono al secondo e al terzo posto tra i contribuenti, dietro un importante istituto di previdenza. Quindi paga, eccome se paga. Ma poiché il teorema esige che evada, le cifre dell’Agenzia vanno oscurate, altrimenti farebbero saltare il teorema.
Son fatte così queste “inchieste”. Perfino la Caritas romana viene messa nel mirino come «proprietaria» di ben 70 immobili. La Caritas non «possiede» nulla ma gestisce, in effetti, mense e comunità di recupero per ex tossicodipendenti, case per malati terminali di Aids o per giovani madri in difficoltà… che per il gruppo guidato da Carlo De Benedetti, così in sintonia con le parole d’ordine e le campagne di Radicali italiani e Massoneria italiana, devono fruttare ampi redditi, e quindi vanno ben spremuti.
Nulla di nuovo, dunque. Anche se con ineffabile faccia tosta qualcuno afferma che la Chiesa manterrebbe un imbarazzato silenzio e non avrebbe mai smentito nulla, tutto è già stato ampiamente confutato dal 2007 in poi; ma la campagna militare esige l’applicazione del mobbing mediatico: so perfettamente che ci sei, mi rispondi e cerchi il dialogo, ma ti ignoro e faccio come se tu non esistessi. Via allora con le cifre sparate a casaccio senza citare fonti controllabili. Così gli immobili di proprietà della Chiesa cattolica, in Italia, ieri erano il 30 per cento, oggi calano al 22 e domani chissà… palesi enormità, avvalorate da numeri che si riferiscono a Roma, dove però tutte le congregazioni religiose del mondo hanno una “casa madre” o una rappresentanza, e molte Conferenze episcopali nazionali hanno i loro collegi dove ospitano i propri studenti che frequentano le Pontificie università. Che un collegio di seminaristi o giovani preti, che studiano e pregano, collegio che non produce reddito alcuno ma ha soltanto dei costi, debba pagare l’Ici è una palese sciocchezza. Nessun istituto d’istruzione la paga.
Ma la campagna contro la Chiesa non teme le sciocchezze. Leggiamo infatti l’elogio dell’emendamento dei Radicali «che farebbe cadere l’esenzione dall’Ici (…) per tutti gli immobili della Chiesa non utilizzati per finalità di culto», con questo elenco: «Quelli in cui si svolgono attività turistiche, assistenziali, didattiche, sportive e sanitarie, spesso in concorrenza con privati che al fisco non possono opporre scudi di sorta». La scure decapiterebbe anche innumerevoli ong, enti di promozione sportiva laicissimi, scuole non cattoliche, realtà culturali, politiche e sindacali. Un massacro. E costerebbe una cifra inaudita (la sola scuola paritaria, pubblica esattamente come la statale, fa “risparmiare” 6 miliardi all’anno) a uno Stato costretto a intervenire là dove la Chiesa, e altri, sarebbe costretti a mollare. Ma che importa? La furia demagogica ha bisogno di un facile bersaglio da additare all’odio popolare. E intanto gli evasori, quelli veri, gongolano.
Umberto Folena
– Qualcosa che impressiona di Marco Tarquinio
– Il Grande Oriente suona la carica | La lettera: «Io, parroco, pago tutto»
– L’OSPITE Chiesa e non profit: la ricchezza dei poveri di Angelino Alfano
L’Ici no, ma la Chiesa qualcosa deve fare
di Alberto Melloni
Farebbero malissimo i vescovi a sottovalutare la richiesta che arriva da più parti e che riguarda i «sacrifici» che anche la Chiesa dovrebbe fare nell’indomabile montare della crisi.
È ovvio che in molti casi queste istanze nascondono la stessa faciloneria che ha convinto milioni di italiani che il problema dei debiti sovrani dipenda in Italia dai privilegi dei politici che esistono e sono odiosi ma non sono certo il cuore della cosa. E dunque potrebbe essere fortissima la tentazione di respingere al mittente tali istanze con argomenti tecnicamente e giuridicamente solidi.
Sui patroni basterebbe ammiccare ai sindaci e agli uffici scolastici per far sì che il calendario delle lezioni reintroduca dalla finestra festività che così verranno sottratte solo ai ceti operai e impiegatizi che non possono permettersi i ponti. Sulle festività che il concordato blinda ci si potrebbe limitare a richiamare la indisponibilità del tema (è la Repubblica che ha deciso insieme alla Santa Sede di mettere sotto l’ombrello di un trattato internazionale le feste dei dogmi di Pio IX e di Pio XII anziché il triduo pasquale: per cui, se ne ha voglia, porti la politica al Papa una legge con allegato il trattato sul triduo di Hans Urs von Balthasar). Sull’8 per mille, materia decisa dal concordato Casaroli-Craxi, i vescovi potrebbero ricordare agli smemorati radicali che gli accordi di Villa Madama prevedevano un riesame in commissione paritetica (nell’infondato timore che la quota stabilita non colmasse la «congrua») e che non è stato un ukaze Cei a impedirlo. Così pure sulle esenzioni Ici i vescovi potrebbero legittimamente rimandare ad una più attenta lettura all’elenco delle Onlus fra le quali (con esiti insostenibili dal punto di vista costituzionale) si chiede di discriminare quelle che hanno «fini di religione», declinati nella libertà della loro espressione.
Così facendo, però, verrebbero meno a quel dovere evocato dal presidente Napolitano nella sua orazione civica di Rimini, e che è una chiamata in attesa di reclute: porsi cioè al livello delle sfide che il Paese non può non affrontare. E qui i vescovi potrebbero cogliere in istanze vulnerabili o populiste una occasione. Il sistema dell’8 per mille, infatti, era stato inventato da grandi ecclesiastici (Casaroli, Silvestrini, Nicora) per dare alla Chiesa italiana, e non alla Santa Sede, una sua autonomia, specialmente rispetto alla politica: e quel sistema aveva una implicazione di parificazione fra Chiese e religioni che non è stato implementato dallo Stato che ne aveva il dovere.
Se il miliardo e passa di entrate non basta a proteggere la Chiesa da una politica delle blandizie la questione, allora, è ancora più grande.
Il denaro dato alla Cei, infatti, è stato speso (quasi sempre) bene: ha rimesso in sesto un patrimonio che il Fondo edifici di culto del ministero degli Interni non poteva mantenere; ha finanziato tanta solidarietà. Non mancano le ombre: ha certo foraggiato sacche di interessi e comprato consensi in vendita, ha dato fiducia a mezze tacche della finanza o della cultura, ha coperto operazioni meschine (d’altronde, come spiegava un grande cardinale italiano, in fatto di denaro «i preti delinquenti si fidano sempre di delinquenti, perché sono anche loro delinquenti; i preti buoni si fidano dei delinquenti perché sono buoni»). Ma non è lo Stato che può dar lezioni di rigore, se non segna un punto e a capo per tutti.
Quel denaro però ha eroso qualcosa di assai più profondo per la Chiesa italiana: e cioè la sua fede nella povertà come via necessaria della Chiesa, secondo il limpido dettato della costituzione conciliare Lumen Gentium 8. Perché — come ha insegnato l’emersione dei crimini di pedofilia — ogni consiglio evangelico può essere vissuto in modo estrinseco o profondo: e come la superficialità esalta le turpitudini, la sincerità anche debole accresce la virtù. Così la scarsa fiducia, per dir così, nella povertà ha sottratto alla Chiesa una credibilità di cui oggi avrebbe bisogno, per essere nella svolta che stiamo vivendo fattore di unità profonda del Paese.
Con quella credibilità potrebbe affrontare tutte le questioni sul tappeto difendendo il diritto delle feste religiose di tutti, cercando un punto di ripartenza del senso civico di tutti, insegnando quel «linguaggio di verità», che il presidente ha evocato sul presente, sui vent’anni ultimi e che forse andrebbe spinto almeno indietro per poter produrre un rinnovamento vero della coscienza civica di tutti.
Qualcosa di limpido e impolitico come un tale atto di fede — con tutte le conseguenze di rigore e di trasparenza che esso comporta — darebbe ai vescovi o comunque accrescerebbe quella autorevolezza di cui hanno bisogno loro, spettatori di rimpianti e di lotte di carriera ecclesiastica spudorate: e di cui ha ancor più bisogno il Paese. Nei giorni più difficili della sua storia post-fascista — l’8 settembre del 1943, il 9 maggio del 1978 — l’Italia ha trovato nella Chiesa un sostegno infungibile e in quei gesti di coraggio la Chiesa ha guadagnato una credibilità capitalizzata per decenni. Nessuno può escludere che giorni, per fortuna diversi nella forma, ma non meno impegnativi nella sostanza, siano oggi innanzi al Paese.
in “Corriere della Sera” del 28 agosto 2011
Rassegna Stampa
.
30 agosto 2011
“«So bene – ha detto Bagnasco… – che il compito è arduo perché si tratta di intaccare consuetudini e interessi vetusti»… ha parlato di «reazione di disgusto» della gente semplice nei confronti, in politica, di «stili non esemplari che sono la norma»… Il vero uomo, ha detto il cardinale, non è quello che ha potere e denaro: «I giovani non vogliono essere ingannati»…”
“Per combattere la corruzione, tornata a galla nelle cronache di questi giorni, bisogna far capire con l’esempio che cos’è il valore della verità… essa va richiesta in modo particolare a coloro che costituiscono, per ruolo o visibilità, modelli di comportamento, [ma] è necessario interrogare in primo luogo se stessi… se abbiamo… la determinazione… di cercare al di là dell’apparenza, di fare fatica. Se si ha voglia, in sintesi, di essere consapevoli o servi”
“Gennaro Acquaviva, che è stato il plenipotenziario di Bettino Craxi per la revisione del Concordato del 1984… non chiede certo alla Chiesa di pensare a «una rinuncia, ma a una riduzione», questo sì, «per coerenza con lo scopo dell’8 per mille»… «Il metodo dei radicali non va bene perché non si può strattonare in questo modo un soggetto come la Chiesa cattolica che letteralmente tiene in piedi e unito il nostro Paese»… Sta alla Cei pensare il da farsi…”
.
29 agosto 2011
“in un momento di straordinaria gravità, non è lecito attendersi dalla Chiesa un qualcosa di più, un gesto unilaterale e di valore sostanziale e simbolico?”.
28 agosto 2011
- Economia e gratuità di Bernard Ginisty in www.garrigues-et-sentiers.org del 28 agosto 2011 (nostra traduzione)
“È una bellissima cosa che degli economisti ci ricordino che la gratuità non è ristretta in una parentesi vacanziera, ma che essa sola dà senso all’arte di vivere da esseri umani”
“Per la strategia liberista, che ha un’ossessiva paura della memoria, la gente deve dimenticare il suo passato sociale… senz’altro ideale che la religione del danaro. Sono da seppellire le aspirazioni condivise di una vita felice per tutti senza confini, il senso di compiutezza umana provato nel lottare insieme per la giustizia… la constatazione che la fatica e il sangue versato sono seme e nutrimento, la speranza contro ogni speranza, l’esperienza che il pane condiviso è pane moltiplicato e fonte di vita per tutti”
“In Cei lo ripetono da giorni: «E’ sbagliato confondere una tassa come l’Ici con l’otto per mille che è un’intesa tra lo Stato e le confessioni religiose». E una cosa è il Vaticano e un’altra le diocesi con le loro spese per culto e carità. Adesso la protesta esce dai Sacri Palazzi e diventa pubblica. Il quotidiano della Conferenza episcopale punta l’indice contro «Radicali, massoni e il potente partito dell’evasione»”
“Quel denaro però ha eroso qualcosa di assai più profondo per la Chiesa italiana: e cioè la sua fede nella povertà come via necessaria della Chiesa, secondo il limpido dettato della costituzione conciliare Lumen Gentium 8. (…) Così la scarsa fiducia, per dir così, nella povertà ha sottratto alla Chiesa una credibilità di cui oggi avrebbe bisogno, per essere nella svolta che stiamo vivendo fattore di unità profonda del Paese.”
“Per restare con i piedi per terra conviene ricordare pacatamente all’Avvenire che sul Fatto Quotidiano è stata posta sin dall’inizio una domanda fondamentale, che circola nelle teste di tanti cittadini credenti e diversamente credenti. La Chiesa è disponibile o no – di fronte al rischio di crack dell’Italia – a rinunciare volontariamente a una parte delle sovvenzioni statali derivanti dall’8 per mille, visto che tagli pesanti sono imposti a settori vitali come sanità, istruzione, enti locali? È una domanda non acrimoniosa, che nulla disconosce dell’impegno della Chiesa per i più deboli. “
“Oggi, la Chiesa ufficiale, quella del Vaticano e della Cei, è un potente sostegno al potere politico, qui da noi. E davanti a una mobilitazione della pubblica opinione, arcistufa dei privilegi fiscali che quel potere ha concesso al sistema ecclesiastico (una “leggenda nera”, secondo il quotidiano dei vescovi), il tirare in ballo il potere occulto della Massoneria suona a dir poco grottesco. Davvero, come ha scritto Avvenire, si tratta di “Qualcosa che impressiona””
“Impressionante la realtà dell’evasione fiscale. Impressionante la disattenzione verso quell’immenso e bistrattato valore e quella portentosa (ma non inesauribile) risorsa che è la famiglia, e la famiglia con figli. Impressionante la campagna politico-mediatica che è stata scatenata contro la Chiesa per il solo fatto di aver detto tutto questo”
.
27 agosto 2011
“è anche vero che spesso non c’è trasparenza nella gestione di tutte le risorse materiali della Chiesa cattolica. Un dibattito aperto e partecipato sulle scelte che è possibile operare e sui criteri da seguire alla luce del Vangelo sarebbe un passo importante.”
“Senza grandi gesti, in realtà, basterebbe che l’8×1000 fosse calcolato esattamente per il gettito che dà”
premesso tutto quanto già sta facendo per fronteggiare la crisi e le ragioni dell’attuale regime fiscale, è immaginabile qualche gesto simbolico e liberamente scelto da parte della Chiesa italiana per contribuire al risanamento del debito pubblico?
“Freneticamente alla ricerca di unità d’azione nel luglio scorso, l’associazionismo cattolico si è ammutolito dopo il decreto anticrisi. Eppure ci sarebbe molto da dire da parte cattolica sullo svuotamento dell’art.18 dello statuto dei lavoratori, sull’evasione fiscale, sui costi della politica. Stupisce particolarmente il silenzio sullo scardinamento – attraverso l’articolo 8 del decreto – del principio della “giusta causa” nei licenziamenti…”
“E’ in giuoco quell’impresa di riappropriazione “pubblica” dei “beni comuni” (al plurale) che pure è stata da più parti segnalata come l’indice di un vento nuovo fatto di insperata coscienza politica e di desiderio di partecipazione” “non va mollata la presa sul tema dei “beni comuni” come tessere di quel più vasto mosaico che è il massimo bene umano possibile, da realizzare non con la delega in bianco a qualcuno ma con il concorso consapevole e il controllo assiduo di tutti.”
26 agosto 2011
“”Possiamo rassicurare tutti, compreso Pierluigi Bersani: le mense della Caritas non si toccano e rimarranno esenti dalle fiscalità come del resto tutte le associazioni di assistenza e beneficenza”.” “L’intento del partito di Marco Pannella è quello di far abolire gli sgravi per le attività commerciali svolte da enti ecclesiastici, come per l’appunto quelle ricettivo-turistiche, assistenziali, ricreative, sportive e sanitarie, “equiparandoli a chi fa le stesse cose senza insegna religiosa””
“A questi ricchi italiani non si chiede la metà in solidarietà, ma solo un piccolo contribuito. E se hanno frodato il Fisco non si chiede loro il quadruplo, ma solo il giusto. Quella di Zaccheo è stata una conversione miracolosa. A questi ricchi si chiede solo una conversione all’equità e alla solidarietà semplicemente umane e all’osservanza delle leggi” “… Se n’è accorta finalmente anche la Conferenza episcopale italiana…”
“Anziché tassare i patrimoni dei ricchi, coloro ai quali anche un forte prelievo fiscale non cambierebbe la vita, s’è preferito colpire quell’ammortizzatore sociale italiano per eccellenza che è la famiglia. Unico vero patrimonio del Paese”