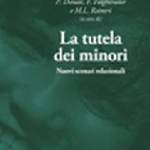Parte preziosa della Chiesa. Il segretario della Cei ha ricordato che “la franchezza e la fede, che ne è la premessa e il fondamento, hanno qualcosa da dire a noi credenti di oggi, soprattutto perché ci invitano a non avere paura di mettere a nudo la nostra poca fede e il nostro scarso coraggio”. “Sommersi da una cultura dai molti feticci, come quello della privacy – così verbosamente sbandierato e altrettanto prontamente mortificato nei fatti – dobbiamo rompere l’incantesimo di una perfino teorizzata dissociazione tra coscienza privata e vita sociale, tra comportamenti personali e ruolo pubblico”. Nel pomeriggio di ieri, mons. Crociata ha aperto i lavori con un saluto dedicato all’azione pastorale della Chiesa, “destinata a rimanere incompiuta se non sarà capace di integrare la dimensione sociale e politica”. “Ogni proposta di formazione si deve innestare in un più vasto percorso di educazione umana e di maturazione nella fede, e il lavoro che voi svolgete – ha aggiunto il segretario rivolgendosi ai direttori degli uffici diocesani di pastorale sociale, responsabili e operatori degli enti diocesani di formazione sociopolitica – somiglia tante volte alla pesca infruttuosa di cui parla l’evangelista Giovanni. La stagione che viviamo è anche motivo di grave riflessione per noi cattolici, perché rispecchia la grande difficoltà di delineare e lasciare intravedere, e tanto meno attuare adeguatamente, progetti ispirati alla nostra visione della persona e della società”. La Chiesa “vi sente parte preziosa, chiamata ad animare in senso cristiano il tempo che ci è stato donato di vivere”, abbracciando “tutte le dimensioni dell’umano”. Bisogna solo “avere fiducia che il lavoro di formazione svolto con intelligenza e passione non rimarrà senza frutto”.
Raggiungere l’uomo là dove è. Sul nesso tra temi sociali e fede cristiana si è soffermato don Paolo Asolan, docente di teologia pastorale alla Pontificia università lateranense: “Una visione cristiana compiuta non considera l’ambito sociale ed economico, e quindi anche politico, come corollario della pratica della carità; piuttosto, – ha detto – come suo connotato essenziale”. L’interesse per la dottrina sociale si collega al compito che “il Creatore affida ad Adamo, reso dal verbo ‘shamar’, che significa custodire”. In quest’ottica la Chiesa deve, dunque, “raggiungere l’uomo là dove nasce, studia, lavora, soffre, si ristora, per aiutare tutti gli uomini a scoprire la fecondità del Vangelo per la vita quotidiana, personale e sociale”. Secondo Asolan “è da rifiutare la concezione della Chiesa come agenzia fornitrice di servizi sociali sul territorio” perché “la fede cristiana non si limita ad alcune preziose forme di aiuto, ma tende a promuovere con impegno una autentica cultura di solidarietà. Non si rinchiude nel ruolo assistenziale, a cui la società comunemente la chiama, ma sviluppa un apporto originale e decisivo attraverso la sua Dottrina sociale”.
Imparare a formare. Una proposta di metodo per le scuole di formazione politica è stata presentata da Leonardo Bechetti, docente di economia politica all’Università di Tor Vergata, per il quale “l’avvizzimento della capacità di fiducia spiega la crisi delle nazione”. Tra le cause che ostacolano la formazione politica, il “riduzionismo antropologico”, che riduce l’uomo alla sua “soddisfazione materiale”, quello organizzativo, che si avvale di un “modello d’impresa che mortifica la diversità organizzativa”, e quello “nella misura del valore”, che non tiene conto del fatto che la ricchezza delle nazioni “non coincide col flusso di beni e servizi economici creati ma con lo stock di beni spirituali, culturali, relazioni, naturali ed economici di una comunità”. Se ciò che serve è “un effettivo cambiamento di mentalità per cercare il vero, il bello e il buono”, occorre “sollecitare le istituzioni a cambiare, costruire indicatori, identificare vie di partecipazione economica e politica attraverso i quali tutti i cittadini possono essere protagonisti del cambiamento verso il bene comune” mediante, ad esempio, bilanci partecipati e gruppi di acquisto solidale. Tra le altre proposte, “identificare nelle esperienze delle amministrazioni locali le migliori pratiche organizzative e riflettere sulla nostra visione di Europa e di regole a livello internazionale per il bene comune”.
ARTICOLI CORRELATI:
Crociata: la fede abbracci tutte le dimensioni
«Dobbiamo riflettere attentamente sui limiti di una presenza sociale e politica dei cattolici oggi da più parti stigmatizzata». Così oggi si è espresso il vescovo Mariano Crociata, segretario generale della Conferenza episcopale italiana, in occasione della seconda giornata del convegno «Educare alla cittadinanza responsabile 2» che coinvolge le scuole di formazione sociopolitica.
Parole che invitano a porsi alcuni interrogativi, soprattutto nel passaggio che richiama al centro del dibattito politico e sociale il ruolo dei cattolici nella società. «Non può essere il vortice disordinato delle opinioni, più o meno interessate e indirizzate a bella posta – ha proseguito il presule -, a dettare l’agenda e i criteri dei nostri giudizi sulla rilevanza sociale e politica del cattolicesimo nel momento attuale; ma è certo che il deficit di incidenza diventa un indice anch’esso significativo quando è carente la capacità di mobilitazione, l’elaborazione di un progetto ispirato, l’assenza di strumenti socialmente e politicamente significativi per testimoniare e trasmettere il senso cristiano della vita sociale nelle sue varie articolazioni».
Un altro delicato passaggio, e al tempo stesso incisivo, il vescovo Crociata lo ha ricordato stamani, nell’omelia della Messa celebrata alla Domus Mariae a Roma, richiamando all’importanza della testimonianza della fede. «La franchezza e la fede, che ne è la premessa e il fondamento – ha osservato il presule – hanno qualcosa da dire a noi credenti di oggi, soprattutto perché ci invitano a non avere paura di mettere a nudo la nostra poca fede e il nostro scarso coraggio».
«Sommersi da una cultura dai molti feticci, come quello della privacy – così verbosamente sbandierato e altrettanto prontamente mortificato nei fatti – dobbiamo rompere l’incantesimo di una perfino teorizzata dissociazione tra coscienza privata e vita sociale, tra comportamenti personali e ruolo pubblico», ha continuato Crociata. «Dallo sforzo verso una coerenza a tutto tondo deve scaturire un percorso che progressivamente superi l’emarginazione nel privato delle ispirazioni ideali – ha aggiunto – e attesti con coraggio le motivazioni che conducono a scelte e comportamenti dal palese rilievo sociale e pubblico».
Per il vescovo, infine, «non bisogna lasciarsi intimorire da momenti di appannamento; ci sono fasi oscure da attraversare; ma non dobbiamo lasciarci sopraffare dalle difficoltà momentanee. Questo è il tempo opportuno del lavorio nascosto ma fecondo della formazione e della maturazione di persone e di comunità dotate di franchezza e della capacità di portare una fede motivata e solida dentro l’intreccio, talora perfino caotico, dell’intera comunità civile».
Il saluto nella giornata di apertura del convegno. Dopo l’esortazione a «tenere vivo e coordinare l’impegno di formazione sociale e politica portato avanti in varie forme nelle nostre Chiese d’Italia» e l’impartizione della «benedizione su di voi e sui vostri lavori», il vescovo Mariano Crociato, segretario generale della Conferenza episcopale italiana ha salutato nella giornata inaugurale del convegno della scuole di formazione sociopolitica, con alcune riflessioni sulla «stagione che viviamo noi cattolici», che «rispecchia la grande difficoltà di delineare e lasciare intravedere, e tanto meno attuare adeguatamente, progetti ispirati alla nostra visione della persona e della società. Ma la molla che ci spinge non è armata da ingegnosa inventiva o da circostanze di favore, bensì predisposta innanzitutto dalla Parola che dice: gettate le reti e troverete».
«La vostra presenza qui è il segno che avete accolto l’invito del Signore e continuerete a farlo» ha proseguito il vescovo Crociata.
«Mentre ci rendiamo conto che ogni proposta di formazione si deve innestare in un più vasto percorso di educazione umana e di maturazione nella fede, ci rafforziamo nella convinzione che l’azione pastorale della Chiesa è destinata a rimanere incompiuta se non sarà capace di integrare la dimensione sociale e politica. Ciò corrisponde a una integrità di fede che, abbracciando tutte le dimensioni dell’umano, in esse è chiamata a esplicarsi e fare frutto».
Nel finale dell’intervento di ieri, l’invito rivolto dal segretario generale della Cei a tutti i presenti al convegno dal titolo «Educare alla cittadinanza responsabile 2», a portare avanti quest’impegno con la grazia di Dio e il sostegno della Chiesa «che vi sente parte preziosa chiamata ad animare di senso cristiano il tempo che ci è stato donato di vivere».