
7° video: don Rinaldo Paganelli S.C.I.
– docente invitato di catechetica presso la facoltà di Scienze dell’Educazione dell’UPS di Roma
Visualizza i video precedenti:

«“Lodate Dio” è il nome di questa lettera. Perché un essere umano che pretende di sostituirsi a Dio diventa il peggior pericolo per sé stesso». Con queste parole si conclude la nuova esortazione apostolica di Papa Francesco, pubblicata il 4 ottobre, festa del Santo di Assisi. Un testo in continuità con la più ampia enciclica Laudato si’ del 2015. In 6 capitoli e 73 paragrafi il Successore di Pietro intende specificare e completare quanto già affermato nel precedente testo sull’ecologia integrale, e al tempo stesso lanciare un allarme e una chiamata alla corresponsabilità di fronte all’emergenza del cambiamento climatico, prima che sia troppo tardi. L’esortazione guarda in particolare alla COP28 che si terrà a Dubai tra fine novembre e inizi di dicembre. Il Pontefice scrive: «Con il passare del tempo, mi rendo conto che non reagiamo abbastanza, poiché il mondo che ci accoglie si sta sgretolando e forse si sta avvicinando a un punto di rottura» e «non c’è dubbio che l’impatto del cambiamento climatico danneggerà sempre più la vita di molte persone e famiglie» (2). È una «delle principali sfide che la società e la comunità globale devono affrontare» e «gli effetti del cambiamento climatico sono subiti dalle persone più vulnerabili, sia in patria che nel mondo»
Il primo capitolo è dedicato alla crisi climatica globale. «Per quanto si cerchi di negarli, nasconderli, dissimularli o relativizzarli, i segni del cambiamento climatico sono lì, sempre più evidenti» spiega il Papa. Che osserva come «negli ultimi anni abbiamo assistito a fenomeni estremi, frequenti periodi di caldo anomalo, siccità e altri lamenti della terra», una «malattia silenziosa che colpisce tutti noi». Inoltre Francesco afferma: «è verificabile che alcuni cambiamenti climatici indotti dall’uomo aumentano significativamente la probabilità di eventi estremi più frequenti e più intensi». Il Pontefice, dopo aver ricordato che se si superano i 2 gradi di aumento della temperatura «le calotte glaciali della Groenlandia e di gran parte dell’Antartide si scioglieranno completamente, con conseguenze enormi e molto gravi per tutti» (5), a proposito di chi minimizza il cambiamento climatico, risponde: «quello a cui stiamo assistendo ora è un’insolita accelerazione del riscaldamento, con una velocità tale che basta una sola generazione – non secoli o millenni – per accorgersene». «Probabilmente tra pochi anni molte popolazioni dovranno spostare le loro case a causa di questi eventi» (6). Anche i freddi estremi sono «espressioni alternative della stessa causa» (7).
«Nel tentativo di semplificare la realtà – scrive Francesco – non mancano coloro che incolpano i poveri di avere troppi figli e cercano di risolvere il problema mutilando le donne dei Paesi meno sviluppati. Come al solito, sembrerebbe che la colpa sia dei poveri. Ma la realtà è che una bassa percentuale più ricca della popolazione mondiale inquina di più rispetto al 50% di quella più povera e che le emissioni pro capite dei Paesi più ricchi sono di molto superiori a quelle dei più poveri. Come dimenticare che l’Africa, che ospita più della metà delle persone più povere del mondo, è responsabile solo di una minima parte delle emissioni storiche?» (9).
Il Papa mette a tema anche la posizione di chi dice che gli sforzi per mitigare il cambiamento climatico riducendo l’uso di combustibili fossili «porteranno a una riduzione dei posti di lavoro». Ciò che sta accadendo, in realtà «è che milioni di persone perdono il lavoro a causa delle varie conseguenze del cambiamento climatico: l’innalzamento del livello del mare, la siccità e molti altri fenomeni che colpiscono il pianeta hanno lasciato parecchia gente alla deriva». Mentre «la transizione verso forme di energia rinnovabile, ben gestita» è in grado «di generare innumerevoli posti di lavoro in diversi settori. Per questo è necessario che i politici e gli imprenditori se ne occupino subito» (10).
«L’origine umana – “antropica” – del cambiamento climatico non può più essere messa in dubbio» afferma Francesco. «La concentrazione dei gas serra nell’atmosfera… è rimasta stabile fino al XIX secolo… Negli ultimi cinquant’anni l’aumento ha subito una forte accelerazione» (11). Allo stesso tempo la temperatura «è aumentata a una velocità inedita, senza precedenti negli ultimi duemila anni. In questo periodo la tendenza è stata di un riscaldamento di 0,15 gradi centigradi per decennio, il doppio rispetto agli ultimi 150 anni… A questo ritmo, solo tra dieci anni raggiungeremo il limite massimo globale auspicabile di 1,5 gradi centigradi» (12). Con conseguente acidificazione dei mari e scioglimento dei ghiacci. La coincidenza fra questi eventi e la crescita di emissioni di gas serra «non può essere nascosta. La stragrande maggioranza degli studiosi del clima sostiene questa correlazione e solo una minima percentuale di essi tenta di negare tale evidenza». Purtroppo, osserva amaramente il Pontefice, «la crisi climatica non è propriamente una questione che interessi alle grandi potenze economiche, che si preoccupano di ottenere il massimo profitto al minor costo e nel minor tempo possibili» (13).
«Sono costretto – continua Francesco – a fare queste precisazioni, che possono sembrare ovvie, a causa di certe opinioni sprezzanti e irragionevoli che trovo anche all’interno della Chiesa cattolica. Ma non possiamo più dubitare che la ragione dell’insolita velocità di così pericolosi cambiamenti sia un fatto innegabile: gli enormi sviluppi connessi allo sfrenato intervento umano sulla natura» (14). Purtroppo alcune manifestazioni di questa crisi climatica sono già irreversibili per almeno centinaia di anni, mentre «lo scioglimento dei poli non può essere invertito per centinaia o migliaia di anni» (16). Siamo dunque appena in tempo per evitare danni ancora più drammatici. Il Papa scrive che «alcune diagnosi apocalittiche sembrano spesso irragionevoli o non sufficientemente fondate», ma «non possiamo dire con certezza» ciò che accadrà (17). È quindi «urgente una visione più ampia… Non ci viene chiesto nulla di più che una certa responsabilità per l’eredità che lasceremo dietro di noi dopo il nostro passaggio in questo mondo» (18). Ricordando l’esperienza della pandemia di Covid-19 Francesco ripete «Tutto è collegato e nessuno si salva da solo» (19).
Nel secondo capitolo Francesco parla del paradigma tecnocratico che «consiste nel pensare come se la realtà, il bene e la verità sbocciassero spontaneamente dal potere stesso della tecnologia e dell’economia» (20) e «si nutre mostruosamente di sé stesso» (21) basandosi sull’idea di un essere umano senza limiti. «Mai l’umanità ha avuto tanto potere su sé stessa e niente garantisce che lo utilizzerà bene, soprattutto se si considera il modo in cui se ne sta servendo… È terribilmente rischioso che esso risieda in una piccola parte dell’umanità» (23). Purtroppo, come insegna anche la bomba atomica, «l’immensa crescita tecnologica non è stata accompagnata da uno sviluppo dell’essere umano per quanto riguarda la responsabilità, i valori e la coscienza» (24). Il Papa ribadisce che «il mondo che ci circonda non è un oggetto di sfruttamento, di uso sfrenato, di ambizione illimitata» (25). Ricorda pure che noi siamo inclusi nella natura, e «ciò esclude l’idea che l’essere umano sia un estraneo, un fattore esterno capace solo di danneggiare l’ambiente. Dev’essere considerato come parte della natura» (26); «i gruppi umani hanno spesso “creato” l’ambiente» (27).
Abbiamo compiuto «progressi tecnologici impressionanti e sorprendenti, e non ci rendiamo conto che allo stesso tempo siamo diventati altamente pericolosi, capaci di mettere a repentaglio la vita di molti esseri e la nostra stessa sopravvivenza» (28). «La decadenza etica del potere reale è mascherata dal marketing e dalla falsa informazione, meccanismi utili nelle mani di chi ha maggiori risorse per influenzare l’opinione pubblica attraverso di essi». Grazie a questi meccanismi si convincono gli abitanti delle zone dove si vogliono realizzare progetti inquinanti illudendoli che si potranno generare delle opportunità economiche e occupazionali ma «non viene detto loro chiaramente che in seguito a tale progetto» resterà «una terra devastata» (29) e condizioni di vita molto più sfavorevoli. «La logica del massimo profitto al minimo costo, mascherata da razionalità, progresso e promesse illusorie, rende impossibile qualsiasi sincera preoccupazione per la casa comune e qualsiasi attenzione per la promozione degli scartati della società… Estasiati davanti alle promesse di tanti falsi profeti, i poveri stessi a volte cadono nell’inganno di un mondo che non viene costruito per loro» (31). Esiste «un dominio di coloro che sono nati con migliori condizioni di sviluppo» (32). Francesco li invita a chiedersi, «di fronte ai figli che pagheranno per i danni delle loro azioni», quale sia il senso della loro vita (33).
Nel capitolo successivo dell’esortazione il Papa affronta il tema della debolezza della politica internazionale, insistendo sulla necessità di favorire «gli accordi multilaterali tra gli Stati» (34). Spiega che «quando si parla della possibilità di qualche forma di autorità mondiale regolata dal diritto, non necessariamente si deve pensare a un’autorità personale» ma di «organizzazioni mondiali più efficaci, dotate di autorità per assicurare il bene comune mondiale, lo sradicamento della fame e della miseria e la difesa certa dei diritti umani fondamentali». Che «devono essere dotate di una reale autorità per “assicurare” la realizzazione di alcuni obiettivi irrinunciabili» (35). Francesco deplora che «le crisi globali vengano sprecate quando sarebbero l’occasione per apportare cambiamenti salutari. È quello che è successo nella crisi finanziaria del 2007-2008 e che si è ripetuto nella crisi del Covid-19», che hanno portato «maggiore individualismo, minore integrazione, maggiore libertà per i veri potenti, che trovano sempre il modo di uscire indenni» (36). «Più che salvare il vecchio multilateralismo, sembra che oggi la sfida sia quella di riconfigurarlo e ricrearlo alla luce della nuova situazione globale» (37) riconoscendo che tante aggregazioni e organizzazioni della società civile aiutano a compensare le debolezze della Comunità internazionale. Il Papa cita il processo di Ottawa sulle mine antiuomo che mostra come la società civile crea dinamiche efficienti che l’ONU non raggiunge.
Quello proposto da Francesco è «un multilateralismo “dal basso” e non semplicemente deciso dalle élite del potere… È auspicabile che ciò accada per quanto riguarda la crisi climatica. Perciò ribadisco che se i cittadini non controllano il potere politico – nazionale, regionale e municipale – neppure è possibile un contrasto dei danni ambientali» (38). Dopo aver riaffermato il primato della persona umana e sulla difesa della sua dignità al di là di ogni circostanza, Francesco spiega che «non si tratta di sostituire la politica, perché… le potenze emergenti stanno diventando sempre più rilevanti». «Proprio il fatto che le risposte ai problemi possano venire da qualsiasi Paese, per quanto piccolo, conduce a riconoscere il multilateralismo come una strada inevitabile» (40). È necessario dunque «quadro diverso per una cooperazione efficace. Non basta pensare agli equilibri di potere, ma anche alla necessità di rispondere alle nuove sfide e di reagire con meccanismi globali». Servono «regole universali ed efficienti» (42). «Tutto ciò presuppone che si attui una nuova procedura per il processo decisionale»; servono «spazi di conversazione, consultazione, arbitrato, risoluzione dei conflitti, supervisione e, in sintesi, una sorta di maggiore “democratizzazione” nella sfera globale, per esprimere e includere le diverse situazioni. Non sarà più utile sostenere istituzioni che preservino i diritti dei più forti senza occuparsi dei diritti di tutti» (43).
Nel capitolo seguente Francesco descrive le diverse conferenze sul clima tenutesi fino ad oggi. Ricorda quella di Parigi, il cui accordo è entrato in vigore nel novembre 2016, ma «pur essendo vincolante, non tutti i requisiti sono obblighi in senso stretto e alcuni di essi lasciano spazio a un’ampia discrezionalità» (47), non sono previste sanzioni per gli obblighi non rispettati e mancano strumenti efficaci per farla osservare, non prevede sanzioni vere e proprie e non ci sono strumenti efficaci per garantirne l’osservanza. E «si sta ancora lavorando per stabilire procedure concrete di monitoraggio e fornire criteri generali per confrontare gli obiettivi dei diversi Paesi» (48). Il Papa accenna alla delusione per la COP di Madrid e ricorda che quella di Glasgow ha rilanciato gli obiettivi di Parigi, con molte “esortazioni”, ma «le proposte volte a garantire una transizione rapida ed efficace verso forme di energia alternativa e meno inquinante non sono riuscite a fare progressi» (49). La COP27 in Egitto del 2022 «è stata un ulteriore esempio della difficoltà dei negoziati» e anche se ha prodotto «almeno un progresso nel consolidamento del sistema di finanziamento per le “perdite e i danni” nei Paesi più colpiti dai disastri climatici» (51) anche su questo molti punti sono rimasti “imprecisi”. I negoziati internazionali «non possono avanzare in maniera significativa a causa delle posizioni dei Paesi che privilegiano i propri interessi nazionali rispetto al bene comune globale. Quanti subiranno le conseguenze che noi tentiamo di dissimulare, ricorderanno questa mancanza di coscienza e di responsabilità» (52).
Guardando alla COP28 Francesco scrive che «dire che non bisogna aspettarsi nulla sarebbe autolesionistico, perché significherebbe esporre tutta l’umanità, specialmente i più poveri, ai peggiori impatti del cambiamento climatico» (53). «Non possiamo rinunciare a sognare che la COP28 porti a una decisa accelerazione della transizione energetica, con impegni efficaci che possano essere monitorati in modo permanente. Questa Conferenza può essere un punto di svolta» (54). Il Papa osserva che «la necessaria transizione verso energie pulite… abbandonando i combustibili fossili, non sta procedendo abbastanza velocemente. Di conseguenza, ciò che si sta facendo rischia di essere interpretato solo come un gioco per distrarre» (55). Non si può cercare soltanto un rimedio tecnico ai problemi, «corriamo il rischio di rimanere bloccati nella logica di rattoppare… mentre sotto sotto va avanti un processo di deterioramento che continuiamo ad alimentare» (57).
Francesco chiede di porre fine «all’irresponsabile presa in giro che presenta la questione come solo ambientale, “verde”, romantica, spesso ridicolizzata per interessi economici. Ammettiamo finalmente che si tratta di un problema umano e sociale in senso ampio e a vari livelli. Per questo si richiede un coinvolgimento di tutti». A proposito delle proteste dei gruppi radicalizzati, il Papa afferma che «essi occupano un vuoto della società nel suo complesso, che dovrebbe esercitare una sana pressione, perché spetta a ogni famiglia pensare che è in gioco il futuro dei propri figli» (58). Il Pontefice auspica che dalla COP28 emergano «forme vincolanti di transizione energetica» che siano efficienti, «vincolanti e facilmente monitorabili» (59). «Speriamo che quanti interverranno siano strateghi capaci di pensare al bene comune e al futuro dei loro figli, piuttosto che agli interessi di circostanza di qualche Paese o azienda. Possano così mostrare la nobiltà della politica e non la sua vergogna… Ai potenti oso ripetere questa domanda: “Perché si vuole mantenere oggi un potere che sarà ricordato per la sua incapacità di intervenire quando era urgente e necessario farlo?”» (60).
Infine il Papa ricorda che le motivazioni di questo impegno scaturiscono dalla fede cristiana, incoraggiando «i fratelli e le sorelle di altre religioni a fare lo stesso» (61). «La visione giudaico-cristiana del mondo sostiene il valore peculiare e centrale dell’essere umano in mezzo al meraviglioso concerto di tutti gli esseri». «Noi tutti esseri dell’universo siamo uniti da legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia universale, una comunione sublime che ci spinge ad un rispetto sacro, amorevole e umile» (67). «Questo non è un prodotto della nostra volontà, ha un’altra origine che si trova alla radice del nostro essere, perché Dio ci ha unito tanto strettamente al mondo che ci circonda» (68). Ciò che conta, scrive Francesco è ricordare che «non ci sono cambiamenti duraturi senza cambiamenti culturali, senza una maturazione del modo di vivere e delle convinzioni sociali, e non ci sono cambiamenti culturali senza cambiamenti nelle persone» (70). «Gli sforzi delle famiglie per inquinare meno, ridurre gli sprechi, consumare in modo oculato, stanno creando una nuova cultura. Il semplice fatto di cambiare le abitudini personali, familiari e comunitarie» contribuisce «a realizzare grandi processi di trasformazione che operano dal profondo della società» (71). Il Pontefice conclude la sua esortazione ricordando che «le emissioni pro capite negli Stati Uniti sono circa il doppio di quelle di un abitante della Cina e circa sette volte maggiori rispetto alla media dei Paesi più poveri». E afferma che «un cambiamento diffuso dello stile di vita irresponsabile legato al modello occidentale avrebbe un impatto significativo a lungo termine. Così, con le indispensabili decisioni politiche, saremmo sulla strada della cura reciproca» (72).

Molti dei gruppi sono stati ritardati dal traffico nella capitale portoghese e sono arrivati in ritardo per la messa. Sotto un cielo nuvoloso ma ancora estivo, i giovani si sono riuniti per la prima volta in un’atmosfera amichevole dove si sono mescolate oltre 200 nazionalità: un record per una GMG .
Al suono di una potente orchestra e di un coro, decine di sacerdoti e vescovi hanno preso posto sul palco costruito per l’occasione, sul quale era stato collocato un altare. Alla vigilia dell’arrivo di papa Francesco a Lisbona, il cardinale Clemente, 75 anni, ha presieduto la messa e ha accolto i 354.000 giovani iscritti ufficialmente nella sua veste di arcivescovo della città.
Nell’omelia il Patriarca di Lisbona ha ripreso il tema della Gmg di quest’anno: “Maria si alzò e partì in fretta”. “Anche voi siete partiti. Per molti è stato un viaggio difficile per la distanza, i collegamenti e i costi che il viaggio richiedeva”, ha riconosciuto, sottolineando la solidarietà che ha permesso ad alcuni pellegrini di raggiungere il Portogallo.
A questi giovani nati nell’era digitale ha spiegato che il virtuale «ci tiene seduti». “Al contrario, la realtà consiste nell’andare incontro agli altri e al mondo così com’è, per ammirarlo e migliorarlo”, ha insistito.
Il Patriarca ha parlato anche della “urgente necessità di annunciare” il messaggio cristiano. Ma «un’urgenza serena e senza calpestio», ha aggiunto. Infine, il cardinale Clemente ha usato l’esempio del saluto di Maria alla cugina Elisabetta nel Vangelo per insegnare ai giovani. “Impariamo da Maria a salutare ogni persona. Mettiamola in pratica intensamente durante questa Giornata Mondiale della Gioventù”, ha raccomandato, sostenendo che “il mondo nuovo comincia nella novità di ogni incontro e nella sincerità del saluto che ci scambiamo”.
La messa si è conclusa con la sigla ufficiale della Gmg di Lisbona, “Há Pressa no Ar” (“C’è fretta nell’aria”), ripresa dalle migliaia di fedeli e dallo sventolamento di migliaia di bandiere.
Domani Papa Francesco arriverà a Lisbona alle 10 (ora locale). Prima saluterà i leader del Paese. Al termine della giornata incontrerà il clero per i vespri e l’omelia.

Il testo, che si intitola “Si avvicinò e camminava con loro” e si compone di tre parti, offre alcune riflessioni suscitate dal racconto di Emmaus – icona scelta per questo anno – e presenta elementi metodologici per valorizzare la grande ricchezza del lavoro finora svolto. Si tratta infatti di proseguire nel percorso avviato, rafforzando l’esercizio del discernimento a partire dai temi e dalle domande proposte nelle Linee guida e indicando decisioni possibili, impegni, aspetti ancora da sviluppare. Il documento evidenzia cinque macro-temi, che raggruppano le istanze raccolte nel biennio dedicato all’ascolto: 1) la missione secondo lo stile di prossimità; 2) il linguaggio e la comunicazione; 3) la formazione alla fede e alla vita; 4) la sinodalità e la corresponsabilità; 5) il cambiamento delle strutture. Ogni macro-tema si articola in alcuni sotto-temi che esplicitano le questioni emerse. Una sola domanda per ciascun tema sollecita la riflessione e chiama le comunità al discernimento. Nelle prossime settimane seguiranno alcune schede operative.
“Queste Linee guida, facendo tesoro del biennio narrativo – sottolinea il Consiglio Episcopale Permanente nell’introduzione al documento – gettano un ponte verso la fase profetica, incamminando le Chiese in Italia verso un discernimento operativo che prepari il terreno alle decisioni, necessariamente orientate a un rinnovamento ecclesiale e mai introverse; anche quando l’attenzione è puntata sulla vita interna delle nostre comunità, il pensiero è sempre quello estroverso della missione: rendere più agili alcune dinamiche ecclesiali (dottrinali, pastorali, giuridiche, amministrative) per rendere più efficace l’incontro tra il Vangelo, energia vivificante e perenne, e l’umanità di oggi”. Soprattutto in un tempo in cui “i lavori sinodali si intrecciano con i problemi e i drammi di ciascuno, che sono i problemi e i drammi del mondo: gli strascichi sanitari, economici e sociali della pandemia, il clima di guerra tragicamente ravvivatosi, le crisi ambientali, occupazionali, esistenziali. Un senso di precarietà e di smarrimento avvolge molte persone e famiglie nel nostro Paese”.
Il testo – che si arricchisce di alcune infografiche – contiene infine il Cronoprogramma con l’agenda delle tappe e degli appuntamenti che condurranno all’apertura della fase profetica nel maggio 2024.

Segnaliamo alcune iniziative formative dell’ ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE DELLA TOSCANA “Santa Caterina da Siena”

Vatican News
Il primo era stato un inedito per Papa Francesco in occasione dei dieci anni di pontificato. Quattro mesi dopo il primo Popecast, Papa Francesco si mette di nuovo in gioco con una delle forme di comunicazione più congeniali alle nuove generazioni: il podcast. “Il podcast? Sì, ora me lo ricordo!”. Proprio con i giovani il Pontefice si mette in relazione, in vista della Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, per il nuovo Popecast realizzato da Salvatore Cernuzio, in collaborazione con la redazione podcast.
Non un classico botta e risposta, ma un dialogo ideale in cui il Papa si pone in ascolto, attraverso un computer portato a Casa Santa Marta, della voce registrata di alcuni ragazzi e ragazze dalla di diversa provenienza e dal diverso background, rappresentanti delle fragilità ma anche della creatività che caratterizzano la gioventù di oggi. Giovani che, senza sapere all’inizio che la loro voce sarebbe stata ascoltata dal Papa, hanno condiviso la loro storia, le loro paure e problematiche, i loro desideri e obiettivi, liberamente e senza alcuna edulcorazione.
Francesco offre a tutti una parola, sempre diversa, come diversa è la storia di ognuno. A tutti però consegna la stessa raccomandazione: “Avanti”. Sempre avanti, anche negli sbagli e nelle cadute, nella certezza di essere accompagnati da un Dio che è “pazzo d’amore” per i giovani.
Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano
“Esta es la juventud del Papa…”
Chi è la gioventù del Papa? Chi sono i giovani oggi? Dal macrocosmo della Gmg – la prossima a Lisbona – difficile forse entrare nelle sfumature di una generazione caratterizzata dall’avanzare delle tecnologie, segnata da tante fragilità, ma che si contraddistingue anche per la voglia di fare, di scoprire, reinventarsi. A farsi colori di generazioni policromatiche come la Gen Z, la Gen X, i millennials, sono Giona, disabile e transessuale, Edward e Valerij, in carcere per furti e rapine, Arianna, affetta da disturbo bipolare che si rifugia nel sonno per sfuggire alle angosce della vita, Giuseppe, che trascorre gran parte delle giornate ai videogames, e tanti altri di cui non conosciamo il volto, ma solo le ferite, le paure, i desideri, i progetti. Li hanno condivisi loro in un podcast.
“Il podcast? Sì, me lo ricordo”, risponde Francesco. Il primo era stato a marzo per i dieci anni di pontificato. La proposta è stata di una seconda puntata in vista della Gmg, dove i protagonisti sono ragazzi e ragazze dal diverso background, i quali, quando hanno parlato, non sapevano ancora che la loro voce sarebbe risuonata dalle casse di un computer a Casa Santa Marta. C’è quindi tutta la genuinità di persone che si sfogano, si raccontano, si confidano. Davanti a quel computer è seduto il Successore di Pietro che ogni tanto fa una smorfia di dolore quando sente parole come suicidio, condanna, emarginazione. Sorride davanti alla diversità degli accenti. La preoccupazione è di dare a tutti una parola. E quella parola è sempre “Dio”, orizzonte della vita. L’altra è “avanti”.
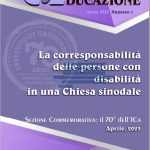
La corresponsabilità delle persone con disabilità in una Chiesa sinodale
Sezione Commemorativa: il 70° dell’ICA
Aprile 2023
ACCEDI ALLA RIVISTA ONLINE nella sezione “CATECHETICA ED EDUCAZIONE”
La rivista Catechetica ed Educazione ha avviato una riflessione sul mondo delle persone con disabilità (PcD) che ha portato dapprima a considerare il concetto di “inclusione” (1/2021) e poi quello di “appartenenza” (1/2022). Il secondo argomento ha avuto, tra gli esiti, quello di considerare riduttiva la mentalità diffusa che vede le PcD semplicemente portatrici di diritti – che pure devono essere salvaguardati dal punto di vista giuridico – ma non riconosce loro dei doveri, cioè quell’assunzione di responsabilità che le rende autenticamente protagoniste nella trasformazione qualitativa della loro esistenza e dell’intera società.
Il cammino di avvicinamento alla celebrazione del Sinodo dei Vescovi, con il richiamo forte alla corresponsabilità di tutti gli uomini e donne di buona volontà, si offre come un’occasione da non perdere per una riflessione sull’apporto che le PcD possono dare alla Chiesa e alla società. È su queste basi che viene pensato il presente fascicolo dal titolo: La corresponsabilità delle persone con disabilità in una Chiesa sinodale.
È una tematica complessa che contempla diversi aspetti dal punto di vista ecclesiale, educativo e catechetico-pastorale, che sono gli ambiti di cui si occupa la rivista, con riferimento alle PcD.
Introduce il fascicolo il contributo di Gilles Routhier, Dix ans d’appels à la coresponsabilité du pape François. L’ecclesiologo canadese rintraccia alcuni principi teologici che fondano il pensiero sulla corresponsabilità dell’attuale Pontefice, il quale fin dal giorno dell’elezione, con la richiesta «Pregate il Signore perché mi benedica», ha voluto coinvolgere l’intero popolo di Dio nel suo ministero e ha indicato uno stile di essere Chiesa che ne rispetti l’autentica natura e possa diventare modello per la prassi delle comunità cristiane di oggi.
Nell’articolo successivo, Camminare insieme. Il cammino sinodale con le PcD per promuovere consapevolezza, responsabilità e partecipazione, il pedagogista sociale Andrea Zampetti, avendo come sfondo gli attuali lavori sinodali, riflette sui passi da compiere per rendere le comunità e le PcD progressivamente consapevoli dell’essere ognuno-dono-per-tutti e, di conseguenza, secondo le possibilità di ciascuno, responsabile e protagonista attivo nel quotidiano.
Seguono due contributi di taglio antropologico a partire da due punti di vista differenti: il primo, in prospettiva filosofica, Dall’essere responsabili all’essere chi-amanti. Nell’universale umano, la particolare questione della disabilità intellettiva, della filosofa Annalisa Caputo, avendo come orizzonte il pensiero di P. Ricoeur, riflette sull’ambiguità del concetto di “responsabilità” e propone l’idea di “responsabilità fragile” (e di “fragilità responsabile”); la responsabilità viene vista come “risposta a una chiamata”, una risposta che, a sua volta – in modo circolare – diviene appello, rendendo ogni persona (chi)amante e non solo (chi)amata. Tali riflessioni sono quindi applicate alle PcD intellettiva grave, per le quali si può parlare di “responsabilità dissimetrica”.
La statunitense Anne Masters, nel suo intervento dal punto di vista teolo-gico, Promoting Responsibility of Persons with Disabilities within a Renewed Theologi-cal Anthropology, afferma che la responsabilità umana è parte integrante del rispetto della dignità di ogni persona, ciascuna creata a immagine di Dio. Le PcD, però, spesso non sono considerate soggetti responsabili nella vita della comunità. Su di loro sono ancora diffuse narrazioni riduttive che riflettono stereotipi obso-leti e/o sentimentali che le ritraggono come oggetti di cura, preoccupazione o addirittura disprezzo, piuttosto che protagonisti responsabili. L’articolo attesta la capacità delle PcD di assumere oneri, pur nella consapevolezza della natura evolutiva della responsabilità.
Luca Badetti, con un background interdisciplinare in disability studies, psicologia clinica e teologia, nel suo contributo, Living out participation. Growing in confidence and belonging, offre una riflessione approfondita su cosa significhi realmente il termine “partecipazione”. Egli propone alcune modalità attraverso le quali la partecipazione delle PcD può essere incoraggiata e sostenuta nella vita individuale e sociale e nella vita della Chiesa. I risultati possono essere raggiunti tramite lo sviluppo delle capacità di autodeterminazione, facendo parte di un gruppo di auto-difesa, rivendicando un’identità positiva di disabilità, crescendo in competenza relazionale e vivendo l’appartenenza.
Andrea Farina affronta la tematica della responsabilità dal punto di vista giuridico. Nel suo intervento, Le persone con disabilità e il concetto di responsabilità. Prospettive giuridiche, alla luce degli sviluppi che storicamente hanno portato all’affermarsi del modello bio-psico-sociale che considera la disabilità quale condizione di salute in un ambiente sfavorevole, il tema delle PcD viene inquadrato all’interno del rapporto diritti-dignità umana, elemento che costituisce la premessa indispensabile per la successiva riflessione sul concetto di responsabilità delle PcD inteso come autodeterminazione, come esercizio dei propri diritti e doveri in tutti gli ambiti di vita.
Seguono due articoli su dei luoghi emblematici per l’accoglienza e la partecipazione: la parrocchia e le Residenze Sanitarie per Disabili (RSD). Ubaldo Montisci, La parrocchia, comunità che accoglie: attese, responsabilità e opportunità, dopo aver richiamato il significato della parrocchia per la vita dei credenti, esamina alcune delle principali difficoltà che essa deve affrontare al momento presente e indica le condizioni che rendono possibile e visibile il suo impegno per l’accoglienza, l’inclusione e la partecipazione di chi a lei si rivolge.
Il tema della funzione sociale delle RSD è al centro del dibattito politico in Italia ed è una questione spinosa. Federica Floris, con il contributo Le Residenze sanitarie per Disabili come spazio di corresponsabilità per le persone con disabilità grave, pone in stretta relazione il rapporto tra le persone e l’ambiente in cui vivono e riflette sull’influsso che può avere tale correlazione sulla Qualità di Vita (QdV) delle PcD. La convinzione di fondo è che, per ottenere un livello soddisfacente di QdV, sia necessario affiancare la PcD con un Progetto di Vita adeguato. Nella seconda parte del contributo, poi, viene riportata un’esperienza concreta di Pro-getto di Vita in una RSD italiana.
Chiude la rassegna l’articolo di Veronica Amata Donatello, «La Chiesa è la nostra casa». La voce delle persone con disabilità al Sinodo. La responsabile del Servizio nazionale per la pastorale delle PcD della Conferenza Episcopale Italiana presenta e commenta il documento, elaborato da PcD dei cinque continenti riunite in assemblea straordinaria, presentato al Papa come contributo specifico del mondo della disabilità ai lavori sinodali. Vengono poi passate in rassegna le più significative iniziative che coinvolgono le PcD nei lavori sinodali messe in atto nelle Diocesi italiane.
Il Sinodo si offre come opportunità significativa per coinvolgere in forma corresponsabile le PcD. È un’occasione da non sprecare. Come osserva papa Francesco, nel Messaggio del 3 dicembre 2022, in occasione della Giornata mondiale delle PcD, «laddove il Sinodo è stato davvero inclusivo, esso ha permesso di sfatare pregiudizi radicati. Sono infatti l’incontro e la fraternità ad abbattere i muri di incomprensione e a vincere la discriminazione; per questo auspico che ogni comunità cristiana si apra alla presenza di sorelle e fratelli con disabilità assicurando sempre a essi l’accoglienza e la piena inclusione».
Sezione Commemorativa: 70° dell’Istituto di Catechetica
Il presente fascicolo tiene conto anche della circostanza bella e significativa dei 70 anni di vita dell’Istituto di Catechetica (ICa) che ha cominciato la sua attività nell’anno accademico 1953-1954. Nei tre numeri del corrente anno, Catechetica ed Educazione presenterà, di volta in volta, alcuni aspetti che hanno caratterizzato la vita di un Istituto che ha offerto molto alla Chiesa, non solo italiana, e alla Congregazione salesiana.
In questo primo numero, Giuseppe Biancardi offre una panoramica storica internazionale sulle istituzioni accademiche di catechetica sorte tra il secondo dopoguerra e il Concilio Vaticano II. Tra loro si staglia l’ICa, a partire dagli anni ’50, con la sua identità e con le molteplici attività accademiche e promozionali nel campo della catechesi e della pedagogia religiosa.
Si fa poi memoria dell’iter redazionale di quattro libri di testo di Religione, redatti da docenti e collaboratori dell’ICa, che hanno segnato la storia della didattica scolastica e dell’educazione religiosa in Italia. La memoria storica è stata affidata ad alcuni autorevoli testimoni e riconosciuti studiosi a livello nazionale e internazionale: così, si susseguono le riflessioni di Maria Luisa Mazzarello, W la vita; Giuseppe Morante, Progetto uomo; Flavio Pajer, Religione e Vangelo oggi in Italia; Maurizio Lucillo, Cultura e religione.
I MEMBRI DELL’ISTITUTO DI CATECHETICA
catechetica@unisal.it
ALLEGATO:

Quella delle istituzioni accademiche pontificie romane è “un eredità ricchissima, che può promuovere vita nuova, ma che può anche inibirla se diventa troppo autoreferenziale” o “un pezzo di museo”. Ricevendo in Aula Paolo VI circa 3.000 persone, tra rettori, docenti, studenti e personale delle Università e Istituzioni pontificie romane, Francesco esorta a “fare coro” per affrontare le sfide inedite del presente (Ascolta il Podcast con la voce del Papa):
Specie dopo la pandemia del Covid 19, urge avviare un processo che porti a una sinergia effettiva, stabile e organica tra le istituzioni accademiche, per meglio onorare gli scopi specifici di ciascuna e per favorire la missione universale della Chiesa. E non andare litigando fra noi per prendere un alunno, un’ora in più. .Vi invito, pertanto, a non accontentarvi di soluzioni dal fiato corto, e a non pensare a questo processo di crescita semplicemente come a un’azione “di difesa”, volta a fronteggiare il calo delle risorse economiche e umane. Va visto, piuttosto, come uno slancio verso il futuro, come un invito ad accogliere le sfide di un’epoca nuova della storia.
“Fare coro” tra le diverse componenti delle comunità e fra le varie istituzioni accademiche sorte a Roma nei secoli grazie alla “generosità e lungimiranza di molti ordini religiosi”, dice il Papa, si impone come necessario. “A fronte del minor numero di allievi e di insegnanti, questa molteplicità di poli di studio rischia di disperdere energie preziose. Così, anziché favorire la trasmissione della gioia evangelica dello studio, dell’insegnamento e della ricerca, minaccia a volte di rallentarla e affaticarla. Dobbiamo prenderne atto”.
L’eredità secolare di facoltà e università pontificie va sviluppata, avviando “al più presto un fiducioso processo” in una “direzione corale”, “con intelligenza, prudenza e audacia, tenendo sempre presente che – precisa il Vescovo di Roma – la realtà è più importante dell’idea”.
Se volete che abbia un futuro fecondo, la sua custodia non può limitarsi al mantenimento di quanto ricevuto: deve invece aprirsi a sviluppi coraggiosi e, se necessario, anche inediti.
A questo proposito il Papa indica nel Dicastero per la Cultura e l’Educazione il referente per accompagnare le istituzioni accademiche in questo cammino.
“Corale” è la realtà della speranza, constata il Pontefice che, contemplando il Cristo Risorto, opera di Pericle Fazzini, dominante il palco dell’Aula Paolo VI, riflette su come le mani di questa scultura assomiglino a quelle di un maestro di coro: la destra aperta sembra dirigere l’insieme dei coristi; la sinistra con l’indice puntato invece suggerisce l’idea che stia convocando un solista, dicendo: “Tocca a te”.
Le mani del Cristo coinvolgono al tempo stesso il coro e il solista, perché nel concerto il ruolo dell’uno si accordi con quello dell’altro, in una costruttiva complementarità. Per favore: mai solisti senza coro. “Tocca a tutti voi!” e al tempo stesso: “Tocca a te!”. Questo dicono le mani del Risorto. Mentre ne contempliamo i gesti, rinnoviamo allora il nostro impegno a “fare coro”, nella sintonia e nell’accordo delle voci, docili all’azione viva dello Spirito.
L’università d’altronde è la scuola dell’accordo e della consonanza tra voci e strumenti differenti: “il luogo”, dice Francesco citando san John Henry Newman, “dove diversi saperi e prospettive si esprimono in sintonia, si completano, si correggono e si bilanciano l’un l’altro”. Un’armonia che va coltivata innanzitutto a partire da sé stessi, accordando le tre intelligenze che vibrano nell’anima: mente, cuore e mani. Queste ultime, paragonate da Aristotele e Kant rispettivamente all’anima e al cervello esterno dell’uomo, esorta il Pontefice, siano “eucaristiche come quelle di Cristo”: capaci di rendere grazie, di misericordia, di generosità e di “stringere altre mani”.
La prima volta che sono uscito in Piazza, da Papa, mi sono avvicinato ad un gruppo di ragazzi ciechi. E uno mi disse: “Posso vederla? Posso guardarla?” Io non capii. “Sì”, gli ho detto. E con le mani cercava…e mi… “Ah grazie”: mi ha visto con le mani. Questo mi ha toccato tanto.
Se “il verbo prendere indica un’azione tipicamente manuale”, prosegue il Vescovo di Roma, esso “è anche radice di parole come comprendere, apprendere e sorprendere: mentre le mani prendono, la mente comprende, apprende e non si lascia sorprendere”:
Perché questo avvenga, ci vogliono mani sensibili. La mente non potrà comprendere nulla se le mani sono chiuse dall’avarizia, o se sono “mani bucate”, che sprecano tempo, salute e talenti, o ancora se si rifiutano di dare la pace, di salutare e di stringere altre mani. Non potrà apprendere nulla se le mani hanno dita puntate senza misericordia contro i fratelli e le sorelle che sbagliano. E non potrà sorprendersi di nulla, se le stesse mani non sanno congiungersi e levarsi al Cielo in preghiera.