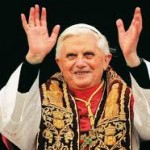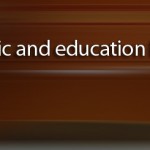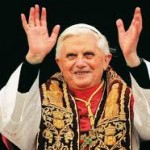
È la crisi economico-finanziaria globale che nasce in Occidente e che scatena i suoi effetti devastanti sui paesi in via di sviluppo a segnare il tradizionale discorso di augurio di inizio anno tenuto ieri da Papa Benedetto XVI al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede.
Sono l’incertezza per il futuro dei giovani e la loro protesta sviluppatasi soprattutto nel Nord Africa e in Medio Oriente. È l’esigenza di un mondo più giusto e sicuro e soprattutto di uno sviluppo che abbia al centro l’uomo e le sue esigenze.
È la domanda di nuove regole e soprattutto di una «maggiore etica» che guidi i comportamenti individuali e sociali nell’economia globale.
È di questo che parla Papa Ratzinger ai 179 rappresentanti dei paesi accreditati presso la Santa Sede, da ultimo la Malesia, ricevuti ieri mattina in udienza nella Sala Regia. La tradizionale cerimonia è stata l’occasione per fare un bilancio dell’anno trascorso.
Malgrado tutto invita ad avere speranza nel futuro, Papa Ratzinger. Ce n’è bisogno. Il quadro è drammatico. Ne è ben consapevole il pontefice.
«Il momento attuale – osserva – è segnato purtroppo da un profondo malessere e le diverse crisi, economiche, politiche e sociali, ne sono una drammatica espressione».
Sottolinea come «gli sviluppi gravi e preoccupanti della crisi economica e finanziaria mondiale» iniziata nei Paesi industrializzati stiano lasciando «disorientati e frustrati soprattutto i giovani».
etica e giovani
Invoca un cambiamento profondo dei comportamenti individuali e sociali, degli individui e degli
Stati. Perché la crisi può essere affrontata come un’occasione per «riflettere sull’esistenza umana e
sull’importanza della sua dimensione etica».
Indica quale debba essere l’obiettivo di questo cambiamento: «Non soltanto cercare di arginare le perdite individuali o delle economie nazionali, ma darci nuove regole che assicurino a tutti la possibilità di vivere dignitosamente e di sviluppare le
proprie capacità a beneficio dell’intera comunità».
È sui giovani che insiste il pontefice. Sono stati loro i protagonisti della «primavera araba». Ricorda
il loro giustificato «malessere». Vittime della povertà e della disoccupazione, in assenza di
«prospettive certe» hanno lanciato – osserva – «quello che è diventato un vasto movimento di
rivendicazione di riforme e di partecipazione più attiva alla vita politica e sociale».
Su di un punto il pontefice insiste: il «rispetto della persona» che deve essere «al centro delle istituzioni e delle leggi». Per questo invoca «nuove regole che assicurino a tutti la possibilità di vivere dignitosamente
e di sviluppare le proprie capacità a beneficio dell’intera comunità».
i punti di crisi
È un appello al cambiamento radicale che per Ratzinger deve trovare le sue fondamenta nell’educazione offerta alle giovani generazioni. Torna così sui contenuti del suo messaggio per la Giornata mondiale della pace.
Rivendica il ruolo centrale della famiglia tradizionale, quella fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. Così arriva a definire «lesive della famiglia» e
«minacciose della dignità umana e del futuro stesso dell’umanità» le leggi che finirebbero per
intaccarla. La sua è una condanna implicita, ma nettissima, verso quelle leggi che equiparano alla
famiglia le coppie di fatto. Esplicita è, invece, quella mossa alle «misure legislative che non solo
permettono, ma talvolta favoriscono l’aborto».
È la difesa dei valori non negoziabili: vita, famiglia,
educazione, libertà religiosa.
Nel suo discorso Benedetto XVI elenca anche gli scenari della crisi internazionale. Dalla drammatica situazione in Siria, per la quale auspica «una rapida fine degli spargimenti di sangue e
l’inizio di un dialogo fruttuoso tra gli attori politici, favorito dalla presenza di osservatori indipendenti», al difficile rapporto tra israeliani e palestinesi in Terra Santa, la situazione in Nigeria, dove la comunità cristiana da Natale è oggetto di violenze e persecuzioni da parte dei
fondamentalisti islamici.
Il Papa ha voluto ricordare il ministro pachistano Shahbaz Bhatti, «la cui infaticabile lotta per idiritti delle minoranze si è conclusa con una morte tragica». Non un caso isolato, ha aggiunto,
denunciando come i cristiani siano ancora «privati dei diritti fondamentali e messi ai margini della vita pubblica; in altri subiscono attacchi violenti. Talvolta, sono costretti ad abbandonare Paesi che
essi hanno contribuito a edificare. Torna a ribadire lo «spirito di Assisi» e invita i governi a percorrere «un cammino di giustizia, di pace e di riconciliazione, in cui i membri di tutte le etnie e
di tutte le religioni siano rispettati»
di Roberto Monteforte
in “l’Unità” del 10 gennaio 2012