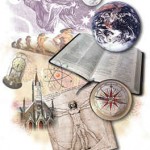Riportiamo alcuni commenti relativi alla decisione presa dal Comitato nazionale di bioetica su l’obiezione di coscienza in bioetica da un punto di vista generale.
La sfida posta dalle nuove frontiere della scienza e della biomedicina allo Stato costituzionale e pluralista è raccolto da un documento del Comitato nazionale per la bioetica sull’obiezione di coscienza diffuso ieri.
Il documento, come è stato già precisato dal vicepresidente del Cnb Lorenzo D’Avack, «è stato esaminato da un punto di vista generale» senza limitarsi a campi in cui sono già in vigore leggi, come quelle sull’aborto o sulla procreazione medicalmente assistita. Il testo è stato approvato praticamente all’unanimità, con un solo voto contrario, quello di Carlo Flamigni, che però si è astenuto sulle conclusioni.
«Si tratta di evitare – afferma tra l’altro il documento redatto da un gruppo di lavoro coordinato da Andrea Nicolussi, ordinario di Diritto civile all’Università Cattolica – di imporre obblighi contrari alla coscienza strumentalizzando chi esercita una professione».
Nelle conclusioni si afferma che l’obiezione di coscienza in bioetica «è costituzionalmente fondata, con riferimento ai diritti inviolabili dell’uomo». Nel sottolineare che essa «va esercitata in modo sostenibile», si ribadisce che è «un diritto della persona e un’istituzione democratica necessaria a tenere vivo il senso della problematicità riguardo ai limiti della tutela dei diritti inviolabili».
Il parere evidenzia peraltro che quando si riferisce a un’attività professionale, essa «concorre a impedire una definizione autoritaria» data per legge delle «finalità proprie» di quella attività. «La tutela dell’obiezione per la sua stessa sostenibilità nell’ordinamento giuridico – si aggiunge – non deve limitare né rendere più gravoso l’esercizio dei diritti riconosciuti per legge né indebolire i vincoli di solidarietà derivanti dalla comune appartenenza sociale».
Il Cnb raccomanda che la legge preveda «misure adeguate a garantire l’erogazione dei servizi, eventualmente individuando un responsabile degli stessi». L’esercizio di questo diritto fondamentale deve essere disciplinato in modo tale «da non discriminare né gli obiettori né i non obiettori e quindi non far gravare sugli uni o sugli altri, in via esclusiva, servizi particolarmente gravosi o poco gratificanti». Allo scopo si chiede «la predisposizione di un’organizzazione delle mansioni e del reclutamento», che «può prevedere forme di mobilità del personale e di reclutamento differenziato, in modo da equilibrare sulla base dei dati disponibili il numero degli obiettori e dei non obiettori».
Si indica anche la strada anche di controlli «a posteriori» per accertare che l’obiettore non svolga attività incompatibili con la sua scelta dichiarata. Sono da evitare però processi alle intenzioni a priori che mortificano la sua libertà. Il parere insomma evidenzia in ogni modo l’«esigenza di rispetto dei principi di legalità e di certezza del diritto», e dei diritti spettanti ai cittadini. Nella parte riservata all’analisi morale si chiarisce che l’obiezione non si basa su una mera opinione soggettiva, ma su di un valore «rincoscibile e comunicabile».
Da un punto di vista giuridico essa viene distinta nettamente da qualsiasi forma di “sabotaggio” di leggi in vigore, ma anche dalla disobbedienza civile e dalla resistenza al potere. Su un piano più generale si osserva che che tale istituto segna «una profonda revisione» della cultura giuridica avvenuta dopo Auschwitz. Nel caso della difesa della vita o della salute il valore richiamato dal medico obiettore rappresenta in effetti una diversa interpretazione del valore protetto dalla Costituzione rispetto a quanto avviene nella legge approvata a maggioranza. La legittimità della obiezione testimonia quindi che il diritto costituzionale più aggiornato «accetta uno spazio critico nei confronti delle decisioni della maggioranza», proprio perché i principi richiamati sono presenti nella stessa Carta fondamentale dello Stato. L’obiezione di coscienza assume, inoltre, un peculiare rilievo «quando è invocata da un soggetto nell’esercizio di un’attività professionale», come risulta dai codici deontologici. In quello dei medici si afferma che l’esercizio della professione è fondato «sulla libertà e sull’indipendenza», «diritto inalienabile del medico», che qualora gli «vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita».
Principi richiamati nel giuramento professionale. Il parere esamina anche il fenomeno del continuo spostamento dei terreni di applicazione dell’etica, osservando che l’agire del medico regredisce dal trattamento chirurgico alla prescrizione del farmaco, o nel caso del farmacista alla somministrazione di esso. Questione che non riguarda solo i farmaci abortivi, tema già trattato dal Cnb, ma anche quelli letali illeciti in Italia, ma ammessi in altri Paesi. La complessità della questione secondo il Comitato suggerisce l’intervento degli ordini professionali per definire coloro che sono legittimati a esercitare l’obiezione. Ma considerando anche i casi in cui tale diritto non è riconosciuto, il parere osserva che «finché l’ordinamento ha la forza di ammettere l’obiezione mantiene un certo equilibrio; quando invece non è riconosciuta o gli obiettori vengono discriminati la legalità si riveste nuovamente del carattere autoritario», come Creonte nell’Antigone di Sofocle.
Pier Luigi Fornari
ARTICOLO CORRELATO:
Il Cnb sull’obiezione di coscienza: diritto della persona
ARTICOLI CORRELATI
di Cinzia Sciuto
Diciamolo chiaramente: di questo parere del Comitato nazionale di Bioetica sull’obiezione di coscienza non se ne sentiva proprio il bisogno. In un paese in cui la quasi totalità dei ginecologi si rifiuta di compiere interruzioni di gravidanza proprio dichiarandosi obiettore di coscienza, e in cui a causa di questi numeri abnormi sta diventando praticamente impossibile abortire in molte strutture pubbliche, il Cnb – organo consultivo del governo – pubblica un parere (approvato con il solo voto contrario e motivato di Carlo Flamigni) in cui difende a spada tratta l’obiezione di coscienza, conferendole il rango di diritto costituzionale. Di più: definendola addirittura un baluardo della democrazia a presidio dei “diritti inviolabili dell’uomo”.
Andiamo con ordine. Il parere pubblicato dal Cnb decide di occuparsi della questione dell’obiezione di coscienza in generale, non con riferimento specifico all’interruzione di gravidanza. L’obiettivo del Comitato è quello di fornire un quadro etico-giuridico che possa essere utile alla regolamentazione dell’obiezione di coscienza. E i princìpi ribaditi nel documento si possono così riassumere:
a) l’obiezione di coscienza è un diritto costituzionalmente fondato (il riferimento è agli articoli 2,3,10,19 e 21 della Costituzione);
b) “la libertà di coscienza da sola non è sufficiente a fondare l’obiezione di coscienzasecundum legem ma dev’essere integrata dal valore richiamato dall’obiettore” perché “quando la legge interviene sulla tutela di un bene fondamentale come la vita o la salute (…), il valore richiamato dal medico obiettore rappresenta una diversa interpretazione del valore protetto dalla Costituzione”.
Dunque, l’obiezione di coscienza “legittima”, o secundum legem, per usare le parole del documento, secondo il Cnb non è determinata dal semplice, arbitrario e soggettivo richiamo alla propria coscienza, ma deve avere anche un “contenuto” che faccia riferimento ai diritti inviolabili dell’uomo, che l’obiettore ritiene essere messi in discussione dalla legge alla quale obietta. L’obiezione di coscienza è infatti definita dal Comitato come “la pretesa del singolo di essere esonerato da un obbligo giuridico, perché egli ritiene che tale obbligo sia in contrasto con un comando proveniente dalla propria coscienza e sia inoltre lesivo di un diritto fondamentale rilevante in ambito bioetico e biogiuridico”. La combinazione di questi due elementi, per un verso, delimita l’ambito di applicazione dell’obiezione di coscienza – non potendosi qualificare come tale qualunque rifiuto arbitrario in materie che non implichino il riferimento a “diritti fondamentali” – ma contemporaneamente fornisce agli obiettori una formidabile giustificazione etica alla loro scelta.
E inoltre implicitamente afferma che le leggi in cui la questione dell’obiezione di coscienza assume una certa rilevanza – come quelle sull’interruzione di gravidanza o sulla procreazione medicalmente assistita – mettono in discussione dei “diritti fondamentali” che la clausola dell’obiezione di coscienza è chiamata a tutelare. Non è un caso, infatti, che in riferimento all’obiezione di coscienza il documento richiami continuamente i concetti di “diritti fondamentali”, “diritti inviolabili dell’uomo”, “diritti costituzionali”, mentre a proposito delle leggi verso le quali l’obiezione è sollevata si parli esclusivamente di “principio di legalità”, senza mai, per esempio, un riferimento al diritto alla salute delle donne – questo sì effettivamente “diritto umano inviolabile” – che è il cuore della legge 194.
Il parere del comitato cade poi in continue ambiguità, e talvolta in vere e proprie contraddizioni. Nel tentare di difendere l’autonomia sia dei singoli medici che della categoria professionale nel suo complesso, il Cnb propone in un esempio paradossale: “Un’eventuale legge che obbligasse il medico a somministrare una emotrasfusione nonostante il rifiuto del paziente maggiorenne e consapevole (ad esempio testimone di Geova) – si legge nel documento – imporrebbe un’idea eteronoma della professione come attività di esecuzione di prestazioni obbligatorie anche per chi le riceve, anziché di prestazioni offerte a persone libere”. Ma qui siamo in presenza di un paziente che rifiuta una cura! L’esempio calzante sarebbe stato quello di un medico testimone di Geova che si rifiuta di fare una trasfusione di sangue su un paziente che ne ha bisogno (e che la consenta). Ossia – in analogia con il più classico caso dell’obiettore di coscienza sull’aborto – l’esempio di un medico che, in nome delle sue convinzioni etiche e religiose, si rifiuta di prestare un servizio previsto dalla sua professione.
Il documento è tutto teso a creare la cornice etico-giuridica per un’obiezione di coscienza costituzionalmente fondata e perfettamente coerente con l’ordinamento giuridico e per fare questo (e anche forse per riuscire ad ottenere una larghissima maggioranza) ribadisce più volte che questo istituto non può diventare un’arma di sabotaggio delle leggi dello Stato. Per questo, nelle conclusioni, il Cnb afferma che “nel riconoscere la tutela dell’obiezione di coscienza nelle ipotesi in cui viene in considerazione in bioetica, la legge deve prevedere misure adeguate a garantire l’erogazione dei servizi, eventualmente individuando un responsabile degli stessi” ed esplicitamente raccomanda “la predisposizione di un’organizzazione delle mansioni e del reclutamento, negli ambiti della bioetica in cui l’obiezione di coscienza viene esercitata, che può prevedere forme di mobilità del personale e di reclutamento differenziato atti a equilibrare, sulla base dei dati disponibili, il numero degli obiettori e dei non obiettori”. Ma è proprio l’ordine del ragionamento a essere capovolto: è la tutela dell’obiezione di coscienza come diritto fondamentale della persona il punto di partenza.
E forse non è un caso che questo parere, che non è stato richiesto dal governo né dal parlamento, ma è un’iniziativa autonoma del Comitato, esca proprio a pochi mesi dall’inizio di una mobilitazione dei medici non obiettori. Con le iniziative della Laiga prima e con la campagna “Il buon medico non obietta” dopo, i non obiettori avevano cominciato ad alzare la testa e a ribadire con forza e orgoglio la propria professionalità, denunciando un fenomeno che sta di fatto rendendo inoperativa la 194. La controffensiva è cominciata.
(31 luglio 2012) La Repubblica