
“Quella porta ci è necessaria”




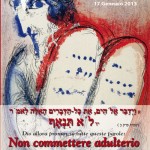
Preceduti da una inchiesta nazionale nel 1986 e promossi dalla Commissione Episcopale per l´educazione cattolica, la cultura e la scuola, si sono svolti, in questi anni, alcuni incontri sia con i sacerdoti incaricati od esperti di pastorale universitaria (17.2.87), sia con i sacerdoti docenti universitari (12.2.88), sia infine con numerosi docenti universitari di ispirazione cattolica (21.5.88 e 27.5.89).
CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

Globalizzare l’umano», cioè «far emergere la creaturalità di tutti e di ciascuno, che costituisce il fondamento di ciò che davvero può essere detto universale».
È la visione di mondializzazione proposta dalla dottrina sociale della Chiesa, per scongiurare una “ideologia” della globalizzazione, ovvero un «uso ideologico dei processi di globalizzazione».A ricordarla è il card. Angelo Bagnasco, Presidente della Cei, che ha aperto venerdì 30 novembre a Roma l’XI Forum del progetto culturale, sul tema “Processi di mondializzazione opportunità per i cattolici”.
Una «lettura unilaterale dei processi di globalizzazione» – ha affermato il Cardinale – «può essere pericolosa perché potrebbe giustificare una forma d’imposizione, a volte anche violenta, del globale sul locale», dando luogo a «un vero fraintendimento di ciò che l’umanità, grazie soprattutto all’elaborazione del pensiero cristiano, ha stabilito realmente universale: la dignità della persona, la salvaguardia della sua libertà, il rispetto della vita in ogni suo momento».«L’utile di una parte dell’umanità non può essere considerato il criterio per stabilire ciò che è bene di tutti», ha ammonito il Cardinale Presidente, secondo il quale «la globalizzazione dev’essere regolamentata secondo giustizia, evitando che si configuri come l’espressione d’interessi particolari imposti universalmente».
SCARICA DOCUMENTO:
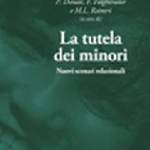
Raccontare le “buone idee” e le “esperienze che funzionano”, per dare stimolo e strumenti a “quegli operatori che raccolgono la scommessa di voler continuare a lavorare sul campo, e a lavorare bene”.
Questo l’intento del 4° Convegno internazionale sulla qualità del welfare, “La tutela dei minori. Buone pratiche relazionali”, organizzato dal Centro studi Erickson e che si terrà a Riva del Garda (Trento) dall’8 al 10 novembre.
L’appuntamento si rivolge ad assistenti sociali, educatori, magistrati, psicologi, neuropsichiatri infantili, insomma a tutti gli operatori che hanno a che fare con situazioni di gravi difficoltà nelle quali sono coinvolti i minori e le loro famiglie.
Incontro e confronto. “Vogliamo offrire una possibilità d’incontro e di confronto agli operatori del settore – spiega al Sir Maria Luisa Raineri, coordinatore scientifico del Convegno, assistente sociale e docente – raccogliendo buone prassi e proponendo riflessioni”.
La chiave di lettura degli aspetti positivi è già stata sperimentata in un analogo convegno tenuto nel 2010: lì, riporta la presentazione dell’iniziativa, “abbiamo iniziato a esplorare l’idea che i percorsi di tutela minorile, per risultare davvero efficaci, vadano costruiti partendo dal punto di vista e dai punti di forza dei minori e delle famiglie interessate”.
Il convincimento è che “le famiglie, anche e soprattutto quelle in difficoltà”, vadano “ascoltate per poter costruire progetti di aiuto che siano davvero praticabili per loro, dal loro punto di vista”. “Lavorare insieme” per “valorizzare il positivo” che si trova anche nelle famiglie in difficoltà è un imperativo per Raineri, che riprende i dati sugli affidi del Centro nazionale per l’infanzia e l’adolescenza: nel 2009 sono stati 32.400 i minori dati in affidamento familiare o accolti nei servizi residenziali; tra le motivazioni, ai primi posti figura una difficoltà educativa da parte della famiglia d’origine, gravi problemi di un genitore o la conflittualità tra i due genitori, che pure recenti casi di cronaca hanno portato alla ribalta.
Esempi di buone pratiche. In effetti, sono molte le buone pratiche che si sperimentano, in Italia o altrove, in questo settore.
Al Convegno del 2010, ad esempio, furono presentati contributi significativi sulle “family group conference”, “incontri – precisa la coordinatrice – organizzati con tutte le figure di riferimento di un bambino o ragazzo che ha un provvedimento di tutela”, al fine di ottimizzare le risorse di cui il minore può disporre, da qualsiasi parte provengano.
Una modalità, racconta Raineri, “diffusa in tutto il mondo, e di cui sono partite sperimentazioni in Italia proprio dopo la presentazione”. Altro esempio, l’operatore-portavoce, ovvero “una figura che ascolta il bambino, o il ragazzo, affinché questi possa dare il suo parere sui problemi che lo riguardano”: pure questa è una pratica che “appartiene – sottolinea – alla tradizione del servizio sociale internazionale, ma della quale non vi è traccia nel nostro Paese”. Terzo, “i gruppi di auto-mutuo aiuto per i genitori i cui figli sono destinatari di un provvedimento di tutela, o che sono stati adottati da altri”, alla stregua dei gruppi di famiglie affidatarie e adottive.
Spesso, infatti, “non si pensa a quale stigmatizzazione ci sia nel dire che il proprio figlio è in affidamento: i servizi sociali non devono solo tutelare il minore, ma pure aiutare i suoi genitori a ‘rimettersi in sesto’ per poi riaccogliere il figlio”.
Un “sostegno sostenibile”. Le buone pratiche, quindi, non mancano, e sono tanto più necessarie quanto più scarseggiano le risorse economiche. “Veniamo da una tradizione – osserva Raineri – d’interventi costosi e pesanti. Ma, se non si trovano modalità alternative, il rischio è che i fondi ci siano solo per i casi più gravi, lasciando perdere tante altre situazioni che però, così facendo, rischiano di deteriorarsi sempre più”.
La coordinatrice del Convegno parla di “sostegno sostenibile” per definire tutte quelle forme di supporto che tendono a valorizzare le risorse presenti – pure quelle, seppure scarse, delle famiglie d’origine – e che alla lunga producono “interventi più efficaci e tendenzialmente meno costosi”. “È perdente pensare di allontanare il minore e poi, in un secondo tempo, aiutare la famiglia”; viceversa, “è sempre più importante che l’operatore abbia lo sguardo rivolto a tutta la famiglia e l’accompagni passo dopo passo, se possibile assieme al loro figlio”.
INFORMAZIONI SUL CONVEGNO:
http://www.fabiofolgheraiter.it/convegni
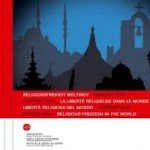
Non cessano le violenze e le persecuzioni a sfondo religioso nel mondo. Cina, Nigeria, Pakistan, Egitto, Kenya, India sono solo alcuni dei Paesi che destano maggiore preoccupazione. Se dunque nel 2011 sul fronte dell’applicazione della libertà religiosa “non vi sono stati miglioramenti”, si riscontra però una tendenza positiva inedita in termini di “consapevolezza relativa al tema della nell’opinione pubblica, dovuta in gran parte all’aumento della copertura mediatica e ad una maggiore disponibilità d’informazioni”.
È il quadro complessivo che emerge dalla XI edizione del Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo presentato oggi a Roma in conferenza stampa da Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs).
Il Rapporto ha preso in esame 196 Paesi del mondo. Da una parte preoccupano in modo particolare le situazioni vissute in Cina, nei Paesi della cosiddetta “primavera araba” e in alcune nazioni dell’Africa; dall’altra il Rapporto evidenzia un aumento di sensibilità nell’opinione pubblica riguardo a questo problema: ne sono prova gli interventi legislativi di vari stati europei e l’impegno mostrato da alcuni parlamenti nazionali (italiano, belga e tedesco) nonché dal Parlamento europeo.
Se dunque, sul piano legislativo “si riscontrano passi in avanti, lo stesso – conclude il Rapporto di Acs – non si può dire riguardo alle violenze e alla persecuzione. Perché le minacce alla libertà religiosa non accennano a diminuire”.
Alcuni dati. Riflettori di Acs puntati sulla Nigeria per la proliferazione di alcuni gruppi islamici: dal 1999 alla fine del 2011 sono stati 14 mila i nigeriani uccisi da violenze a sfondo religioso. Lo scorso anno, nella sola settimana di aprile successiva alle elezioni presidenziali del giorno 16, almeno 800 persone sono rimaste uccise e 65 mila hanno dovuto abbandonare le proprie case. In India – si legge nel Rapporto – è lunghissima la lista degli attacchi alle minoranza mentre “il 2011 è stato un anno terribile per il Pakistan”: “Dopo l’omicidio a gennaio del governatore del Punjab, Salman Taseer, il 2 marzo viene ucciso il ministro federale per le Minoranze, il cattolico Shahbaz Bhatti”. Nessuna modifica è stata apportata alla legge anti-blasfemia, a causa della quale nel 2011 sarebbero state almeno 161 le persone incriminate e 9 quelle uccise con esecuzioni extra-giudiziali. Mai come nel 2011 anche in Cina è stata lunga la lista degli arresti di cristiani (cattolici e protestanti), islamici e buddisti (tibetani); la maggiore durezza del governo si deve probabilmente al crescente interesse religioso riscontrato nel Paese, in particolare nei confronti del cristianesimo. Le ulteriori tensioni tra Pechino e la Santa Sede sono legate alle nuove ordinazioni illecite e ai numerosi casi di arresti, torture e “rieducazioni tramite il lavoro” subiti da chi, fedele al Papa, rifiuta di aderire all’Associazione Patriottica.
Il caso dell’Egitto. A parlare della situazione della libertà religiosa nei Paesi arabi è stato padre Samir Khalil Samir, islamologo, che ha portato la storia dei due bambini copti analfabeti, di 8 e 10 anni, Mina Nadi Faraj e Nabil Naji Rizq, che sono stati arrestati con l’accusa di aver urinato su dei fogli di carta sui quali erano scritti dei versetti del Corano. “Questo – ha detto padre Samir – ci fa dire che stiamo prendendo una direzione pericolosa. Stiamo per tornare ad un’epoca che ormai non conoscevamo più: quella del fanatismo religioso. Negli ultimi trenta anni si sono verificati degli episodi, ma mai si era arrivati a mettere in prigione dei bambini analfabeti accusati di oltraggio all’Islam”. Queste situazioni, però – ha aggiunto l’islamologo – devono incrementare l’impegno del dialogo: “Insieme, musulmani e cristiani, dobbiamo lottare per più giustizia e per la dignità per tutti, lottare in favore dei più disagiati. Dobbiamo imparare insieme che la religione non è fatta per condannare chiunque, ma per aiutare tutti quanti ad essere più umani e più aperti ad ogni essere umano!”.
Dietro le statistiche. “La libertà religiosa è come tutti sanno una battaglia non solo dei credenti ma di tutti coloro che difendono il principio di libertà d’opinione”, ha detto il giornalista del “Sole 24 Ore” Alberto Negri. Ed ha aggiunto: “Sebbene redatto da una fondazione cattolica”, il Rapporto “non si limita a denunciare le violazioni alla libertà religiosa subite dalle comunità cristiane ma fa un quadro della situazione in 200 Paesi con riferimento alla condizione dei fedeli di ogni credo. La libertà religiosa è la cartina di tornasole per verificare l’applicazione dei diritti fondamentali dell’uomo”. “Ovviamente – ha concluso mons. Sante Babolin, presidente del Segretariato italiano di Acs -, le statistiche, spesso aride e fredde, vanno sempre collocate in un contesto geografico e culturale: dietro ogni cifra si nascondono volti e nomi precisi, persone che hanno pagato con la vita la loro fedeltà al Vangelo di Cristo. E a ricordarcelo, in questi ultimi mesi, ci sono le innumerevoli domeniche di sangue in Nigeria e le continue sofferenze dei cristiani iracheni e di quelli pachistani”.
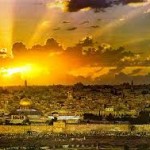
di don Mariusz Frukacz
“Alla ricerca di un uomo in un uomo. Radici cristiane della speranza” è il tema del IV Congresso. È questa una delle iniziative più importanti in Polonia, nata per idea di mons. Józef Życiński, Arcivescovo Metropolita di Lublino, morto nel 2011, per la promozione del dialogo della Chiesa con la cultura contemporanea e tra le religioni.
Nell’edizione di quest’anno, che si svolgerà presso l’Università Cattolica di Lublino, sono invitati illustri ospiti, tra cui, in particolare, spicca il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura che riceverà un dottorato honoris causa presso l’Ateneo. Saranno presenti anche padre prof. Tomàs Halik, il prof. Zygmunt Bauman, il ministro Rocco Buttiglione.
Hanno confermato la propria presenza anche George Weigel, Nunzio Apostolico in Polonia; l’Arcivescovo Celestino Migliore; don Janusz Mariański, famoso sociologo e don Józef Niewiadomski, preside della Facoltà di Teologia a Innsbruck.
Il Congresso è concepito come un dibattito europeo fra i credenti e non credenti sulla speranza nella cultura contemporanea.
Aprirà i lavori, venerdì 28 settembre, la conferenza dell’Arcivescovo Celestino Migliore sul “Contributo di Giovanni Paolo II alla comprensione della missione della Chiesa in politica europea e mondiale”. Subito dopo, Rocco Buttiglione interverrà sul ruolo del Beato e della Chiesa Cattolica nel dibattito sui diritti umani.
Il giorno successivo, sabato 29, i partecipanti al Congresso potranno ascoltare una lezione del filosofo Bauman intitolata: “Immagine postmoderna dell’uomo nella società. Dove sono le fonte di speranza per un futuro migliore?”. Sarà il turno, poi, del Nunzio apostolico, George Weigel che parlerà della “Visione della speranza cristiana al neo-paganesimo del mondo moderno.”
In programma, sabato sera, l’iniziativa chiamata “Dibattito per due pulpiti” sul tema de “La fede e incredulità nella vita dei polacchi”, che si tiene tradizionalmente nella Chiesa dei Padri Domenicani nel centro storico di Lublino.
L’ultimo giorno del Congresso, il 30 settembre, gli organizzatori hanno previsto, infine, una conferenza di padre prof. Tomasz Halik sull’argomento “L’Europa ha subito una decristianizzazione? Le prospettive per il dialogo tra cristianesimo e neo-paganesimo”. Farà seguito il sociologo Mariański che presenterà una “mappa religiosa dell’Europa e delle sue dinamiche contemporanee”.
Parallelamente alle lezioni del Congresso si svolgeranno alcuni dibattiti su otto “pannelli” che affronteranno temi di grande attualità come: il dialogo tra fede e scienza; la carità; il femminismo; lo spirito cristiano della cultura europea e via dicendo. Tra questi, uno spazio sarà dedicato alla persona di mons. Józef Życiński, metropolita di Lublino, iniziatore del Congresso.
Il primo Congresso della cultura cristiana, vide la luce, sotto gli auspici del Pontificio Consiglio della Cultura, il 6-7 novembre 2000. In quell’occasione, sul tema “Il Sacro e la cultura: le radici cristiane del futuro”, intervennero eccezionali personalità ecclesiastiche, come Paul Poupard e Miroslav Vlk, e numerosi luminari del mondo della cultura e della scienza, quali Ryszard Kapuscinski, Leszek Kolakowski e Andrzej Wajda.
Per maggiori informazioni, consultare il sito web del Congresso:www.kongres.lublin.pl
Un percorso di una settimana tra testimonianze, dibattiti ed attività formative, per fornire strumenti nuovi per approcciarsi alla politica ispirandosi all’insegnamento di Tommaso d’Aquino.
E’ stata questa la scuola di politica organizzata dalle Acli della Capitale – “L’arte della politica” – che, alla sua prima edizione, si è svolta dal 17 al 22 luglio presso il Monastero benedettino di Santa Scolastica di Civitella S. Paolo, in provincia di Roma.
Un percorso dedicato agli oltre trenta giovani, fra i 18 e i 30 anni, che hanno deciso di partecipare al campo desiderosi di toccare con mano «il senso della buona e della cattiva politica, per scoprire insieme che cosa vuol dire oggi essere cittadini››.
Durante le giornate si sono affrontati i temi del conoscere, ascoltare, prendere parte, mediare e decidere, per trasformare l’idea di bene comune in un qualcosa da costruire insieme, con metodo.
Gli incontri sono stati introdotti dalla meditazione spirituale pensata con lo scopo di introdurre l’argomento del giorno e fornirne una prima analisi di tipo spirituale, mentre nel corso della prima parte della mattinata si sono svolti gli incontri con gli ospiti seguiti dalla fase di dibattito con la platea.
Nel pomeriggio si sono svolte attività pratiche e ludiche per mettere in opera quanto precedentemente affrontato in aula: dalla pinacoteca della politica durante la quale i ragazzi hanno potuto dipingere la propria idea di politica, al tribunale nel quale l’imputato “Politica” è stato accusato e difeso dai partecipanti divisi in due gruppi fino ad arrivare alla messa in scena di un caso politico.
Per l’attività di cineforum è stato proiettato il film “Buongiorno, Notte”, ambientato nel 1978 narra del rapimento e della detenzione, da parte delle Brigate Rosse, di Aldo Moro.
Alle giornate hanno partecipato, il presidente delle Acli di Roma, Cristian Carrara, i deputati Enrico Letta e Luigi Bobba, il presidente delle Acli nazionali, Andrea Olivero, il giurista Alberto Gambino, il segretario generale aggiunto della Cisl Giorgio Santini, il direttore della Società, Claudio Gentili, Don Andrea Palamides (sacerdote della Comunità della Riconciliazione – Santa Teresa di Gesù Bambino), il direttore delle relazioni esterne, affari istituzionali e marketing di Autostrade per l’Italia Francesco Delzio, il poeta Davide Rondoni, la iena Filippo Roma, il direttore generale di Peter Pan Onlus, Gian Paolo Montini, la giornalista Stefania Divertito e l’assessore alla Famiglia, all’Educazione ed ai Giovani di Roma Capitale, Gianluigi De Palo.
Primo passo di un percorso che tende a replicarsi in futuro, questa scuola mira anche ad essere un punto di partenza per promuovere un’opera di sensibilizzazione sui temi della politica per portare i giovani ad essere di nuovo protagonisti attivi e consapevoli della società.
Cogliendo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e che hanno dedicato con cura il proprio tempo mirando alla buona riuscita della scuola, vi invitiamo a vedere le foto nella sezione fotografica del sito.
ROMA, venerdì, 3 agosto 2012 (ZENIT.org) –