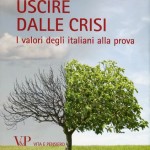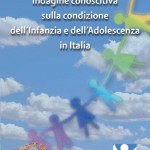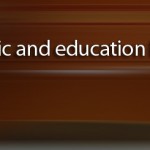Le elezioni politiche in Egitto si stanno svolgendo in più tornate successive e dureranno molti mesi. Ma è bastato il primo test elettorale al Cairo, ad Alessandria e in alcune altre città per seminare allarme.
I Fratelli Musulmani, col Partito della libertà e della giustizia, hanno ottenuto il 36 per cento dei voti. Il Blocco egiziano, che raggruppa le formazioni più sensibili alle richieste di libertà di piazza Tahrir, il 15 per cento. Ma la vera sorpresa è stato il 25 per cento di voti andato al Partito della Luce, Hizb an Nour, fondato dieci mesi fa dai salafiti, ossia dagli islamisti più radicali.
Nelle cancellerie dell’Occidente si è subito temuta una saldatura tra i Fratelli Musulmani e i salafiti, che sommati totalizzerebbero i due terzi dei seggi del futuro parlamento egiziano.
Ma un simile sbocco è tutt’altro che probabile. Per i Fratelli Musulmani i salafiti non sono affatto un possibile alleato, ma l’avversario più pericoloso ed ostile.
Padre Rafic Greiche, portavoce della minuscola Chiesa cattolica egiziana, prevede piuttosto che il Partito della libertà e della giustizia si allei con il blocco dei movimenti democratici. Una previsione che per lui è anche un auspicio: “per fermare leggi illiberali e pericolose per la minoranza cristiana”.
Il programma politico dei Fratelli Musulmani è lungo 45 pagine ed è quanto di più inaccettabile ci sia per gli integralisti salafiti. Così lo riassume Daniele Raineri in un reportage dal Cairo per “il Foglio”: “Adesione piena e senza ambiguità ai principi democratici della rappresentanza politica e del rinnovo periodico del potere con elezioni, piena dignità davanti alla legge di tutti gli egiziani, nessuna discriminazione per sesso, religione o razza, quindi non contro le donne o contro la minoranza cristiana. Due priorità: la sicurezza e l’economia”.
In una Fratellanza che nei suoi 83 anni di vita ha sempre alternato estremismo a moderazione e a dissimulazione, questo improvviso e conclamato innamoramento per la democrazia desta sospetti.
Ma è anche incontestabile che se c’è un modello al quale oggi i Fratelli Musulmani egiziani guardano, questo non è l’islamismo fondamentalista e retrogrado dei wahhabiti dell’Arabia Saudita, ma quello pragmatico della Turchia di Recep Tayyip Erdogan.
La recente visita del primo ministro turco in Egitto ha registrato un’accoglienza trionfale. In lui i Fratelli Musulmani vedono non solo un grande leader sunnita capace di conciliare islamismo e modernità, ma anche colui che ha restituito diritto di cittadinanza all’islam popolare, in una Turchia non più ostaggio dei generali.
In un Egitto dove tutte le cariche religiose, da al-Azhar all’ultima delle moschee, sono state fin qui di nomina del governo e sotto la tutela dell’esercito, l’apologia della laicità fatta da Erdogan durante la sua visita è stata interpretata da molti come un messaggio liberatorio, a favore di una religione finalmente affrancata dal controllo del Principe.
I Fratelli Musulmani si presentano anche con un volto amico per i copti, che con oltre dieci milioni di fedeli costituiscono la più grande minoranza cristiana in un paese arabo. Ne hanno messi alcuni nelle liste elettorali. Ed è copto il vicepresidente del Partito della libertà e della giustizia.
Ma fino a che punto è credibile – in particolare per i cristiani – questa metamorfosi del Fratelli Musulmani?
L’eccidio del 9 ottobre 2011 nel quartiere Maspero del Cairo, con 22 copti uccisi dai blindati dell’esercito, è stato per i cristiani d’Egitto un trauma senza precedenti, più sconvolgente di quelli provocati dagli innumerevoli atti di violenza e di vessazione subiti ad opera dei musulmani.
Quel baluardo di protezione ultima che, nella visione dei copti, era stato fin lì l’esercito, si era rivoltato loro contro, con l’opinione pubblica anch’essa schierata contro di loro.
Ed è passato un mese prima che il grande imam della moschea di al-Azhar, Ahmad Muhammad al-Tayyeb, convocasse dei leader musulmani e cristiani nella “Casa delle famiglia egiziana” ed emettesse un comunicato che definisce “martiri” gli uccisi e invoca “provvedimenti pratici necessari per rafforzare il dettato costituzionale del principio di cittadinanza per tutti gli egiziani”.
Il grande imam al-Tayyeb è uno dei firmatari della lettera amichevole inviata a Benedetto XVI da 138 saggi musulmani dopo la lezione di Ratisbona. Ma è anche colui che ha rotto le relazioni col Vaticano prendendo a pretesto la preghiera del papa per i cristiani uccisi nell’attentato dello scorso Capodanno in una chiesa copta di Alessandria d’Egitto e per tutte le vittime della violenza interreligiosa.
Al-Tayyeb ha anche rifiutato di prendere parte all’incontro di Assisi dello scorso 27 ottobre. Prima di essere grande imam della prima moschea del Cairo, è stato gran mufti e rettore dell’università di al-Azhar, la più importante del mondo musulmano sunnita. Ogni volta per nomina del presidente Mubarak, dal quale, dopo la sua caduta, ha preso marcatamente le distanze.
Sta di fatto che il rapporto tra musulmani e copti, in Egitto, si è molto deteriorato da un secolo a questa parte.
Nell’analisi che segue, Tewfik Aclimandos, docente di storia contemporanea del mondo arabo al Collège de France, tratteggia l’evoluzione di questo rapporto, giunto in questi ultimi anni al suo punto più critico.
L’analisi è uscita sull’ultimo numero di “Oasis”, la newsletter in cinque lingue, tra cui l’arabo, diretta da Maria Laura Conte e promossa dall’omonima fondazione internazionale con sede a Venezia, a sua volta nata da un’idea del cardinale Angelo Scola, quand’era patriarca della città.
__________
COPTI E MUSULMANI D’EGITTO: COME SI È ARRIVATI ALL’EMERGENZA DI OGGI
di Tewfik Aclimandos
[…] L’emancipazione copta è un processo messo in atto dalla dinastia di Mehemet Ali, soprattutto con l’abrogazione del testatico nel 1855 voluta da Said, culminata nell’unione sacrée dell’insurrezione anti-britannica del 1919. Laure Guirguis ha mostrato nella sua tesi l’originaria ambivalenza della concordia e della fraternizzazione tra comunità nell’ambito del grande partito nazionalista Wafd (1919). Il discorso del Wafd sulla laicità e sulla secolarizzazione è molto più islamico di quanto generalmente si creda. La monarchia egiziana e la costituzione del 1923 non smantellano le strutture dello Stato confessionale e non rimettono in discussione neppure per un istante l’esistenza di più statuti personali. Modernizzano le strutture e i dispositivi, li adattano, per quanto possibile, all’imperativo di uguaglianza e all’idea regolatrice di cittadinanza.
Ma, nei fatti, questa unione sacrée o questa simbiosi si basa su istituzioni, organizzazioni dello spazio, modi di fare, pratiche quotidiane che organizzano e facilitano la coesistenza. I quartieri “indigeni” dove abitano copti e musulmani e che possono essere contrapposti ai quartieri “europei” o “occidentalizzati” delle classi superiori e delle comunità europee sono bastioni del nazionalismo. Si vive uno accanto all’altro, si parla, ci si rende visita. Un sistema educativo statale che progressivamente prende il sopravvento su quello tradizionale controllato dagli ulema è accessibile agli egiziani delle classi medie emergenti, indipendentemente dalla loro confessione. I liceali manifestano insieme, fanno sport insieme, studiano insieme. Si conoscono.
Ma dopo il 1945 ciò che rendeva possibile questa unione verrà eroso. Non mi soffermerò qui sulla nascita della questione identitaria: l’Egitto è ancora un paese musulmano, con tutto ciò che questo implica? La domanda è stata posta, diffusa, espressa e valorizzata dalla confraternita dei Fratelli Musulmani. Ricordo però ciò che è meno evidente: uno dei fatti sociali principali degli ultimi cento anni è stato la liberazione della donna, la quale ha avuto accesso all’istruzione, al mercato del lavoro e ha scelto il proprio marito. La comparsa della donna nello spazio pubblico sarà una delle cause, se non la principale, della creazione delle strutture comunitarie. In effetti, essa ha reso possibili i matrimoni tra persone di religioni differenti.
Considerati gli statuti personali e la legislazione, ogni matrimonio “misto” è però una conquista per la comunità musulmana e una perdita per le comunità non musulmane: se lo sposo è musulmano, lo saranno anche i figli, e un non musulmano per sposare una musulmana dovrà convertirsi all’islam. Stando così le cose, verranno lentamente attivate pratiche sociali volte a proibire la donna copta allo sguardo musulmano (per esempio, il capo di famiglia copto porterà i suoi figli da un medico copto) e a organizzare la promiscuità uomo-donna in uno spazio comunitario (le chiese creano dei club annessi al luogo di culto).
Per altri versi il principale deficit dei successori del presidente Nasser è stata l’indifferenza di fronte al terribile declino del sistema educativo egiziano, quando la scuola era il fattore e lo spazio d’integrazione per eccellenza. La degradazione e l’estensione dello spazio urbano rimettono in discussione gli stili di vita quotidiani e il vivere insieme, che erano lo zoccolo duro dell’unità nazionale. Infine, all’interno della comunità copta, gli equilibri interni tra grandi proprietari e clero si sono rotti a vantaggio di quest’ultimo a causa dei colpi inflitti ai primi dalle riforme nasseriane.
Forse queste evoluzioni erano difficili da contrastare. Ma le scelte politiche del presidente Sadat le aggraveranno al punto che esse si riveleranno irrimediabili. Il successore di Nasser, che vuole riconquistare il Sinai (occupato nel 1967) e mettere fine al partenariato con l’ingombrante padrino sovietico, ha bisogno dell’Arabia Saudita all’esterno e degli islamisti all’interno. Per distruggere le roccaforti di sinistra all’università cavalcando l’ondata di religiosità e di “ritorno a Dio” che ha fatto seguito alla disfatta del 1967, favorirà la nascita di un movimento islamista plurale, di discorsi islamisti radicali, alimentando troppo spesso uno o più odiosi discorsi anti-cristiani. Gli islamisti più estremisti non si accontentano di “suonarle alla sinistra”: le loro estorsioni a danno dei copti – da un racket presentato come ripristino della jizya agli omicidi, passando per l’incendio delle chiese – sono sempre più numerose. E soprattutto lo Stato, su indicazione dei vertici, guarda altrove.
La ferita è profonda e non sarà mai rimarginata. Queste pratiche rianimano la solidissima tradizione vittimistica e il culto del martirio dei copti, i quali percepiscono l’ambiente come unanimemente ostile e preferiscono il ripiegamento su se stessi. Diversi osservatori sono molto critici verso la gestione delle relazioni con lo Stato da parte di papa Shenuda III e ritengono che egli sia arrivato troppo spesso al “braccio di ferro”, che abbia fatto tutto il possibile per opporsi a Sadat, che si sia preoccupato soprattutto di consolidare il dominio del clero sulla comunità e che abbia favorito, all’interno di essa, la diffusione di ideologie antipatiche quanto i discorsi anti-cristiani dell’altra sponda. Non sono sicuro che questi analisti abbiano ragione su tutti i punti. Ricordo solamente che non è chiaro se papa Shenuda abbia avuto tutta la libertà che gli viene attribuita. Si tende a credere che egli sia all’origine di tutti gli “errori” della sua comunità o delle sue rivendicazioni, comprese le più irrealistiche, ma questo non è provato. Segnaliamo, al contrario, che il suo atteggiamento ostile verso Israele gli sarebbe valso un sostegno molto solido nella comunità intellettuale egiziana, musulmani e copti indistintamente, e che sarebbero stati numerosi i membri musulmani di questa comunità che avrebbero provato simpatia e manifestato il loro sostegno alle principali rivendicazioni copte.
Nonostante il proliferare, all’interno di ciascuna comunità, di discorsi odiosi che consolidano sgradevoli “immagini dell’altro”, nonostante l’attuazione quotidiana di pratiche di costruzione di spazi comunitari, nonostante il moltiplicarsi delle discriminazioni quotidiane ad opera di tutti, agenti dell’apparato di Stato e copti inclusi, nonostante infine la relativa frequenza di incidenti violenti, che sono talvolta veri e propri pogrom, la “questione confessionale” resta tabù fino al 2004 quando diventa improvvisamente uno dei temi principali del dibattito pubblico.
L’emergere della questione e le sue molteplici sfaccettature sono state studiate molto bene da Laure Guirguis. Non mi interessa qui studiare le prese di posizione assunte dagli uni e dagli altri, ma ricordare che la gerarchia copta non ha sempre dato prova di saggezza o giudizio. Oltre a qualche sconcertante eccesso verbale di alcune personalità (l’amba Bishoi, numero due della Chiesa, per esempio) che in virtù delle loro funzioni avrebbero dovuto essere prudenti, la sua gestione degli incidenti relativi alle conversioni reali o presunte all’islam delle mogli di alcuni preti desiderose di lasciare i loro mariti, è stata disastrosa. Tra l’altro queste mogli non si sono più viste, ciò che rende credibili le tesi e le voci che facevano pensare a un loro sequestro. Infine, la gerarchia copta ha spesso dato l’impressione di essere arrogante e di sfruttare la fragilità di un regime ansioso di piacere a Washington e di preparare la trasmissione ereditaria del potere. Dire questo naturalmente non significa affermare che gli attori statuali o religiosi musulmani siano stati molto più brillanti e la saggezza e l’umanità degli ultimi due grandi imam di al-Azhar sono l’importante eccezione che conferma la regola.
Ora c’è una situazione di emergenza. La principale evoluzione degli ultimi dodici anni è la “democratizzazione” degli incidenti interconfessionali. Questi non sono più appannaggio di qualche islamista fanatico che sente il bisogno di rifarsi sui copti. Oppongono ormai persone che abitano nello stesso quartiere. In qualsiasi lite fra vicini si rischia di perdere il controllo della situazione ed è un miracolo che ciò non accada più spesso.
Gli incidenti principali hanno due tipi di cause. A) la questione della costruzione delle chiese, un dossier che ormai non dà tregua all’apparato statale. Allo stato attuale è praticamente impossibile ottenere un’autorizzazione per la costruzione di chiese. I copti costruiscono perciò chiese illegali […] e spesso, queste chiese illegali o decretate tali sono incendiate da una popolazione infastidita dalla loro presenza, con una intolleranza, sia detto en passant, che cinquant’anni fa sarebbe stata inimmaginabile. B) le storie d’amore tra persone di confessione diversa, soprattutto se si traducono nella partenza della giovane, che lascia il domicilio famigliare. Nessuna delle due comunità sembra disposta a riconoscere il diritto degli individui alla felicità; e quella copta è maggiormente giustificabile poiché perde membri a ogni matrimonio misto.
Questo quadro, molto fosco, spiega il vero e proprio panico che si è impadronito della comunità copta. Essa sapeva che l’assolutismo di Mubarak, malgrado i suoi difetti, costituiva una protezione e apportava una dose apprezzata di liberalismo. Mubarak poteva fare concessioni agli oscurantisti, ma non era uno di loro. Certamente non ha riservato al problema l’attenzione che meritava ma, fino a prova contraria, non l’ha consapevolmente aggravato. Questo panico sarà acuito, in un primo tempo, dall’eccidio del 9 ottobre 2011 nel quartiere Maspero del Cairo (nell’inconscio copto l’esercito era il baluardo del legame nazionale, il rappresentante dello Stato-nazione egiziano, il protettore ultimo). Il protettore è diventato nel giro di poche ore il carnefice e questo lascerà tracce profonde. In alcune città di provincia le famiglie che hanno i mezzi per farlo cercano di emigrare e, dallo scorso gennaio, oltre 93.000 copti hanno abbandonato il territorio. Resta da capire se è una situazione temporanea a meno.
Il quadro è già abbastanza cupo e non è il caso di dipingerlo a tinte ancora più fosche. È bene notare che la comunità intellettuale, l’intelligentsia, è molto sensibile al problema e sono molto numerosi i suoi membri che hanno spesso preso le difese dei copti, sapendo trovare le parole giuste e sbagliando di rado. Ancora più rassicurante è il fatto che se i copti, in generale, hanno avuto il sostegno dei musulmani che non avevano alcun problema con la nozione di uguaglianza dei cittadini, ricevono sempre più l’appoggio di quanti, molto numerosi, pur non accettando questa nozione di uguaglianza e non amando veramente i cristiani, sono indignati dai maltrattamenti inflitti ai copti e condannano con fermezza e veemenza le uccisioni, gli incendi dei luoghi di culto e dicono a voce alta che l’Islam “non è questo” e che non vogliono più che si verifichino fatti simili.
Resta ancora molto da fare – tra le altre, un aggiornamento copto – e non dovremmo minimizzare i pericoli: abbiamo visto come alcune centinaia di militanti siano riusciti, l’11 settembre 2001, a devastare il rapporto tra l’islam e l’Occidente per almeno un decennio. Detto questo, non bisogna neppure sottovalutare le energie e la vitalità dell’umanesimo musulmano, il primo a essere minacciato dall’estremismo.
__________
Il testo integrale dell’analisi di Tewfik Aclimandos, in “Oasis”:
> Copti e musulmani d’Egitto: come si è arrivati all’emergenza di oggi
__________
Il comunicato del grande imam di al-Azhar, Ahmad Muhammad al-Tayyeb, a commento dell’eccidio di copti compiuto dall’esercito il 9 ottobre 2011 nel quartiere Maspero del Cairo:
> Uno shock per la coscienza dell’Egitto
________
Sulla Turchia di Erdogan come modello per i Fratelli Musulmani d’Egitto, in un’analisi di Tewfik Aclimandos per “Oasis”:
> Come Erdogan affascina gli egiziani
__________
Sugli orientamenti dell’opinione pubblica egiziana, in un’inchiesta del Pew Forum on Religion & Public Life di Washington:
> Il “democratico” Egitto manda a morte gli apostati