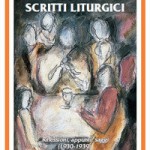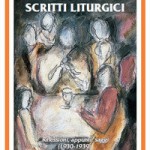
Giovanni Battista Montini, Scritti liturgici. Riflessioni, appunti, saggi (1930-1939), a cura di Inos Biffi (Collana Quaderni dell’Istituto Paolo VI), Studium, Roma 2010, pp. 304 – € 35,00.
Presentazione
Sono raccolti in questo volume testi editi e inediti di Giovanni Battista Montini dalla fine degli anni ’20 alla fine degli anni ’30. E precisamente: il commento alle feste dell’anno liturgico apparso sulla rivista della FUCI, «Azione Fucina», dal Novembre 1930 al Novembre 1931; due quaderni (inediti) di appunti stesi per la spiegazione della liturgia in generale, dei riti della Messa e delle Messe domenicali e festive relativi agli anni 1926-1933 e 1936-1937; il commento (inedito) ai «Vangeli domenicali su Gesù Cristo» degli anni 1938-1939; un gruppo di saggi di argomento liturgico-artistico risalenti a quegli anni. Alcuni dei documenti hanno più la forma di appunti che non di completa stesura. Tuttavia nelle note, dettagliate e meticolose, il Curatore ha cercato di svolgerli, completando riferimenti e allusioni e mettendone in luce il vario contenuto in apposite introduzioni. Anche grazie a tale più compiuta lettura questi scritti rivelano singolare importanza: indicano cioè quanto fosse versatile e approfondita, sotto diversi aspetti precorritrice, la cultura liturgica del giovane Montini ed ampia e multiforme la sua informazione bibliografica. In particolare, egli aveva un’autentica e precisa teologia della liturgia, intesa sempre come reale ed efficace presenza del mistero di Cristo e come versione orante della fede e del dogma. Montini concepiva la liturgia come principio e risorsa primaria dell’esperienza e della spiritualità cristiana. Non mancava di sottolineare con vigore la funzione educativa della pietà, ponendone in evidenza la dimensione ecclesiale. Coglieva inoltre l’importanza della storia della liturgia, che dava prova di ben conoscere nelle sue linee principali, mostrandosi specialmente sensibile alla proprietà estetica dei riti, alla loro arte e poesia. Una visione che in quegli anni ben pochi possedevano e che troveranno pratica attuazione anche negli anni dell’episcopato milanese, trovando poi compiuta sistemazione nella costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium.
Quella trama dove passa il filo di Dio
Nel volume Scritti Liturgici. Riflessioni, appunti, saggi (1930-1939) – Brescia- Roma, Istituto Paolo VI – Studium, 2010, pagine 296 euro 35 – sono raccolti i più antichi testi dedicati da Giovanni Battista Montini alla liturgia e precisamente: il commento all’anno liturgico apparso in “Azione Fucina” (dal novembre 1930 al novembre 1931); due Quaderni di appunti stesi negli anni 1926-1933 e 1936-1937 per la spiegazione della liturgia in generale, dei riti della messa, e delle messe domenicali e festive; il commento ai “Vangeli domenicali su Gesù Cristo”, che è ancora un’analisi dell’anno liturgico (anni 1938-1939) e infine un gruppo di brevi saggi di argomento liturgico, risalenti a quegli anni. Pubblichiamo ampi stralci della Presentazione scritta dal curatore.
Egli già possedeva un’autentica e precisa teologia della liturgia, intesa come reale ed efficace presenza del mistero di Cristo e come versione orante della fede e del dogma. La celebrazione era da lui concepita come principio e risorsa primaria dell’esperienza e della spiritualità cristiana, e come componente essenziale per l’educazione alla pietà, mentre ne poneva in chiara evidenza la dimensione ecclesiale.
“Montini, assistente della Fuci – scrive Marcocchi – concepì la liturgia non come realtà estetizzante o archeologica o rubricistica, ma come il luogo privilegiato per entrare in comunione con Cristo e ancorare la vita spirituale ai fatti della vita del Signore attualizzati nell’anno liturgico”.
Montini coglieva inoltre l’importanza della storia liturgica, che dava prova di conoscere nelle sue linee principali, mostrandosi specialmente sensibile alla proprietà estetica dei riti, alla loro “arte” e poesia. Come si vede una visione della liturgia, multiforme, poliedrica e dagli svariati intrecci, che ben pochi in quegli anni possedevano, soprattutto con la perspicacia e il vigore del giovane Montini, che aveva saputo assimilare tanto intimamente le fonti, da saperle riesprimere con un tono e un linguaggio tipicamente suo, e non senza suscitare tenaci e autorevoli opposizioni da parte di chi giudicava la mentalità e l’educazione liturgica una specie di pericolosa gnosi.
A dire, inoltre, quanto la liturgia occupasse il sapere e il gusto di Montini, sono eloquenti le sue iniziative pratiche, ossia la sua predicazione e le sue lezioni, in cui trasmetteva nell’ambiente intorno a sé la sua conoscenza e il suo gusto per la liturgia. Chi seguirà il successivo pensiero liturgico di Montini come arcivescovo di Milano e come Papa, che approverà la costituzione liturgica Sacrosanctum concilium, lo troverà esattamente coerente con le riflessioni e considerazioni disseminate in questi scritti giovanili. In quegli anni si distingueva nello scrivere di liturgia con acutezza e fascino specialmente Romano Guardini, che nel 1918 con Lo spirito della liturgia aveva inaugurato la collana “Ecclesia orans”, promossa e diretta dall’abate di Maria Laach, Ildephons Herwegen. Per interessamento anche di Montini e con la prefazione di padre Giulio Bevilacqua il suggestivo volumetto apparirà tradotto nel 1930 presso la Morcelliana, che si mostrava vivamente interessata delle opere liturgiche di Guardini, e in generale del tema liturgico. D’altra parte, questa attenzione alle opere di Guardini si inseriva in una sensibilità cristocentrico-liturgica che aveva profondamente e variamente segnato l’educazione di Montini, grazie soprattutto all’opera dello stesso padre Bevilacqua, che fu il suo grande maestro.
Tra i testi qui pubblicati abbiamo un commento all’anno liturgico 1930-1931, apparso in “Azione Fucina”, il quindicinale della Fuci. Vi possiamo rilevare come tratti emergenti anzitutto una lucida teologia della ricorrenza degli eventi salvifici secondo il calendario della Chiesa: l’anno sacro è “stagione completa dello spirito”, rinnovamento e ripetizione della vita di Cristo e dei suoi misteri, così che la sua storia diventi storia dell’anima, è riflessione sulla sua dottrina, rigenerazione dell’incarnazione; giro di evoluzione totale dell’anima.Sono gli splendidi accenti e qui, direi, di sapore quasi caseliano, con cui Montini apre il suo commento: “Questo ciclo liturgico sarà ciclo dell’anima. Questa storia di Cristo deve ripetersi come storia della mia anima. Ogni anno la Chiesa rinnova il suo racconto su la vita di Gesù, ne ripensa la stessa dottrina, ne ripresenta i misteri, affinché tale vicenda sia la stagione completa dello spirito, avido di santità, avido di rigenerare in sé l’incarnazione del Signore. Vivere questa vicenda è compiere un giro di evoluzione totale dello spirito cristiano”.
Nella stessa linea, la vicenda della liturgia è sentita come riflesso e disegno della vicenda della vita, dal suo inizio alla sua fine: “Nella vicenda liturgica si riflette (…) la vita”.
Questa concezione dell’anno liturgico più analiticamente risalta in questo ampio sguardo che Montini volge sul corso del tempo coinvolto nella trama di un anno sacro: “L’anno liturgico è come l’immagine completa della vita: l’infanzia a Natale, l’adolescenza all’Epifania, la virilità, la fatica, il dolore, l’amore alla Pasqua, la pienezza e la fecondità alla Pentecoste, la saggezza e l’esperienza della cosidetta “vita vissuta” nel periodo successivo. Poi l’insistente meditazione dell’al di là, suscitata dalle solennità dei Santi e dei Morti aveva riempito lo spirito di gravi ed alti pensieri; s’era giunti al punto di desiderare l’eternità: ma come si poteva qualificare simile desiderio quale indice di vecchiaia e foriero della fine? che l’ultima avventura dell’uomo sia la sorpresa, e perciò lo spavento, di finire? L’ultima scena dovrebbe allora esser tragica e tremenda anche nel dramma liturgico. E lo è, difatti. L’ultima domenica dell’anno spirituale è infatti improntata a carattere di apocalittica tragicità”. “Dopo averci prospettato Gesù Fanciullo, Gesù Redentore, Gesù Pastore e Maestro, la liturgia ci svela, su uno sfondo di conflagrazione cosmica, Gesù Giudice”.
L’anno liturgico, dal suo inizio con la Prima domenica di Avvento, è sentito, in particolare, come un itinerario di ricerca del Signore, che parte dalla coscienza del proprio peccato: “Eravamo partiti – scrive Montini – in cerca del Salvatore per aver sperimentata la miseria dell’uomo”; ed ecco, di domenica in domenica, di festa in festa, il suo trascorrere scandire, non senza tratti drammatici segnati dalla stessa liturgia, le vicissitudini dell’anima.
D’altronde, secondo Montini, abbiamo “venuta di Dio nel cuore del tempo”. Lo stesso passare del tempo è, infatti, tutto avvertito non come un trascorrere cronologico insensato, ma come un tragitto temporale attraversato dalla grazia.
Con sensibilità e linguaggio, che ci verrebbe da dire “esistenziale”, discorre de “l’istante, in cui il fuggevole flutto del fiume, ch’è la nostra vita, sarà toccato dall’istante eterno. Il contatto del tempo con l’eternità riempie di trepidazione e di stupore”; la vita si trova interpretata come “trama dove il filo di Dio sta per passare a tessere l’unica tela della vostra vita!”.
È la ragione per cui – continua Montini – “ancor prima che l’aureo filo di Dio, scorra nei poveri cànapi umani, già questi mi son divenuti cari e preziosi. E mentre prima non capivo dove tendevano e come si sarebbero sbrogliati dall’intricata matassa delle vicende senza senso e senza connessione, ora già vedo come si distendono in sapiente disegno, e come la trama sfilacciata della vita umana si può intrecciare, serrare, unificare e fluire, come serico manto che rimonta su le spalle di Cristo”.
Questo – com’è chiamato – “aureo filo di Dio” è esattamente la grazia del tempo liturgico, in cui, tramite la memoria della Chiesa, si dispongono gli avvenimenti della salvezza: tale grazia riscatta e conferisce valore a tale “intricata matassa delle vicende” e ne permette una lettura soprannaturale, di là dal “ditirambo risonante” di altre “mille voci”, devianti e vane.
Mentre, proprio nel messaggio e nel dono delle molteplici festività dell’anno della Chiesa, e quindi in Cristo, da esse rivelato e offerto, l’uomo trova, in maniera multiforme, a seconda delle ricorrenze liturgiche, il compimento dei suoi più intimi desideri e quindi del suo amore.
Con spirito agostiniano Montini ritorna su questo tema dei desideri raccolti in “fascio”, che presentono Cristo e sono avviati e allineati a Lui, l’Uomo Dio nel quale si incarnano.
La concezione dell’anno liturgico si fonda, a sua volta, sulla convinzione che “i fatti storici della vita del Signore devono tradursi in fatti spirituali delle nostre anime”.
Scrive Montini in una magnifica pagina: “L’economia seguita da Dio nel disporre vicende della storia del Salvatore, corrisponde all’economia segreta e intima da realizzare nella direzione degli spiriti fedeli. Ciò che fu del Fratello Primo deve rinnovarsi in tutti i fratelli uomini. Ciò che fu nelle circostanze della sua vita fatto esteriore oltre che interno mistero, deve riprodursi nell’educazione delle nostre coscienze. La vita seguita da Dio per venire a noi segna la nostra via per andare da lui. Se così è: l’infanzia di Cristo ha da essere l’infanzia nostra. Come la nascita sua all’ordine nostro naturale deve significare nascita nostra all’ordine suo, soprannaturale, così ogni passo della sua vita darà ora un impulso al cammino spirituale dell’anima. Perciò il problema mio sarà questo: interpretare il significato spirituale della vita di Gesù per farlo precetto della mia. E qui la liturgia mi è chiave d’interpretazione. Letterale, simbolica, analogica, o quale? La liturgia dirà. E mostrerà quale ricchezza concettuale, quale meditazione teologica arricchisca la preghiera cristiana”.
È il motivo che si va ripetendo: il ciclo dell’anno liturgico, con le sue feste principali, tratteggia e raffigura “le leggi di sviluppo della spiritualità cristiana” descrivendo appunto così “l’itinerario dell’anima”, sul quale la “storia di Cristo” si ripete nostra storia, “come storia della mia anima”. Questi semplici accenti lasciano indovinare l’inesauribile ricchezza delle pagine liturgiche del giovane Montini: anche dopo i cambiamenti della riforma conciliare, esse conservano intatto il loro valore e la loro suggestione. Del resto, è quello che si deve riconoscere a tutto l’acuto e intenso magistero di Paolo VI, ingiustamente rimosso e trascurato.
Alcuni dei documenti pubblicati in questo volume hanno la forma di rapidi appunti, che le note provvedono a svolgere, completandone i riferimenti e le allusioni. Anche grazie a tale più compiuta lettura, rivelano la loro singolare importanza: indicano cioè quanto fosse approfondita e versatile la cultura liturgica del giovane Montini, e ampia la sua informazione bibliografica.
(©L’Osservatore Romano 23 luglio 2011)