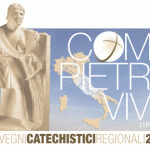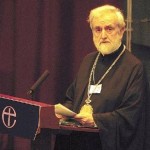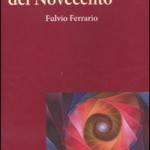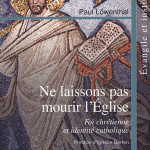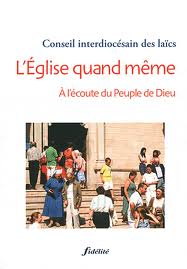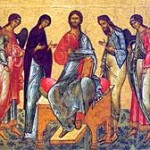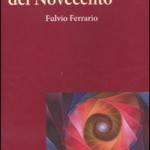
Il libro:
Fulvio Ferrario, “La teologia del Novecento”, Carocci, Roma, 2011, pp. 304, euro 24,00.
È uscito quest’anno in Italia un libro sulla teologia del Novecento scritto da un teologo protestante, il valdese Fulvio Ferrario, che colpisce non solo per la rara chiarezza e ricchezza dell’esposizione e per l’efficacia narrativa, ma anche per il rilievo dato ad alcuni grandi teologi che sono, tra i non cattolici, proprio i più vicini alla visione e alla sensibilità dell’attuale papa, lui stesso teologo.
*
Il primo è Oscar Cullmann (1902-1999), nato a Strasburgo, vissuto a Basilea e ospite a Roma, negli anni del Concilio Vaticano II, della stessa facoltà teologica valdese nella quale Ferrario insegna.
Ferrario lo annovera “tra i teologi protestanti più apprezzati in campo cattolico”. Pur meno famoso di un Barth, di un Bultmann, di un Bonhoeffer, Cullmann ha lasciato un’impronta forte e durevole.
È lui che ha coniato la formula – divenuta d’uso universale – del “già e non ancora” per esprimere la dialettica tra la salvezza già realizzata da Cristo e l’attesa del compimento finale.
Ed è lui, soprattutto, che ha insistito in ogni sua opera – da “Cristo e il tempo” a “La cristologia del Nuovo Testamento” – sulla continuità tra il Gesù della storia e il Cristo della fede. Cullmann era prima di tutto un grande esegeta delle Sacre Scritture, ma ha sempre coniugato la ricerca filologica e storiografica alla riflessione teologica. E “nella ricerca di questo difficile equilibrio – scrive Ferrario – egli costituisce un modello, in una stagione nella quale la difficoltà di comunicazione tra le due discipline raggiunge livelli pericolosi”.
*
Un secondo grande teologo messo in primissimo piano da Ferrario è il tedesco Wolfhart Pannenberg, luterano, 83 anni.
In lui il nesso tra teologia e filosofia è strettissimo. Il Cristo crocifisso e risorto è l’evento capitale – raggiungibile anche dalla scienza storica – che consente di afferrare il senso della storia universale dell’uomo e del mondo. La rivelazione di Dio è storia; e lo smarrimento di questo orizzonte è la radice della crisi della cultura contemporanea. “È abbastanza facile notare – scrive Ferrario – le obiettive convergenze di questa impostazione con molte tesi del magistero cattolico romano”.
Non solo. Anche nella dottrina dei sacramenti e dei ministeri ordinati le riflessioni del protestante Pannenberg si avvicinano a quelle cattoliche. Ferrario sottolinea che “egli ritiene non solo possibile, ma a certe condizioni persino auspicabile, che il protestantesimo riconosca l’importanza del cosiddetto ‘ministero petrino’, cioè del papato”.
Lo stesso avviene nel campo della teologia morale:
“L’orientamento generale del pensiero di Pannenberg e la sua fiducia nelle possibilità teoriche di un’etica filosofica di derivazione aristotelica lo conducono a guardare con un marcato sospetto a molti orientamenti delle società secolarizzate in campo morale, ad esempio in materia di sessualità. In alcune occasioni egli esprime pubblicamente il proprio disaccordo nei confronti di posizioni che gli appaiono troppo ‘permissive’ delle Chiese evangeliche tedesche”.
Ma ciò non trattiene Ferrario dal concludere il profilo di Pannenberg – cioè del più “ratzingeriano” dei grandi teologi protestanti viventi – con questo altissimo apprezzamento:
“Nel contesto postmoderno, il pensiero di Pannenberg detiene un’inattualità che affascina e stimola. L’appello al rigore e alla portata universale della ragione critica, l’insistenza su una visione della fede come ‘grande narrazione’, addirittura storico-universale, costituisce una provocazione nei confronti della retorica di una teologia che vorrebbe ridursi all’autobiografia del teologo. Pannenberg ha in comune con i classici della riflessione teologica l’idea di un pensiero intrepido, che non accetta di fermarsi prima di aver incontrato la realtà di Dio. Ed è questo ardire del concetto che ne fa, al di là di ogni critica, un maestro”.
*
Una terza personalità messa in forte rilievo da Ferrario nel capitolo dedicato alla teologia delle Chiese ortodosse è Ioannis Zizioulas, metropolita di Pergamo.
Zizioulas è il vescovo-teologo più autorevole del patriarcato ecumenico di Costantinopoli ed è amico di lunga data di Joseph Ratzinger. “Egli sviluppa – scrive Ferrario – l’idea della Chiesa come comunità che scaturisce dall’eucaristia. E in quanto tale essa è, non in senso teorico ma altamente realistico, corpo terreno del Risorto e partecipazione alla vita trinitaria”.
Non meraviglia, quindi, che “l’ecclesiologia eucaristica di Ioannis di Pergamo è assai utilizzata e apprezzata in ambito ecumenico. Essa è infatti molto organicamente, ed elegantemente, legata all’insieme della visione teologica e permette una comprensione della Chiesa in chiave anzitutto mistico-sacramentale, contro una deriva giuridica della quale, a volte, gli stessi cattolici romani evidenziano almeno alcuni limiti”. Una comprensione della Chiesa alla quale, riconosce Ferrario, “la mentalità protestante reagisce per contro in modo ambivalente”.
*
Nella pagina finale del suo avvincente viaggio nella teologia del Novecento, Ferrario cita la lezione di Benedetto XVI a Ratisbona, con la sua rivendicazione di uno spazio pubblico per la teologia nelle moderne università del sapere.
E così conclude:
“Il nostro sguardo alla storia della teologia del Novecento dovrebbe aver mostrato che la teologia è stata ‘pubblica’ proprio quando è stata ecclesiale: quando cioè ha dato espressione intellettualmente critica al tentativo della comunità cristiana di annunciare l’evangelo nel mondo. […]
“I metodi esegetici, storici, filologici impiegati dalla teologia saranno gli stessi delle scienze religiose o delle teorie del cristianesimo che già ora l’affiancano e con le quali il pensiero ecclesiale è chiamato a dialogare serenamente.
“Ma diverso è il compito che la teologia cristiana si ostina a ritenere che le sia assegnato dal suo Signore: quello di contribuire, mediante la riflessione, al ministero della Chiesa, cioè alla predicazione della morte e della risurrezione di Gesù Cristo, nell’attesa della sua venuta”.
E con questa limpida sentenza del più autorevole teologo protestante italiano, i molti falsi teologi che oggi affollano il proscenio – per “umanizzare” Gesù invece che predicarlo vero Dio e vero uomo – sono serviti.
__________
L’autore è professore di dogmatica e discipline affini presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma e docente invitato presso l’Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino di Venezia. Dirige la rivista teologica della Facoltà Valdese “Protestantesimo”.
Sandro Magister