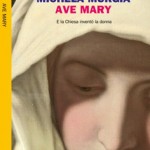
Presentazione
La chiesa è ancora oggi, in Italia, il fattore decisivo nella costruzione dell’immagine della donna. Partendo sempre da casi concreti, citando parabole del Vangelo e pubblicità televisive, icone sacre e icone fashion, encicliche e titoli di giornali femminili, questo libro dimostra che la formazione cattolica di base continua a legittimare la gerarchia tra i sessi, anche in ambiti apparentemente distanti dalla matrice religiosa. Anche tra chi credente non è. Con la consapevolezza delle antiche ferite femminili e la competenza della persona di fede, ma senza mai pretendere di dare facili risposte, Michela Murgia riesce nell’impresa di svelare la trama invisibile che ci lega, credenti e non credenti, nella stessa mistificazione dei rapporti tra uomo e donna.
“All’Azione Cattolica col biondo Nemecsek”
intervista a Michela Murgia, a cura di Mirella Serri
in “La Stampa” del 16 luglio 2011
«Regalare libri è come attivare una bomba a orologeria che magari non deflagra subito ma si accende anche molto tempo dopo». Il pacco dono che ha innescato la miccia di Ave Mary polemico
saggio Einaudi di Michela Murgia su Maria di Nazareth, approdato velocemente nelle classifiche – è stato un gentile omaggio di più di dieci anni fa del teologo Lucio Casula. «Si trattava di In memoria di lei, fondamentale ricerca di Elisabeth Schüssler Fiorenza che è rimasta stampigliata nella mia memoria dando origine all’avventura di Ave Mary poiché mi ha aperto gli occhi sul rapporto tra donne e Chiesa», commenta la scrittrice che ha esordito con Il mondo deve sapere (Isbn edizioni), la prima eclatante denuncia dello sfruttamento dei lavoratori dei call center. Da cui Paolo Virzì ha tratto il film Tutta la vita davanti .
L’anno scorso si è conquistata il Campiello con Accabadora (Einaudi) e ora è entrata nella schiera degli scrittori che – da Piergiorgio Odifreddi a Giulio Mozzi, autore con Valter Binaghi di 10 buoni motivi per essere cattolici (Laurana editore) – si cimentano con temi religiosi («Mozzi l’ho apprezzato, ma Odifreddi, che si dichiara ateo, è meglio che non si occupi di temi che possono essere di pertinenza di un cristiano critico»). Cumula successi letterari ma ha alle spalle una vita di precariato – venditrice di multiproprietà, operatore fiscale, dirigente amministrativo, portiere di notte -, una lunga militanza nell’Azione cattolica, studi di teologia all’istituto di Scienze religiose.
La narratrice di Cabras è, insomma, proprio una tipa tosta e dura al pari di quei cristalli di quarzo bianco e rosa che danno luce alle bellissime spiagge dove è vissuta e cresciuta.
La sua carriera di lettrice ha preso avvio tra sapori di mare e anche profumi di fritti delristorante paterno.
«Specialità pesce. Io viaggiavo con un piatto in mano e in tasca Erno Nemecsek, biondo, delicato e magro protagonista dei Ragazzi della via Paal , destinato a morire di polmonite. Nessun libro è innocente, lascia sempre un’impronta indelebile. Erno è il primo morto che incontro nella mia vita, un ragazzino che come me giocava per strada. Un trauma. A farmi compagnia c’era anche Mark Twain con Le avventure di Tom Sawyer, meraviglioso per l’invenzione linguistica. Poi è arrivata la serie degli Harmony che ha avuto un’influenza positiva. Mi identificavo con quelle giovani donne, protagoniste semplici e sognanti che ambivano a una casa, un giardinetto, tanti bambini ma che trovavano tanti ostacoli sulla loro strada. Oggi circolano molti snobismi. Credo che non si debba disprezzare la letteratura di genere. Federico Moccia, per esempio, dà vita a cliché in cui i giovani si riconoscono, riprende la storia di Giulietta e Romeo e la cala nel presente. Tutto questo invoglia alla lettura».
In famiglia si leggeva?
«Mia madre soprattutto, e mi ha contagiato. Un virus che non sempre ha dato buoni frutti».
Cos’è successo?
«Avevamo un piccolo negozio in cui si vendevano oggetti di artigianato locale ma anche qualche manufatto di valore. E io anche lì davo una mano. Ero tutta immersa in Stephen King che mi teneva con il fiato sospeso quando, nella stanza a fianco alla mia, arrivano i ladri: così concentrata non li sento e loro si portano via un plateau di gioielli».
Un libro cambia la vita, direbbe Marzullo. Qualche volta in peggio.
«Quella della mia famiglia non c’è dubbio. Mi assolsero dalle mie colpe, ma poi arrivò anche un altro libro a mutare il corso della mia esistenza. Mi dedicavo interamente, con grande trasporto, al volontariato nell’Azione cattolica. All’epoca il mio autore preferito era Erri De Luca che mi travolgeva con lo stile semplice e per la grande profondità della riflessione. A seguire i miei corsi di religione a scuola, su Gesù, San Pietro o gli apostoli, c’erano anche allievi che non erano credenti.
Per coinvolgerli mettevo a confronto cinema, musica, arte, letteratura, mostrando le differenze tra i dissacratori Black Sabbath, gruppo heavy metal britannico, e il più tradizionale Jesus Christ Superstar ; oppure tra il Vangelo secondo Matteo di Pasolini e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Mi cimentai anche nel confronto tra Ipotesi su Gesù di Vittorio Messori e L’ultima tentazione di Cristo di Nikos Kazantzakis, assai discusso per il suo impegno nel dimostrare che il figlio di Dio, pur privo di peccato, era comunque oggetto di ogni forma di tentazione».
Fu galeotto di sventura?
«Venni chiamata in Curia, io che ero vicepresidente diocesano dell’Azione cattolica di Oristano. Il vescovo mi dice: “Carissima, ti seguo con stima e affetto, ma di Kazantzakis non ne devi parlare”.
L’ho vissuto come un affronto. Giro pagina e cerco altri sbocchi professionali, cominciando ad acquistare competenze come direttore del personale in una centrale termoelettrica».
Altre letture che l’hanno segnata?
«Leggevo grandi russi e grandi italiani. Passavo da Dostoevskij a Salvatore Satta, da Tolstoj a Giuseppe Dessì. Poi è arrivato Kafka e poi c’è stato il periodo della letteratura latinoamericana, da García Márquez a Isabel Allende a Borges. Gli inglesi e gli americani non me li sono mai fatti mancare: dal Grande Gatsby di Fitzgerald a Graham Greene al meraviglioso Cronin de Le chiavi del regno , racconto delle vicende di padre Francis Chisholm, missionario in Cina. A questi si aggiunge la scoperta di italiani, Moravia, in particolare La noia , Calvino, Primo Levi e poi degli story teller Ken Follett e Wilbur Smith e anche degli ebrei americani, da Philip Roth a Paul Auster».
E’ capitato che altri libri regalati segnassero il corso della sua vita? In campo sentimentale?
«Un coetaneo che pensavo mi corteggiasse mi porta un dono: Stefano Benni Il bar sotto il mare , raccolta di racconti dove il bar è un luogo fantastico, si incontrano misteriosi avventori. Però poi la nostra storia non ha decollato: voleva un rapporto intellettuale. Alle ragazze con cui si desiderava avere un flirt si offrivano cd».
Quando lavorava come portiere di notte leggeva?
«Antropologia, sociologia, psicologia mi accompagnavano fino alle prime luci del mattino. Mi ricordo Filippo D’Arino, Manuale di sparizione , che spiega come in un momento in cui la nostra identità è al centro di reti di controllo telematiche sempre più intrusive e anche di relazioni personali sempre più vincolanti e soffocanti, forse non si vuole altro che sparire. Alternavo il Simposio di Platone e Max Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo che mette in relazione due fenomeni omogenei: la mentalità religiosa calvinista e la mentalità capitalista».
Ultimi lidi su cui è sbarcata?
«Sorella di Marco Lodoli mi ha riconciliato con la narrativa. Ho alzato il telefono e anche se non lo conoscevo l’ho chiamato per dirgli quanto mi è piaciuto l’incontro tra la suora Amaranta e “il bambino speciale”, un ragazzino afflitto da una forma di autismo, raccontato con una scrittura agile, piacevole, intensa. Poi c’è Elisa Ruotolo, Ho rubato la pioggia , con il suo affresco di una provincia campana superstiziosa, terra dove si fanno mestieri inverosimili da tempi immemorabili. E perché si smetta di utilizzare il corpo femminile come luogo simbolico, sia nel bene che nel male, mi piace ricordare il video di Lorella Zanardo dedicato al Corpo delle donne. Meditate gente davanti a certe immagini, mi viene da dire».

















 Sarebbe improprio voler estrarre da questi testi, il cui fine è più pastorale che dottrinale, una ricognizione sistematica e comparativa, tra ieri e oggi, a proposito del ruolo della donna nella vita religiosa, benché il Papa non esiti in alcune circostanze a sollevare, anche a tal riguardo, problemi importanti, come quando afferma che le donne, pur essendo escluse dal sacerdozio ordinato, hanno avuto e hanno un ruolo peculiare nella Chiesa, grazie ai carismi di cui sono spesso gratificate dallo Spirito Santo. Si riferisce specialmente ai doni della visione e della “capacità a discernere i segni dei tempi”, cioè di profetizzare per il bene del popolo cristiano, come fecero nel medioevo Ildegarda di Bingen e Brigida di Svezia. Alcune delle sante donne, di cui Benedetto XVI analizza e presenta qui la vita, avevano però superato le fratture tradizionali riguardanti le specializzazioni dei ruoli tra uomini e donne. È il caso, per esempio, di Ildegarda, che fu autorizzata da Eugenio III sia a rivolgersi ai fedeli e al clero per riportarli a una vita migliore sia a predicare a Colonia contro i catari.
Sarebbe improprio voler estrarre da questi testi, il cui fine è più pastorale che dottrinale, una ricognizione sistematica e comparativa, tra ieri e oggi, a proposito del ruolo della donna nella vita religiosa, benché il Papa non esiti in alcune circostanze a sollevare, anche a tal riguardo, problemi importanti, come quando afferma che le donne, pur essendo escluse dal sacerdozio ordinato, hanno avuto e hanno un ruolo peculiare nella Chiesa, grazie ai carismi di cui sono spesso gratificate dallo Spirito Santo. Si riferisce specialmente ai doni della visione e della “capacità a discernere i segni dei tempi”, cioè di profetizzare per il bene del popolo cristiano, come fecero nel medioevo Ildegarda di Bingen e Brigida di Svezia. Alcune delle sante donne, di cui Benedetto XVI analizza e presenta qui la vita, avevano però superato le fratture tradizionali riguardanti le specializzazioni dei ruoli tra uomini e donne. È il caso, per esempio, di Ildegarda, che fu autorizzata da Eugenio III sia a rivolgersi ai fedeli e al clero per riportarli a una vita migliore sia a predicare a Colonia contro i catari. 

