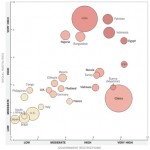Rivista Liturgica 98/4 (2011) :
Editoriale
Nella sua storia quasi centenaria Rivista Liturgica ha elaborato monografie di vario genere e spessore tematico. Alcune “nuove” rispetto all’ordinario modo di considerare la liturgia; altre “ovvie” per l’importanza del tema che, di tanto in tanto, ha bisogno di essere riproposto anche in base alle variabili che la vita liturgica richiede.
Il presente volume rientra nella prima tipologia di temi mai affrontati; e anche questa volta lo facciamo quasi in punta di piedi, consapevoli della complessità dei problemi e delle realtà in gioco. E, soprattutto, tenendo presente che l’argomento considera in modo pressoché esclusivo la situazione italiana (ma l’urgenza della formazione liturgica dei docenti è presente anche in altri contesti culturali ed ecclesiali).
1. Educazione e formazione a partire anche dalla scuola?
La storia di ogni persona è anche la storia della propria educazione. Tutti – o quasi – vanno a scuola. E se molti pensano che la scuola sia il luogo dove si studiano varie discipline, pochi invece sono convinti che anche materie “figlie di un dio minore” – come l’educazione fisica, la religione, ecc. – sono saperi scolastici da studiare. Meno ancora sono coloro che pensano che l’educazione e la formazione integrale dell’uomo sono le finalità della scuola che con orgoglio si definisce laica, ma anche confessionale e libera.
Quando invece consideriamo la formazione non soltanto compito della scuola ma anche di quelle altre scuole frequentabili nei non-luoghi della quotidianità e in famiglia, molti non ne valutano la portata. Nel contesto si tenga presente la distinzione che intercorre tra catechesi e insegnamento della religione. Una distinzione che se in passato non è stata sempre chiara a livello operativo-scolastico, oggi risulta imprescindibile, anche in vista di un’accettazione più libera dell’offerta formativa nella scuola pubblica.
Rivista Liturgica non ha mai trattato questo argomento; se ora lo fa è per rispondere a istanze che provengono da luoghi e sensibilità di vario genere, ma soprattutto per non perdere l’occasione di ribadire che la liturgia non è solo “rito” fine a se stesso, ma espressione culturale che si inscrive nell’intimo della persona, e che è capace di incidere in modo determinante al fine di elaborare cultura proprio a partire da ciò che il culto è nella sua essenza.
2. Tra istanze e problematiche
Una prima e sia pur parziale risposta all’emergenza formativa è presente in Rivista Liturgica n. 2, sotto il titolo: La risorsa educativa della liturgia. Nelle pagine che seguono siamo andati oltre e soprattutto è stata attuata la scelta di far interagire due ambiti che tradizionalmente trovano luoghi diversi di realizzazione: la liturgia nella Chiesa e l’insegnamento della religione nella scuola. Potrebbe mai durante l’ora di insegnamento della religione cattolica (= irc) verificarsi un’actuositas culturale a partire anche da istanze e contenuti che provengono dalla liturgia?
I contributi di questo numero tentano di evidenziare l’interazione tra liturgia e irc; ma soprattutto si impegnano a motivare istanze non sempre considerate in primo piano da parte di liturgisti e docenti di religione (= idr). Istanze che tentano di dare un contributo reale, concreto, professionale a quell’urgenza educativa più volte ricordata dal Magistero, e implicitamente condivisa da quelle voci senza pulpito di coloro che credono e operano nella scuola.
Le istanze alle quali queste pagine intendono offrire un’analisi concreta invitano ad una ulteriore ricerca per aprirsi a risposte operative e di competenza. È in questa linea che formuliamo domande che ci sembrano urgenti:
- È possibile insegnare la liturgia – nella sua dimensione culturale – in quel tempo di apprendimento costituito dall’irc?
- Quale definizione di sé la liturgia deve darsi per potersi presentare, quasi con un suo statuto epistemologico costituito da un metodo e da contenuti scolastici allo scopo di acquisire competenze adeguate ai traguardi previsti dall’irc?
- Cosa pensano i liturgisti e gli IDR di queste prime due problematiche? Possono offrire lo spazio per un dibattito e soprattutto per un positivo incontro?
- Docenti di altre discipline, che insegnano in sinergia e in cooperazione con l’iDR, ritengono che la liturgia sia da riservare alla catechesi e non all’irc? Come è possibile interagire con loro quotidianamente da parte dell’IDR anche nell’ambito della proposta culturale della liturgia?
- Simili posizioni sono in sintonia con le risoluzioni d’intesa e di programmazione tra le due Istituzioni che presiedono all’irc, cioè il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (= MIUR) e la Conferenza Episcopale Italiana (= CEI), che regolamentano la configurazione e l’operatività scolastica dell’irc?
3. Per un quadro di riferimento e di azione
Alcune risposte a questi e ad altri interrogativi possono essere raccolte anche nelle pagine che seguono. Possiamo infatti trovare riferimenti a documentazione non sempre conosciuta sia in ambito ecclesiastico che statale. Ma possiamo incontrarci anche con letture degli obiettivi di apprendimento correlati in modo esplicito o implicito con la liturgia.
Un aspetto che va tenuto ben presente è costituito dal fatto di non creare confusione tra gli ambiti e gli obiettivi propri della catechesi e quelli dell’IRC; complementarietà rimanda alla differenza e alla distinzione, e viceversa, purché tutto concorra – secondo i rispettivi contesti e metodologie – alla formazione integrale della persona.
Poiché ogni insegnamento si avvale di strumenti di mediazione didattica specifici (libri di testo) come pure di media complementari e realmente incidenti (come internet, cellulari, face book, …) nell’apprendimento, si impone il confronto con i risultati circa la presenza del linguaggio liturgico nei testi per l’irc. Dall’esame fatto emerge che il riferimento alla liturgia è scarso. Una situazione che pone ulteriori interrogativi:
- Qual è la formazione liturgica degli Autori?
- Qual è la cura redazionale ed editoriale di consulenza (liturgica) nella progettazione e pubblicazione di un testo di religione da parte delle case editrici?
- Qual è la competenza professionale pedagogico-didattica e biblico-teologico-liturgica dei revisori-censori che provvedono a valutare i libri di testo?
Quest’ultimo interrogativo richiama l’attenzione sui revisori-recensori scelti dal Servizio Nazionale per l’irc della CEI per quanto riguarda l’ambito pedagogico-didattico, e dell’Ordinario per quanto riguarda la “conformità alla dottrina della Chiesa”. Senza il nulla osta dalla CEI e l’imprimatur dell’Ordinario diocesano non è possibile infatti pubblicare e quindi adottare un testo, come concordato nell’Intesa originaria tra l’allora Ministero della Pubblica Istruzione e la CEI, e in quella aggiornata tra il MIUR e la CEI. La vigilanza appare alquanto delegata o addirittura disattesa qualora si considerino i risultati rilevabili dall’esame dei testi. E poiché ogni insegnamento è incarnato da un docente, ci si domanda ancora:
- Quale consapevolezza hanno gli IDR circa il ruolo della liturgia nella formazione religiosa? E quale spazio di proposta formativa occupa la liturgia nella loro programmazione didattica?
- Dal momento che la liturgia è “atto teologale” nel suo divenire esperienziale – e dunque espresso in una forma concreta e storicizzata –, può trovare valenze epistemologiche nei confronti di saperi destinati a divenire vita?
Da tutto ciò scaturisce il dovere di suscitare sensibilità negli idr. Si tratta di un impegno affidato dal MIUR esclusivamente alla CEI e al suo Servizio Nazionale per l’irc e delegato agli Ordinari diocesani che, a loro volta, si avvalgono degli Uffici di Curia (Ufficio scuola per l’irc, Ufficio di pastorale scolastica e irc, Servizio diocesano per l’irc, ecc.). Da qui il bisogno di rilevarne la sensibilità e la consapevolezza mediante la richiesta di quanto questi organismi istituzionali avessero fatto o prevedono di realizzare con interventi, convegni, corsi di aggiornamento… sulla liturgia e sulla sua didattica nell’irc. Richiesta da noi proposta a circa cinquanta Uffici scuola per l’irc, tra cui quelli di diocesi come Milano, Torino, Bologna, Bari, Napoli, Palermo… che gestiscono la formazione e l’aggiornamento di migliaia di idr.
Quali i risultati? I pochissimi Uffici che hanno risposto non pensano a un corso di formazione liturgica per sensibilizzare gli idr per la valorizzazione anche della cultura liturgica durante l’ora di religione. Una constatazione che solleva interrogativi, come si evince anche dalle risposte raccolte nel dossier.
Un servizio di qualificazione professionale per l’idr dovrebbe essere offerto da riviste specializzate. Da qualche anno in Italia per gli idr esistono soltanto quelle edite dalla Elle Di Ci: una per la Scuola dell’infanzia e primaria (L’Ora di Religione) e l’altra per la Scuola secondaria di primo e secondo grado (Insegnare religione). Abbiamo consultato le due ultime annate. Non c’è niente di liturgia, ancor meno di liturgia nell’irc. Formuliamo l’auspicio che queste pagine possano stimolare l’orgoglio e l’impegno di periodici che orbitano nel campo dell’educazione ad interessarsi di cultura specificamente liturgica.
Alcuni Uffici scuola per l’irc propongono l’aggiornamento degli IDR anche mediante pubblicazioni in carta oppure on line, come per esempio l’ufficio scuola dell’arcidiocesi di Milano (Informazioni IRC), di Bari-Bitonto (Tempo pieno, rivista per la scuola). La diocesi di Roma ha dismesso la rivista Religione Scuola Città, che si pubblicava in carta da quasi quindici anni. Ora occasionalmente appare qualche numero “in forma ridotta e digitale”, per “aiutare gli insegnanti nel proprio cammino personale, sia dal punto di vista spirituale che culturale” più che per professionalizzare gli idr. Altre riviste ospitano occasionalmente notizie riguardanti l’irc e gli idr. Per le une e le altre è possibile farsi un’opinione più documentata visitando i variegati e difformi siti delle diocesi italiane.
Vari docenti invece si sono fatti operatori di carità professionale grazie ai propri siti: qui è possibile rintracciare quel menu di operatività (esperienze didattiche, aggiornamenti, consulenze giuridiche), e quella solidarietà professionale che permette di sentirsi sempre in compagnia in un lavoro che rischia di autoreferenziarsi. Ed è possibile rintracciare anche qualcosa di liturgico, come documenta una ricerca pubblicata nelle pagine che seguono.
La formazione a monte degli idr avviene negli Istituti Superiori di Scienze Religiose (= ISSR). Era necessario quindi rintracciare nella ratio studiorum la presenza della liturgia, per quanto si può intravedere nei titoli e nel numero dei corsi, nella presenza di seminari di didattica dell’irc. E tutto questo alla luce della missio degli ISSR, che è quella di offrire opportunità di approfondimento della fede in vista di due competenze educative, quella del catechista e quella dell’idr, per quanto distinte e complementari.
L’impegno per un’educazione integrale, interculturale e interreligiosa, che le istituzioni scolastiche italiane tentano di dichiarare nelle intenzioni e i docenti progettano e praticano, induce anche a rilevare quanto la liturgia può favorire questo dialogo interreligioso nell’irc.
4. Se non nell’insegnamento della religione cattolica, dove? Se non l’insegnante di religione, chi?
Tutte queste, ed altre possibili questioni, sono sottese al contesto di problematicità, ma anche di progettualità formative reali che oggi la scuola e i suoi professionisti vivono, e talora subiscono. Nel caso dell’interazione liturgia-irc sono coinvolti i liturgisti e i docenti di religione, e con loro tutto quell’universo di ecclesialità e di cittadinanze civili che esigono una distinzione e complementarietà tra la confessionalità della liturgia nella catechesi e la laicità dello Stato nella scuola mediante i loro responsabili rappresentanti e professionisti.
Queste pagine intendono elevare ad urgenza educativa il problema dell’interazione liturgia-irc; e soprattutto evidenziare il bisogno di gestire questa presenza della liturgia nell’irc. I docenti sono consapevoli che l’urgenza formativa è veramente sentita e assunta solo quando si propongono soluzioni che si sperimentano. Altrimenti un’altra urgenza sarà sciupata e con essa sarà perduta un’ulteriore opportunità di responsabilizzare chi educa nella Chiesa e nella scuola.
E se contestualizziamo questo specifico ambito di relazione tra liturgia e irc in quello più ampio delle opportunità di cultura religiosa, è necessario riconoscere che da molti anni è solo l’idr con il suo irc che assicura un’alfabetizzazione alle future generazioni. Da qui ancora altri interrogativi:
- Se non è l’idr, chi può oggi incontrare una media del 91% degli studenti italiani che si avvalgono, ogni settimana, anche se in piccola misura, dell’ora di religione?
- Perché non si investe di più e meglio sulla professionalità degli idr, senza per questo diminuire l’impegno nei confronti degli operatori della pastorale e della catechesi?
- La formazione degli educatori non dovrebbe essere un’urgenza prioritaria nell’educazione stessa?
- Chi educherà, se l’educatore non è educato e non si lascia educare?
Forse anche per queste considerazioni, dal versante ecclesiastico cominciano a pervenire riconoscimenti all’irc e anche all’idr; tardivi, ma pur sempre gratificanti nelle parole sono almeno tre documenti ufficiali:
– Il Discorso pronunciato da Benedetto XVI durante l’incontro con i docenti di religione italiani (1 maggio 2009) dove, tra l’altro, si afferma:
«L’insegnamento della religione cattolica è parte integrante della storia della scuola in Italia, e l’insegnante di religione costituisce una figura molto importante nel collegio dei docenti. […]
Con la piena e riconosciuta dignità scolastica del vostro insegnamento, voi contribuite, da una parte, a dare un’anima alla scuola e, dall’altra, ad assicurare alla fede cristiana piena cittadinanza nei luoghi dell’educazione e della cultura in generale. Grazie all’insegnamento della religione cattolica, dunque, la scuola e la società si arricchiscono di veri laboratori di cultura e di umanità, nei quali, decifrando l’apporto significativo del cristianesimo, si abilita la persona a scoprire il bene e a crescere nella responsabilità, a ricercare il confronto e a raffinare il senso critico, ad attingere dai doni del passato per meglio comprendere il presente e proiettarsi consapevolmente verso il futuro. […]
Certamente uno degli aspetti principali del vostro insegnamento è la comunicazione della verità e della bellezza della Parola di Dio, e la conoscenza della Bibbia è un elemento essenziale del programma di insegnamento della religione cattolica. Esiste un nesso che lega l’insegnamento scolastico della religione e l’approfondimento esistenziale della fede, quale avviene nelle parrocchie e nelle diverse realtà ecclesiali. Tale legame è costituito dalla persona stessa dell’insegnante di religione cattolica: a voi, infatti, oltre al dovere della competenza umana, culturale e didattica propria di ogni docente, appartiene la vocazione a lasciar trasparire che quel Dio di cui parlate nelle aule scolastiche costituisce il riferimento essenziale della vostra vita. Lungi dal costituire un’interferenza o una limitazione della libertà, la vostra presenza è anzi un valido esempio di quello spirito positivo di laicità che permette di promuovere una convivenza civile costruttiva, fondata sul rispetto reciproco e sul dialogo leale, valori di cui un Paese ha sempre bisogno […]».
– L’Esortazione apostolica Verbum Domini di Benedetto XVI, frutto della XII Assemblea generale del Sinodo su: La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa (ottobre 2008), 30 settembre 2010:
«Non si deve trascurare, poi, l’insegnamento della religione, formando accuratamente i docenti. In molti casi esso rappresenta per gli studenti un’occasione unica di contatto con il messaggio della fede. È bene che in questo insegnamento sia promossa la conoscenza della sacra Scrittura, vincendo antichi e nuovi pregiudizi, e cercando di far conoscere la sua verità» (n. 11).
– Gli Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 2011-2020, in Educare alla vita buona del Vangelo, 4 ottobre 2010:
«Al raggiungimento [degli] obiettivi può dare un qualificato contributo il docente di religione cattolica, che insegna una disciplina curriculare inserita a pieno titolo nelle finalità della scuola e promuove un proficuo dialogo con i colleghi, rappresentando […] una forma di servizio della comunità ecclesiale all’istituzione scolastica.
L’insegnamento della religione cattolica permette agli alunni di affrontare le questioni inerenti il senso della vita e il valore della persona, alla luce della Bibbia e della tradizione cristiana. Lo studio delle fonti e delle forme storiche del cattolicesimo è parte integrante della conoscenza del patrimonio storico, culturale e sociale del popolo italiano e delle radici cristiane della cultura europea. Infatti, “la dimensione religiosa… è intrinseca al fatto culturale, concorre alla formazione globale della persona e permette di trasformare la conoscenza in sapienza di vita”.
Per questo motivo la scuola e la società si arricchiscono di veri laboratori di cultura e di umanità, nei quali, decifrando l’apporto significativo del cristianesimo, si abilita la persona a scoprire il bene e a crescere nella responsabilità, a ricercare il confronto e a raffinare il senso critico, ad attingere dai doni del passato per meglio comprendere il presente e proiettarsi consapevolmente verso il futuro» (n. 47).
5. Il presente fascicolo
L’insieme della ricerca lascia intravedere prospettive programmatiche in merito ad un progetto culturale della Chiesa italiana per e nella scuola, da concretizzare valorizzando l’irc e i suoi professionisti, praticando e testimoniando nei fatti la laicità e la confessionalità dell’irc, esigendo una qualità professionale dagli idr e dalle istituzioni che cooperano, e infine non abbandonando all’iniziativa personale chi, come l’idr, non può che insegnare in cooperazione e in comunione.
Tema di attualità: ne siamo ben consapevoli noi e tutti coloro che hanno risposto all’invito di collaborare a questo progetto, come pure coloro che non hanno risposto sia pur con motivazioni diversificate. L’urgenza comunque della trattazione non ci ha distolti dal realizzare il progetto che ora affidiamo ai lettori; e siamo ben lieti di poter accogliere eventuali “reazioni” che possono contribuire al dibattito e alla soluzione di problematiche che chiamano in causa la formazione integrale delle persone. È in questa linea che va ricordato il significato dell’IRC come luogo di confronto per un dialogo fra culture e religioni, come ambito di nuovi percorsi per favorire una reciproca accoglienza, ma anche per offrire a chi viene da altri orizzonti culturali l’opportunità di conoscere gli elementi essenziali della cultura che li accoglie.
– Studi. I primi sei contributi tracciano il quadro generale della problematica affrontando da prospettive diversificate la complessa questione e situazione dell’IRC in Italia.
– Note. I quattro successivi approfondimenti danno completezza a ciò che è richiesto dai docenti nell’affrontare una simile missio nella scuola.
– Dossier. Le tre risposte a domande specifiche costituiscono il contenuto racchiuso nel dossier che avrebbe potuto essere ben più ampio; le testimonianze possono comunque rimanere esemplificative di una situazione molto articolata.
Affidiamo queste pagine soprattutto a due categorie di colleghi. Ai professori di religione, perché si confrontino con le istanze proprie della liturgia: la loro riscoperta potrà continuare ad offrire elementi preziosi per una formazione professionale che integri la liturgia e la renda proponibile nel loro insegnamento. Ai liturgisti, perché nella loro missione di docenti tengano ben presente la formazione dei futuri docenti di religione: qui non si tratta di presentare la liturgia come si fa ad uno studente di teologia che si prepara ad essere presbitero; al contrario, si tratta di far conoscere una liturgia non solo nella sua integrità misterica ma anche in quelle sue dimensioni che ne favoriscono la comprensione sia nelle assemblee celebranti come in quelle mediazioni culturali e didattiche proprie dell’IRC.
«Rivista Liturgica»
www.rivistaliturgica.it
Sommario del numero
Rivista Liturgica 98/4 (2011)
la liturgia nell’insegnamento della religione cattolica
Sommario
Editoriale pp. 000-000
Studi
B. Bordignon pp. 000-000
L’impianto delle Indicazioni nazionali per l’irc
L’impianto, cioè il principio ordinatore dell’articolazione delle Indicazioni nazionali, è approfondito sia con riferimento all’organizzazione della scuola italiana che alla teoria della conoscenza che sottostà ad esse, con un breve accenno allo sviluppo della dimensione logica della conoscenza umana. Il problema di fondo è rappresentato da un’assurda identità della scuola di Stato, che tende a livellare l’esperienza religiosa, per relegarla al di fuori dei processi di insegnamento e di apprendimento e delle scuole. Senza autentiche esperienze religiose, liberamente scelte e tolleranti, non si sviluppano i valori e viene soffocata la convivenza civile.
C. Cibien pp. 000-000
Presenza-assenza di riferimenti liturgici in alcuni Documenti della CEI relativi all’irc
Nel maggio 1991 la CEI emanò la Nota pastorale sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche: Insegnare religione cattolica oggi. Ogni anno, poi, i Vescovi della Commissione per l’Educazione cattolica, la Scuola, la Cultura e l’Università scrivono una Lettera nella quale si sollecitano gli studenti italiani di ogni ordine ad “avvalersi” dell’Insegnamento della religione cattolica. Tutto questo materiale viene letto, alla ricerca di indicazioni che in qualche modo si possano riferire alla liturgia.
V. Trapani pp. 000-000
La liturgia nei vari ordini e gradi scolastici. Una lettura critica degli obiettivi di apprendimento per l’irc correlati alla liturgia
L’articolo si prefigge di rilevare la presenza del dato liturgico nei Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze e gli obiettivi di Apprendimento, al fine di valutare il ruolo dell’approccio didattico in prospettiva liturgica nell’irc. Di fronte ad una carenza metodologica e contenutistica in merito, si cerca di indagarne le cause, non mancando altresì di formulare proposte operative che possano recuperare, anche nell’attuale assetto didattico, delle piste percorribili al fine di rendere giustizia del ruolo fontale della liturgia nell’insegnamento della religione cattolica.
P. Troía pp. 000-000
La liturgia e i suoi linguaggi di comunicazione in alcuni recenti libri di testo per l’irc
Le recenti Indicazioni per l’irc nel primo ciclo hanno indotto la CEI ad esigere nuovi testi scolastici per l’imminente anno scolastico 2011-2012. Nelle Indicazioni sono riscontrabili elementi che richiamano la liturgia cristiana. In alcuni recenti libri di testo, ritenuti adottabili e conformi alle Indicazioni, sono state rilevate puntualmente alcune tipologie del ‘liturgico’ e in particolare la definizione della liturgia. Mediamente emerge una conoscenza ‘solitaria’ e ‘vecchia’ della liturgia da parte degli Autori e di chi ha concesso l’adozione. Rispetto ad una precedente e simile ricerca pubblicata nel 1998 in Rivista Liturgica (pp. 605-626), i testi attuali sono migliorati, ma non più di quanto sarebbe necessario.
G. Usai pp. 000-000
Ars celebrandi e ars educandi: una lettura dialogica dalla prospettiva dell’irc
L’articolo intende sviluppare un confronto dialogico tra liturgia ed educazione nella mediazione dell’insegnamento della religione cattolica. Tale contestualizzazione conferisce alla riflessione un preciso indirizzo di tipo scolastico, vincolato a finalità, obiettivi e metodi specifici. La consonanza tra liturgia ed educazione è evidenziata da un’argomentazione centrata su aspetti di indole culturale, antropologica e religiosa, coagulati attorno al tema della celebrazione, delle competenze simboliche e della mediazione significativa. L’approccio si muove in una traiettoria pratico-teorica, in cui l’uso della categoria di “arte” meglio evidenzia la natura prassica tanto dell’educazione quanto della liturgia.
V. Annicchiarico pp. 000-000
La liturgia nella catechesi e nell’irc: complementarietà e differenza
L’Autore, dopo aver delineato che cosa si intenda per liturgia, illustra la natura della catechesi e traccia il profilo dell’IRC oggi in Italia, al fine di farne cogliere le differenti finalità e allo stesso tempo la complementarità che ne consegue proprio per il fatto che l’una e l’altro si svolgano nell’orizzonte culturale italiano in Europa, segnato dalla presenza del cristianesimo-cattolico. Giunge in questo modo a far notare come, sia la catechesi che l’IRC attingano alla “liturgia” la linfa per le loro trattazioni e argomentazioni educative e formative, e sia la catechesi che l’IRC, nella originalità dei loro metodi, in qualche modo “celebrino” quell’incontro tra l’umano e il divino che la liturgia, mirabile sintesi, esprime nel culto pubblico e nel rito.
note
N. Galantino pp. 000-000
La preparazione degli insegnanti alla luce delle ratio studiorum degli ISSR
Nel rispetto dello statuto epistemologico della Teologia liturgica, l’insegnamento impartito negli ISSR non può ignorare il proprium derivante dalle finalità della istituzione all’interno della quale questo insegnamento viene offerto. Per questo, il compito di offrire indicazioni precise perché l’insegnamento della Teologia liturgica contribuisca a “qualificare i docenti di religione” spetta ai singoli ISSR e, prima ancora, al docente di questa disciplina. Solo la pigrizia mentale o una ingessata interpretazione dello statuto epistemologico di una disciplina di insegnamento può impedire a un docente di rendersi conto della differente destinazione del suo servizio. Solo chi accetta la sfida proveniente dalla diversità dei destinatari del proprio insegnamento riesce a trasformarlo in veicolo di “formazione qualificata” e riesce ad armonizzare metodi e contenuti e finalità.
A. Toniolo pp. 000-000
Quali aspetti liturgici sono da valorizzare nei testi per l’irc?
Dopo aver tratteggiato le motivazioni che caratterizzano le modalità della presenza dell’irc nella scuola italiana, l’A., soffermandosi sull’esperienza dell’uso del libro di testo da parte dell’insegnante della disciplina scolastica dell’irc riflette sulla opportunità di introdurre elementi di Liturgia nell’IRC. Individua quattro settori di compartecipazione scientifica: linguistico, fenomenologico, storico e pedagogico. La conclusione ritorna sugli elementi espressi nella premessa, perché l’aspetto normativo giuridico dell’IRC ne condiziona le caratteristiche fondamentali, vincolando ogni forma di rapporto, dalla valutazione ai contenuti.
P. Troía pp. 000-000
Feste e tradizioni ebraiche in alcuni recenti libri di testo per l’irc
La parentela familiare tra ebraismo e cristianesimo esigerebbe una particolare e specifica compresenza dell’ebraismo nell’irc e nei suoi media di comunicazione scolastica. In questa ricerca sono documentate alcune costatazione relative alle feste e alle tradizioni ebraiche in recenti libri di testo per l’irc. Gli Autori non evidenziano competenze di eccellenza in merito all’ebraismo, la loro documentazione è alquanto generica. In questi testi per l’irc non emerge la specificità della preghiera liturgica e delle feste ebraiche e l’ebraismo non è mediamente valorizzato come una risorsa per l’irc. Purtroppo è veramente un’occasione mancata per contribuire al dialogo ebraico-cristiano, soprattutto mediante i testi per l’irc e per l’irc stesso.
L. Paolini pp. 000-000
Universi liturgici nel web
Il web è una fonte inesauribile di materiali, che hanno a che fare anche con la/le liturgia/e; specialmente con l’avvento del web 2.0, con il web sociale, le fonti di informazioni si sono moltiplicate e diversificate proprio perché create dagli utenti stessi. È questa una opportunità unica per insegnanti ed educatori di reperire strumenti e informazioni che possano aiutare il loro lavoro a scuola o in parrocchia. L’articolo prende in esame le principali risorse presenti al momento sul web suggerendo metodi e strategie di applicazione pratica.
DOSSIER pp. 000-000
Corsi di aggiornamento professionale per l’idr: quale rilevanza per la liturgia? (M. Maretti – F. Morlacchi – B. Tarantino)