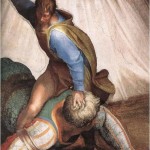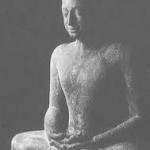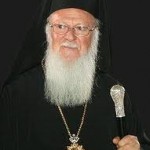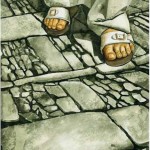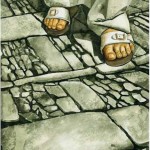
|
XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
|
Lectio – Anno A
Prima lettura: Ezechiele 33,1.7-9
|
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «O figlio dell’uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu sarai salvato».
|
v Se il Vangelo c’invita a essere custodi gli uni degli altri, a sua volta il testo del profeta Ezechiele indica nell’immagine della sentinella la caratterizzazione del proprio ruolo. Tale immagine, naturale in un contesto militare e in cui la guerra ha un posto importante nella vita quotidiana, come in una civiltà nella quale le mura della città erano appunto custodite da sentinelle, era immediatamente percepibile: la sentinella ha il compito di avvertire il popolo appena avvista il pericolo. Il profeta, da parte sua, non avvista i pur notevoli pericoli di eserciti nemici, bensì quelli ancora più insidiosi dell’allontanamento da Dio, dalla sua legge.
Ciò che, però, il profeta Ezechiele afferma si rivela sorprendente perché egli non sarà sentinella nel senso che, avendo visto l’empio agire male, lo riprende di sua iniziativa. Al contrario, dovrà seguire un criterio ben preciso e determinato: «O figlio dell’uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia» (33,7). Dunque, è Dio stesso che si preoccuperà di dare l’«allarme» alla sentinella-profeta! Dio, cioè, si renderà garante dell’oggettività del richiamo, che ha il solo scopo di conseguire la salvezza dell’empio, la cui vita, davanti agli occhi di Dio, non ha meno valore di quella del giusto, essendo Egli il creatore dell’una come dell’altra: «Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te» (33,8).
Il profeta risulta perciò responsabile in caso di omissione del compito che Dio gli ha affidato: anche la vita dell’empio appartiene al Signore ed Egli non vuole certo sciuparla, perderla. Tuttavia, l’empio, da parte sua, conserva la responsabilità sulla propria vita e sul suo esito, qualora si ostini a non convertirsi: «Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato» (33,9). Si tratta del famoso principio della responsabilità personale, secondo il quale le colpe personali ricadono soltanto su chi le ha commesse. Di questo l’empio dev’essere altamente consapevole, sapendo comprendere e scorgere nel richiamo del profeta-sentinella l’occasione per approfittare dell’offerta di misericordia da parte di Dio.
Seconda lettura: Romani 13,8-10
|
Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore vicendevole; perché chi ama l’altro ha adempiuto la Legge. Infatti: «Non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai», e qualsiasi altro comandamento, si ricapitola in questa parola: «Amerai il tuo prossimo come te stesso». La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge infatti è la carità.
|
v Fungere da sentinella, avvertendo con saggezza unita a fermezza circa i pericoli di determinati comportamenti, non è un compito tra i più gratificanti nell’ambito di una comunità, grande o piccola che sia. Bene lo sapevano i profeti dell’antichità come pure i profeti di oggi. Non si può negare, però, che anche questo rappresenti un vero servizio d’amore a vantaggio di un’umanità spesso disorientata. Ed è proprio sull’amore che l’apostolo Paolo invita a riflettere, insistendo su un particolare di non poco conto: l’osservanza della legge. Infatti, contrariamente a chi lo dipinge come abrogatore della legge, Paolo intende incoraggiare i cristiani di Roma a realizzare il fine proprio della legge, ossia l’amore.
Esaminando i tre versetti del brano, iniziamo dalla prima affermazione, la cui formulazione può sembrare un po’ strana: «non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore vicendevole; perché chi ama l’altro ha adempiuto la Legge» (13,8). Paolo ritiene che, se dev’esserci una qualche obbligazione tra fratelli di una comunità, questa non può che essere l’agape, l’amore, di cui ha già parlato abbondantemente in 12,9-21, esortando a essere sinceri nella carità e a non rendere a nessuno male per male, bensì a vincere il male con il bene.
Nel versetto 9, poi, citando esplicitamente alcuni dei precetti mosaici e richiamando allusivamente gli altri, tira una conclusione che ben conosciamo, essendo tipica anche di altri passi del Nuovo Testamento, in particolare del Vangelo (Mc 12,28-31; Mt 22,34-40; Lc 10,25-28; Gv 13,34-35): «Infatti: “Non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai”, e qualsiasi altro comandamento, si ricapitola in questa parola: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”». I tanti precetti della legge, cioè, in chi è giunto alla maturità della fede e dell’amore verso Dio, si rivelano riassumibili nel precetto dell’amore per il prossimo, il quale non ha bisogno di vietare, ma al contrario di spingere a fare di più per i fratelli. D’altronde, l’amore rende il cristiano più capace di vedere i bisogni di chi è il suo prossimo, non raramente anche di prevenirli.
Infine, con il v. 10 si chiude la breve riflessione, ribadendo il rapporto tra amore e compimento della legge: «La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge infatti è la carità». È utile sottolineare che quanto dice Paolo non costituisce una semplice parenesi, quasi un appello ai buoni sentimenti, ma un ritrovare nel nucleo stesso della rivelazione (la legge) le motivazioni profonde che insegnano l’agire di Dio agli uomini.
La legge, quindi, secondo l’insegnamento paolino (cf. Romani e Galati), rimane efficace e necessario pedagogo che conduce a Cristo, giacché, in ultima analisi, colui che compie la legge si mette sulla medesima scia segnata dal Figlio di Dio, che ha interpretato la sua morte in croce come compimento della legge nell’amore. Una scia che porta alla croce, in quanto l’amore significa comunque rinunciare a se stessi per far posto a Dio e imitare la vita del Figlio.
Vangelo: Matteo 18,15-20
|
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano.
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».
|
Il vangelo in immagini
XXIII DOM TEMP ORDINARIO (A)
Esegesi
Il capitolo 18 del Vangelo di Matteo, rispondendo alla domanda riguardo ai fondamenti della vita di una comunità, ne presenta due di non trascurabile valore: la correzione fraterna e la preghiera in comune.
Iniziamo dalla correzione fraterna, che viene esposta dall’evangelista in maniera abbastanza giuridica, come si deduce dal tipo di ragionamento seguito: a) v. 15, ossia la correzione in privato: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello»; b) v. 16, la correzione in presenza di testimoni «se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni»; c) v. 17, correzione davanti all’assemblea come extrema ratio, prima dell’espulsione: «Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano».
In realtà, tra i vari riferimenti del Nuovo Testamento alla correzione (Mt 7,4; Lc 6,41-42; Gal 6,1; 2Ts 3,15; 1Tm5,l; 2Tm 2,25; Tt 3.10; Gc 5,19-20), questo di Matteo è il più preciso, ma è anche quello che si rivela subito, allo stato dei fatti, il più irrealizzabile, se non nel contesto limitato di comunità come Qumran (presso la quale esisteva una disciplina precisa in proposito) e, successivamente, quelle monastiche (si pensi al capitolo delle colpe). Può darsi che nella comunità dell’evangelista, di carattere giudeocristiano, si agisse in questo modo, poiché tale prassi risente della tradizione biblica. Infatti, 18,16 cita esplicitamente Dt 19,15, mentre il concetto generale della correzione fraterna si trova in Lv 19,17: «Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai d’un peccato per lui».
Pur coscienti della problematicità storica di tale prassi nelle comunità antiche, non si può negare un dato: ogni membro della comunità si sente un po’ responsabile di chi gli sta a fianco, il che vuol dire che, per la salvezza del fratello e il buon nome della comunità stessa, egli ritiene proprio dovere intervenire nella correzione. Questa, poi, può addirittura giungere all’estremo dell’espulsione nei casi di perdurante ostinazione da parte di chi è stato corretto. Per confermare questo tipo di «potere» da parte della comunità. Gesù dice: «In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo» (18,18). Anche Dio accetta la decisione che la comunità, dopo aver attentamente ponderato ed esplorato ogni possibile strada di correzione, consideri non più discepolo l’ostinato e lo affidi alla misericordia divina affinché lo faccia ritornare sui propri passi.
L’altro fondamento, quello della preghiera in comune, è strettamente legato a quanto abbiamo detto finora: soltanto una comunità che sa riunirsi nella concordia della preghiera e della professione di fede in Gesù Cristo può intercedere per coloro che hanno voltato le spalle al vero pastore dell’umanità. Anzi, ancora più radicalmente, il Vangelo afferma che basta essere in due, che, in accordo, possono chiedere qualsiasi cosa al Padre, perché egli la conceda. E quale cosa migliore si può chiedere al Padre se non che nessuno si perda di quelli che Egli ha chiamato?
Quando tutte le altre metodologie falliscono, non rimane che implorare dal Padre il suo onnipotente intervento per raddrizzare ciò che ha preso una cattiva piega.
Meditazione
La fede in Dio diviene responsabilità verso il fratello e questa si declina come ammonizione e correzione del fratello: questo il messaggio che unisce prima lettura e vangelo.
La correzione fraterna richiede un profondo senso di fede. Questo emerge dalle parole di Gesù secondo le quali essa deve esercitarsi nei confronti di chi «ha peccato», commettendo una colpa pubblica, non diretta in modo particolare contro l’altro. Il testo non dice: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te». In quel caso, rivelerà Gesù, vi è il perdono senza misura (Mt 18,21-22).
La maturità di fede consiste nel sentirsi feriti dal peccato in quanto tale, non soltanto dall’offesa personale.
La correzione fraterna si oppone al silenzio complice, alla pigrizia di chi non vuole inimicarsi l’altro, ai meccanismi di autogiustificazione sempre pronti a trovare buoni motivi per non intervenire e non denunciare il male là dove è commesso. A livello ecclesiale la correzione corrisponde a una parola audace e profetica pronunciata a qualunque prezzo, perché di mezzo c’è il vangelo. Uno dei più frequenti peccati di omissione è il sottrarsi alla denuncia del male e del peccato, è il sottrarsi alla correzione fraterna.
La capacità di correzione dice la libertà del credente. E anche la sua obbedienza radicale al vangelo e la sua appartenenza al Signore.
L’autenticità dell’amore sgorgato dal vangelo si manifesta nella capacità di correggere colui che si ama. L’amore «spirituale», non psichico, vince la tentazione di tacere il peccato commesso dall’amico per timore di perderne l’amicizia. La correzione fraterna dice che l’amore cristiano deve essere vissuto all’interno della responsabilità per gli altri e per il mondo.
La correzione fraterna va colta anche dal punto di vista di chi la riceve, che è sempre un fratello, un membro della comunità cristiana. Occorre molta umiltà e disponibilità a ricredersi e a ricominciare. L’autentica correzione fraterna non è un giudizio, e ancor meno una condanna, ma un evento sacramentale che fa regnare Cristo come terzo tra chi la esercita e chi la riceve. Essa richiede il coraggio della parola: coraggio che può nascere solo radicando la propria parola nella parola evangelica.
I tre «gradi» del processo disciplinare nei confronti di chi ha peccato nella chiesa (Mt 18,15-17) indicano quantomeno imprudenza e la gradualità in cui si svolge il tentativo di accordare l’istanza evangelica con il rispetto del fratello peccatore al fine di recuperarlo. L’orizzonte della correzione è infatti quello espresso dal profeta Ezechiele, secondo cui Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva (cfr. Ez 33,11).
La scomunica (Mt 18,17) appare come extrema ratio. E certamente la prassi storica delle comunità potrà e dovrà creare e inventare forme di intervento che cerchino in ogni modo di evitare l’allontanamento di un fratello. Impressiona, nella Regola di san Benedetto, la procedura prevista nei confronti di un fratello peccatore: «L’abate si comporti come un esperto medico: se ha usato i lenitivi, gli unguenti delle esortazioni, i medicamenti delle divine Scritture, e, da ultimo, il cauterio dell’esclusione o delle battiture della verga, se vede che tutto il suo darsi da fare non serve a nulla, allora ricorra a ciò che è ancor più efficace: la preghiera sua e di tutti i fratelli per lui, affinché il Signore, che tutto può, operi la guarigione del fratello malato» (28,2-5).
L’estensione ai membri della comunità, o almeno ai suoi responsabili, del potere di «sciogliere e legare», riservato al solo Pietro in Mt 16,19, dice l’importanza della corresponsabilità nell’esercizio dell’autorità nella comunità cristiana. E ribadisce un principio importante della prassi sinodale: «Ciò che nel corpo ecclesiale concerne tutti, deve essere discusso e approvato da tutti».
Se nella Chiesa vi è divisione e peccato, essa però trova la sua unità nel Nome del Signore: lì, fosse ben tra due o tre credenti, perché mai nel Nuovo Testamento la Chiesa dipende dal numero, si può creare la sinfonia (vb. symphonéo: v. 19) gradita al Signore e da lui ascoltata.
Preghiere e racconti
Le sentenze dei padri del deserto
Per molti anni due uomini erano vissuti insieme senza mai litigare. Un giorno, uno disse: “E se litigassimo almeno una volta come fanno tutti?”. L’altro rispose: “Io non so come si fa a litigare… Il primo disse: “Ecco: io colloco un mattone fra noi due e io dico che è mio e tu dici che è tuo. È così che comincia un litigio. Collocarono quindi il mattone fra di loro. Uno disse: “È mio”. L’altro disse: “No, è mio”. Riprese il primo: “Sì è tuo; prendilo e vattene. E si separarono senza riuscire a litigare.
(L. Regnault, Le sentenze dei padri del deserto)
Correzione con amore
«Rabbi Aronne arrivò un giorno nella città in cui cresceva il piccolo Mardocheo, il futuro Rabbi di Lechowitz. Il padre di questi gli condusse il ragazzo e si lamentò che non avesse costanza nello studio. “Lasciatemelo qui un poco”, disse Rabbi Aronne. Quando fu solo con il piccolo Mardocheo, strinse il bambino al suo cuore e in silenzio ve lo tenne vicino fino a che il padre tornò. “Gli ho fatto un discorsino” disse quindi Rabbi Aronne. “D’ora in poi la costanza non gli mancherà”. Quando il Rabbi di Lechowitz raccontava questa vicenda aggiungeva: “Ho imparato allora come si convertono gli uomini”».
(MARTIN BUBER, I racconti dei Chassidim, Milano, Garzanti,1985, 245).
Assemblea nella falegnameria
Raccontano che nella falegnameria si ebbe un volta una strana assemblea. Fu una riunione di utensili (attrezzi) per risolvere le loro differenze. Il martello esercitò la presidenza, ma l’assemblea gli notificò che doveva rinunciare. La causa? Faceva troppo rumore! E, inoltre, passava il tempo battendo. – Il martello accettò la sua colpa, ma chiese che fosse anche espulsa la vite ; disse che era necessario dare molti giri perché servisse per qualche cosa . – Davanti a questo attacco, la vite accettò anche, ma a sua volta chiese l’espulsione della lima. Fece vedere che era molto aspra e aveva sempre frizioni con gli altri. – E la lima fu d’accordo, a condizione che fosse espulso il metro che passava il tempo misurando gli altri come se lui fosse l’unico perfetto.
Stando così le cose entrò il falegname, si mise il grembiale e iniziò il suo lavoro. Utilizzò il martello, la lima, il metro e la vite. Finalmente, l’aspro legno iniziale diventò un bellissimo mobile.
Quando la falegnameria restò di nuovo vuota, l’assemblea riprese la deliberazione. Fu allora che prese la parola la sega e disse: “Signori, è rimasto chiaro che abbiamo difetti, ma il falegname lavora con le nostre qualità. E’ questo che ci fa preziosi. Dunque non dobbiamo pensare ai nostri punti cattivi e concentriamoci nell’utilità dei nostri punti buoni.”
L’assemblea trovò allora che il martello era forte, la vite univa e dava forza, la lima era speciale per affinare e limare le asprezze e osservarono che il metro era preciso ed esatto. Si sentirono tutti un’equipe capace di produrre mobili di qualità. Si sentirono orgogliosi delle loro fortezze e di lavorare insieme.
L’amicizia e la correzione fraterna in S. Giovanni Crisostomo
«Più di noi stessi, se lo volete, voi potete beneficarvi a vicenda: passate più tempo insieme, conoscete meglio di noi le vostre relazioni reciproche, non vi sono nascoste le vostre mancanze vicendevoli, avete più franchezza, più amore, più consuetudine reciproca: questi non sono piccoli vantaggi per ammaestrare, anzi ne offrono una possibilità grande e opportuna; e più di noi potete rimproverare ed esortare. E non solo questo, ma io sono solo, e voi molti; e tutti potete, quanti siete, essere maestri. Perciò vi scongiuro: non trascurate questa grazia! Ciascuno ha una moglie, ha un amico, ha un servo, ha un vicino: questi ammonisca, quelli esorti. Non è un assurdo? Per il cibo si fanno banchetti e simposi, vi sono giorni stabiliti per riunirsi e quello in cui uno manca personalmente, viene compiuto dalla società, come ad esempio se si debba partecipare a un funerale, o a un banchetto, o si debba aiutare in qualcosa un prossimo. E, invece, per ammaestrare alla virtù non si fa nulla di ciò! Sì, vi scongiuro! Nessuno lo trascuri! Riceverà da Dio una grande ricompensa!
[…] «Ma non so parlare» si dice. Non c’è bisogno di saper parlare né d’eloquenza. Se vedi un tuo amico che si abbandona all’impudicizia, digli: «Ciò che fai è un’azione cattiva; non ti vergogni? Non arrossisci? È male!». Ma lui non sa che è male? si obietta. Certo, lo sa, ma la passione lo trascina. Anche gli ammalati sanno che una bevanda fredda fa loro male, e tuttavia c’è bisogno di chi glielo impedisca. Chi soffre, non sa facilmente dominarsi, se è ammalato. C’è bisogno di te, che sei sano, per curarlo; e se non riesci a persuaderlo a parole, osserva dove va e impedisciglielo, forse se ne vergognerà. «Ma che giova se agisce così per me, se solo per me se ne trattiene?». Non sottilizzare troppo: intanto distoglilo in qualsiasi modo dall’azione cattiva; si abitui a non precipitarsi in quel baratro sia per te, sia per qualsiasi altro impedimento: è già un guadagno. E quando si sarà abituato a non recarsi più là, allora, dopo che si sarà un po’ riavuto, potrai riavvicinarlo e insegnargli che bisogna evitare ciò per Dio e non per gli uomini. Non pretendere di correggerlo tutto in una volta, perché non ci riuscirai; bensì piano piano, un po’ alla volta.
E se lo vedi andare a bere, se lo vedi recarsi a banchetti dove ci si ubriaca, comportati nello stesso modo. Anzi, supplicalo di aiutarti a correggerti se vede che tu hai qualche difetto. In tal modo rivolgerà in sé il rimprovero, vedendo che anche tu hai bisogno di ammonizione, e che lo aiuti non perché sei il correttore di tutti, o il maestro, ma sei un amico e un fratello. Digli: Ho giovato a te ricordandoti qualcosa di utile; anche tu, se vedi in me qualche difetto, prendimi per i capelli e raddrizzami: se mi vedi irascibile, o avaro, frenami e legami con le tue ammonizioni. Questa è l’amicizia, così il fratello viene aiutato dal fratello e diventa una città fortificata (cf. Pr 18,19). Non è il mangiare o il bere insieme che crea l’amicizia: così l’hanno anche i ladri e gli assassini; ma se siamo amici, se veramente ci diamo pensiero l’uno dell’altro, ci dobbiamo anche accordare. E questo ci porta a un’amicizia utile e ci impedisce di precipitare nella geenna.
D’altra parte chi viene rimproverato non si turbi, siamo uomini e abbiamo difetti; e chi rimprovera non lo faccia pubblicamente, insultando e facendo mostra di sé, ma a quattr’occhi e con dolcezza; ha bisogno di tanta dolcezza colui che ammonisce, se vuole che sia ben accolto il suo discorso tagliente. Non vedete i medici, quando bruciano o quando tagliano, con quanta dolcezza applicano la loro terapia? E molto più lo deve fare chi ammonisce, perché il rimprovero è più violento del ferro e del fuoco, e fa sobbalzare. Per questo motivo anche i medici si esercitano molto per riuscire a incidere con calma, e lo fanno con dolcezza, in quanto è possibile, e incidono un poco e poi permettono di riprendere il fiato. Così si devono fare anche i rimproveri, perché chi viene ammonito non se ne sottragga. E se fosse necessario venire insultati e anche schiaffeggiati, non ricusiamolo; anche quelli infatti che subiscono un intervento urlano mille cose contro coloro che li operano, però essi non guardano a nulla di ciò, ma solamente alla salute dei pazienti. Così, anche nel nostro caso, si deve fare di tutto perché il rimprovero risulti utile, e si deve sopportare tutto guardando il premio che c’è preparato. È detto: Portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge del Cristo (Gal 6,2). Così, ammonendoci e sopportandoci a vicenda, potremo completare l’edificazione del Cristo».
(Cfr. GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelie sulla lettera agli ebrei, 30,2).
Correzione fraterna
Ciascuno deve rispondere del fratello, ciascuno è custode del fratello. Un’espressione tipica di questa corresponsabilità è data appunto dalla correzione fraterna. A proposito della quale sarà opportuno fare alcune precisazioni fondamentali:
1. Essere custode non significa comportarsi da spia o poliziotto dell’altro.
2. “Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te…”. Bisogna accertare la colpa, prima di tutto. E vedere di che colpa si tratta. Il fratello non pecca contro di te se non ha le tue stesse idee, non condivide le tue simpatie o antipatie, non si arruola per le tue cause. Il fratello non va ripreso per la colpa di non essere a tua immagine e somiglianza, a portare in giro la “sua” faccia, che non coincide con la tua.
Attenti, perciò, a non confondere il peccato con il diverso. A non definire “male” ciò che semplicemente non rientra nei nostri gusti e nei nostri schemi. Attenti, soprattutto, a non intervenire continuamente per delle sciocchezze, per delle cose assolutamente marginali. Certe persone religiose pare possiedano l’arte di “asfissiare”, più che liberare, aiutare, promuovere.
3. La procedura indicata da Matteo (Mt 18,15-20) non va confusa con un processo. Si tratta piuttosto di una mano tesa ostinatamente ma con delicatezza estrema verso l’altro che minaccia di allontanarsi, di separarsi. E non è detto che le fasi debbano essere rigidamente tre. Possono e devono essere molte di più, con tutte le iniziative suggerite dalla fantasia e dal cuore che non si arrende mai, malgrado i ripetuti insuccessi.
4. Prima ancora di far capire al fratello che ha sbagliato, occorre dimostrargli e convincerlo che è amato, nonostante tutto. La carità, la pazienza, la misericordia, la sensibilità, sono la luce indispensabile attraverso la quale il deviante può scoprire il proprio errore di rotta. Più che richiamano all’ordine, occorre richiamarlo a lasciarsi amare.
5. La correzione fraterna implica, oltre che la carità, anche l’umiltà. Umiltà che si traduce nell’abbandono di qualsiasi atteggiamento di superiorità. Il peccatore deve comprendere che chi lo ammonisce è peccatore quanto e più di lui, uno che condivide la sua stessa fragilità e miseria. Non: «Guarda che cosa hai fatto!», ma: «Guarda che cosa siamo capaci di fare…».
6. Il metodo più efficace per far capire l’errore, non è l’impiego delle parole e delle dimostrazioni teoriche o le citazioni di un codice, ma l’illustrazione pratica, personale, della virtù dimenticata, del valore disatteso, dell’ideale calpestato. Meglio sempre gli “annunci” che le “denunce”. Anche perché le denunce possono essere sospette per il fatto stesso che non costano niente. Sovente parliamo e gridiamo troppo, perché la nostra condotta non è abbastanza eloquente. Siamo predicatori implacabili e moralisti insopportabili perché la santità della nostra vita non è tale da costituire una silenziosa condanna di certi difetti e deviazioni. Si può insegnare in maniera efficace anche col silenzio. Sempre che la vita parli, naturalmente.
7. I ruoli non sono mai definiti, ma risultano intercambiabili. Per cui non ti è consentito rivendicare il dovere di criticare l’altro, se non gli concedi il diritto di criticare, a sua volta, i tuoi comportamenti poco corretti.
8. La scomunica e l’esclusione, più che un elemento punitivo, devono costituire un motivo di riflessione e uno stimolo alla conversione. Devono avere una funzione pedagogica, non vendicativa. Non è tanto la comunità che decreta l’esclusione, quanto il fratello, peccatore ostinato, che si pone automaticamente, e pervicacemente, in stato di separazione, fuori dalla comunione. E lui che si scomunica. La comunità non fa altro che prendere atto, dolorosamente. Si tratta, perciò, di «aiutare il fratello a prendere coscienza del suo stato di separazione, perché possa, di conseguenza, ravvedersi. Lo scopo è quello di creare nel peccatore uno stato di disagio, perché è proprio in una situazione di disagio che spesso Dio si inserisce e spinge al ritorno» (B. Maggioni). Illuminante, a questo proposito, risulta la cosiddetta “parabola del figliol prodigo”. Comunque, la comunità non deve mai alzare il ponte levatoio. Deve sempre tenere la porta aperta, la luce accesa. Una comunità si rivela cristiana quando non si rassegna alla perdita definitiva di un membro, ma si dimostra sempre pronta ad accogliere, perdonare, riconciliare. E fa tutti i passi possibili e impossibili perché avvenga il ritorno atteso. E ci dovrebbe sempre essere aria di festa, non musi lunghi, quando il fratello, lo sbandato, ricompare all’orizzonte. Teniamo pronta la musica, la tavola imbandita, non i rimbrotti, le accuse.
Tutti siamo al sicuro soltanto quando nessuno è fuori.
9. …E anche quando l’altro si pone fuori dalla comunità, si autoesclude, non per questo hai esaurito il tuo compito. Gli “devi” ancora più amore.
(A. Pronzato, “Tu solo hai parole . Incontri con Gesù nei vangeli”, vol. III, Torino, Gribaudi, 264-269).
Correzione fraterna: la correzione evangelica
Quando vuoi ammonire qualcuno alle cose belle, prima da’ ristoro al suo corpo e onoralo con una parola colma di amore. Non c’è nulla che renda modesto un uomo e lo persuada a convertirsi dalle cose cattive a quelle buone, come il bene corporale e l’onore dimostratogli da qualcuno.
Un secondo strumento di persuasione è lo sforzo di un uomo a essere lui stesso uno spettacolo lodevole. Colui che ha ottenuto di possedere se stesso per mezzo della preghiera e della vigilanza, potrà facilmente avvicinare il suo compagno alla vita, anche senza la fatica delle parole o l’ammonizione esplicita. Colui che prende le difese dell’oppresso, trova un difensore nel suo Creatore. Colui che presta il suo braccio per aiutare il suo prossimo, riceve il braccio di Dio per lui. Colui che accusa suo fratello per i suoi mali, troverà Dio come suo accusatore. Colui che raddrizza suo fratello nel segreto di una stanza, cura il suo male; ma colui che lo accusa nell’assemblea, rinsalda le sue ferite.
Colui che cura suo fratello in privato, rivela la forza del suo amore; ma colui che lo espone all’occhio dei suoi compagni, fa conoscere la forza della sua propria invidia. L’amico che cura nel segreto, è un medico sapiente; ma colui che cura all’occhio di molti, in verità è uno che ingiuria. Il segno della misericordia è il perdono di qualsiasi offesa, e il segno di una cattiva intelligenza è che si mutino le parole rivolte al peccatore. Colui che accosta la medicina alla correzione, corregge con amore, ma colui che cerca la vendetta è vuoto di amore. Dio corregge nell’amore e non per amore di vendetta. Non sia mai! Perché egli cerca di guarire la sua immagine e non conserva la sua collera. Se sei adirato contro qualcuno, o ardi di zelo a motivo della fede o a motivo delle sue opere cattive, o lo accusi o lo ammonisci, vigila sulla tua anima, perché tutti abbiamo nei cieli un giudice giusto.
Se infatti tu hai pietà e cerchi di convertirlo alla verità, soffrirai sofferenza a causa sua. Con lacrime e con amore gli dirai una o due parole, senza ardere d’ira contro di lui, allontanando da te i segni dell’inimicizia.
L’amore non sa adirarsi, non si irrita, non rimprovera con passione. Il segno dell’amore e della conoscenza è una profonda umiltà che proviene dall’intelligenza dell’intimo. Guarda di non essere dominato dalla passione di coloro che sono ammalati del desiderio di correggere gli altri e che da se stessi vogliono essere i censori e i correttori di tutte le infermità degli uomini. Questa è una dura passione …
In verità, è meglio per te trovarti a cadere nella lussuria, piuttosto che in questa malattia.
(ISACCO DI NINIVE, Un umile speranza, Magnano, Qiqajon, 1999, 198 -200).
Con grande misericordia e discrezione
Quelli cui è stata affidata la guida di molti con la loro mediazione devono far progredire i più deboli nel cammino di assimilazione a Cristo, come dice il beato Paolo: «Fatevi miei imitatori, come anch’io lo sono di Cristo» (1 Cor 1,1). Conviene dunque che essi per primi diventino un esempio perfetto praticando quella misura di umiltà che ci è stata consegnata dal Signore nostro Gesù Cristo. Egli dice infatti: «Imparate da me, che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,29). La mitezza nell’agire e l’umiltà di cuore siano quindi i caratteri propri di chi presiede la comunità. Se infatti il Signore non si è vergognato di servire i suoi servi, ma ha acconsentito a farsi servo della terra e del fango, che egli stesso ha plasmato e cui ha dato forma umana – dice infatti: «Io sono in mezzo a voi come colui che serve» (Lc 22,27) – che cosa non dovremo fare noi per i nostri simili prima di crederci giunti a imitarlo? Questa è dunque la prima qualità che deve possedere in così grande misura chi presiede. Sia inoltre misericordioso e sopporti pazientemente quelli che mancano al loro dovere per inesperienza, non passi sotto silenzio i peccati ma sopporti con mitezza chi si comporta come un bambino e gli offra le sue cure con grande misericordia e discrezione. Dev’essere infatti capace di trovare il modo appropriato per curare ogni passione, senza rimproverare con arroganza, ma ammonendo e correggendo con mitezza, come sta scritto (cfr. 2Tm 2,25); sia attento all’oggi, previdente per il domani, capace di lottare con i forti e di portare le infermità dei deboli, di fare e dire ogni cosa per guidare alla perfezione quanti vivono con lui.
(BASILIO DI CESAREA, Regole diffuse 43,1-2, in ID., Le regole, Bose, 1993, pp. 192-193).
Preghiera
Grande è il tuo amore, o Dio!
Tu vuoi aver bisogno di uomini
per farti conoscere agli uomini,
e così leghi la tua azione e la tua parola divine
all’agire e al parlare di persone
né perfette né migliori degli altri.
Grande è il tuo amore, o Dio!
Non hai timore della nostra fragilità
e neppure del nostro peccato: l’hai fatto tuo,
perché fosse nostra la tua vita
che guarisce ogni male.
Grande è il tuo amore, o Dio!
Ancora rinnovi la tua alleanza
grazie a chi tra noi spezza il Pane di vita,
a chi pronuncia le parole del perdono,
a chi fa risuonare annunci di vangelo,
a chi si fa servo dei fratelli,
testimoni del tuo amore infinito
che rendono visibile il Regno.
Ti preghiamo, o Dio: fa’ che queste persone
non vengano mai meno!
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Lezionario domenicale e festivo. Anno A, a cura della Conferenza Episcopale Italiana, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2007.
– Temi di predicazione. Omelie. Ciclo A, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2004.
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, «Allegato redazionale alla Rivista del Clero Italiano» 92 (2011) 5, 42 pp.
– COMUNITÀ DI BOSE, Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche. Anno A, Milano, Vita e Pensiero, 2010.
– Fernando ARMELLI, Ascoltarti è una festa. Le letture domenicali spiegate alla comunità, Anno A, Padova, Messaggero, 2001.