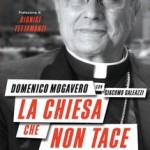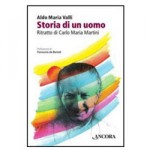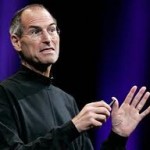|
XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
|
Lectio – Anno A
Prima lettura: Is 45,1.4-6
|
Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: «Io l’ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte e nessun portone rimarrà chiuso. Per amore di Giacobbe, mio servo, e d’Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non c’è alcun altro, fuori di me non c’è dio; ti renderò pronto all’azione, anche se tu non mi conosci, perché sappiano dall’oriente e dall’occidente che non c’è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n’è altri».
|
v Il profeta fa in questo brano una rivelazione da parte di Dio che a prima vista suona strabiliante: Ciro, un re pagano uno che non conosce il Signore (Is 45,4) è chiamato «eletto» (Is 45,1), anzi il termine ebraico è «unto», messia, titolo riservato normalmente al re di Israele (1Sam 9,26). Ma i piani di Dio sono «imperscrutabili» (cf. Is 55,6-9) ed egli è Signore della storia: «non c’è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n’è altri» (Is 45,5).
Dentro alla storia universale ce n’è una guidata in modo particolare da Dio. È la storia di Israele; infatti Dio spiega la scelta di Ciro in questo modo: «Per amore di Giacobbe, mio servo, e d’Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca» (Is 45,4). Tali parole fanno chiaramente vedere che l’iniziativa è del Signore, che agisce in piena libertà, al di fuori di ogni iniziativa umana. Del resto chi può vantare di aver dato consigli a Dio? (cf. Is 14,13).
La chiamata di Dio è per il servizio, la gloria se arriverà sarà conseguenza dell’aver servito fedelmente nella missione affidata da Dio. Ciro come eletto da Dio è anche suo servo e il modello per eccellenza del «servo del Signore» è Israele, la cui chiamata è per il bene delle nazioni e non per la propria gloria.
Seconda lettura: 1Ts 1,1-5
|
Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicési che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo: a voi, grazia e pace. Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo continuamente presenti l’operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro. Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da lui. Il nostro Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione.
|
v La seconda lettura ci presenta l’inizio della prima lettera ai Tessalonicesi. Paolo e i suoi compagni Silvano e Timoteo augurano «grazia e pace» «alla Chiesa dei Tessalonicési che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo» (1Tes 1,1).
Vale la pena di soffermarsi su questo saluto augurale, che racchiude significati profondi. L’espressione di saluto si ripete all’inizio e alla fine delle lettere paoline; essa può venire letta come formula stereotipata, oppure nello spessore che le due parole, grazia e pace, assumono nell’orizzonte biblico. Tale è la molteplicità e la ricchezza dei loro significati che in questo contesto è possibile solo qualche accenno fugace.
Grazia è il favore di Dio assolutamente libero da ogni condizionamento, strettamente legato alla sua misericordia (cf. Es 33,19; Sap 3,9). In Cristo abbiamo ricevuto la grazia e la misericordia di Dio, che in lui ha rivolto il suo sguardo benevolo sui peccatori (cf. Rm 3,21-26).
Pace è bene grande e comprensivo di tutti gli altri beni donati da Dio. Pace su Israele è invocata dalla benedizione sacerdotale (cf. Num 6,26); pace è una caratteristica fondamentale dell’epoca messianica; titolo del Messia è «principe della pace» (cf. Is 9,5); la pace stessa insieme con la giustizia governeranno in Sion città del Signore: «Costituirò tuo sovrano la pace, tuo governatore la giustizia» (Is 60,17).
Nel saluto è sottolineata anche la caratteristica essenziale della Chiesa: essere «in Dio Padre e in Gesù Cristo». La missione della Chiesa è diffondere il vangelo, opera possibile per mezzo della parola, sostenuta, però, dalla potenza divina, vale a dire lo Spirito Santo (1Tes 1,5).
«Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da lui» (1Tes 1,4). L’elezione è dono gratuito di Dio ed anche per i discepoli della chiesa di Tessalonica vale quanto detto nella prima lettura: l’iniziativa è di Dio, a lui bisogna rispondere, lui bisogna servire a modello del «servo Israele», a cui si è conformato Gesù Cristo.
Vangelo: Mt 22,15-21
|
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio».
|
Immagini sul vangelo
XXIX DOM TEMP ORDINARIO (A)
Esegesi
Nella prima parte del brano che leggiamo oggi sono nominati tre gruppi di ebrei: i farisei, i sadducei e gli erodiani, attivi ai tempi di Gesù. Gli erodiani erano i sostenitori del re Erode e nei vangeli sono nominati normalmente insieme ai farisei; non traspare un preciso pensiero teologico a loro attribuito. I farisei e i sadducei, invece, si qualificavano per un diverso e incompatibile atteggiamento rispetto al valore della Torâh scritta (Pentateuco) e della Torâh orale, che potremmo chiamare la Tradizione. Molto schematicamente, possiamo dire che i sadducei, il gruppo da cui uscivano i sacerdoti del tempio, sostenevano che ci si doveva attenere alla lettera della Torâh scritta; i farisei, invece, accettavano lo sviluppo della Torâh orale, che credevano contenuta anch’essa nella rivelazione a Mosè al Sinai.
Essi si adoperavano, perché, tutto il popolo, non solo i sacerdoti o i dottori della legge, conoscesse i precetti e li mettesse in pratica (per un utile approfondimento cf. J. NEUSNER, Il giudaismo nei primi secoli del cristianesimo, Morcelliana, Brescia 1989; G. STEMBERG, Farisei, Sadducei, Esseni, Paideia, Brescia 1993). Le dispute fra i vari gruppi avvenivano spesso in un clima polemico, come si intravvede anche dal brano di oggi.
I sadducei sono presentati nei vangeli come «coloro che non credono nella risurrezione e disputano su questo argomento con Gesù» (Mc 12,18-27; Mt 22,23-33; Lc 20,27-39).
Più variegato è l’incontro-scontro con i farisei, il cui atteggiamento polemico sia con Gesù, sia, come nel caso del nostro brano, con i sadducei, che «Gesù aveva ridotto al silenzio», è senz’altro riconducibile allo zelo per la Torâh e al loro interesse di trovare i modi più adatti per metterla in pratica nella situazione concreta. All’interno stesso del gruppo dei farisei c’erano diversità di vedute; lo intravediamo in Luca dove i farisei ospitano Gesù (cf. Lc 7,36; 11,37; 14,1) e sono dei farisei che avvertono Gesù del pericolo dell’ostilità di Erode: «In quel momento si avvicinarono alcuni farisei a dirgli: ‘Allontanati da qui, perché, Erode vuole ucciderti’» (Lc 13,31). Matteo è più interessato alla disputa teorica e meno attento alla realtà storica, a cui invece guarda Luca e dalla quale risulta che, anche all’interno di uno stesso gruppo, vi sono posizioni e atteggiamenti diversi.
L’annotazione di Matteo secondo cui i farisei prendono coraggio di interrogare Gesù dopo che hanno udito che «aveva chiuso la bocca ai sadducei» e lo fanno per «metterlo alla prova» (Mt 22,34) porta subito all’atmosfera di polemica, che regnava fra i diversi gruppi, ma al tempo stesso mostra che Gesù è riconosciuto un maestro.
Al Maestro veritiero che insegna la via di Dio e non guarda in faccia a nessuno (Mt 22,16) viene posta la cruciale questione, che spaccava di netto le correnti ebraiche del tempo, sulla legittimità di versare il tributo all’imperatore romano. Gesù rispose riproponendo la stessa alternativa tra Dio e gli uomini. Si dia pure, per ora, il tributo a Cesare, ma si ricordi che la scelta decisiva sta nel rendere a Dio quel che è di Dio; proprio come prima era decisivo sapere, come fecero i pubblicani e le prostitute (Mt 21,32), che il battesimo di Giovanni veniva dal cielo e non dagli uomini.
Per giungere a questa conclusione Gesù si fa mostrare la moneta del tributo chiedendo di chi sia l’effigie e l’iscrizione impressa su di essa. All’inevitabile risposta che esse appartengono a Cesare, Gesù replica affermando: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio» (Mt 22,21; Mc 12,17; Lc 20,26). Il verso impiegato da tutti e tre i sinottici in questa risposta (apodidômi) allude a un significato non solo di un semplice dare, quanto piuttosto di un «dare indietro», di un «restituire». Restituite pure a Cesare quanto è suo, come è comprovato dall’effigie e dall’iscrizione, ma soprattutto restituite a Dio quanto porta impressa in sé la sua immagine: cioè voi stessi. È l’uomo stesso la moneta di Dio che gli deve essere restituita con frutto (cf. Mt 25,14-30). Rashi, — il massimo commentatore ebreo medievale della Bibbia — nel suo commento alla Genesi, chiosa così il versetto secondo cui Dio creò l’uomo a sua immagine (Gn 1,27): Cioè secondo il modello fatto per lui. Infatti tutte le altre cose furono create con la Parola, ma l’uomo fu creato con le mani, come sta scritto: «Hai posto su di me la tua mano» (Sal 139,5). Egli fu fatto con un sigillo, come una moneta che è fatta con un conio. Allo stesso modo sta scritto: «Si trasforma come creta da sigillo» (Gb 38,14)» (cf. Commento alla Genesi, cit., 13). Chi porta in se stesso l’immagine e il sigillo del Signore a lui appartiene, a lui deve innanzitutto obbedire (cf. At 5,29). (PIERO STEFANI, Sia santificato il tuo nome, Commenti ai Vangeli della domenica. Anno A, Marietti, Genova 1986, 200s).
Gesù non cade nel tranello di risolvere una questione contingente, relativa all’istituzione politica del momento, per la quale sono gli interessati stessi che devono trovare una soluzione adatta a quel preciso momento. Egli, da parte sua, ribadisce il principio della dignità delle persone umane, che hanno la facoltà di scegliere proprio perché create ad immagine di Dio.
Meditazione
La signoria di Dio è al cuore della prima lettura come del vangelo. Isaia presenta un’audace pagina di teologia della storia in cui si afferma che Ciro, re persiano, dunque pagano, è stabilito da Dio come Messia, con un’estensione inaudita di quella che era una prerogativa della dinastia davidica. Il passo profetico sottolinea l’assoluta libertà di Dio e la sua unicità («Io sono il Signore, non ce n’è altri»: Is 45,6). Il vangelo mostra la rela-tivizzazione delle autorità umane, anche l’imperatore, che all’epoca era divinizzato, davanti a Dio. Se l’autorità statale può esigere tasse e tributi (cfr. Rm 13,7), se alle autorità va accordato il rispetto (Rm 13,7), il timore va riservato a Dio (1Pt 2,17), creatore e signore di ogni uomo.
La risposta di Gesù alla domanda trabocchetto che gli viene rivolta dai suoi avversari batte due piste: evita la politicizzazione dell’immagine di Dio e si oppone alla sacralizzazione del potere politico. Gesù infatti, da un lato, si distanzia dagli zeloti che consideravano Dio come unico «Cesare» legittimo e, dall’altro, critica la sacralizzazione del potere politico demitizzando Cesare. In entrambi i casi siamo di fronte a tentazioni idolatriche. Nel primo caso la tentazione è di dare a Dio quel che spetta a Cesare, all’entità statale, cadendo in posizioni religiose totalitarie e non dialogiche, irrispettose dalla «laicità» dello stato e del potere politico; nel secondo, la tentazione è di dare a Cesare quel che spetta a Dio, all’interno di una assolutizzazione del potere politico.
Interessante il commento a questo passo di Kierkegaard, commento giocato sul tema dell’infinita indifferenza di Gesù nei confronti di Cesare e dell’infinita differenza che egli pone tra Dio e Cesare: «O infinita indifferenza! Che Cesare si chiami Erode o Salmanassar, che sia romano o giapponese, è cosa che a Gesù non importa minimamente. Ma, d’altra parte, quale abisso d’infinita differenza egli stabilì fra Dio e Cesare».
Le parole di risposta di Gesù ai suoi interlocutori sono importanti particolarmente nella loro seconda parte, quando Gesù aggiunge – non necessaria perché non richiesta dalla domanda che gli era stata posta – l’affermazione che riguarda il «dare a Dio quel che è di Dio». Questa rivendicazione significa che, se l’imperatore esige per sé ciò che spetterebbe a Dio, come l’adorazione, il cristiano – memore della parola che dice: «Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini» (At 5,29) – non è tenuto a dargliela, anzi può perfino affrontare il martirio, mostrando che solo Dio è il Signore della vita.
Tertulliano scrive: «Quali saranno le cose di Dio che siano simili al denaro di Cesare? Si intende l’immagine e la somiglianza con lui. Egli comanda quindi di rendere l’uomo al creatore, nella cui immagine e nella cui somiglianza era stato effigiato» (Contro Marcione IV, 38,1). Se il tema dell’immagine rinvia naturalmente all’uomo creato da Dio e capax Dei, il tema dell’iscrizione la si ritrova in un passo isaiano in cui designa l’appartenenza dell’uomo a Dio. I convertiti alla fede nel Dio d’Israele porteranno sulla mano l’iscrizione «Del Signore» e diranno: «Io appartengo al Signore» (Is 44,5). Le parole di Gesù spingono ogni credente a porsi la domanda: a chi appartengo? Chi è il mio signore?
Nella dialettica posta da Gesù tra Cesare e Dio si situa la condizione del credente che è nel mondo, ma non del mondo (cfr. Gv 17,11.16), che abita la città secolare, ma attende il Regno di Dio, che vive la pólis, ma ha il políteuma, la cittadinanza nei cieli (cfr. Fil 3,20). Una fedeltà alla terra e alla pólis autentica il cristiano la vive grazie alla sua riserva escatologica, alla sua attesa escatologica.
Il ridare a Dio quel che è di Dio va inteso anche nel senso di operare perché il mondo – uscito dalle mani di Dio e affidato a quelle dell’uomo -, nei suoi ordinamenti e nelle sue istituzioni, possa rispondere a quei requisiti di giustizia e diritto che sono propri della prassi messianica.
Ciò che è di Dio è anche, propriamente, ciò che è dell’uomo e nell’uomo, l’umano. E rendere a Dio ciò che è suo implica anche il compito umano di divenire la propria umanità, di umanizzare il mondo e i suoi rapporti.
Preghiere e racconti
Dio e Cesare
Dobbiamo concedere certe cose al corpo, un tributo a Cesare a seconda dei casi, cioè nella misura richiesta. Ma le cose che riguardano la natura delle nostre anime, cioè quelle che conducono alla virtù, bisogna offrirle a Dio.
(Origene, Catena aurea).
La moneta del tesoro divino
Siamo fatti ad immagine e somiglianza di Dio (Gen 1,26). Tu sei uomo, o cristiano. Sei quindi la moneta del tesoro divino che reca l’effigie e la scritta dell’imperatore divino. Perciò, io chiedo con il Cristo: «Quest’effigie e questa scritta di chi sono?». Tu rispondi: «Di Dio». Aggiungo: «Perché quindi non rendi a Dio ciò che è suo?».Se vogliamo essere realmente un’immagine di Dio dobbiamo assomigliare al Cristo, poiché egli è l’immagine della bontà di Dio e l’effigie che esprime il suo essere (cf. Eb 1,3). E Dio ha destinato coloro che conosceva in anticipo ad essere l’immagine del suo Figlio (Rm 8,29)… Così coloro che somigliano al Cristo con la loro vita, la loro condotta e le loro virtù, modellandosi su di lui, rendono veramente visibile l’immagine di Dio.
(Lorenzo da Brindisi, Omelia sul Vangelo)
Chiesa e comunità politica
La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l’una dall’altra nel proprio campo. Tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone umane… Predicando la verità evangelica e illuminando tutti i settori dell’attività umana con la sua dottrina e con la testimonianza resa dai cristiani, [la Chiesa] rispetta e promuove anche la libertà politica e la responsabilità dei cittadini.
(Vaticano II, Costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, 76; EV 1/1581)
Memorie della clessidra
Il volto di Dio
nel bronzo o nella cera,
il volto di Dio
chi saprà dirmelo?
In quale secolo in quale luogo
raggiungere questo volto?
Il volto di Dio
è senza casa e senza età.
Narciso nel suo specchio
invano si contempla
sognando di scorgere
un dio che gli somigli.
Interrogare il cielo
del solstizio e il suo midollo
di fuochi? È un altare
che nasconde troppe stelle.
Forse con occhi
di bambini, puri come neve,
il volto di Dio
sarà intrappolato?
(J. Vuaillat, Memorie della clessidra)
Angeli smemorati
Un giorno Dio si rallegrava e si compiaceva più del solito nel vedere quello che aveva creato. Osservava l’universo con i mondi e le galassie, ed i venti stellari sfioravano la sua lunga barba bianca accompagnati da rumori provenienti da lontanissime costellazioni che finivano per rimbombare nelle sue orecchie. Le stelle nel firmamento brillavano dando significato all’infinito.
Mentre ammirava tutto ciò, uno stuolo di Angeli gli passò davanti agli occhi ed Egli istintivamente abbassò le palpebre, ma così facendo gli Angeli caddero rovinosamente. Poveri angioletti, poco tempo prima si trovavano a lodare il Creatore rincorrendosi tra le stelle ed ora si trovavano su di un pianeta a forma di grossa pera!
“Che luogo è questo?” chiesero gli Angeli a Dio.
“E’ la Terra.” Rispose il Creatore.
“Dacci una mano per risalire”, chiesero in coro le creature, “perché possiamo ritornare in cielo”.
Dopo una pausa di attesa (secondo i tempi divini!), Egli rispose:
“No! Quanto è accaduto non è avvenuto per puro caso. Da molti secoli odo il lamento dei miei figli e mai hanno permesso che rispondessi loro. Una volta andai di persona, ma non tutti mi ascoltarono. Forse ora ascolteranno voi, dopo quello che hanno passato e passano seguendo falsi dei.
Andate creature celesti, amate con il mio cuore, cantate inni di gioia, mischiatevi tra i popoli in ogni luogo della terra e quando avrete compiuto la missione, allora ritornerete e faremo una grande festa nel mio Regno”.
Da allora tutti gli Angeli, felici di quanto si apprestavano a compiere per il bene degli uomini, se ne vanno in giro a toccare i cuori della gente e gioiscono quando un anima trova l’Amore.
Ma la cosa più sorprendente era che, toccando i cuori, scoprirono che molti di essi erano … Angeli che urtando il capo nella caduta avevano perduto la memoria.
E la missione continua anche se ancora ci sono molti Angeli smemorati, che magari alla sera, seduti sul davanzale della propria casa, guardano il cielo stellato in attesa di un significato scritto nel loro cuore.
Se solo si guardassero “dentro”!
Dio richiede la sua immagine impressa nell’uomo
Se con la dissomiglianza ci allontaniamo da Dio, con la somiglianza ci avviciniamo a lui. Quale somiglianza? La somiglianza secondo la quale siamo stati creati, che peccando abbiamo rovinato, che abbiamo ritrovato con il perdono dei peccati. È un’immagine che si rinnova nel profondo di noi stessi, è l’immagine del nostro Dio che viene, per così dire, scolpita nuovamente sulla moneta, cioè nell’anima perché ritorniamo a far parte dei suoi tesori. Perché, fratelli, il Signore nostro Gesù Cristo volle mostrare a quanti lo tentavano ciò che Dio richiede da noi si servì di una moneta? A proposito del tributo dovuto a Cesare, essi cercavano un pretesto per calunniarlo (cfr. Mt 22,15-22); vollero consultarlo come maestro di verità e lo tentarono chiedendogli se fosse lecito o no pagare il tributo a Cesare. Ed egli cosa rispose? Perché mi tentate, ipocriti? Chiese che gli fosse portata una moneta e quando gli fu portata, disse: «A chi appartiene l’immagine?». Risposero a Cesare. Ed egli: «Rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio» (Mt 22,21).
E come se dicesse: Se Cesare richiede la sua immagine impressa sulla moneta, forse che Dio non richiede la sua immagine impressa nell’uomo? Il nostro Signore Gesù Cristo invitandoci a tale somiglianza ci comanda di amare anche i nostri nemici e da quale esempio Dio stesso. Dice: «Siate come il Padre vostro che è in cielo fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Siate dunque perfetti come il Padre vostro è perfetto» (Mt 5,45-48). Quando dice: «Siate perfetti come egli lo è», ci invita a alla somiglianza con lui. E se ci invita alla somiglianza, ciò significa che, diventati dissimili, ci eravamo allontanati. Andati lontano per la dissomiglianza, ci riavviciniamo attraverso la somiglianza.
(AGOSTINO DI IPPONA, Esposizione sul salmo 94,2, NBA XXVII, pp. 306-308).
Il diamante caduto nel fango
Ho conosciuto un santo, gli ero intimo amico come un Figlio di Dio: si chiamava Don Giovanni Calabria, fondatore d’una grande opera caritativa.
Quando c’incontrammo in occasione della mia prima messa, mi disse: «Se tu trovassi sulla strada un diamante caduto nel fango che cosa faresti?». Risposi: «Non avrei nessuna ripugnanza a sporcarmi; lo prenderei su, lo laverei, ridonandolo in tal modo alla sua originale brillantezza». «Fà così con l’uomo» soggiunse.
(Zeno SALTINI, L’uomo è diverso, Ed. Stai).
Preghiera
O Dio, tu sei il Re della storia e tutto fai concorrere al bene di coloro che ti amano: anche le prove più difficili, i nostri esili. Ti preghiamo di donarci il tuo Spirito, affinché possiamo vedere nella luce della fede le complesse vicende della storia, scorgendovi la tua mano amorosa che realizza il meraviglioso piano di salvezza per il tuo popolo e per l’intera umanità. Ti ringraziamo perché ci chiami a collaborare al tuo progetto e ci chiedi di saper assumere le nostre responsabilità nell’ambito civile e politico. La parola del tuo Figlio c’infonde un’accresciuta consapevolezza: il potere umano non può essere né demonizzato né divinizzato, ma in esso si deve manifestare l’orientamento della nostra libertà.
Ti ringraziamo per averci fatti a tua immagine e per averci rivelato la nostra vocazione cristiana: essa ci impegna a rispondere della qualità morale delle scelte grandi e piccole nella vita d’ogni giorno. Grazie perché con il tuo aiuto potremo vivere tutto questo, rendendo a Cesare ciò che è di Cesare e a te, o nostro Dio, quanto è tuo. Ossia le nostre stesse vite!
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Lezionario domenicale e festivo. Anno A, a cura della Conferenza Episcopale Italiana, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2007.
– Temi di predicazione. Omelie. Ciclo A, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2004.
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, «Allegato redazionale alla Rivista del Clero Italiano» 92 (2011) 5, 42 pp.
– COMUNITÀ DI BOSE, Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche. Anno A, Milano, Vita e Pensiero, 2010.
– Fernando ARMELLI, Ascoltarti è una festa. Le letture domenicali spiegate alla comunità, Anno A, Padova, Messaggero, 2001.