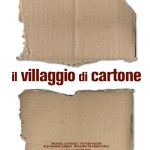|
XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
|
Lectio – Anno A
Prima lettura: Malachia 1,14-2,2.8-10
|
Io sono un re grande – dice il Signore degli eserciti – e il mio nome è terribile fra le nazioni. Ora a voi questo monito, o sacerdoti. Se non mi ascolterete e non vi darete premura di dare gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, manderò su voi la maledizione. Voi invece avete deviato dalla retta via e siete stati d’inciampo a molti con il vostro insegnamento; avete distrutto l’alleanza di Levi, dice il Signore degli eserciti. Perciò anche io vi ho reso spregevoli e abietti davanti a tutto il popolo, perché non avete seguito le mie vie e avete usato parzialità nel vostro insegnamento. Non abbiamo forse tutti noi un solo padre? Forse non ci ha creati un unico Dio? Perché dunque agire con perfidia l’uno contro l’altro, profanando l’alleanza dei nostri padri?
|
v Il testo profetico, tratto da Malachia, è un severo monito rivolto ai sacerdoti, che dimostrano di avere poco a cuore la gloria di Dio. Il problema non è da poco, dal momento che la posizione dei sacerdoti quali educatori del popolo di Dio risulta fondamentale. Come può Dio farsi ascoltare dai sacerdoti disobbedienti? La minaccia è seria e concreta: trasformare in maledizione le loro benedizioni, come la Parola di Dio afferma: «Ma se non obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, se non cercherai di eseguire tutti i suoi comandi e tutte le sue leggi che oggi ti prescrivo, verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste maledizioni» (Dt 28,15).
Ai sacerdoti venivano portate le primizie, in segno di ringraziamento a Dio per i beni della terra, che permettevano di vivere e godere del frutto del proprio lavoro. I beni della terra sono, quindi, benedizione del Signore, ma rischiano di diventare frutti amari e acerbi se non si è in sintonia con lui. Riconoscere, invece, che tutto proviene da Dio, al quale si dimostra riconoscenza rispettandone i comandi, vuol dire prendere a cuore la gloria sua.
Purtroppo, il profeta è costretto a richiamare alla fedeltà i sacerdoti, responsabili dell’allontanamento del popolo dal Signore e della loro stessa rovina: «Voi invece avete deviato dalla retta via e siete stati d’inciampo a molti con il vostro insegnamento; avete distrutto l’alleanza di Levi, dice il Signore degli eserciti. Perciò anche io vi ho reso spregevoli e abietti davanti a tutto il popolo, perché non avete seguito le mie vie e avete usato parzialità nel vostro insegnamento» (2,8-9).
L’appello di Malachia, al v. 10, si fa davvero struggente per l’intensità e la sincerità: «Non abbiamo forse tutti noi un solo padre? Forse non ci ha creati un unico Dio? Perché dunque agire con perfidia l’uno contro l’altro, profanando l’alleanza dei nostri padri?». Il profeta, dunque, c’invita a guardare alle nostre origini, che si trovano in Dio, sicché colui che compie del male contro il suo prossimo danneggia la sua stessa carne e il suo proprio sangue, oltre a offendere la Parola di verità e di comunione che Dio ha donato ai padri. Ai sacerdoti si raccomanda di ricordare e far ricordare tutto questo. Infatti, se agiscono diversamente, compromettono la loro dignità e missione in mezzo all’umanità, costringendo quest’ultima a rivolgersi altrove e a sostituire Dio con qualcos’altro. La fedeltà al Signore non costituisce una trappola, ma un vero cammino di libertà e di fraternità, da cui nasce quella benedizione che il mondo chiede, affinché ognuno possa chiamare Dio padre e Gesù maestro e sentirsi sazio di pane e verità.
Seconda lettura: 1Tessalonicesi 2,7-9.13
|
Fratelli, siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri figli. Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Voi ricordate infatti, fratelli, il nostro duro lavoro e la nostra fatica: lavorando notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi, vi abbiamo annunciato il vangelo di Dio. Proprio per questo anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio perché, ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l’avete accolta non come parola di uomini ma, qual è veramente, come parola di Dio, che opera in voi credenti.
|
v La polemica di Gesù con gli scribi e i farisei da una parte e il monito di Malachia ai sacerdoti dall’altra, hanno qualcosa in comune con quanto scrive Paolo nella prima lettera ai cristiani di Tessalonica. Infatti, l’apostolo si rivolge alla comunità da lui fondata, ricordando il tempo della sua permanenza in mezzo a essa con parole piene di affetto: «Siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri figli. Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari» (2,7-8).
Impressiona il forte linguaggio di Paolo, che addirittura adopera l’immagine della madre, per indicare la misura, certo notevole, dell’amore che ha nutrito per i membri di quella comunità. Questa era nata dopo le vicende convulse patite a Filippi (cf. At 16,19-40, ove si racconta di Paolo e Sila, prima malmenati, poi portati in prigione e, infine, liberati il giorno seguente) e che egli ricorda in 2,2a. D’altronde, anche a Tessalonica Paolo ebbe problemi, fomentati dai suoi connazionali, a seguito della sua predicazione (2,2b: «abbiamo avuto il coraggio nel nostro Dio di annunziarvi il vangelo di Dio in mezzo a molte lotte»; cf. anche At 17,1-9), di cui continuò a subire la comunità. Ciò spiega ancora meglio la disponibilità dell’apostolo a dare persino la propria vita, oltre al dono già prezioso del vangelo.
Il dono del vangelo, poi, non è avvenuto con atteggiamenti di superbia, alterigia e superiorità da parte di Paolo, e tanto meno egli ha preteso di essere mantenuto a carico della comunità per le sue esigenze personali, piuttosto la sua libertà e la credibilità del vangelo hanno ricevuto una forte conferma dal momento che egli dimostra totale disinteresse per il suo tornaconto personale: «Voi ricordate infatti, fratelli, il nostro duro lavoro e la nostra fatica: lavorando notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi, vi abbiamo annunciato il vangelo di Dio» (2,9). I frutti della missione a Tessalonica Paolo li considera abbastanza buoni, perciò si dispone a ringraziare quella comunità per la sensibilità che ha dimostrato, quando ha accolto la predicazione, considerandola non semplice parola umana, bensì parola divina, che opera meraviglie in colui che la riceve: «Proprio per questo anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio perché, ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l’avete accolta non come parola di uomini ma, qual è veramente, come parola di Dio, che opera in voi credenti» (2,13). L’efficacia della parola rappresenta agli occhi di Paolo la prova che essa è stata recepita con fede, con entusiasmo, facendosi fecondare da essa, al fine di rinnovare la mente e il cuore, oltre a cambiare coloro che ci stanno attorno. Alla fine, bisogna ammettere che ancora una volta Paolo ha dato una lezione di stile pastorale, che non è semplice strategia o pragmatismo, bensì in primo luogo un ambito in cui se non si sa amare coloro che Dio ha posto da pascere, tutto si rivela inutile e controproducente.
Vangelo: Matteo 23,1-12
|
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato».
|
Commmento del Vangelo in immagini
XXXI DOM TEMP ORD ANNO A
Esegesi
Le parole che Gesù pronuncia nel brano evangelico di questa domenica devono naturalmente essere inquadrate nel contesto narrativo matteano: nel capitolo 19 ha avuto inizio una sezione narrativa, che termina proprio con il capitolo 23, dopo il quale si trova il discorso escatologico (capp. 24-25) e, infine, il racconto della passione, morte e risurrezione.
Nell’ambito della sezione narrativa a cui abbiamo fatto riferimento, occorre ancora ricordare che in 21,1-11 si racconta che Gesù è entrato a Gerusalemme, dove avvengono scontri decisivi con le autorità sacerdotali e con gli altri gruppi. Dal momento che Gesù ha definitivamente chiarito la propria posizione rispetto a farisei, sadducei, erodiani, ora ne smaschera le pretese e ne dimostra l’ipocrisia al cospetto delle folle e dei propri discepoli. La polemica con gli esponenti più in vista del popolo ebraico (a cui Gesù, è sempre utile ricordarlo, apparteneva), copre l’intero capitolo 23, del quale questa domenica si leggono soltanto i primi 12 versetti.
Il primo elemento che Gesù prende in considerazione è che gli scribi e i farisei rappresentano la tradizione e si occupano dell’interpretazione della legge mosaica: questo vuol dire essere seduti sulla cattedra di Mosè. Trasmettere la conoscenza della legge è un compito apprezzato da Gesù («Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono»), ma egli ha già, in diverse occasioni, sottolineato la scarsa fedeltà interpretativa e i comportamenti contraddittori di quei «maestri» («ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno»). Esemplificazioni a questo proposito se ne trovano nel brano successivo, in cui i vari casi sono introdotti dall’espressione «guai». Riguardo all’interpretazione della legge, segnaliamo, ad esempio, il confronto che Gesù ha sostenuto relativamente alla questione del divorzio in 19,3-9. L’incoerenza è totale, poiché essi stessi non vivono secondo quanto insegnano: «Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito» (v. 4).
Non secondaria è la critica all’ostentazione, al mettere in mostra le pubbliche virtù, perché lo scopo non è piacere a Dio bensì trovare la propria ricompensa nell’essere ammirati dagli uomini, come era già stato detto in 6,1-18. Allargare i filatteri (piccole scatole racchiudenti parole della legge e appese al braccio o alla fronte, cf. Es 13,9.16; Dt 6,8 e 11,18), allungare le frange (fiocchi per ricordare i comandi del Signore, cf. Nm 15,18ss), prediligere posti d’onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e saluti nelle piazze, oltre a essere chiamati rabbi dalla gente: questa era l’aspirazione degli scribi e dei farisei.
Gesù sa bene che anche tra i suoi discepoli può insinuarsi questo tipo di mentalità, perciò i vv. 8-12 sembrano essere indirizzati proprio a loro. Egli insiste su tre cose: non farsi chiamare rabbi e guida (al v. 10 c’è il termine kategetès, che può essere tradotto anche così), per non anteporre alcun’altra autorità a lui stesso e non perdere il senso della fratellanza; non chiamare nessuno padre, per non anteporre alcun’altra paternità a Dio; sapere che essere più grande significa essere a servizio.
Meditazione
All’invettiva profetica contro i sacerdoti infedeli nella prima lettura risponde l’invettiva profetica di Gesù rivolta a scribi e farisei nel vangelo. Entrambi i testi denunciano non solo l’ipocrisia e la doppiezza, ma anche il potere che può essere esercitato da chi detiene un’autorità.
Ai sacerdoti il profeta rimprovera la scissione del loro insegnamento dall’ascolto della Parola di Dio, l’unica che può dare fondamento, contenuto e autorevolezza alla loro parola. Senza la Parola di Dio, il sacerdote non ha nulla da dire, essendo il suo ministero un servizio della Parola di Dio.
L’accusa contro «l’agire perfido» (Ml 2,10) colpisce il tradimento della fiducia. Chi riveste una responsabilità religiosa non può non essere cosciente della valenza simbolica della sua persona: egli deve pertanto essere fidabile e credibile. Se tradisce la fiducia che altri ri-pongono in lui, diviene responsabile anche dell’eventuale allontanamento da ciò egli rappresenta nel suo ministero.
Intendere la pagina di Matteo come antigiudaica e le parole di Gesù come rivolte esclusivamente a scribi e farisei, significa non comprendere l’intenzione del testo (che dal v. 8 ha di mira i discepoli e dunque i cristiani) e cadere nell’ipocrisia denunciata da Gesù stesso. Commentando i versetti 5-7 Gerolamo ha scritto: «Guai a noi, miserabili, che abbiamo ereditato i vizi dei farisei». Le parole di Gesù colpiscono il clericalismo cristiano e riguardano vizi religiosi, non giudaici. Le situazioni denunciate da Gesù in Mt 23 sono nostre, tutte, «nessuna esclusa: da quelle ridicole, ma non per questo meno pericolose – i paludamenti, i titoli, i posti d’onore – a quelle ancor più gravi: l’intellettualismo, il verbalismo, il proselitismo, la casistica, il ritualismo, la persecuzione dei profeti vivi e la strumentalizzazione dei profeti morti» (Vittorio Fusco).
Le parole dure di Gesù, che non sono maledizioni ma invettive e lamenti al tempo stesso, parole piene di collera e di sofferenza – le due facce dell’amore tradito -, svolgono una sorta di terapia d’urto nei confronti di una distorsione del magistero e dell’autorità religiosa che occorre definire patologica.
Gesù denuncia l’irresponsabilità della parola. Irresponsabilità che consiste nel dire senza fare, quasi che il parlare di Vangelo dispensi dal viverlo o equivalga al metterlo in pratica. Irresponsabilità che è imposizione agli altri di pesi schiaccianti (l’immagine sottostante è quella dei mercanti che caricavano pesi immensi sulle loro bestie da soma perché li portassero per loro), dunque come comando che vale per l’altro e non per sé e dunque è ignorante del peso che l’altro deve portare e della sua fatica.
Dovremmo anche interrogarci sull’esibizionismo religioso (cfr. Mt 23,5-6), sullo scialo di titoli onorifici (cfr. Mt 23,7-10) rivolti a personalità ecclesiastiche (l’episcopale «Eccellenza» è di derivazione fascista ed è stato applicato ai vescovi per attribuire loro una dignità non minore di quella riservata da Mussolini ai suoi prefetti), sulla fastosità e ricercatezza barocca di vesti liturgiche (cfr. Mt 23,5). Se il Crisostomo criticava chi onorava Cristo all’altare con «vesti di seta» mentre fuori di chiesa vi era chi moriva di freddo per la nudità, Bernardo di Clairvaux scriveva a papa Eugenio III dicendogli che «Pietro non si presentò mai in pubblico bardato di gemme o in cappe di seta o coperto d’oro» e che «sotto questo aspetto, tu non sei il successore di Pietro ma di Costantino» (Della considerazione IV,3,6).
Titoli, vesti, onori: trattandosi di cose esteriori, vale la pena di perder tempo a criticare queste cose? Mi limito a citare le parole di p. Yves Congar: «Si può beneficiare ordinariamente di privilegi senza arrivare a pensare che sono dovuti? O vivere in un certo lusso esteriore senza contrarre certe abitudini? E essere onorati, adulati, trattati in forme solenni e prestigiose, senza mettersi moralmente su un piedistallo? È possibile comandare e giudicare, ricevere uomini in atteggiamento di richiesta, pronti a complimentarci, senza prendere l’abitudine di non più veramente ascoltare? Si può trovare davanti a sé dei turiferari senza prendere un po’ il gusto dell’incenso?».
Preghiere e racconti
Due gruppi di persone
Le persone si distinguono in due categorie: quelle che cercano e vivono per il successo e quelle per la gioia.
Le prime sono sempre su un palcoscenico disposte a fare ciò che gli altri vogliono per poter applaudire; il secondo gruppo rifugge dal rappresentarsi e sceglie di essere.
In un caso il metro è l’applausometro, nell’altro il rispetto di se stessi innanzitutto, ed è il più difficile.
Conosco persone piene di gioia e non hanno mai ottenuto un applauso. Il mattino guardandosi nello specchio, accennano ad un sorriso. Le persone del successo alla prima sbirciata corrono subito per il trucco. Non sanno stare senza gli altri, devono avere il chiasso dell’approvazione sempre attorno. La persona gioiosa sa che anche da soli si possono fare tante cose utili, e non per se stessi soltanto.
La nostra è la società del successo, dell’esistere per gli altri e come gli altri desiderano: dei perfetti burattini. Un successo misurato dal denaro: tanto maggiore è il successo, tanto più alto è il compenso, più grande l’auto e più lunga la barca già ormeggiata in un porticciolo o dentro la testa, nella sezione del desiderio. Questo è anche il programma di molti giovani e di molti genitori: tentare la fortuna che conduca al successo.
Strumenti accidentali
Gli apostoli furono considerati dal Cristo come rappresentanti degli altri credenti, o piuttosto come i suoi propri rappresentanti. In realtà, egli è il solo e l’unico a sedersi sul trono del regno; è la sola autorità del suo impero, pur essendo invisibile. Essi sono solo i suoi reggenti, dei semplici viceré, in sua assenza, e qualunque sia il loro potere, non è un potere che possiedono in proprio, ma un potere che viene da lui; e come questo potere non ha la sua origine in loro, così non ha la sua fine in loro. Essi sono stati solo strumenti accidentali, benché particolarmente favoriti, del compimento della prodigiosa opera del Cristo… E quali che siano stati i loro onori e i loro poteri, non è necessario immaginare che questi onori e questi poteri siano finiti con loro, dal momento che non li avevano mai posseduti veramente in proprio.
(J.H. Newman, Sermoni sui temi del giorno 16)
Grazie, Signore (Lc 5,27-32)
Signore, ti ringrazio perché mi hai messo al mondo:
aiutami perché la mia vita
possa impegnarla per dare gloria a te e ai miei fratelli.
Ti ringrazio per avermi concesso questo privilegio:
perché tra gli operai scelti, tu hai preso proprio me.
Mi hai chiamato per nome
perché io collabori con la tua opera di salvezza.
Grazie perché il mio letto di dolore è fontana di carità,
è sorgente di amore.
Di amore per te, anche di amore per tutti i fratelli.
Signore, io seguo te più da vicino, in modo più stretto.
Voglio vivere in un legame più forte
per poter essere più pronto a darti una mano,
più agile perché i miei piedi che annunciano la pace sui monti
possano essere salutati da chi sta a valle.
Concedimi il gaudio di lavorare in comunione
e inondami di tristezza ogni volta che, isolandomi dagli altri,
pretendo di fare la mia corsa da solo.
Salvami, Signore, dalla presunzione di sapere tutto.
Dall’arroganza di chi non ammette dubbi.
Dalla durezza di chi non tollera i ritardi.
Dal rigore di chi non perdona le debolezze.
Dall’ipocrisia di chi salva i principi e uccide le persone.
Toccami il cuore e rendimi trasparente la vita,
perché le parole, quando veicolano la tua,
non suonino false sulle mie labbra.
(Don Tonino Bello)
«La messa è finita, andate in pace!»
Al termine della Messa il prete ci congeda con la formula: “La Messa è finita, andate in pace!”. Sono sempre tentato di correggere: andate, perché la Messa non è finita, non finisce mai. Questo infatti è un inizio, non una conclusione. Il sacerdote non vuol dire: “Bravi, avete fatto il vostro dovere, potete andare tranquilli”; al contrario, è come se dicesse: “Adesso tocca a voi, è il vostro momento”. Dunque non un segnale di “riposo”, ma di “partenza” per una missione. Significa “agganciarsi” alla vita quotidiana. Ci si alza dalla mensa eucaristica e si attacca a lavorare, a costruire il Regno.
(Alessandro Pronzato).
L’albero generoso
C’era una volta un albero che amava un bambino. Il bambino veniva a visitarlo tutti i giorni.
Raccoglieva le sue foglie con le quali intrecciava delle corone per giocare al re della foresta. Si arrampicava sul suo tronco e dondolava attaccalo ai suoi rami. Mangiava i suoi frutti eppoi, insieme, giocavano a nascondino.
Quando era stanco, il bambino si addormentava all’ombra dell’albero, mentre le fronde gli cantavano la ninna-nanna.
Il bambino amava l’albero con tutto il suo piccolo cuore.
E l’albero era felice.
Ma il tempo passò e il bambino crebbe.
Ora che il bambino era grande, l’albero rimaneva spesso solo.
Un giorno il bambino venne a vedere l’albero e l’albero gli disse:
«Avvicinati, bambino mio, arrampicati sul mio tronco e fai l’altalena con i miei rami, mangia i miei frutti, gioca alla mia ombra e sii felice».
«Sono troppo grande ormai per arrampicarmi sugli alberi e per giocare», disse il bambino, «io voglio comprarmi delle cose e divertirmi. Voglio dei soldi. Puoi darmi dei soldi?».
«Mi dispiace, rispose l’albero «ma io non ho dei soldi. Ho solo foglie e frutti. Prendi i miei frutti, bambino mio, e va’ a venderli in città. Così avrai dei soldi e sarai felice».
Allora il bambino si arrampicò sull’albero, raccolse tutti i frutti e li portò via.
E l’albero fu felice.
Ma il bambino rimase molto tempo senza ritornare… E l’albero divenne triste.
Poi un giorno il bambino tornò; l’albero tremò di gioia e disse:
«Avvicinati, bambino mio, arrampicati sul mio tronco e fai l’altalena con i miei rami e sii felice».
«Ho troppo da fare e non ho tempo di arrampicarmi sugli alberi», rispose il bambino. «Voglio una casa che mi ripari», continuò. «Voglio una moglie e voglio dei bambini, ho dunque bisogno di una casa.
Puoi darmi una casa?».
«Io non ho una casa» disse l’albero. «La mia casa è il bosco, ma tu puoi tagliare i miei rami e costruirti una casa. Allora sarai felice».
Il bambino tagliò tutti i rami e li portò via per costruirsi una casa. E l’albero fu felice.
Per molto tempo il bambino non venne. Quando ritornò, l’albero era così felice che riusciva a malapena a parlare.
«Avvicinati, bambino mio», mormorò «vieni a giocare».
«Sono troppo vecchio e troppo triste per giocare», disse il bambino. «Voglio una barca per fuggire lontano di qui. Tu puoi darmi una barca?».
«Taglia il mio tronco e fatti una barca», disse l’albero. «Così potrai andartene ed essere felice».
Allora il bambino tagliò il tronco e si fece una barca per fuggire. E l’albero fu felice… ma non del tutto.
Molto molto tempo dopo, il bambino tornò ancora.
«Mi dispiace, bambino mio», disse l’albero «ma non resta più niente da donarti… Non ho più frutti».
«I miei denti sono troppo deboli per dei frutti», disse il bambino.
«Non ho più rami», continuò l’albero «non puoi più dondolarti».
«Sono troppo vecchio per dondolarmi ai rami»,disse il bambino.
«Non ho più il tronco», disse l’albero. «Non puoi più arrampicarti».
«Sono troppo stanco per arrampicarmi», disse il bambino.
«Sono desolato», sospirò l’albero. «Vorrei tanto donarti qualcosa… ma non ho più niente. Sono solo un vecchio ceppo. Mi rincresce tanto…».
«Non ho più bisogno di molto, ormai», disse il bambino. «Solo un posticino tranquillo per sedermi e riposarmi. Mi sento molto stanco».
«Ebbene», disse l’albero, raddrizzandosi quanto poteva «ebbene, un vecchio ceppo è quel che ci vuole per sedersi e riposarsi. Avvicinati, bambino mio, siediti. Siediti e riposati».
Così fece il bambino.
E l’albero fu felice.
(Shel Silverstein)
Dagli scritti di Madre Teresa di Calcutta
Il frutto del silenzio è la preghiera,
il frutto della preghiera è la fede,
il frutto della fede è l’amore,
il frutto dell’amore è il servizio,
il frutto del servizio è la pace.
Il servo di tutti
A volte, Signore, la piccolezza del mio essere creatura mi appare inadeguata e insufficiente a contenere i miei più grandi desideri. E faccio di tutto per rompere quelli che avverto come limiti al mio bisogno di espandermi, di ‘sentirmi grande’: essere più degli altri, ricevere più degli altri, contare più degli altri.
Tu vieni incontro a questo prepotente bisogno di emergere e mi proponi di metterlo a servizio dell’amore, facendomi l’ultimo di tutti, il servo di tutti, il più pacifico, il più mite, il più misericordioso, accogliente verso tutti…
Manda dall’altro il tuo Spirito di sapienza, perché faccia della mia vita un’opera di pace.
Preghiera
Signore Gesù, liberaci dall’ipocrisia. Desideriamo con l’aiuto del tuo Santo Spirito perseguire quello stile di vita che ci qualifica come tuoi veri discepoli. Permettici di riconoscere le nostre incoerenze, che offuscano lo splendore del tuo vangelo, e di vegliare sull’autenticità della nostra relazione con te e fra di noi.
Ti ringraziamo perché nella tua Pasqua tu ci hai generati a nuova vita, manifestando l’amore del Padre verso di noi. Per questo c’impegniamo davanti a te a non permettere che nei nostri rapporti comunitari prevalga la ricerca dell’apparire e del dominare. Ci impegniamo a custodire la consapevolezza della nostra immeritata figliolanza divina e della fraternità che deve regnare tra noi, nostro compito ma soprattutto tuo inestimabile dono.
Signore Gesù, desideriamo restare radicalmente tuoi discepoli, senza pretendere di diventare maestri di altri, perché dalla bocca tua, o solo Maestro, potremo comprendere, con sempre rinnovata gioia, l’amore di Dio Padre per noi suoi figli.
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Lezionario domenicale e festivo. Anno A, a cura della Conferenza Episcopale Italiana, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2007.
– Temi di predicazione. Omelie. Ciclo A, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2004.
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, «Allegato redazionale alla Rivista del Clero Italiano» 92 (2011) 5, 42 pp.
– COMUNITÀ DI BOSE, Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche. Anno A, Milano, Vita e Pensiero, 2010.
– Fernando ARMELLI, Ascoltarti è una festa. Le letture domenicali spiegate alla comunità, Anno A, Padova, Messaggero, 2001.