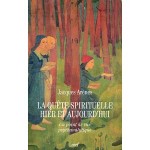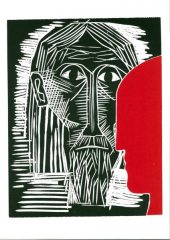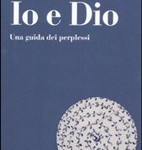
in dialogo con Vito Mancuso
Continuo la riflessione avviata nel numero scorso sull’ultimo libro di Vito Mancuso (Io e Dio. Una guida dei perplessi, Garzanti, 2011). Un secondo problema sul quale mi soffermo, dopo aver esaminato quello della relazione comunitaria (Noi e Dio), riguarda il carattere personale di Dio. A proposito dell’esistenza di Dio e della sua dimostrazione Mancuso si diffonde ampiamente con lo sviluppo di varie argomentazioni. Le sue posizioni sono molto chiare. Egli sostiene che la ragione può dimostrare l’esistenza di un essere o un bene assoluto ma non il suo carattere personale. Alla scoperta di un Dio personale, egli sostiene, si può pervenire solo con argomenti sviluppati all’interno dell’esperienza di fede (in particolare, ma non solo, cristiana), argomenti quindi validi solo per i credenti. Esaminiamo brevemente il significato e le motivazioni di queste posizioni. esiste un Assoluto Mancuso più volte ripete che non vi devono essere dubbi sull’esistenza di un Essere, di un Bene, di una Vita assoluti. È innegabile che esista «l’essere-energia… dentro la quale tutti siamo venuti all’esistenza, verso la quale tutti camminiamo e nella quale tutti con la morte saremo assorbiti. Siamo emersi dall’essere-energia come da una sorgente… e in questa stessa sorgente, alla fine pensabile come porto, ritorneremo quando la nostra libertà non esisterà più. Questo è un semplice dato di fatto…» (pp. 108-109). «Se poniamo Assoluto=Essere, è evidente che l’Assoluto esiste» (p. 109). Riflettendo in questo modo, però, arriviamo «solo a ciò che comunemente viene detto Essere o anche Totalità, Assoluto, Uno, Tutto» (p. 109). «Se si intende questo, è chiaro che Dio esiste, è evidente che c’è. È il Dio di Spinoza su cui si struttura tutta la sua Ethica…» (ib.). Lo ripete poco dopo: «È chiaro che il bene, nel senso di bonum, esiste… Ciò di cui posso conoscere l’esistenza riflettendo seriamente con la mia ragione è quanto Pascal chiamava Dio dei filosofi e si potrebbe chiamare anche Assoluto, Sommo Bene, Uno, Tutto. È la cifra di molte altre speculazioni» (p. 110). Si deve notare che anche se «evidente» o «un dato di fatto», tuttavia non è detto che questa Realtà suprema sia affermata da tutti, perché, in ogni caso, l’acquisizione e la conseguente affermazione è risultato di esperienze vissute con consapevolezza, è un’interpretazione razionale della vita, che consente di vivere in pienezza, ma che, come tale, potrebbe anche non essere raggiunta. Mancuso qualifica questa esperienza come spirituale e la collega alle «altre forme mediante cui è giunta a espressione la dimensione spirituale, come la pittura, la scultura, la danza, il teatro, la poesia, la musica» (p. 114). Sono «invenzioni umane» «ma l’orizzonte dischiuso da queste discipline inventate dagli uomini non è necessariamente falso. Lo è per chi non ha idea di che cosa vi sia in gioco, per chi non sente queste dimensioni dell’essere ritenendole solo un bizzarro passatempo o un proficuo investimento. Ma per chi vive per esse, a volte per esse soffre la fame, e vi dedica tutta la vita, non esiste nulla di più reale e concreto. Si tratta di invenzioni, sì, ma nel senso etimologico del termine» (p. 114), cioè di scoperte della realtà profonda della vita. «Inventare [infatti] nella sua radice latina (invenire) significa ‘imbattersi in qualcosa, trovare, scoprire’. L’invenzione è anzitutto scoperta» (p. 115). Come accade a molti cultori della scienza che hanno scoperto energie e leggi della natura prima ignote e non utilizzate, così nel mondo dello spirito umano esistono possibilità di «invenzioni». Per esemplificare Mancuso richiama il fascino della bellezza. «Chiunque abbia avuto una reale esperienza estetica sa che si è trattato al contempo di qualcosa di estatico, qualcosa che l’ha fatto uscire da sé verso una dimensione più grande, preesistente, rispetto alla quale tuttavia non si è sentito estraneo ma coappartenente» (p.115). Ciò vale per tutte le esperienze ‘spirituali’: «quando si esce da sé senza tuttavia perdersi, ma ritrovandosi a un livello più alto»; vale, ad esempio, per «l’emozione purissima che una poesia, un quadro, una musica, una preghiera, una carezza fa sorgere dentro di noi». Mancuso si chiede: «come nominare questa dimensione più grande alla quale tuttavia si sente di appartenere: regno della suprema bellezza, dell’armonia compiuta, della pace del cuore, della luce buona dell’essere?» (p. 115). Risponde: «il complesso di termini quali ‘Dio, divino, divinità’ racchiude i simboli più efficaci ‘inventati’ dalla mente umana per nominare questa realtà avvolgente, materna e paterna, che si dischiude alla mente e al cuore in alcune peculiari esperienze vitali… Tali immagini cercano di portare al pensiero… una realtà che c’è da sempre» attraverso di esse «lo spirito… attinge il profondo dell’uomo» (pp. 115-116). È vero quindi che Dio è «invenzione» umana «per quanto attiene al concetto, ma questo non implica che la realtà cui rimanda il termine Dio sia falsa» (p.114), anzi la concretezza dell’esperienza induce la certezza della sua esistenza. Il Bene, la Vita, la Verità, la Bellezza esistono in forma piena e si esprimono in modo parziale e frammentario in noi. il carattere personale di Dio è dato di fede Mancuso però nega che questa realtà assoluta a cui si perviene riflettendo sulle varie esperienze umane, possa già essere scoperta come «persona», dotata, cioè, di conoscenza e di amore. La realtà divina a cui si perviene riflettendo sulla forza che sostiene il processo vitale è impersonale, è la «potenza neutra dell’essere-energia» (p. 108): «Così arrivo non a Deus, ma arrivo a Deum» (p. 109), a quello che S. Anselmo designava come «ciò di cui non si può pensare uno più grande». L’assoluto a cui si perviene con la riflessione di ragione «questo bonum impersonale non sarà conoscibile con certezza razionale come bonus, come Dio personale» (p. 110). Se quindi «si intende dire che sopra questa totalità onnicomprensiva dell’essere-energia, o al di fuori di questa totalità, o dentro di essa in una dimensione più profonda, o chissà dove altro ancora, vi sia un essere personale a cui potersi rivolgere dicendo Abbà-Padre, allora non è più evidente, non lo è per nulla, che tale Deus esista» (p.109). La realtà a cui si perviene non è «il tenero Abbà-Padre di Gesù. Di questo non si potrà mai conoscere razionalmente l’esistenza. Con buona pace del dogma cattolico» (p. 110). Mancuso nega quindi che a questo stadio il divino possa essere termine di una relazione personale, possa essere invocato, benedetto, lodato, adorato. Il Dio personale, come quello della tradizione ebraico-cristiana, lo si conosce solo per la rivelazione e lo si incontra solo nell’esercizio della fede. Senza questa esperienza personale non si può affermare l’esistenza del Dio credo per la testimonianza di Gesù. Egli conclude: «Sto dicendo, in un certo senso, che Dio esiste solo per chi lo fa esistere. Chi lo fa esistere avrà trovato ponte tra la sua fame e sete di giustizia e il senso ultimo del mondo: verus pontifex maximus» (p. 428). Potrebbe suscitare confusione il fatto che il carattere personale di Dio sia difeso con chiarezza da Mancuso e sia argomentato con lo stesso tipo di ragionamento con il quale egli afferma l’esistenza ‘evidente’ di un Assoluto. Scrive infatti: «la mia fede in Dio si determina come fede in un Dio certamente personale, dato che, in quanto principio di tutte le cose, Dio è anche al principio della personalità che quindi non deve e non può essere esclusa dal suo essere» (p. 79). Per questo aspetto Mancuso riassume la sua posizione con le parole di Immanuel Kant: «Anche se vi vedrete costretti a desistere dal linguaggio del sapere, vi sarà sufficiente un linguaggio, che pur vi resta, di una salda fede, giustificato dalla più rigorosa ragione» (Critica della Ragion pura, (1781) citata a p. 108). Egli ricorda anche che lo stesso filosofo nella prefazione alla seconda edizione della sua famosa opera scriveva: «Ho dunque dovuto sospendere il sapere per far posto alla fede» (ib. (1787) citato a p. 114). Come si vede si tratta di un «linguaggio della salda fede»; esso si svolge però sorretto da una «rigorosa ragione» e segue le regole dell’argomentazione logica. L’esperienza di fede inizia e si sviluppa per dinamiche di testimonianza che precedono la ragione, anche se la coinvolgono nel suo sviluppo e nell’analisi del suo fondamento. L’esercizio della fede non nasce per conclusione di ragionamenti, ma la ragione entra in azione quando il credente cerca la motivazione delle sue scelte e intende spiegarne il fondamento. Si dovrebbe forse aggiungere che anche chi non vive la fede, può già partire dalla consapevolezza della propria tensione vitale e dall’esercizio del proprio amore per argomentare che il Tutto che l’avvolge e lo sostiene è un Tu che, conoscendolo e amandolo, può condurre là dove la vita tende come a compimento. Mi sembra che in fondo sia questa «la sfida che attende la teologia cristiana contemporanea» (p. 426). Solo alcuni dei molti stimoli preziosi che il libro del giovane teologo può offrire alla ricerca attuale di Dio. La sua diffusione può favorire tale ricerca da varie parti avvertita
in “Rocca” del 15 novembre 2011