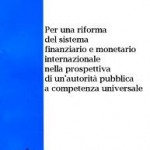Censis: a scuola meno abbandoni ma uno su quattro non si diploma
In Italia diminuiscono gli abbandoni scolastici, però è ancora lontano l’obiettivo europeo di giungere nel 2020 ad una media del 10% di ‘early school leavers’ cioè gli abbandoni prematuri della scuola. Non solo. Tra i giovani che si iscrivono alle superiori solo il 75% dei 19enni riesce a raggiungere il diploma. E’ quanto emerge dal 45° Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese del Censis.
Nel 2010 la quota di giovani 18-24enni in possesso della sola licenza media e non più inseriti in percorsi formativi è scesa dal 19,2% al 18,8%, con varia intensità in tutte le aree del Paese, ad eccezione del Centro che rimane però l’area dove tale indicatore è più contenuto (14,8%).
Restano però numerosi i punti critici e le discontinuità di intervento che rendono non lineari i risultati degli interventi di prevenzione e contrasto al fenomeno della dispersione scolastica. Sono soprattutto gli studenti delle isole maggiori a distinguersi per una profonda disaffezione ai percorsi scolastici e formativi. Ad esempio in Sicilia, dove gli ‘early school leavers’ sono più di un quarto dei 18-24enni residenti.
Inoltre, rileva il Rapporto, non sembra essere stato ancora adeguatamente affrontato il fenomeno laddove ha maggiore intensità, ovvero nel primo e, in misura minore, nel secondo anno delle superiori. Tra il 2006-2007 e il 2009-2010 la quota di abbandoni del percorso scolastico entro il biennio si è ampliata, passando dal 15,6% al 16,7%, in misura maggiore negli istituti professionali.
Ulteriore elemento di disomogeneità è rappresentato dalla maggiore o minore sinergia tra i soggetti istituzionali e non impegnati nel contrasto dei fenomeni di disagio giovanile.
E un altro fattore di complessità è rappresentato dal fatto che abbandoni e irregolarità sono sovente la conseguenza di un fenomeno pià ampio di disaffezione allo studio, determinato anche dalla carenza di prospettive di lavoro e da incerte traiettorie di vita futura.
Secondo il 54,4% dei dirigenti scolastici tra i propri allievi prevale la propensione a continuare negli studi, ma spesso senza un progetto di vita e di lavoro. Un ulteriore 45,1% osserva che i propri studenti non sembrano essere del tutto consapevoli delle reali difficoltà del mondo esterno alla scuola.
E’ semmai il disorientamento rispetto a un futuro incerto e precario, probabilmente aggravato dal perdurare della crisi economica, che nelle nuove generazioni può offuscare la riflessione rispetto al proprio percorso futuro.
–>
tuttoscuola.com
Censis: Italia ultima in Europa per l’occupazione dei laureati
Si interrompe la crescita dell’educazione degli adulti, l’istruzione tecnica non soddisfa le esigenze delle imprese

Il Rapporto Censis presentato oggi non si limita a dare una fotografia della scuola, ma esamina diffusamente tutto il mondo del lavoro, trattando di università, delle relazioni tra formazione e lavoro, e dell’educazione degli adulti.
Per quello che riguarda l’università, in Italia trova lavoro il 76,6%, dei laureati e il Belpaese si piazza all’ultimo posto tra i Paesi europei: la media Ue è dell’82,3%. Inoltre, difficilmente i giovani sono chiamati a coprire ruoli di responsabilità in tempi brevi, iniziando i percorsi professionali, nella maggioranza dei casi, al di sotto delle loro competenze: il 49,2% dei laureati 15-34enni e il 46,5% dei diplomati al primo impiego risultano sottoinquadrati. Sul fronte della mobilità transnazionale, poi, la partecipazione italiana necessita per il Censis di essere agevolata: il 12,1% dei giovani di età compresa tra 15 e 35 anni che dichiarano di aver soggiornato all’estero per istruzione e formazione è al di sotto della media europea (15,4%) di oltre 3 punti percentuali: valore ben lontano dal 27,8% e dal 23,6% di austriaci e svedesi.
Riguardo invece all’istruzione degli adulti, si è interrotto il trend di sia pur moderata crescita, attestandosi nel 2009 al 6% e risalendo debolmente l’anno successivo al 6,2, a fronte di una media europea del 9,1 nel 2010 e della soglia del 15% posta dalla strategia Europa 2020. L’istruzione degli adulti sembra essere relegata a un ruolo sempre più marginale: la relativa voce di spesa è diminuita di 72 punti percentuali passando dai 16 milioni di euro del 2009 ai 4,4 del 2011.
Un capitolo a parte merita merita l’ultima riforma del sistema scolastico italiano, che sembra aver dato nuovo slancio agli istituti tecnici che, supportati anche da un attivo interessamento da parte della rappresentanza imprenditoriale, registrano nel corrente anno scolastico un incremento dello 0,4% di iscrizioni al primo anno rispetto al 2010-2011 (dati riferiti alla sola scuola statale).
Il rinnovato appeal non si estende agli istituti professionali, che nello stesso periodo hanno perso ben il 3,4% di neoiscritti, a favore soprattutto dei percorsi liceali. Le annuali rilevazioni del Sistema informativo Excelsior sui fabbisogni professionali delle imprese italiane evidenziano, al contrario, come per le figure professionali assimilabili a quelle formate negli istituti professionali e/o nel circuito della formazione professionale di base ci sia una richiesta tutto sommato interessante e come nel 2011, rispetto al 2010, le richieste di personale con la sola qualifica professionale siano aumentate, passando dall’11,7% al 13,5%.
L’offerta di percorsi triennali di IeFp (Istruzione e Formazione professionale) non sembra riuscire a colmare questa lacuna, almeno in termini quantitativi. I giovani che si rivolgono a questo tipo di percorsi costituiscono solo il 6,7% del totale degli iscritti al secondo ciclo di istruzione, pari a circa 38.000 studenti. Mentre in Germania e in Austria il 95% dei giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni ritiene che i percorsi professionalizzanti possano costituire un’opzione interessante, in Italia tale posizione è espressa solo dal 50%, il valore più basso di tutta l’area.
–>
tuttoscuola.com













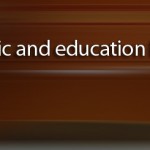


![VIRTU LOCANDINA OK[1].pdf](http://mail.google.com/mail/images/pdf.gif)