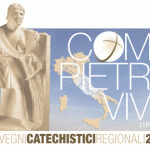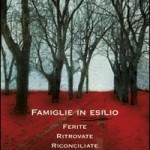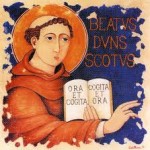Prima lettura: Esodo 20,1-17
|
In quei giorni, Dio pronunciò tutte queste parole: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile: Non avrai altri dèi di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano. Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà. Non ucciderai. Non commetterai adulterio. Non ruberai. Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo».
|
Il testo del Decalogo nel libro dell’Esodo è preceduto, al cap. 19, dalla grandiosa teofania in cui il Signore rivela la sua presenza sul Sinai, la «montagna sacra» (19,23). Soltanto Mosè, in rappresentanza del popolo raccoglie le «Dieci parole» che racchiudono la volontà del Signore e le riferirà agli Israeliti, che prometteranno di osservarle accettando l’alleanza (24.3). All’inizio del cap. 20 il Decalogo è introdotto bruscamente, senza collegamento diretto quanto precede. Improvvisamente, Dio parla: risalta cosi l’assoluta libertà dell’iniziativa divina.
Il Decalogo
Non deve stupire la difficoltà a individuare con sicurezza nel testo i dieci comandamenti come sono formulati nei catechismi. Già nella seconda stesura (nel Deuteronomio) il Decalogo presenta qualche differenza: è poi citato con notevole libertà nei Profeti, nei Salmi, in altri scritti dell’Antico Testamento, nei Vangeli. Basta questo a farci comprendere che la legge del Signore, benché scolpita sulle «tavole di pietra», non deriva da questo la sua solidità, e che non è il rispetto esteriore e formale della «lettera» che conta, ma l’accordo interiore del «cuore» alla parola di Dio.
Otto comandamenti su dieci hanno una forma negativa, e questa lista di divieti può urtare qualcuno. Ma tutto cambia se riflettiamo che dire «cosa non bisogna fare» ci lascia molto più liberi. Dio pone dei divieti certo; ma è vietato solo ciò che priva noi e gli altri della libertà; la violenza, l’assassinio, l’adulterio, il furto, la falsa testimonianza. Per il resto, Dio non obbliga; cosa bisogna fare, è lasciato alla nostra libertà. Dio non comanda nemmeno di essere adorato, non chiede sacrifici (cf. Is 1,12-13; Ger 7 22): lo stesso comandamento del sabato, più che imporre una pratica religiosa, comanda di non fare qualcosa, di astenersi dal lavoro.
Note esegetiche
vv. 2-3: In positivo, la prima parola del Decalogo — il 1° comandamento nella tradizione dell’Ebraismo – non è precisamente un comandamento, e impegna Dio piuttosto che l’uomo. Dio si presenta, offre le sue credenziali: non chiede di essere obbedito senza essere conosciuto. Per questo può dire «non avrai altri dèi»: non basta confessare che Dio è uno, la Bibbia non predica un monoteismo filosofico, astratto, «numerico». La Bibbia dice chi è Dio, raccontando quello che ha fatto per noi. È il Dio che libera anzi il Dio che ha liberato te, oggi: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto». Tutto il Decalogo discende da questa affermazione iniziale, come un torrente dalla montagna.
vv. 4-6: La formulazione del divieto dell’idolatria è in stretto collegamento con il racconto della creazione in Gn 1. Dio ha fatto cielo terra e mare e ciò che contengono; ha fatto l’uomo a sua immagine; ha dato all’uomo il compito di sottomettere la terra. Nell’idolatria, l’ordine è stravolto: l’uomo adora le creature (astri, animali…) invece di dominarle, sostituisce all’immagine creata da Dio immagini di idoli fatte con le sue mani. Invece di adorare Colui che lo ha fatto, l’uomo adora la cosa che ha fatto. Questo rovesciamento della verità – questa menzogna – è proibito, perché Dio è geloso: la gelosia dell’amore che ha scelto l’uomo e stabilito l’alleanza, amore sovrabbondante di grazia, mille volte più del castigo (v. 5b-6). Tutti i peccati previsti nel Decalogo hanno radice nell’idolatria.
v. 7: Invano (lašawe) indica il vuoto, la falsità, anche la magia. «Pronunciare invano il Nome» significa trattare Dio come un idolo: qualcosa di manipolabile, di cui l’uomo possa impadronirsi per strumentalizzarlo ai suoi fini. La stessa parola è usata nell’8° comandamento: la falsa testimonianza contro il fratello, immagine di Dio, è grave come il falso culto a Dio. Una pietà esteriormente corretta e ossequiente alle regole, cui non corrisponda la giustizia nei rapporti con gli altri, riduce a menzogna il Nome del Signore.
v. 8-11 : Il comandamento del sabato è la chiave di volta del Decalogo. Come il quarto, è formulato in positivo («ricordati»); come gli altri, è anche negativo («non farai alcun lavoro…»); come il primo, è motivato con la creazione (nel Deuteronomio invece, con il ricordo della schiavitù in Egitto). Non si interrompe il lavoro, banalmente, perché è bene riposarsi; ma piuttosto per imitare, quale immagine di Dio, il riposo del settimo giorno della creazione. Si tratta quindi della più alta realizzazione dell’essere uomo: il sabato è un comandamento che riguarda Dio (la «prima tavola»), ma è anche quello che con maggiore insistenza parla della comunità umana («né tu, né tuo figlio….»), e l’unico in cui esplicitamente sia citato lo straniero. Il sabato è la legge più specifica che caratterizza l’identità ebraica, e insieme la più universale, perché l’ebreo è chiamato a condividere la santità del sabato con tutta la creazione, senza distinzioni di sesso, di condizione sociale (lo schiavo), di appartenenza etnica o religiosa (lo straniero) e perfino umana (il bestiame). Anche qui c’è l’accenno all’idolatria: il potere di «fare», di costruire opere (idoli) con le proprie mani, rischia di precipitare l’uomo in un delirio di onnipotenza, se non interviene la pausa del sabato a ricondurre tutto al Creatore.
v. 12: Il quarto comandamento, come la «prima parola», rivolge l’uomo verso l’origine. Il «padre e la madre» sono l’anello di congiunzione fra l’uomo di oggi e ciò che lo ha preceduto, fino all’origine prima; attraverso padre e madre, nella tradizione ebraica e non solo, si trasmette la memoria dell’azione di Dio in favore del popolo, a partire dall’Esodo, e in favore dell’umanità, a partire dalla creazione. Perciò questo comandamento è l’unico che parli di un «premio», una conseguenza positiva per l’uomo: la vita, dono di Dio dalla creazione in poi, cui l’uomo e la donna partecipano nel generare il figlio. Adamo generò un figlio a sua immagine (Gn 5,3): il potere di generare, purificato dalla pretesa di onnipotenza possessiva e iscritto nell’onore (kavôd: la gloria, riservata a Dio) reso all’origine, si oppone al fare del lavoro, che deve essere interrotto nel giorno di sabato per non diventare costruzione di idoli.
vv. 13-16: Da qui, i comandamenti della «seconda tavola» che riguardano i rapporti umani. Non uccidere, esteso a ogni forma di violenza; non commettere adulterio, perché l’amore sponsale è figura del rapporto unico fra Dio e il popolo. Non dire falsa testimonianza, in parallelo con il v. 7.
v. 17: Il nono e il decimo comandamento sono nella tradizione ebraica uno solo: il Decalogo si conclude penetrando nel segreto del cuore, dove si nasconde il desiderio. Non è il desiderio in sé che è peccato, ma il desiderio contro giustizia: volere tutto, senza riconoscere alcun ostacolo, nemmeno nella sfera di ciò che attiene all’altro. Al fondo, è ancora la pretesa di sostituirsi a Dio, in una volontà di potenza accaparratrice che non lascia spazio all’amore, che non lascia vivere, che trascina inesorabilmente alla distruzione.
Seconda lettura: 1Corinzi 1,22-25
|
Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.
|
La prima lettera ai Corinzi si apre con la polemica fra l’Apostolo e gli avversari che hanno introdotto divisioni e contrasti all’interno della comunità. Paolo difende con passione sia l’unità del Vangelo di Cristo, sia la corrispondenza della sua predicazione con questo Vangelo. A propria difesa, Paolo non invoca la «sapienza del discorso», ma la fedeltà alla croce di Cristo, che non deve essere «resa vana» (v. 17). L’argomentare di Paolo procede con l’audace contrapposizione fra la «sapienza degli uomini» e la «stoltezza» della parola della croce (vv. 18-21). A questa antitesi fra la parola di Dio e la parola del mondo si collega il proclama di «Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani» (v. 23).
Note esegetiche
v. 22: «Giudei» e «Greci» (o «Gentili»: v. 23) rappresentavano al tempo di Paolo le due parti dell’umanità, contrapposte non tanto dal punto di vista religioso, quanto per il modo di porsi di fronte alla realtà. I Giudei, per credere, chiedono «segni» (semeia; miracoli, prodigi), prove storiche su cui poggiare la loro fede; i Greci cercano «sapienza» (sofia), per essere razionalmente convinti.
v. 23: Un’avversativa, «noi invece…», sottolinea l’assoluta novità della predicazione di Paolo: «Cristo crocifisso», e introduce il secondo binomio: scandalo/stoltezza. Alla «prova» chiesta dai Giudei si contrappone la «pietra d’inciampo» (skàndalon), alla razionalità dei Greci la «stoltezza della croce» (morì an).
v. 24: Il contrasto fra le due coppie di termini opposti è risolto nel cuore dell’annuncio, accolto dai «chiamati», sia Giudei che Greci: per loro la debolezza della croce mostra la potenza di Dio, e la stoltezza ne rivela la sapienza. La comprensione della fede consente di leggere la realtà con occhi nuovi e di riconoscere l’azione di Dio nella dedizione incondizionata di Colui che «amò i suoi fino alla fine» (Gv 13,1). Il Crocifisso è «il luogo dell’agire divino potentemente e sapientemente salvifico e tale appare agli occhi dei credenti» (G. BARBAGLIO, La Prima Lettera ai Corinzi, EDB 1996, p. 143).
v. 25: All’opposizione stoltezza/sapienza viene accostata qui quella debolezza/forza. Non si tratta di anteporre la sapienza di Dio a quella umana dichiarandone la superiorità, ma di una alternativa assoluta fra due contrari. Non si tratta nemmeno di paragonare semplicemente due punti di vista opposti, che provocano visioni fra loro incompatibili. La morte sulla croce rimane follia e il Cristo consegnato ai carnefici mostra la sua debolezza, liberamente scelta; ma sono la debolezza e la follia di chi soccombe alla violenza piuttosto che farsene complice, di chi vince l’odio con la sovrabbondanza dell’amore, di chi viene a guarire dall’interno il cuore malato dell’uomo. In questo, la debolezza si mostra più forte della forza, e la stoltezza più sapiente della sapienza.
Vangelo: Giovanni 2,13-25
|
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo.
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che
egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.
|
Esegesi
La «purificazione del tempio», che i Sinottici collocano poco prima della Passione, è narrata da Giovanni all’inizio del ministero pubblico. L’evangelista vuole così sottolineare subito sia la grande novità del messaggio di Gesù, sia la continuità ideale con la predicazione dei profeti d’Israele. L’episodio si inserisce chiaramente in un contesto pasquale, nella prima delle tre Pasque di Gesù a Gerusalemme ricordate da Giovanni.
Si distinguono due brevi scene, ciascuna seguita da un versetto di commento; a conclusione, un sommario storico aggiunge una riflessione sulla fede autentica.
vv. 13-16: La prima scena è la cacciata dei mercanti dal Tempio.
La notazione temporale e geografica è precisa: la Pasqua «dei Giudei», così differenziata dalla Pasqua cristiana, segnala una situazione di distacco tra la comunità cristiana e la sinagoga, già definitiva al tempo della stesura del Vangelo. Gesù è tuttavia un ebreo osservante, e da Cafarnao — posta sul lago sotto il livello del mare — «sale» a Gerusalemme, a 800 m. di altezza.
I pellegrini che provenivano da ogni parte, non solo dalla Giudea, dovevano procurarsi in loco gli animali da offrire in sacrificio e pagare la tassa di mezzo siclo al Tempio. Spesso però essi disponevano solo di denaro romano o di altri paesi, monete non ammesse al Tempio perché coniate con effigi pagane. Era quindi necessaria, per lo svolgimento delle pratiche religiose, la presenza nelle vicinanze del Tempio di cambiavalute e mercanti di bestiame. La parola qui usata (hieròn) indica il recinto sacro, esterno al Tempio vero e proprio e comprendente il cosiddetto «cortile dei pagani», dove era consentito l’ingresso anche ai non israeliti. Sembra quindi eccessiva la severità di Gesù, oltre che inconsueta rispetto al comportamento mite che la tradizione gli attribuisce.
Tuttavia nulla è casuale o fuori luogo nel Vangelo di Giovanni. Il gesto di Gesù è chiaramente simbolico, che non vuol dire romanzato o fantasioso, ma al contrario, l’atto spettacolare rinvia a significati profondi e ricchi di conseguenze per la vita della comunità. Gesù si inserisce nella tradizione profetica e ne riprende linguaggio e atteggiamenti; il suo scopo non è scardinare il culto israelitico, ma riportarlo alla purezza originaria, impedire che l’osservanza esteriore di pratiche abituali scada nella superstizione e nel formalismo.
Le sue parole sono una citazione quasi letterale di passi dell’Antico Testamento (cf. Zac 14,21; Sal 69,10; Ger 7,11). Alcuni commentatori notano una sottile intenzione sociale, nella linea del profeta Amos: mentre rovescia i banchi dei cambiavalute e caccia il bestiame grosso, Gesù si mostra più paziente verso i venditori di colombe, animali offerti in sacrificio dai poveri. Notare il possessivo: «la casa del Padre mio», indizio di un rapporto unico di figliolanza tra Gesù e il Padre.
v. 17: Il versetto è il commento posteriore dell’evangelista, il ricordo interpretante che a posteriori, alla luce della Pasqua e sulla falsariga della rilettura dell’Antico Testamento, spiega il senso dell’evento. Sono commenti tipici di Giovanni (cf. v. 22): anche nei Sinottici è sottolineata la comprensione post-pasquale dei gesti e delle parole di Gesù, che solo alla luce della risurrezione rivelano il loro pieno significato; qui c’è in più la riflessione cosciente, la consapevolezza che la distanza temporale dall’evento ha peso per l’ermeneutica e consente una comprensione progressiva della rivelazione.
Nella citazione del Sal 69,10 il verbo è cambiato dal presente «divora» al futuro «divorerà», per esplicitarne il valore di annuncio profetico della Passione.
vv. 18-21: I giudei rispondono, non tanto alle parole quanto ai gesti di Gesù. Presentati da Giovanni come gli avversari di Gesù, essi tuttavia hanno ben capito che il suo comportamento ricalca quello dei profeti, perciò gli chiedono un «segno» che ne attesti l’autorità. Gesù, come spesso avviene in Giovanni, risponde in forma enigmatica. Non rifiuta di dare il segno, ma invece di ricorrere a un prodigio come si aspettavano i giudei, propone loro una sfida che può essere letta su due livelli di senso, e che lascia quindi gli avversari davanti alla scelta tra la fede e l’incredulità. L’imperativo «distruggete» sta per un condizionale, come in molti oracoli profetici; Gesù gioca sul doppio senso tra il Tempio di pietre e il Tempio del suo corpo, e lascia intendere sia il nuovo Tempio dell’era messianica, sia la sua risurrezione. La parola usata nel v. 19 non è la stessa dei vv. 14-15; naòs è la costruzione al centro del Tempio, con il Santo dei Santi, il luogo in cui abita Dio.
I giudei si fermano al primo livello, quello immediato: manca loro la fede necessaria a operare il salto di senso, per giungere al secondo livello, la spiegazione dell’evangelista nel v. 21.
v. 22: Anche i discepoli però non capiscono tutto subito: Giovanni sottolinea che solo dopo hanno capito il compimento della Scrittura.
vv. 23-25: Il sommario storico distingue i diversi livelli della fede. Molti credettero vedendo i segni: è già un primo passo rispetto all’incredulità dei giudei, ma non è ancora la fede autentica. Per questo Gesù non si fida pienamente: sa che non tutti reggeranno alla prova della Passione e della morte e che non tutti sapranno leggere le Scritture. La sua venuta è anche per il giudizio, nel senso inteso qui: per svelare ciò che sta nel cuore degli uomini e porli davanti alla scelta fondamentale e sincera.
Meditazione
«Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme», nota l’evangelista Giovanni. Anche per noi si sta avvicinando la Pasqua e l’Eucaristia di questa terza domenica di Quaresima ci unisce nuovamente al gruppo degli discepoli che accompagnano Gesù. Nella settimana appena conclusa ci siamo forse distratti dal cammino del Signore perché presi da noi stessi e dagli impegni della vita. Come i discepoli di allora, anche noi spesso siamo concentrati più sulle nostre preoccupazioni che su quelle del Vangelo. L’egocentrismo ci spinge sempre lontano dal Signore e dai suoi fratelli. Ma le domeniche tornano. E tornano come le tappe del cammino: ci radunano assieme e ci immergono nell’itinerario che la Parola di Dio traccia per noi. Non siamo un popolo che cammina nelle tenebre. Il Signore non ci fa mancare la luce che illumina i nostri passi. La lettura dell’antica alleanza presenta le ‘dieci parole’, cioè, i Dieci Comandamenti. Sono le parole che costituiscono il fondamento della fede del popolo di Dio. Anche noi le abbiamo ascoltate sin dalla nostra infanzia, e fanno parte del ‘primo’ bagaglio religioso.
I Dieci Comandamenti, a guardarli con attenzione, non sono semplicemente una serie di alte e universali norme morali. Sono molto di più: in essi si esprime il contenuto fondamentale da cui dipendono tutta la legge e i profeti, ossia l’amore per il Signore e l’amore per il prossimo. Le prime ‘parole’ delineano il rapporto del popolo con il suo Dio: un rapporto d’amore esclusivo. Quando il Signore ordina: «Non avrai altri dèi di fronte a me», non propone una fredda definizione di tipo monoteistico, bensì una richiesta di amore totale. È vero che non sarà mai possibile per noi raggiungere la qualità dell’amore di Dio, ma siamo chiamati a partecipare ad esso. «Siate perfetti com’è perfetto il Padre vostro che sta nei cieli», dice Gesù. La proibizione di avere immagini risponde alla esclusività che Dio pretende dal suo popolo: il suo amore è troppo personale e intenso per ammettere altri ‘amori’. Lo stesso si può dire dei credenti che si fabbricano idoli cui sacrificare la propria vita. Solo il Signore è degno di lode e di fede. Il sabato — continua il testo biblico — è il giorno del riposo, o meglio, della festa con Dio e con i fratelli. Per noi, cristiani, il giorno di festa e del riposo è quello della risurrezione di Gesù. La domenica è dunque il giorno grande ed eterno: anticipa il paradiso, annunzia la gioia, è fonte di godimento, muove alla contemplazione.
Segue la seconda parte del Decalogo ove si elencano sette comandamenti che delineano il corretto modo di vivere i rapporti tra gli uomini. Anche qui non si tratta unicamente di norme morali, bensì di indicazioni tese a preservare l’immagine di Dio inscritta nel cuore degli uomini. Sono sette parole che descrivono i limiti estremi da non valicare. Perciò, questi ‘comandi’, prima di essere una legge che verrebbe sancita da un castigo, esprimono una esigenza d’amore, di un amore non parziale o fiacco, come può essere il nostro, ma di un amore esclusivo ed esigente, com’è quello di Dio: «Io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso», dice lo stesso Signore.
Il Vangelo presenta la scena della cacciata dei venditori dal tempio, che si potrebbe interpretare come una manifestazione di santa gelosia da parte di Gesù, il quale si rimette alla gelosia di Dio. Del resto dice il profeta: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà», cioè, sento dentro di me, come un dovere estremo, la difesa della dignità del Signore. Infatti, Gesù, appena vide il tempio invaso da venditori, nota l’evangelista Marco, fece una cordicella e cominciò a sferzarli e a rovesciare i loro banchetti. È un Gesù che non picchia nessuna persona ma, con una indignazione risoluta, non tollera che nessuno inquini la santità del tempio, la casa del Padre, lì dove Dio ha posto la sua dimora. Gesù sa bene che in un tempio ove si tollerano piccoli commerci di piccoli venditori, si arriva a comprare qualcosa così importante come è la vita di un uomo per soli trenta denari.
Ma qual è il mercato che scandalizza Gesù? Qual è la compra-vendita che Gesù non può sopportare? Senza dubbio la lettera di questa pagina evangelica interpella il nostro modo di gestire gli edifici di culto, affinché diventino davvero luoghi di preghiera e di incontro con Dio e non piuttosto luoghi sciatti e pieni di confusione. Bisogna imparare da questo Vangelo la responsabilità che hanno le nostre comunità perché non siano palestre per il proprio egocentrismo o per quant’altro che non riguardi lo «zelo per la casa del Signore». Tuttavia, c’è un altro mercato sul quale è importante porre la nostra attenzione: è quello che si svolge dentro i cuori. Ed è un mercato che scandalizza ancor più il Signore Gesù perché il cuore è il vero tempio che Dio vuole abitare. Tale mercato riguarda il modo di concepire e di condurre la vita. Quante volte la vita viene ridotta ad una lunga ed avara compra-vendita, senza più la gratuità dell’amore! Quante volte dobbiamo constatare, a partire da noi stessi, il rarefarsi della gratuità, della generosità, della benevolenza, della misericordia, del perdono, della grazia! La ferrea legge dell’interesse personale, o di gruppo, o di nazione, sembra presiedere inesorabilmente la vita degli uomini. Tutti, chi più chi meno, siamo impegnati a trafficare per noi stessi e per il nostro guadagno; e non badiamo se da tale pratica crescono le erbe velenose dell’arroganza, dell’insaziabilità e della voracità. Quel che conta e quel che vale è il proprio personale guadagno; a qualsiasi prezzo.
Gesù entra ancora una volta nella nostra vita, come entrò nel tempio, e manda all’aria le bancarelle dei nostri interessi meschini e riafferma il primato assoluto di Dio. È lo zelo che Gesù ha per ognuno di noi, per il nostro cuore, per la nostra vita perché si apra ad accogliere Dio. Il Vangelo è la «spada a doppio taglio» di cui parla la Lettera agli Ebrei, che penetra sin nelle midolla per separarci dal male. Purtroppo capita non di rado di metterci dalla parte di quei responsabili dei luoghi sacri come il tempio, i quali, al vedere un ‘laico’ qual era Gesù agire dentro l’area sacra, si scandalizzano e chiedono ragione di tale brusco e ‘irriverente’ intervento. «Quale segno ci mostri per fare queste cose?», chiedono a Gesù. È la sorda opposizione che ancora facciamo di fronte all’invadenza del Vangelo nella nostra vita. Il male e il peccato, l’orgoglio e l’egoismo, cercano tutti i modi per ostacolare la presenza dell’amore nella vita del mondo. Eppure è proprio nell’accogliere l’amore del Signore che noi troviamo la salvezza. E più che mai necessario lasciarci sferzare dal Vangelo per essere liberati dalla legge del mercato, ed entrare così nel tempio dell’amore che è Gesù stesso.
Preghiere e racconti
Breve apologo insegnato dal Vedanta
Una vecchia leggenda indù racconta che vi fu un tempo in cui tutti gli uomini erano dèi. Ma essi abusarono talmente della loro divinità che Brahma, il signore degli dèi, decise di togliere loro il potere divino e di nasconderlo in un posto dove sarebbe stato loro impossibile ritrovarlo. Il grande problema fu dunque di trovargli un nascondiglio.
Quando gli dèi minori furono convocati in Consiglio per risolvere il problema, gli proposero così: «Seppelliamo la divinità dell’uomo nella terra!»
Ma Brahma rispose: «No, non sarà sufficiente, perché l’uomo la scaverà e la troverà…».
Allora gli dèi replicarono: «In questo caso, gettiamo la divinità nel più profondo degli oceani!» Ma Brahma rispose di nuovo: «No! Perché presto o tardi l’uomo esplorerà le profondità di tutti gli oceani, ed è certo che un giorno la troverà e la riporterà in superficie…!».
E gli dèi minori conclusero: «Non sappiamo più dove nasconderla, perché non sembra esistere, sulla terra o nel mare, un posto in cui un giorno l’uomo non possa arrivare…».
Allora Brahma disse: «Ecco quello che faremmo della divinità dell’uomo: la nasconderemo nel più profondo di se stesso, perché è il solo posto in cui non penserà mai di cercare…».
Da allora, l’uomo ha fatto il giro della terra, ha esplorato, scalato, si è immerso e scavato… alla ricerca di qualcosa che si trova in lui…
Il segreto del nostro cuore
Siamo così tornati al mistero del nostro cuore, che è il centro della nostra vita e identità umana. È nel cuore che le nostre idee, intuizioni, emozioni e decisioni più profonde hanno la loro sorgente. Ma è anche nel cuore che spesso ci alieniamo di più da noi stessi. Sappiamo poco o nulla del nostro cuore. Giriamo alla larga, come se ne avessimo paura. Ciò che è più intimo ci spaventa di più. Proprio dove siamo più veramente noi stessi, siamo spesso estranei a noi stessi. È questo il lato doloroso del nostro ‘essere uomini’. Non riusciamo a conoscere i nostri centri nascosti, e ci capita perfino di vivere e morire senza sapere chi siamo in realtà. Se ci chiediamo perché pensiamo, sentiamo e agiamo in una data maniera, spesso non sappiamo rispondere, e dimostriamo così che siamo forestieri perfino in casa nostra.
Il mistero della vita spirituale è che Gesù vuole incontrarci nel segreto del nostro cuore, per farci conoscere il suo amore, liberarci dalle nostre paure e farci conoscere la nostra personalità più profonda. Nel segreto del nostro cuore, perciò, possiamo imparare non solo a conoscere Gesù ma anche, attraverso Gesù, a conoscere noi stessi. Se ci rifletti su un istante, vedrai un’interazione tra l’amore di Dio che ti si rivela e una crescita costante nella conoscenza che hai di te stesso. Ogni volta che lasci penetrare l’amore di Dio più profondamente nel tuo cuore, perdi un po’ della tua ansietà, e ogni volta impari a conoscerti meglio e brami di essere più conosciuto dal tuo Dio che ti ama.
(H.J.M. NOUWEN, Lettere a un giovane sulla vita spirituale, Brescia, Queriniana, 72008, 75).
Il nuovo tempio per l’incontro con Dio Gesù
«Il regno di Dio è dentro di voi» (Lc 17,21), dice il Signore. Volgiti a Dio con tutto il tuo cuore, lasciando questo misero mondo, e l’anima tua troverà pace. Impara a disprezzare ciò che sta fuori di te, dandoti a ciò che è interiore, e vedrai venire in te il regno di Dio. Esso è, appunto, «pace e letizia nello Spirito Santo» (Rm 14,17); e non e concesso ai malvagi.
Se gli avrai preparato, dentro di te, una degna dimora, Cristo verrà a te e ti offrirà il suo conforto. Infatti ogni lode e ogni onore, che gli si possa fare, viene dall’intimo (Sal 44,14); e qui sta il suo compiacimento.
Per chi ha spirito di interiorità è frequente la visita di Cristo; e, con essa, un dolce discorrere, una gradita consolazione, una grande pace e una familiarità straordinariamente bella. Via, anima fedele, prepara il tuo cuore a questo sposo, cosicché si degni di venire presso di te e di prendere dimora in te. Egli dice infatti: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e verremo a lui e abiteremo presso di lui» (Gv 14,23). Accogli, dunque Cristo e non far entrare in te nessun’altra cosa.
Se avrai Cristo, sarai ricco, sarai pienamente appagato. Sarà lui a provvedere vedere e ad agire fedelmente per te. Cristo «resta in eterno» (Gv 12,4) e sta fedelmente accanto a noi, sino alla fine.
(Imitazione di Cristo).
40 giorni nel deserto
Un uomo d’affari stressato e logorato dai troppi impegni si presentò ad un maestro di vita spirituale a chiedere un consiglio.
Gli disse il maestro: “Quando un pesce finisce al secco comincia a morire. Anche tu cominci a morire quando ti lasci prendere dalle cose del mondo. Il pesce può salvarsi se torna subito nell’acqua. Tu devi tornare nella solitudine”.
L’uomo d’affari si spaventò: “Devo lasciare tutti i miei affari e rifugiarmi in un convento?”
“No no, conserva i tuoi affari e rifugiati nel tuo cuore”.
Angeli smemorati
Un giorno Dio si rallegrava e si compiaceva più del solito nel vedere quello che aveva creato. Osservava l’universo con i mondi e le galassie, ed i venti stellari sfioravano la sua lunga barba bianca accompagnati da rumori provenienti da lontanissime costellazioni che finivano per rimbombare nelle sue orecchie. Le stelle nel firmamento brillavano dando significato all’infinito.
Mentre ammirava tutto ciò, uno stuolo di Angeli gli passò davanti agli occhi ed Egli istintivamente abbassò le palpebre, ma così facendo gli Angeli caddero rovinosamente. Poveri angioletti, poco tempo prima si trovavano a lodare il Creatore rincorrendosi tra le stelle ed ora si trovavano su di un pianeta a forma di grossa pera!
“Che luogo è questo?” chiesero gli Angeli a Dio.
“E’ la Terra.” Rispose il Creatore.
“Dacci una mano per risalire”, chiesero in coro le creature, “perché possiamo ritornare in cielo”.
Dopo una pausa di attesa (secondo i tempi divini!), Egli rispose:
“No! Quanto è accaduto non è avvenuto per puro caso. Da molti secoli odo il lamento dei miei figli e mai hanno permesso che rispondessi loro. Una volta andai di persona, ma non tutti mi ascoltarono. Forse ora ascolteranno voi, dopo quello che hanno passato e passano seguendo falsi dei.
Andate creature celesti, amate con il mio cuore, cantate inni di gioia, mischiatevi tra i popoli in ogni luogo della terra e quando avrete compiuto la missione, allora ritornerete e faremo una grande festa nel mio Regno”.
Da allora tutti gli Angeli, felici di quanto si apprestavano a compiere per il bene degli uomini, se ne vanno in giro a toccare i cuori della gente e gioiscono quando un anima trova l’Amore.
Ma la cosa più sorprendente era che, toccando i cuori, scoprirono che molti di essi erano … Angeli che urtando il capo nella caduta avevano perduto la memoria.
E la missione continua anche se ancora ci sono molti Angeli smemorati, che magari alla sera, seduti sul davanzale della propria casa, guardano il cielo stellato in attesa di un significato scritto nel loro cuore.
Se solo si guardassero “dentro”!
Il luogo della lotta: il cuore
La vita spirituale procede da un centro intimo, un organo centrale, una radice dell’essere umano che la Bibbia chiama “cuore”. Nell’antropologia biblica il cuore è la sede della vita psicologica e morale, dunque della vita interiore.
Luogo dell’intelligenza e della memoria, della volontà e del desiderio, dell’amore e del coraggio, come di molti altri sentimenti, il cuore è l’organo che meglio rappresenta la vita nella sua totalità: esso designa ciò che per noi è la “persona”, soprattutto la “coscienza” personale. Luogo intimo nell’uomo ma scrutato e discreto da Dio, esso è il luogo del sorgere della fede, dell’accoglienza della Parola di Dio e dei doni divini: lo Spirito santo (Galati 4,6), l’amore di Dio (Romani 5,5), la pace di Cristo la pace di Cristo (Colossesi 3,15). Il Cristo stesso abita per la fede nel cuore dell’uomo (Efesini 3,17) e dal cuore sale a Dio la risposta umana in forma di amore, preghiera, invocazione (Galati 4,6; Efesini 5,19; Colossesi 3,16; Marco 12,30). Luogo dell’incontro fra Dio e uomo, il cuore è anche, secondo la Bibbia, la sede di cupidigie e di passioni: «Dal di dentro, cioè dal cuore degli uomini escono le intenzioni cattive» (Marco 7,21-23): così il cuore diviene il luogo della lotta spirituale, del combattimento interiore dove si scontrano le tendenze di peccato e l’azione della grazia di Dio. Il cuore può indurirsi nel rifiuto di ascoltare e accogliere la Parola di Dio (Matteo 13,15; Atti 28,27), può chiudersi alla compassione (Marco 3,5), può essere incapace di comprendere e di discernere (Marco 6,52; 8,17-21), può essere doppio, cioè insincero, menzognero (Atti 8,21; Giacomo 1,8; 4,8), nutrire odio e rancore (Levitico 19,17), gelosia e invidia (Giacomo 3,14). Prima di essere consumato esteriormente, nei gesti e nelle azioni, il peccato viene consumato nel cuore (cfr. Matteo 5,28). Si tratta allora, di far spazio allo Spirito santo perché Dio possa unificare (Salmo 86,11; Geremia 32,39), purificare (Salmo 51,12), circoncidere (Deuteronomio 10,16; 30,6), rinnovare (Ezechiele 36,26-27), ricreare (Salmo 51,12) il cuore dell’uomo. Ecco dunque il cuore come luogo della lotta invisibile, luogo dove può avvenire la decisione del ritorno a Dio e l’accoglienza della grazia che rende possibile tale ritorno, e dove avviene anche la scelta a favore della vita e la rottura con il peccato.
(Luciano MANICARDI, La lotta spirituale, in CENTRO REGIONALE VOCAZIONI (PIEMONTE-VALLE D’AOSTA), Corso di avvio all’accompagnamento spirituale. Atti, a cura di Gian Paolo Cassano, Casale Monferrato, Portalupi, 2007, 142-143).
Un cuore chiuso
Ti aspettavo, Signore,
ma non sei venuto.
L’attesa è stata lunga,
e solo tardi ho capito
che non eri entrato
perché il cuore non ti aspettava.
Avevi bussato alla porta:
«Alzati, amica mia,
mia bella e vieni!
Perché l’inverno è passato,
è cessata la pioggia,
i fiori sono apparsi nei campi,
la stagione del canto è tornata
e si sente cantare la tortora.
Aprimi!».
Ma il cuore era chiuso,
appiattito su orizzonti terreni.
Ma quando sei finalmente entrato,
vincendo la mia sordità,
ho capito, Signore,
che il cuore si popola di idoli
quando tu scompari,
e che tu abiti, soltanto,
dove ti si lascia entrare.
Se preghi per te soltanto,
preghi per il tuo interesse.
S. Ambrogio
(Vittorio PERI, Pregare è dire sì, Elle Di Ci-Velar, 2005).
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2002-2003; 2005-2006.
– Comunità di S. Egidio, La Parola e la storia. Tempo di Quaresima e Pasqua, Milano, Vita e Pensiero, 2012.
– Comunità monastica Ss. Trinità di Dumenza, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
– J.M. NOUWEN, Un ricordo che guida, in ID., Mostrami il cammino. Meditazioni per il tempo di Quaresima, Brescia, Queriniana, 2003.
QUARESIMA III QUARESIMA ANNO B