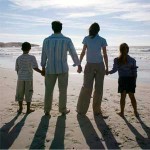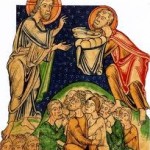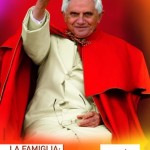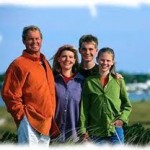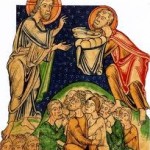
Prima lettura: Esodo 24,3-8
|
In quei giorni, Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo!». Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con dodici stele per le dodici tribù d’Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione, per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l’altra metà sull’altare. Quindi prese il libro dell’alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto». Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole!».
|
Il capitolo 24 del libro dell’Esodo narra la conclusione dell’alleanza stipulata tra il Signore Dio e Israele con la mediazione di Mosè. Questi, infatti, era stato più volte convocato da Dio sul monte per ricevere le “parole”, riferirle poi al popolo e ritornare da Dio per portare la risposta affermativa del popolo. Anche questa volta troviamo Mosè che «andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo!» (24,3).
Ricevuto l’assenso da parte del popolo, Mosè diede inizio a un rito: prima costruì un altare con dodici stele, una per ogni tribù d’Israele (cf. 24,4), poi fece offrire da alcuni giovani olocausti e sacrifici di comunione in onore del Signore (cf. 24,5). Infine, completò il rito così: «Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l’altra metà sull’altare. Quindi prese il libro dell’alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto». Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole!» (24,6-8).
Attraverso questo rito Mosè vuole quindi esprimere una profonda realtà: egli è situato tra i due contraenti: il primo è Dio, che viene rappresentato dall’altare; il secondo è il popolo, al quale viene di nuovo letto l’intero libro dell’alleanza affinché, in modo consapevole, possa pronunciare il suo sì.
Che cosa può unire i due contraenti, per suggellare solennemente il patto? Mosè sceglie allora il segno del sangue, il quale, versato per metà sull’altare e per l’altra metà sul popolo, stabilisce tra i due una ”comunione”. Non è difficile, nelle parole del versetto 8, riconoscere l’analogia con il sangue di un’altra vittima, ben più importante di quegli animali sacrificati. Infatti, Gesù Cristo, sull’altare della croce, versa il proprio sangue con cui viene aspersa l’umanità per ritrovare, finalmente la pace e la riconciliazione con il Padre (cf. Col 1,19-20). Il sangue, tra l’altro indica anche un rapporto di “parentela”, che ci viene guadagnato da Gesù Cristo. In virtù di questo sangue, allora, non siamo «più stranieri né ospiti, ma siamo concittadini dei santi e familiari di Dio» (Ef 2,19), addirittura figli di adozione di un Padre eccezionale, che per farci entrare nella sua famiglia non ha esitato di mandare sulla croce il suo Figlio Unigenito.
Seconda lettura: Ebrei 9,11-15
|
Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d’uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo – il quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio – purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente? Per questo egli è mediatore di un’alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l’eredità eterna che era stata promessa.
|
Su questa linea si trova anche lo stupendo brano della Lettera agli Ebrei. L’autore, in poche battute, evidenzia i due grandi mezzi con i quali Cristo entra nel santuario. Egli, venuto in mezzo all’umanità in qualità di sommo sacerdote dei beni futuri per il fatto che ci ha ottenuto la redenzione eterna, entrò nel santuario «attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d’uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue» (9,11-12).
Ma occorre chiarire bene a che cosa si riferisca l’autore con i termini ‘tenda” e “santuario”. Infatti, la tenda, più grande e perfetta, non può essere paragonata con la tenda che Mosè eresse nel deserto per custodire l’arca dell’alleanza, perché designa un’altra realtà, che era ben nota ai primi cristiani. Inoltre essa va intesa in rapporto all’altro mezzo ossia al sangue, e alle ulteriori qualificazioni, su cui bisogna fare delle precisazioni: quando si dice che la tenda è «non costruita da mano di uomo» ci si collega con Mc 14,58, dove i falsi testimoni, durante il processo, accusarono Gesù dicendo: «Noi lo abbiamo udito mentre diceva: Io distruggerò questo tempio fatto da mani d’uomo e in tre giorni ne edificherò un altro non fatto da mani d’uomo». Benché tale affermazione si trovi in una deposizione di falsi testimoni, il suo tenore orienta chiaramente a capire che non è questo che l’evangelista considera falso, poiché un confronto con Gv 2,19 conferma che Gesù ha realmente affermato tale “profezia”. La tenda è, quindi, il corpo glorioso di Cristo, nuova creazione realizzata in tre giorni per mezzo dell’effusione del suo sangue.
La tenda, che è il corpo glorioso di Cristo, consente all’umanità aspersa dal sangue di lui, di entrare in contatto, o meglio in comunione, con il santuario, ossia con la santità e la trascendenza di Dio Padre. Cristo ha, in altre parole, portato a compimento ciò che nell’Antico Testamento era desiderato ma impossibile da realizzare. D’altronde, se Dio si accontentava di considerare efficaci i sacrifici animali, come non doveva reputare “definitivo” quello di suo Figlio? «Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo – il quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio – purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente?» (9,13-14).
In forza di tutto questo, Cristo può ben essere considerato «mediatore di una nuova alleanza, perché, essendo ormai intervenuta la sua morte per la redenzione delle colpe commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l’eredità eterna che è stata promessa» (9,15).
Vangelo: Marco 14,12-16.22-26
|
Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?».
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio».
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.
|
Esegesi
Il brano evangelico proposto in quest’anno liturgico ci riconduce immediatamente al contesto insieme semplice e solenne della Pasqua. Così infatti inizia Marco: «Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?» (14,12). La Pasqua rappresentava la festa più importante dell’anno liturgico ebraico: con essa il popolo d’Israele si ricollega ancora oggi all’evento salvifico vissuto con Mosè e ricorda la liberazione dalla schiavitù in Egitto, emblema di liberazione da ogni qualsivoglia forma di schiavitù e dipendenza, sia materiale che spirituale. Fondamentale risulta il patto che viene stipulato: Dio consegna la Legge e s’impegna a essere il Dio d’Israele, svolgendo anche la funzione di padre, di soccorritore, di giudice e medico, di ispiratore e difensore. Da parte sua, Israele promette fedeltà, cioè di eseguire tutto ciò che il Signore comanda. Tale alleanza viene suggellata attraverso il sangue di animali quali vittime offerte in sacrificio, come poi vedremo nella prima lettura.
Alla festa di Pasqua ne fu associata un’altra, pur importante, tanto da divenire un tutt’uno, ossia la festa degli Azzimi. Quest’ultima era connessa all’usanza primaverile agricola di iniziare l’anno nuovo con il primo raccolto dell’orzo. Perciò tale inizio veniva espresso con l’eliminazione del vecchio lievito (durante la settimana degli azzimi gli alimenti fatti con il lievito vecchio devono sparire, perché si mangia pane non lievitato in attesa del lievito nuovo alla fine della festa). Il tutto confluisce nella cena pasquale, quando si mangia il pane azzimo, unitamente all’agnello, maschio, senza difetto e nato nell’anno (cf. Es 12,5), secondo l’usanza dei pastori per la loro festa di primavera. Con questi cibi, che indicano il rinnovarsi della vita nella tradizione pastorale e in quella agricola, Israele rammenta che la propria origine è legata all’azione salvifica e liberatrice di Dio.
Il momento in cui i discepoli pongono a Gesù la domanda circa la preparazione della cena pasquale è quello dell’inizio della settimana degli Azzimi, il giorno in cui i sacerdoti, nel tempio, di pomeriggio, immolavano gli agnelli che sarebbero poi stati consumati a Pasqua. Marco, però, mostra che Gesù aveva già pensato al luogo della cena e, addirittura, indica ai discepoli pure a chi devono rivolgersi appena entrati in città: «Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua» (14,13-16). La pericope letta non comprende i versetti che ci presentano lo smascheramento di Giuda (vv. 17-21), per cui si passa subito al racconto dell’istituzione.
Non è certo facile commentare in poco spazio il racconto dell’istituzione dell’eucaristia, perciò è preferibile soffermarsi sul senso del sangue in rapporto all’alleanza, argomento poi da completare con la trattazione delle altre letture bibliche.
Che cosa sia il sangue per l’uomo biblico viene chiarito da Lv 17,11.14: «Poiché la vita della carne è nel sangue. Perciò vi ho concesso di porlo sull’altare in espiazione per le vostre vite; perché il sangue espia, in quanto è la vita […]; perché la vita di ogni essere vivente è il suo sangue, in quanto sua vita; perciò ho ordinato agli Israeliti: Non mangerete sangue di alcuna specie di essere vivente, perché il sangue è la vita d’ogni carne; chiunque ne mangerà sarà eliminato». Esso è dunque un elemento vitale, necessario all’uomo per la sua vita biologica della quale, in qualche modo, segna anche il limite, la peribilità. Difatti, quando tra i giudei si voleva alludere alla fragilità della condizione umana, si usava spesso la formula basar wadam (carne e sangue), come Gesù stesso fece in Mt 16,17. Ma il sangue è anche elemento di trasmissione di vita da un essere a un altro. Se il sangue è legato inscindibilmente alla vita e alla sua trasmissione, l’espressione “versare il sangue”, invece, ha il significato di “uccidere”.
Tenendo presente tutto ciò, noi ci orientiamo alla contemplazione di Gesù crocifisso, che non ha rifiutato di “versare il sangue”, ossia di venire ucciso per noi, perché egli sapeva bene che dal suo sangue sparso scaturisce l’espiazione e la vita per chi confida in Lui: «E disse loro: Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti » (14,24). Egli, dunque, è libero e sovrano nel suo donarsi a nostro favore, non solo attraverso una morte violenta, che manifesta tutto il livore dei suoi avversari, bensì anche con l’atto di imbandire una mensa con il pane-corpo e il vino-sangue, a sostegno della nostra cronica debolezza. È il banchetto eucaristico, il quale, mentre ci fa ricordare la tragica morte del Giusto per eccellenza, ci restituisce la gioia di “proclamare” la sua risurrezione, per cui egli è presente e vivo in mezzo a noi, sostenendo con fedeltà, il peso dell’alleanza.
Meditazione
Sullo sfondo dell’ultima cena di Gesù si stende idealmente la grande scena dell’alleanza al Sinai. Nella cornice aspra e solitaria di quel monte del dialogo tra Dio e Israele si compie un rito, solennemente descritto dal capitolo 24 dell’Esodo. Il sangue è il simbolo della vita, l’altare è il segno della presenza di Dio, il popolo è tutto attorno all’altare come un’unica comunità spirituale. Il sangue sacrificale è versato da Mosè sull’altare e sul popolo, quindi su Dio e sull’uomo. Un patto di sangue lega ormai il Signore e Israele in una relazione di intimità e di amore. È proprio a quelle parole che Gesù rimanda nell’ultima sera della sua vita terrena, quando nella «grande sala con i tappeti» del Cenacolo celebra la cena pasquale coi suoi discepoli.
Il rito pasquale giudaico entrava nel vivo con la benedizione del pane nuovo azzimo, cioè senza lievito (Esodo 12-13). «Sii lodato tu, Signore, Dio nostro, re del mondo, che hai fatto nascere pane dalla terra»; così si esprimeva l’antica benedizione del pane. A quel punto il capofamiglia spezzava la focaccia azzima e la offriva ai commensali in segno di comunione e di benedizione. Gesù, pur seguendo il rituale, ne offre all’improvviso un significato sorprendente e inedito. Decisive, infatti, sono le parole della sua “benedizione del pane”: «Prendete, questo è il mio corpo», che nel linguaggio semitico significano semplicemente e paradossalmente: «Questo sono io stesso». Spezzando quel pane e offrendolo ai commensali Cristo stabiliva con loro un legame di comunione profonda, facendo sì che essi entrassero nella sua stessa vita, nella sua morte e nella sua gloria.
Nel rito giudaico, alla consumazione del pane azzimo e dell’agnello pasquale seguiva la benedizione solenne del calice, che spesso veniva anche inghirlandato. Anche a questo punto Gesù imprime al rituale una svolta con le parole del suo “ringraziamento” (in greco il termine è “eucaristia”): «Questo è il mio sangue, il sangue dell’alleanza, versato per molti». È qui che riecheggiano le parole di Mosè al Sinai: il vino della Pasqua è ora il sangue di Cristo e il sangue di Cristo crea l’alleanza piena e perfetta tra Dio e l’uomo. È un «sangue versato per molti», espressione orientale per indicare che è il sangue di una persona sacrificata per salvare tutti gli uomini.
Gesù indirizza infine ai suoi discepoli un ultimo messaggio che si affaccia sul suo futuro: egli annunzia che, dopo la cena eucaristica e la pausa buia della morte, berrà il calice del vino nuovo nel regno di Dio. È il banchetto della perfezione celeste cantato da Isaia, durante il quale si «eliminerà la morte per sempre e il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto» (25,8; vedi Apocalisse 21,4). La cena eucaristica che noi oggi celebriamo nella solennità del Corpo e del Sangue del Signore è, quindi, una pregustazione di un’intimità senza incrinature e senza frontiere con Dio. È per questo che l’eucaristia domenicale è celebrata sempre «nell’attesa della venuta» gloriosa del Cristo. L’eucaristia è espressione della presente vicinanza di Dio al suo popolo, che pellegrina in mezzo alle oscurità della storia, ma è anche squarcio di luce verso la speranza che il dolore e la morte saranno espulsi dalla storia. Quando celebriamo l’eucaristia dovremmo scoprire un bagliore del senso ultimo della vita nostra e dell’umanità, anche se attorno – come in quella sera – calano le tenebre della morte, si consuma il tradimento.
Preghiere e racconti
«Amen»
Celebrando l’eucaristia, la comunità ecclesiale partecipa al gesto di autoconsegna e di compassione di Gesù, lo rivive in sé e accetta di lasciarsi plasmare da esso, impegnandosi a trasformare i rapporti tra gli uomini in rapporti di consegna e di compassione.
L’eucaristia porta in sé la forza di cambiare in ciò che essa è coloro che la celebrano e mangiano di quell’unico pane e bevono di quel calice. Una prospettiva che trova il suo fondamento nell’atto stesso di istituzione dell’eucaristia ed appare tipica della patristica e della grande tradizione teologica. Basta ricordare, per tutti, uno straordinario testo di Agostino rivolto ai battezzati che, per la prima volta, si accostavano alla mensa eucaristica: alla mensa eucaristica:
«Se voi siete il corpo e le membra di Cristo, il vostro mistero è deposto sulla tavola del Signore: voi ricevete il vostro proprio mistero!
Voi rispondete “Amen” a ciò che voi siete, e con la vostra risposta sottoscrivete. Sentite dire: “Corpus Christi, il Corpo di Cristo” e rispondete: “Amen”! Siate dunque membra del corpo di Cristo, affinché il vostro “Amen” sia vero».
(S. AGOSTINO, Sermo 272, in PL 38, 1247).
Il nascondimento di Dio nell’eucaristia
Anche in questa lettera voglio tornare per un istante sul tema dell’eucaristia, perché l’eucaristia può definirsi a buon diritto il sacramento in cui Dio si nasconde. Che c’è di più comune di un po’ di pane e di un bicchiere di vino? Che c’è di più semplice delle parole: «Prendete e mangiate, prendete e bevete: questo è il mio corpo e sangue. Fate questo in memoria di me»?.
Mi sono trovato spesso con degli amici intorno a una piccola tavola, ho preso del pane e del vino e ho ripetuto le parole dette da Gesù quando si congedò dai suoi discepoli. Niente di speciale o di spettacolare, nessuna grande folla, nessun canto straordinario, nessuna formalità. Solo alcune persone che mangiano un pezzo di pane che non basta a sfamarli e bevono un sorso di vino che non basta a dissetarli. Eppure… in questo nascondimento è presente Gesù risorto e si rivela l’amore di Dio. Come Dio si fece uomo per noi nel nascondimento, così pure nel nascondimento egli si fa per noi cibo e bevanda. Tanta gente passa vicino all’eucaristia senza curarsene, eppure l’eucaristia è il più grande avvenimento che possa accadere tra noi uomini.
Durante il mio soggiorno all’‘Arca’, in Francia, ho scoperto la stretta relazione tra il nascondimento di Dio nell’eucaristia e il suo nascondimento nel popolo di Dio. Mi ricordo che una volta madre Teresa mi disse che non si può vedere Dio nei poveri, se non lo si vede nell’eucaristia. Quelle parole mi sembrarono allora un po’ esagerate; ma ora che ho passato un anno intero con gli handicappati comincio a capirne meglio il significato. Non è realmente possibile vedere Dio negli esseri umani, se non lo si vede nella realtà nascosta del pane che scende dal cielo. Fra gli esseri umani puoi vedere tipi di ogni specie: angeli e demoni, santi e bruti, anime caritatevoli e malevoli maniaci del potere. Tuttavia, è solo quando hai imparato per esperienza personale quanto Gesù si curi di te e quanto egli desideri essere il tuo cibo quotidiano, è solo allora che impari anche a vedere ogni cuore come dimora di Gesù. Quando il tuo cuore è toccato dalla presenza di Gesù nell’eucaristia, ricevi occhi nuovi, capaci di conoscere la stessa presenza nel cuore degli altri. I cuori si parlano fra loro. Il Gesù che è nel nostro cuore parla al Gesù che è nel cuore dei nostri fratelli e delle sorelle. È questo il mistero eucaristico di cui noi facciamo parte. Noi vogliamo vedere dei risultati e se possibile – vogliamo vederli subito. Ma Dio opera in segreto e con pazienza divina. Partecipando all’eucaristia riuscirai un po’ alla volta a comprendere questa verità. E allora il tuo cuore potrà cominciare ad aprirsi al Dio che soffre in chi ti sta intorno.
(H.J.M. NOUWEN, Lettere a un giovane sulla vita spirituale, Brescia, Queriniana, 72008, 78).
Parola ed eucaristia
L’eucaristia, con tutta la realtà sacramentale che da essa promana, è memoria della Pasqua di Gesù, non nel senso psicologico del ricordo, sulla misura e secondo le leggi della memoria umana, bensì nella luce della potenza dell’amore divino manifestato nella Pasqua. In Gesù morto e risorto Dio proclama e attua la sua amorosa volontà di vicinanza all’uomo, di presenza nella storia, di perdono del peccato, di vittoria sulla morte, di inizio di una vita nuova. L’eucaristia è la concreta modalità storica con cui l’amore onnipotente di Dio, culminante nella Pasqua di Gesù, raggiunge il suo intento di rendersi realmente presente e operante in ogni momento della storia umana.
L’eucaristia è presenza viva e reale di Gesù, del suo mistero, del suo sacrificio, della sua Pasqua. Tutta la vicenda di Gesù, dall’incarnazione del Figlio preesistente alla dolorosa umiliazione del Crocifisso, alla glorificazione del Cristo risuscitato e datore dello Spirito, si ripropone a noi nell’eucaristia, in forza dell’interiore efficacia del sacrificio pasquale.
(Carlo Maria MARTINI, Incontro al Signore risorto, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2009, 142-143).
Diventare segni di Cristo amore
Lo Spirito di Cristo che ha parlato per mezzo dei profeti, e che nel Cristo morto e risorto ha ridato al mondo la speranza dell’amore, è presente e operante nella Chiesa, che non cessa di ripresentare all’uomo d’oggi l’istanza suprema della verità e della carità [ … ].
La Chiesa, infatti, ha la missione, umile e ardente, povera e fiduciosa insieme, di riconciliare con l’amore la società e di restituire l’unità al mondo.
Noi Chiesa, come comunione d’amore, come luogo della perfetta amicizia, siamo chiamati, partendo dalla nostra povertà, fragilità, dal nostro peccato, a essere principio da cui procede la vita autentica del singolo; siamo chiamati come Chiesa – perché Gesù ci ama – a essere il noi del mondo riconciliato che ha come legge suprema, e in un certo senso unica, la carità, cioè l’amore gratuito e autentico.
Questa Chiesa, di cui siamo grati di essere membra e servitori, ci presenta Gesù, esempio e fonte di carità perfetta principalmente nell’eucaristia. È Gesù nell’atto di dare la vita per te che ti viene proposto nel mistero della Cena.
O Gesù, Cristo amore,
manifesta la tua presenza in mezzo a noi!
Fa’ che ci accostiamo alla tua cena
non come Giuda, che pensa ai suoi trenta denari:
ma come Pietro che ti dice: Signore, purificami interamente!
Lavami piedi, testa e tutte le membra,
purifica ogni mio amore sbagliato,
rendimi capace di amore vero.
Fammi, o Signore, segno di unità
nella tua Chiesa;
fammi strumento della tua pace nel mondo!
(Carlo Maria MARTINI, Incontro al Signore risorto, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2009, 156-157).
Il mistero del corpo e del sangue
Concluse le antiche feste della Pasqua che si celebravano per ricordare l’antica liberazione dalla schiavitù d’Egitto del popolo di Dio, Cristo è passato alla nuova Pasqua e ha voluto che la chiesa la celebrasse in memoria della sua redenzione. Al posto della carne e del sangue dell’agnello sostituì il mistero del suo corpo e del suo sangue. […] Egli stesso spezza il pane che porge ai discepoli per dimostrare che il suo corpo sarà in futuro spezzato non contro la sua volontà, ma, come dice altrove, egli ha il potere di offrire la sua vita da se stesso e di riprenderla di nuovo (cfr. Gv 10,18). E prima di spezzare il pane, lo benedice con la grazia sicura del sacramento perché insieme con il Padre e lo Spirito santo ricolma di grazia divina la natura umana che ha assunto per sottostare alla passione. Benedisse dunque il pane e lo spezzò perché volle sottomettersi alla morte in modo da dimostrare che in lui era veramente la potenza della divina immortalità e insegnare così che il suo corpo ben presto sarebbe risorto dalla morte. «E preso un calice, rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero» (Mc 14,23). Nell’imminenza della passione rese grazie dopo aver preso il pane. […] E lui che non meritò affatto di soffrire, umilmente nella sofferenza benedisse per mostrare come deve comportarsi chiunque non soffre per propria colpa. Infatti, nel momento stesso in cui per compiere ogni giustizia si addossa il peso della nostra colpa, rende ugualmente grazie al Padre proprio per mostrare in che modo dobbiamo sottometterci alla correzione. «E disse loro: Questo è il mio sangue della nuova alleanza, versato per molti» (Mc 14,24). Poiché il pane rinvigorisce il corpo, mentre il vino agisce sul sangue, misticamente il primo si riferisce al corpo di Cristo e il secondo al suo sangue. Ma poiché è necessario che noi restiamo in Cristo e Cristo in noi, il vino del Signore si mischia nei calici con l’acqua, dato che Giovanni testimonia: «Le acque sono i popoli» (Ap 17,15). A nessuno è consentito di fare offerta di sola acqua o solo vino, come neppure di grano che non sia stato impastato con l’acqua per fame pane. E questo perché non si pensi che il corpo debba essere separato dalle membra, o che Cristo abbia sopportato la passione non per amore della nostra redenzione, o che noi possiamo essere salvati e offerti al Padre senza la passione di Cristo.
(BEDA IL VENERABILE, Commento al vangelo di Marco 4, COL 120, pp. 611-612).
La singolarità dell’eucaristia
«Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro» (Gv 21, 18). Questa comunione di mensa tra Gesù e i suoi, anche se non è un’eucaristia propriamente detta, riprende il vocabolario eucaristico del Nuovo Testamento e ci invita a riflettere sulla cena e sull’eucaristia.
L’eucaristia, così come è accolta nella fede della Chiesa, presenta un aspetto sorprendente, che sconvolge l’intelligenza e commuove il cuore. Siamo di fronte a uno di quei gesti abissali dell’amore di Dio, davanti ai quali l’unico atteggiamento possibile all’uomo è una resa adorante piena di sconfinata gratitudine.
L’eucaristia non è solo la modalità voluta da Gesù per rendere perennemente presente l’efficacia salvifica della Pasqua.
In essa non è presente soltanto la volontà di Gesù che istituisce un gesto di salvezza; in essa è presente semplicemente (ma quali misteri in questa semplicità!) Gesù stesso.
Nell’eucaristia Gesù dona a noi se stesso. Solo lui può lasciare in dono a noi se stesso, perché solo lui è una cosa sola con l’amore infinito di Dio, che può fare ogni cosa.
Certo, occorre badare anche agli strumenti umani, di cui Gesù si serve. Poiché la Pasqua rivela e insieme celebra l’amore di Dio che attrae l’uomo a sé, troviamo plausibile che Gesù nell’ultima cena abbia valorizzato la tensione alla comunione con Dio espressa nel gesto del mangiare insieme e soprattutto abbia fatto riferimento al valore commemorativo dell’alleanza, che era proprio della liturgia pasquale veterotestamentaria. È quindi normale e doveroso che la Chiesa, nel configurare concretamente la liturgia eucaristica, abbia assunto nel passato e debba assumere e aggiornare continuamente le espressioni celebrative provenienti dalla nativa spiritualità umana e dalla liturgia veterotestamentaria.
Ma tutto questo è percorso e oltrepassato da una novità assoluta: è tale la forza di camminare manifestata e attuata nel sacrificio della croce, che essa rende presente nell’eucaristia il Cristo stesso nell’atto di donarsi al Padre e agli uomini per restare sempre con loro.
Gesù, che già in molti modi attrae a sé la Chiesa con la forza del suo Spirito e della sua Parola, suscita nella Chiesa la volontà di obbedire al suo comando: «Fate questo in memoria di me» (Lc 22,19).
E quando la Chiesa, nell’umiltà e nella semplicità della sua fede, obbedisce a questo comando, Gesù, con la potenza del suo Spirito e della sua Parola, porta l’attrazione della Chiesa a sé al livello di una comunione così intensa, da diventare vera e reale presenza di lui stesso alla Chiesa: il pane e il vino diventano realmente, per quella misteriosa trasformazione che è chiamata transustanziazione, il corpo dato e il sangue versato sulla croce; nei segni conviviali del mangiare, bere, festeggiare si attua la reale comunione dei credenti col Signore; le funzioni sacerdotali si svolgono non per designazione o delega umana, ma per una reale assunzione dei ministri umani nel sacerdozio di Cristo, secondo le modalità stabilite da Cristo stesso.
L’eucaristia si presenta così come la maniera sacramentale con cui il sacrificio pasquale di Gesù si rende perennemente presente nella storia, dischiudendo a ogni uomo l’accesso alla viva e reale presenza del Signore.
Si tratta di prodigi che fioriscono su quel prodigio di inesauribile amore, che è il mistero pasquale. D’altra parte si potrebbe dire che si tratta della cosa più semplice: Dio, nell’eucaristia di Gesù, prende sul serio la propria volontà di alleanza, cioè la decisione di stare realmente con gli uomini, di accoglierli come figli, di attrarli nell’intimità della sua vita.
(Carlo Maria MARTINI, Incontro al Signore risorto, vol. II: Dalla croce alla gloria, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2007, 91-94).
Non di solo pane vive l’uomo
Che cosa voleva dire Gesù affermando che l’uomo non vivrà di solo pane? Perché usa questa espressione al futuro invece che al presente? Il Maestro ci vuole far comprendere che la vita vera, quella che attende l’uomo, non la puoi conseguire con i beni materiali. Essi tutt’ al più permettono alla carne e al sangue di sopravvivere nel frammento di tempo presente, ma senza le prospettive che si aprono sull’ eternità. Se vuoi vivere in pienezza, oltre i limiti dello spazio e la corrosione del tempo, devi nutrirti di un altro pane, il pane della vita, che viene dal cielo e non dalla terra: «Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno» (Gv 6,51). Caro amico, la realtà del nostro tempo è sotto i tuoi occhi. Guardati intorno ed esamina la tua situazione esistenziale. Quante sono le persone che hanno fame del pane vivo che dà la vita eterna? Quanti sono quelli che sentono il bisogno di cercare Gesù e di scoprirlo nella loro vita? I beni materiali sono divenuti una droga, di cui hanno continuamente bisogno, ma che li irretiscono nella tela che il ragno infernale tende instancabilmente. Non attendere che la clessidra del tempo si sia svuotata del tutto per renderti conto dell’inganno mortale.
(Padre Livio FANZAGA, Fa’ posto a Dio, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2009, 9).
Nel tuo tabernacolo
Signore Gesù,
c’è grande silenzio nel tuo tabernacolo.
Dov’è la tua luce? Chi sente la tua voce?
Chi ode i tuoi passi?
Nel tuo tabernacolo, o Signore,
tutto è immobile, tutto è silenzio, tutto è mistero.
Eppure, ogni giorno la tua parola invita alla lode.
Eppure, ogni giorno, tu imbandisci una mensa
per coloro che ti amano.
Davanti al tuo santo altare
quanti hanno ritrovato la fede,
quanti hanno riacquistato la grazia,
quanti si sono votati alla tua causa!
Tu solo conosci l’intima storia di innumerevoli anime
che qui, dinanzi a te,
hanno espresso la loro gioia,
hanno versato calde lacrime,
hanno ritrovato fiducia e speranza.
Nel tuo tabernacolo, o Signore, c’è pienezza di vita.
Tu parli, o Signore.
Tu ascolti, o Signore,
Tu ami, o Signore.
Preghiera
Signore Gesù,
con gioia ci prostriamo in adorazione presso il tuo santo altare.
Con te, o Gesù,
tutto è merito di vita eterna,
tutto è luce che rischiara la vita,
tutto aiuta a proseguire il cammino,
tutto è dolcezza… anche il dolore!
Tu sei fonte copiosa di purissima gioia.
Gioia che cominciamo a gustare qui,
nella valle del pianto,
e che sarà piena quando ci svelerai la tua gloria:
al gaudio della fede subentrerà quello della visione.
Signore Gesù,
tu, pane vivo disceso dal cielo, ci basti.
Non abbiamo bisogno di altri.
Tu sei la nostra vita.
Tu sei la nostra gioia.
Tu sei il nostro tutto.
Ci affidiamo a te:
nostro conforto,
nostro gaudio,
nostra pace.
(Paolo VI).
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2002-2003; 2005-2006- .
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
———
– COMUNITÀ DI S. EGIDIO, La Parola e la storia. Tempo di Quaresima e Pasqua, Milano, Vita e Pensiero, 2012.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. II: Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– C.M. MARTINI (card.), Incontro al Signore risorto, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Giovanni Paolo II. Il mio amato predecessore, Cinisello Balsamo/Città del Vaticano, San Paolo/Libreria Editrice Vaticana, 2007.
– J.M. NOUWEN, Un ricordo che guida, in ID., Mostrami il cammino. Meditazioni per il tempo di Quaresima, Brescia, Queriniana, 2003.
AMPLIAMENTO:
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (B)