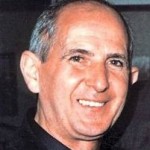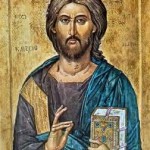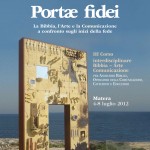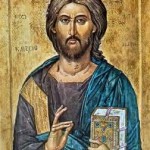
Prima lettura: Ezechiele 2,2-5
|
In quei giorni, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. Mi disse: «Figlio dell’uomo, io ti mando ai figli d’Israele, a una razza di ribelli, che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: “Dice il Signore Dio”. Ascoltino o non ascoltino – dal momento che sono una genìa di ribelli –, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro».
|
Nei capp. 1-3 del libro di Ezechiele troviamo raccolte alcune visioni avute dal profeta Ezechiele: la visione del «carro del Signore», che indica la mobilità di Dio che segue il suo popolo dovunque, anche in terra di esilio (1,4-28; 3,12-16) e la visione del libro, che sottolinea come le parole dette dal profeta sono in realtà parole di Dio (2.1-3,11). Si ritiene che la visione del libro fosse quella inaugurale, legata cioè alla visione di Ezechiele (nel 593 a.C.). La nostra breve I Lettura contiene appena gli inizi di questa suggestiva scena programmatica, in cui il Signore ordina al profeta di mangiare e assimilare il libro, ossia la sua Parola.
Questi quattro versetti (vv. 2-5) andrebbero integrati nell’insieme della visione, per meglio coglierne la valenza profetica.
— Nella loro brevità, contengono preziose indicazioni sulle tre fondamentali coordinate di ogni missione: il mandante, il mandato, i destinatari.
a) Mandante, colui che manda Ezechiele («io ti mando», v. 3) è il Signore Dio. Qui il profeta non lo contempla direttamente ma attraverso alcuni segni della sua presenza: uno spirito (= ruah) o forza divina che lo solleva e lo rende capace di ascolto (v. 2), la parola o voce (v. 3), una mano tesa contenente un rotolo (v. 9). Segni che velano la vera identità di Dio e ne sottolineano il mistero, la trascendenza.
b) Mandato è il profeta, caratterizzato frequentemente (più di 90 volte) qui e altrove, come Figlio dell’uomo, figlio di Adamo tratto dalla terra, e pertanto essere debole, fragile, effimero. Nonostante questa sua condizione di estrema debolezza, il profeta è abilitato a parlare in nome di Dio, a riferirne le parole: Dice il Signore Dio (v. 4). Il fatto che il profeta è mandato ed esercita la sua missione («un profeta si trova in mezzo a loro», v. 5) dimostra — di per sé e indipendentemente dall’ascolto che avrà («ascoltino o non ascoltino») che Dio è presente nella storia del suo popolo e veglia sul suo piano salvifico. Il fatto stesso della presenza di un profeta prova l’interesse di Dio per il suo popolo.
c) Destinatari della missione sono gli Israeliti, storicamente gli esuli delle 10 tribù del nord ed il resto del regno di Giuda. La storia lunga della loro infedeltà, considerata sia nel passato («i loro padri») che nel presente («di me fino ad oggi», v. 3) è caratterizzata come storia di ribelli non contro una legge o un patto, ma «contro di me» (cf. v. 5).
Tre espressioni caratterizzano l’infedeltà degli israeliti:
— si sono rivoltati contro di me (v. 3), per la precisione si tratta del gesto arrogante con cui il suddito rifiuta il vassallaggio al proprio sovrano;
— hanno peccato (v. 3), cioè hanno trasgredito precisi obblighi e statuti che avevano con me;
— figli testardi e dal cuore indurito (v. 4). Alla lettera: impudenti di faccia e duri di cuore. Il peccato si traduce in un duplice indurimento, interiore (cuore) ed esteriore (faccia), che solo un cuore di carne (cf. Ez 36,26) potrà eliminare.
Seconda lettura: 2 Corinzi 12,7-10
|
Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che l’allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza». Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: infatti quando sono debole, è allora che sono forte.
|
Ci troviamo all’interno della terza sezione della 2Cor, rappresentata dai capp. 10-13. È una sezione particolare che si può definire globalmente Apologia di Paolo (come fa la Bibbia di Gerusalemme) dai toni violenti e sferzanti: l’Apostolo difende il suo ministero contro alcuni «falsi apostoli» (11,13) che lo accusano e lo screditano davanti alla comunità di Corinto. L’Apostolo parla anche di se stesso, facendo in certo qual modo il proprio elogio. La lettura odierna rappresenta un momento importante di questa confessione autobiografica (11,22-12,13), riconoscendo che dietro la sua debolezza agisce la potenza di Dio (12,7-10).
Siccome precedentemente ha parlato di favori e rivelazioni, Paolo parla ora di una prova particolare destinato a evitare che egli monti in superbia (v. 7).
Il breve brano presenta alcuni punti, che vanno chiariti. Consideriamo le seguenti espressioni:
a) una spina nella carne, termine enigmatico, variamente interpretato nella storia dell’esegesi: malattia cronica, persecuzioni (padri latini e greci), tentazioni contro la castità (Gregorio Magno), ecc. Oggi si tende a vedere nella «spina» una malattia che poneva intralci e ritardi al ministero di Paolo.
b) un inviato di Satana, inteso in senso metaforico, esprime la convinzione ebraica secondo cui prove, disgrazie, sofferenze, vengono non da Dio, ma da Satana. È la stessa concezione che troviamo nel libro di Giobbe (cf. Gb 2.6).
c) mi vanterò, mi compiaccio (vv. 9.10), sono verbi che dovrebbero avere come oggetto realtà gloriose: vittorie, virtù, imprese, ecc. Paradossalmente qui hanno come oggetto delle condizioni di cui umanamente ci si vergogna: «debolezze», «infermità», «angosce», ecc.
d) quando sono debole, è allora che sono forte (v. 10). Altro noto paradosso.
Questi paradossi esprimono questa convinzione di Paolo: è la potenza salvifica di Cristo che opera in lui quando è debole. Ecco perché non solo accetta le prove, ma addirittura si vanta e si compiace in esse.
Vangelo: Marco 6,1-6
|
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.
|
Esegesi
Dopo una serie di prodigi culminati nel racconto di una risurrezione (c. 5) si direbbe che Mc comincia a preparare il destino di condanna e di morte, cui Gesù va incontro, narrando le reazioni di scetticismo e di rifiuto che egli affronta nella sua stessa patria (6,1-6), cioè a Nazaret. È questo il brano del Vangelo di questa domenica.
— Lo stupore, in senso scettico, che l’insegnamento di Gesù desta nei suoi compatrioti, si esprime in una serie incalzante di cinque domande (vv. 2-3). Esaminiamone distintamente il senso:
a) Prima domanda: Da dove gli vengono queste cose? (v. 2), «queste cose» sono le cose che insegna. L’insegnamento di Gesù potrebbe avere diverse origini, ed il dove? varie risposte: dal cielo o dagli uomini (cf. Mc 11,30), da Satana (3,22.30), ecc. Il fatto che, pur conoscendone il nome, i suoi compatrioti lo indichino ripetutamente dicendo «costui» esprime distanza e dubbio.
b) Seconda domanda: dietro l’insegnamento c’è un certo tipo di sapienza che secondo gli ascoltatori egli non possiede da sé, ma gli è stata data. Questo passivo esige un completamento, un agente: sapienza data da chi? Le risposte possono essere due: o da Dio (passivo «divino»), o da Satana (passivo «diabolico»). Il fatto che i compatrioti si scandalizzino di lui (v. 3) indica che essi pensino alla seconda, non alla prima, possibilità.
c) Terza domanda, relativa ai prodigi cui si assiste (vedi cap. 5). Se i prodigi avvengono attraverso le mani del taumaturgo, la domanda che ci si pone è: chi opera questi fatti tramite Gesù? Se si esclude che egli sia il Messia, non resta altra risposta che questa: non Dio, ma il diavolo opera questi strani miracoli.
d) Quarta e quinta domanda, partono dall’origine di Gesù, nota a tutti, per affermare che non può essere il Messia, che invece — secondo la tradizione ebraica — non sarebbe stato conosciuto da nessuno, date le sue origini misteriose. Di Gesù si indica prima la nota professione personale, il falegname (non «il figlio del carpentiere» come in Mt 13,55), e poi le persone della sua parentela: figlio di Maria (probabilmente è avvenuta già la morte di Giuseppe), con «fratelli» e «sorelle» (congiunti) a tutti noti.
— Ed era per loro motivo di scandalo (v. 3). «Scandalizzarsi» propriamente designa una caduta provocata da un inciampo (skándalon). Nel Nuovo Testamento spesso questo termine lo si indica in senso religioso, un’occasione di peccato, una seduzione all’apostasia e all’incredulità. Gesù diventa occasione di scandalo per i suoi compaesani, perché in certo senso ne provoca la caduta (peccato di incredulità) con il suo insegnamento e le sue azioni.
— Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria (v. 4). Indirettamente e senza grosse polemiche, Gesù reagisce enunciando il principio del profeta disprezzato in patria; e non solo nel suo paese natio, ma anche tra i suoi parenti e nella sua stessa famiglia. Marco accentua questi due ultimi termini (parentela, famiglia) radicalizzando così il rifiuto che Gesù ha trovato tra i suoi (vedi 3,21). Dicendo «un profeta» e attribuendo a sè tale detto, in qualche modo Gesù rivendica la dignità e le prerogative del profeta escatologico rifiutato dagli altri.
— E lì non poteva compiere nessun prodigio (5a). Frase apparentemente in contrasto con quella che segue: impose le mani a pochi malati e li guarì (5b). In realtà, l’evangelista non vuole assolutizzare il principio che l’incredulità escluda del tutto i miracoli e paralizzi la compassione di Gesù. Con il v. 5b vuole lasciarci un’impressione positiva.
— Si meravigliava della loro incredulità (v. 6). Anche se ha enunciato il principio del v. 4 (un profeta non è disprezzato che…). Gesù prova un certo stupore verso l’incredulità dei suoi. Questo vuol dire che, benché sia di regola così, l’incredulità non è, per lui un fatto scontato, da accogliere con supina rassegnazione.
Meditazione
La pagina evangelica di questa domenica ci narra la visita di Gesù alla sua città natale. È la prima volta che Gesù, dall’inizio del suo ministero pubblico, fa ritorno nella sua patria. A Nazaret «era stato allevato» (Lc 4,16) e aveva trascorso i primi trent’anni della sua vita (cfr. Lc 3,23), conducendo un’esistenza segnata dall’ordinarietà e dalla condivisione del comune destino dei suoi abitanti. Gli evangelisti non ci dicono pressoché nulla di questi anni di vita ‘nascosta’ e noi non possiamo far altro che prendere atto di questo riserbo rispettando un silenzio che, forse, la dice lunga sulla ‘serietà’ di quel mistero che noi chiamiamo incarnazione.
Possiamo immaginare la curiosità e l’animazione dei nazaretani nel rivedere un loro concittadino diventato tanto ‘famoso’ negli ultimi tempi (già dopo il primo miracolo a Cafàrnao si dice che «la sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea»: Mc 1,28). Una curiosità che si tramuta in stupore appena cominciano a sentirlo parlare nella loro sinagoga, nella consueta celebrazione liturgica sabbatica. «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data?…» (vv. 2-3). L’evangelista accumula qui una serie di ben cinque domande per dare corpo a tutta la meraviglia degli abitanti di Nàzaret: come è possibile che quest’uomo parla in questo modo e compie tali cose? Lo conosciamo bene tutti: è uno di noi…! E così lo stupore iniziale cede subito il passo a un atteggiamento di scetticismo e di incredulità: «Ed era per loro motivo di scandalo» (v. 3b). È lo sconcerto di chi non riesce a mettere insieme una sapienza e una potenza che si reputa non possano venire altro che da Dio con le modeste e umili origini di colui che è conosciuto come «il falegname, il figlio di Maria» (v. 3a). Come può il divino conciliarsi con un umano così ‘umano’? Come può Dio manifestarsi in una realtà così quotidiana e familiare? La presunta conoscenza di Gesù da parte dei nazaretani è l’ostacolo più grande alla loro apertura di fede, a una fede che si apre a un ‘oltre’ che travalica l’immediatezza della propria esperienza quotidiana, pur non negandola. «La meraviglia è un pochino sempre a doppio esito: c’è la meraviglia che vuol capire, che si lascia educare a capire. […] E c’è invece la meraviglia che non nasce dall’intelligenza, cioè dalla volontà dell’uomo di capire, di piegarsi e di incontrare la verità o comunque ciò che gli si manifesta: ma è la meraviglia della ragione, che conduce a misurare questa cosa secondo il metro che sono io. Questa meraviglia conduce all’incredulità e al rifiuto, mentre la prima conduce all’ammirazione, si lascia educare dall’avvenimento, si lascia piegare» (G. Moioli).
È significativo che a questa meraviglia incredula faccia eco l’amara meraviglia di Gesù: «E si meravigliava della loro incredulità» (v. 6a). Gesù non riesce a capacitarsi che si possa arrivare a un tale livello di incredulità. E proprio tra i suoi parenti, nella sua casa, nella sua patria… Sembra una costante nella storia della salvezza, ma proprio i più vicini, coloro che dovrebbero conoscere meglio l’inviato di Dio, che vantano con lui una certa familiarità, sono quelli che meno accolgono il suo messaggio, che più si chiudono alla sua azione. Ne sono testimonianza le parole disincantate che il profeta Ezechiele riceve da parte del Signore: «Figlio dell’uomo, io ti mando ai figli d’Israele, a una razza di ribelli… Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito…» (Ez 2,3-4; prima lettura). Il detto popolare, citato da Gesù, sul profeta disprezzato tra i suoi (cfr. Mc 6,4) è una conferma di questo atteggiamento di ‘ribellione’ del popolo al quale Dio manda i suoi messaggeri. Si potrebbe dire che Gesù è sì stupito e sorpreso di questo rifiuto, ma non impreparato: conosce, infatti, la sorte di tutti i profeti che lo hanno preceduto.
In questo clima di incredulità Gesù non può compiere alcun miracolo. La non-fede degli abitanti di Nàzaret ha il triste effetto di ridurre all’impotenza Gesù («E lì non poteva compiere nessun prodigio»: v. 5a); al contrario della fede della donna emorroissa e del capo della sinagoga Giairo (cfr. Mc 5,21-43), che permettono a Gesù di sprigionare tutta la sua potenza salvifica, capace persino di risuscitare i morti! La fede può tutto (cfr. Mc 9,23), l’incredulità invece rende impossibile ogni opera di Dio. I gesti e i prodigi che Gesù compie sono sempre in vista della fede e in risposta a essa; per questo non ha alcun senso un miracolo fuori dall’’ambito vitale’ in cui solamente esso può avvenire.
Tuttavia, prima di lasciare la sua città, Gesù riesce a compiere qualche guarigione (cfr. v. 5b), segno che il rifiuto non è stato totale: qualche barlume di fede si è trovato anche lì, tra i suoi compatrioti. L’insuccesso sperimentato non ferma la ‘corsa’ del vangelo: a dispetto di tutto, Gesù continua a percorrere i villaggi della Galilea portando a tutti la sua parola di vita. Anche da profeta inascoltato e disprezzato continua a diffondere con fiducia il seme del vangelo.
Un’ultima osservazione circa la ‘parentela’ di Gesù. Già in Mc 3,33 Gesù chiedeva ai suoi ascoltatori: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Conosciamo la risposta che lo stesso Gesù da subito senza aspettare la reazione dei suoi interlocutori. Qui a Nàzaret, dove Gesù giunge con i suoi discepoli (la sua ‘nuova famiglia’), si fa ancora più acuto il contrasto tra parentela ‘carnale’ e parentela ‘di fede’. La prima non è negata, né disprezzata, ma, ai fini della comunione con il Signore, deve sfociare nella seconda. Perché il solo legame che rende ‘familiari’ del Figlio dell’uomo è l’obbedienza della fede e l’ascolto sincero della parola di Dio.
Preghiere e racconti
Viveva di fede come noi
«Quanto avrei voluto essere sacerdote per poter predicare sulla Madonna! Una sola volta sarebbe stata sufficiente per dire tutto quello che penso a questo proposito. Prima avrei fatto capire quanto poco conosciamo la sua vita. Non occorre dire cose inverosimili o che non sappiamo; per esempio che, da piccola, a tre anni, la Madonna ha offerto se stessa a Dio nel Tempio con sentimenti ardenti di amore e del tutto straordinari ; mentre forse ci é andata semplicemente per obbedire ai suoi genitori… Perché una omelia sulla Madonna possa piacermi e farmi del bene, occorre che io veda la sua vita reale, non la sua vita supposta ; e sono certa che la sua vita reale era molto semplice. Ce la mostrano inabbordabile, mentre bisognerebbe mostracela imitabile, fare vedere le sue virtù, dire che viveva di fede come noi, dare delle prove di questo per mezzo del Vangelo in cui leggiamo : « Non compresero le sue parole » (Lc 2,50). E questa parola molto misteriosa : « I suoi genitori si stupivano delle cose che si dicevano di lui » (Lc 2,33). Questo stupirsi suppone un certo meravigliarsi, non è vero? Sappiamo bene che la Madonna è Regina del Cielo e della terra, eppure è più madre che regina, e non occorre dire a motivo delle sue prerogative, che lei eclissi la gloria di tutti i santi, come il sole al suo sorgere fa scomparire le stelle. Mio Dio! quanto questo mi appare strano! Una madre che fa scomparire la gloria dei suoi figli! Io penso tutto il contrario, ritengo che essa farà crescere molto lo splendore degli eletti. È bene parlare delle sue prerogative, ma non occorre dire soltanto questo… Forse qualche anima andrà fino al punto di sentire allora una certa lontananza con una tale creatura talmente superiore e dirà : « Se le cose stanno così, ci accontenteremo di andare a brillare in un angolino».Ciò che la Madonna aveva in più rispetto a noi, era il fatto che non poteva peccare, che era esente dalla macchia originale, ma d’altra parte, è stata meno fortunata di noi, poiché non ha avuto la Madonna da amare, e questa è una tale dolcezza per noi».
(Santa Teresa del Bambin Gesù (1873-1897), carmelitana, dottore della Chiesa, in Ultimi colloqui, 21/08/1897).
Secondo la fede
Così la multiforme sapienza di Dio distribuisce la salvezza degli uomini con una molteplice e insondabile compassione e accorda il dono della sua generosità secondo la capacità di ciascuno. Per le guarigioni stesse che opera non vuole regolarsi sull’uniforme potenza della sua maestà, ma sulla fede che trova in ciascuno di noi o che egli stesso ha distribuito. L’uno crede che per essere purificato dalla lebbra basti la sola volontà di Cristo; Cristo lo guarisce con il solo assenso della sua volontà dicendo: «Lo voglio, sii guarito» (Mt 8,3). Un altro lo supplica di venire da lui e di resuscitare sua figlia imponendole le mani; entra a casa sua e gli concede l’oggetto della richiesta nella maniera sperata (cfr. Mt 9,18). Un terzo crede che la salvezza risieda nell’ordine dato con parole: «Dì soltanto una parola e il mio servo sarà guarito» (Mt 8,8); con il comando della sua parola restituisce alle membra illanguidite il loro vigore primitivo: «Va’ e ti sia fatto secondo la tua fede» (Mt 8,13). Altri sperano di trovare guarigione toccando la frangia del suo vestito; egli dona loro con generosità il dono della salute (cfr. Mt 9,20). Accorda agli uni la guarigione delle loro malattie su loro richiesta, ad altri offre un rimedio spontaneo, altri li esorta alla speranza dicendo: «Vuoi essere guarito?» (Gv 5,6); porta il suo aiuto ad altri che non speravano più. Sonda i desideri degli uni, prima di soddisfare la loro volontà: «Che volete che vi faccia?» (Mt 20,32). A un altro che non sa per quale via ottenere quello che desidera, dice con bontà: «Se credi, vedrai la gloria di Dio» (Gv 11,40). Su altri effuse abbondantemente la sua potenza di guarigione al punto che l’evangelista riferendosi a essa concluse: «Egli guarì tutti i loro malati» (Mt 14,14); presso altri, però, l’abisso senza limiti dei suoi benefici venne bloccato tanto che si disse: Gesù non poteva operare nessun miracolo a causa dell’incredulità (cfr. Mc 6,5-6). E così la generosità di Dio si conforma alla capacità di fede dell’uomo, al punto di dire a uno: «Ti avvenga secondo la tua fede» (Mt 9,29); a un altro: «Va’ e ti sia fatto come hai creduto» (Mt 8,13); e a un altro: «Ti sia fatto come tu vuoi» (Mt 15,28); e a un altro ancora: «La tua fede ti ha salvato» (Mc 5,34).
(GIOVANNI CASSIANO, Conferenze 13,15, SC 54, pp. 175-176).
I sepolcri imbiancati
II maestro sembrava non essere assolutamente toccato da ciò che la gente pensava di lui, pur non essendo sempre un rigorosissimo osservante. Quando i discepoli gli chiesero come avessero raggiunto questo grado di libertà interiore, egli rise forte e disse: «Fino a 20 anni non mi è importato nulla di che cosa la gente pensasse di me; dopo i 20 anni mi preoccupavo immensamente di che cosa pensassero i miei vicini; poi un giorno, dopo i 50 anni, capii improvvisamente che essi non pensavano minimamente a me».
(Racconto ebraico).
Questi è davvero il profeta
Furono riempite dodici ceste. Questo fatto è mirabile per la sua grandezza, utile per il suo carattere spirituale. Quelli che erano presenti si entusiasmarono, mentre noi, al sentirne parlare, rimaniamo freddi. Questo è stato compiuto affinché quelli lo vedessero ed è stato scritto affinché noi lo ascoltassimo. Quello che essi poterono vedere con gli occhi, noi possiamo vederlo con la fede. Noi contempliamo spiritualmente ciò che non abbiamo potuto vedere con gli occhi. Noi ci troviamo in vantaggio rispetto a loro, perché a noi è stato detto: Beati quelli che non vedono e credono (Gv 20,29). Aggiungo che forse a noi è concesso di capire ciò che quella folla non riuscì a capire. Ci siamo così veramente saziati, in quanto siamo riusciti ad arrivare al midollo dell’orzo. Insomma, come reagì la gente di fronte al miracolo? Quelli, vedendo il miracolo che Gesù aveva fatto, dicevano: Questi è davvero il profeta (Gv 6,14). […] Ma Gesù era il Signore dei profeti, l’ispiratore e il santificatore dei profeti, e tuttavia un profeta, secondo quanto a Mosè era stato annunciato: Susciterò per loro un profeta simile a te (Dt 18,18). Simile secondo la carne, superiore secondo la maestà. E che quella promessa del Signore si riferisse a Cristo, noi lo apprendiamo chiaramente dagli Atti degli apostoli. Lo stesso Signore dice di se stesso: Un profeta non riceve onore nella sua patria (Gv 4,44). Il Signore è profeta, il Signore è il Verbo di Dio e nessun profeta può profetare senza il Verbo di Dio; il Verbo di Dio profetizza per bocca dei profeti, ed è egli stesso profeta. Cristo è profeta e Signore dei profeti, così come è angelo e Signore degli angeli. Egli stesso è detto angelo del grande consiglio (cfr. Is 9,6). E del resto, che dice altrove il profeta? Non un inviato né un angelo, ma egli stesso verrà a salvarci (cfr. Is 35,4); cioè a salvarci non manderà un messaggero, non manderà un angelo, ma verrà egli stesso.
(AGOSTINO, Omelie sul vangelo di Giovanni 24,6-7, in Opere di sant’Agostino, pp. 564-566).
Ogni giorno è da vivere
Ogni mattina
è una giornata intera
che riceviamo dalle mani di Dio.
Dio ci dà una giornata da Lui stesso preparata per noi.
Non vi è nulla di troppo e nulla di «non abbastanza»,
nulla di indifferente e nulla di inutile.
È un capolavoro di giornata
che viene a chiederci
di essere vissuto.
Noi la guardiamo come una pagina d’agenda,
segnata d’una cifra e d’un mese.
La trattiamo alla leggera
come un foglio di carta.
Se potessimo frugare il mondo
e vedere questo giorno elaborarsi
e nascere dal fondo dei secoli,
comprenderemmo il valore di un solo giorno umano.
(M. Delbrêl).
Bramo la tua voce, o Dio
Quando mi fermo stanco sulla lunga strada
e la sete mi opprime sotto il solleone;
quando mi punge la nostalgia di sera
e lo spettro della notte copre la mia vita,
bramo la tua voce, o Dio,
sospiro la tua mano sulle spalle.
Fatico a camminare per il peso del cuore
carico dei doni che non ti ho donati.
Mi rassicuri la tua mano nella notte,
la voglio riempire di carezze,
tenerla stretta:
i palpiti del tuo cuore
segnino i ritmi del mio pellegrinaggio.
(Rabindranath Tagore)
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2002-2003; 2005-2006- .
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
———
– COMUNITÀ DI S. EGIDIO, La Parola e la storia. Tempo ordinario. Parte prima, Milano, Vita e Pensiero, 2012.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. II: Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011.
XIV DOM TEMP ORD ANNO B