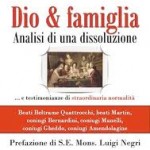Prima lettura: Esodo 16,2-4.12-15
|
In quei giorni, nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del Signore nella terra d’Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine». Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Ho inteso la mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: “Al tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane; saprete che io sono il Signore, vostro Dio”».
La sera le quaglie salirono e coprirono l’accampamento; al mattino c’era uno strato di rugiada intorno all’accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c’era una cosa fine e granulosa, minuta come è la brina sulla terra. Gli Israeliti la videro e si dissero l’un l’altro: «Che cos’è?», perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: «È il pane che il Signore vi ha dato in cibo».
|
Dopo l’epica trionfale del passaggio del mar Rosso, celebrata nel c. 15 dal canto dei figli d’Israele, i lunghi anni di peregrinazioni nel deserto vedono i ripensamenti, le mormorazioni, le ribellioni del popolo, e la paziente cura con cui Dio lo assiste. È una lunga pedagogia attraverso la quale il popolo dovrà imparare che solo da Dio viene la salvezza e la vita.
È il tema della «tentazione» e della «prova»: il popolo «tenta» Dio con le sue accuse, perché non si fida; Dio «mette alla prova» il popolo per temprarlo a dargli forza.
Nel racconto prevale la redazione dovuta alla fonte sacerdotale (P), la più recente, che con uno stile più involuto e barocco insiste sugli aspetti anche rituali della vita della comunità, presenta Aronne accanto a Mosè, richiama la legge del sabato (anche se non è stato ancora consegnato il decalogo).
1. NOTE ESEGETICHE
vv. 2-4 — A Mara l’intervento del Signore ha reso dolce e potabile l’acqua; nel deserto di Sin gli Israeliti patiscono la fame. Tutta la comunità si lamenta: singolare questa sottolineatura di una unanimità nella ribellione. È più facile compattare il popolo nella sterile protesta, che far nascere una comunione di spiriti concorde nella sequela del Signore.
Termine della protesta non è il Signore, ma i suoi portavoce: Mosè e Aronne. La libertà costa cara, è un dono che va anche guadagnato passo dopo passo nella lunga traversata del deserto: il popolo non regge al peso.
Il ricordo della schiavitù si sbiadisce e cede il posto al ricordo del cibo assicurato.
Il Signore parla a Mosè, prima ancora che questi abbia potuto trasmettergli le lamentele del popolo: previene l’intercessione, che pure è un compito che Mosè assolve di frequente a favore del popolo (cf. 14,13-15).
Il Signore farà piovere il pane dal cielo: è la gratuità assoluta del dono, intervento miracoloso dall’alto; ma il popolo dovrà ogni giorno — con l’eccezione del sabato — «uscire» e «raccogliere» la razione quotidiana.
È richiesta quindi anche una attività, per così dire, di cooperazione al dono divino.
Uscire (jatsa’) è il verbo usato per l’uscita, cioè la liberazione, dall’Egitto: il popolo, materialmente già liberato con il passaggio del mare, deve ora liberarsi spiritualmente, smettere di rimpiangere la terra di schiavitù e accogliere consapevolmente e responsabilmente la difficile condizione di libertà.
Raccogliere (laqat) è il lavoro del contadino, ma anche la spigolatura (cf. Rut): lavoro sì quindi, ma reso possibile da un’offerta e da una disponibilità gratuita, accolto con umiltà.
La razione del giorno allontana ogni tentazione di accumulo e di possesso; il termine è diverso (la LXX traduce tò tès emèras, e non epioùsios), eppure forte è la valenza evocativa del «pane quotidiano» del Padre nostro.
Il dono è anche una prova (nasah) per verificare l’osservanza della Legge da parte del popolo. Dio non «mette alla prova» mandando chi sa quali sventure, ma donando il necessario per vivere: accettare la vita come dono di Dio è un atto di fede non sempre così scontato.
v. 12 — Ed ecco ancora ripetute le parole del Signore che preannunciano il duplice prodigio: la carne al tramonto e il pane al mattino, con il consueto ritornello: così il popolo saprà che il Signore è il suo Dio.
vv. 13-15 — Viene descritta ora la realizzazione del prodigio. Come avviene per il passaggio del mare, si tratta di fenomeni naturali (i forti venti che provocano le secche nel «mare dei giunchi», il passaggio periodico degli uccelli migratori, la resina che si forma sulle tamerici del deserto), che assumono tuttavia la forma del miracolo per l’eccezionalità con cui si verificano e la corrispondenza alla parola del Signore. L’apparire della manna al mattino è descritto con stupore sacrale: qualcosa di granuloso, fine come la brina, che gli Israeliti non avevano mai visto. E questo stupore rimane nel nome: la domanda «cos’è?» (man hu) è un’etimologia popolare della parola «manna». Mosè dà la risposta giusta, det-tata dalla fede e non dalla botanica: è il pane che il Signore ha promesso e dato, è il «pane dal cielo» di cui Gesù darà una nuova lettura nel cap. 6 del vangelo di Giovanni.
Seconda lettura: Efesini 4,17.20-24
|
Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più come i pagani con i loro vani pensieri. Voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e se in lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, ad abbandonare, con la sua condotta di prima, l’uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità.
|
Vicina per tema e per stile alla lettera ai Colossesi, quella agli Efesini è stata paragonata alle variazioni infinite e alle concatenazioni di un’opera musicale barocca. Piuttosto che una lettera ai cristiani di Efeso, è probabilmente una circolare diretta alle assemblee della Frigia. Indicata fra le «lettere della prigionia», potrebbe risalire agli anni 65/70, per mano di uno dei discepoli di Paolo, forse dopo la scomparsa dell’Apostolo.
1. NOTE ESEGETICHE
Il capitolo 4 apre la parte parenetica della lettera.
v. 17 — Dopo aver fortemente richiamato la centralità di Cristo, il capo da cui tutto il corpo ecclesiale trae linfa vitale «in modo da edificare se stesso nella carità» (v. 16), l’esortazione si fa più precisa. Essa poggia su una serie di opposizioni fra ieri e oggi, fra i pagani e coloro che hanno «imparato a conoscere il Cristo», fra l’umanità antica e quella nuova.
L’autore prende le distanze dallo «ieri» dei pagani per esortare alla scelta di un comportamento «nuovo».
vv. 20-21 — «Avete imparato a conoscere il Cristo» significa lasciarsi istruire da lui a vivere secondo l’abito nuovo, quello del battesimo. Emàthete (avete imparato) è la stessa radice di mathetès (discepolo).
vv. 22-24 — L’uomo vecchio, che si corrompe seguendo illusorie chimere, deve essere abbandonato: nel battesimo siamo «sepolti» con Cristo (Rm 6,4). L’uomo nuovo, che corrisponde al disegno della creazione, esige un rinnovamento della mentalità: una metanoia, una conversione. «Rivestire Cristo» e «nuova creatura» sono temi ricorrenti nell’epistolario paolino (cf. Ef 2,15; Rm 13,14; 2Cor 5,17; Col 3,10).
Vangelo: Giovanni 6,24-35
|
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!».
|
Esegesi
Il capitolo 6 del vangelo di Giovanni è dedicato alla moltiplicazione dei pani e al lungo discorso tenuto da Gesù nella sinagoga di Cafarnao, in cui egli si identifica nel «pane disceso dal cielo». La tradizione dottrinale e liturgica della Chiesa ha da sempre applicato questo discorso al mistero dell’eucarestia.
Compiuto il miracolo, Gesù sfugge alla folla che vorrebbe farlo re e si ritira solo sul monte: non è un messianismo trionfalistico il suo, ed è necessaria una lunga catechesi perché gli stessi discepoli possano essere condotti ad accettare la via della croce. Segue l’episodio di Gesù che cammina sulle acque, segno anticipatore della risurrezione, alla luce della quale soltanto i discepoli potranno comprenderlo.
La pericope che qui commentiamo contiene la rivelazione di Gesù, vero pane di vita.
vv. 24-25 — La folla attraversa il lago in direzione di Cafarnao, alla ricerca di Gesù. Il tema della ricerca è costante nei Vangeli: si tratta spesso di una ricerca iniziale, inconsapevole, non riflessa, che scaturisce da esigenze primarie e immediate, come il bisogno di pane. Gesù non respinge questa esigenza elementare e non disdegna di soddisfarla, come ha mostrato con il miracolo; ma altro è il dono che egli porta.
I due versetti sono prospettici: il v. 24, che introduce la ricerca (zetèo), rinvia al 26 (mi cercate…), mentre il v. 25, in cui si chiede «come mai» (pote) Gesù è arrivato oltre il lago, rinvia al 52: «come (pos) costui può darci da mangiare la sua carne?».
v. 26 — Gesù conosce i cuori degli uomini e sa che lo cercano perché vogliono saziare la loro fame.
Non hanno ancora compreso che il miracolo non è un prodigio che mira a sorprendere, un modo per risolvere a buon mercato i problemi quotidiani, una soddisfazione materiale o un atto di potenza; il miracolo è segno, indica al di là di sé una verità più profonda, ed è quella che bisogna cercare. Non hanno visto il segno, si sono fermati al pane: da qui parte Gesù per la grande catechesi eucaristica, per rivelare quale è il pane vero che dà la vita eterna. E solo pochi sapranno intendere le sue parole (cf. vv. 66-69).
I vv. 26-27, riferiti alla moltiplicazione dei pani, sono come la proposizione del tema: Gesù (il Figlio dell’uomo) da un cibo che non perisce.
vv. 27-30 — Il tema qui introdotto è la fede, e la parola-chiave che lega questi versetti è operare/opera (ergàzein/ergon): l’opera di Dio è credere.
L’esortazione di Gesù al v. 27, «procuratevi (ergàzesthe) il cibo che rimane», è ripresa nella domanda del v. 28: «cosa dobbiamo fare per compiere (ergazòmetha) le opere di Dio?» L’aporia che sembra sussistere tra un’attività tesa a procurarsi il cibo, e il fatto che questo cibo sia un dono (il Figlio dell’uomo ve lo darà), viene risolta al v. 29: l’opera consiste nel credere (pistèuete) in colui che Dio ha mandato. Le opere di cui i discepoli non hanno ancora capito il senso (erga) del v. 28 —; pensano infatti a precetti da osservare, a opere meritorie da compiere — diventano in bocca a Gesù un’unica opera (ergon): la fede, decisione radicale che coinvolge la libertà dell’uomo e trasforma la vita, è l’opera di Dio che apre alla possibilità della vita eterna (il cibo che rimane per la vita eterna).
v. 30 — La domanda è legata a ciò che precede («cosa fai?», tì ergathe) e a ciò che segue, il ricordo della manna che provoca la spiegazione/rivelazione di Gesù. Cominciano a intuire di non aver percepito i «segni» di cui parla Gesù («non perché avete visto dei segni», v. 26), ma chiedono ancora il «segno» come una prova, una garanzia miracolistica che svuoterebbe la decisione di fede dal coinvolgimento libero, responsabile e personale.
v. 31 — L’espressione di Gesù (che crediate in colui che Egli ha mandato) è chiaramente messianica, e coerentemente i suoi uditori si richiamano all’Esodo, figura di liberazione e di salvezza.
vv. 32-35 — Il tema è ora il discorso di rivelazione: Gesù è il pane del cielo, il vero pane di Dio. Gesù infatti interpreta il miracolo della manna: non Mosè, ma Dio dà il pane del cielo; e il pane vero, di cui la manna è semplice figura, è quello che scende dal cielo (preesistenza del Figlio) e dà la vita al mondo (missione universale di Gesù).
La richiesta del v. 34 ricalca quella della Samaritana (cf. 4,15), con lo stesso fraintendimento tra il livello del cibo e dell’acqua materiali e il livello del segno salvifico. La conclusione di Gesù è il discorso di rivelazione, introdotto dalla formula «Io sono». Gesù si identifica con «il pane di vita», la fede in lui è ciò che dà la salvezza, libera dalla fame e dalla sete, non solo in senso materiale. Questa è la novità sconvolgente, su cui il discorso di Cafarnao continua, fino a provocare scandalo (v. 61) e scissione nella comunità: «da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro» (v. 66). La salvezza consisterà nel riconoscere nella fede le «parole di vita eterna» (v. 68).
Meditazione
Nel Vangelo di Giovanni i segni che Gesù opera sono sempre accompagnati e interpretati dai suoi discorsi. Se il segno conferma l’efficacia della Parola, sigillandone la rivelazione, è la Parola che consente di non fraintendere il segno. Non è pertanto ‘vedere’ il segno a generare la fede, piuttosto è credere nella parola di Gesù che consente di ‘vedere’ nel modo giusto il segno e di accoglierlo nel suo significato più vero e fecondo per la nostra vita. Questa dinamica caratteristica del IV Vangelo ritorna evidente al capitolo sesto, dove il discorso nella sinagoga di Cafarnao interpreta il gesto con cui Gesù ha sfamato le folle. Quanto accade nel racconto di Giovanni è peraltro ciò che si ripete in ogni celebrazione eucaristica, nella quale siamo invitati ad alimentare la nostra fede personale e la nostra vita comunitaria all’unica mensa della Parola e del Corpo di Cristo, secondo la suggestiva espressione del Vaticano II (cfr. DV 21). Questa unità tra Parola e Segno va tenuta presente anche nel leggere Giovanni 6. Secondo la tradizione sinottica, Gesù risponde alla prima tentazione del deserto citando Dt 8,3: «Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (cfr. Mt 4,4). Anche in questo ‘deserto’ Gesù dona il cibo, ma non fa mancare la sua parola, che consente di accogliere il pane quale esso veramente è: segno di Dio che rivela se stesso prendendosi cura della vita dell’uomo. Anzi, offrendo il proprio Figlio come pane per la vita dell’uomo. Pane che nutre l’esistenza umana a condizione che ci sia una parola che porti alla luce la sua fame nascosta e più vera. Anche in Samaria la donna incontrata presso il pozzo si era vista consegnare, sempre dalla parola di Gesù, alla sua vera sete. Qual è dunque la nostra fame?
La liturgia della parola domenicale, dopo aver proclamato il segno nella scorsa domenica, per quattro domeniche consecutive ci fa ascoltare il discorso che segue. L’inevitabile suddivisione del capitolo in cinque parti rende più difficile seguirne lo sviluppo unitario. Può essere perciò utile ricordare subito la trasformazione che, grazie al gesto e alla parola di Gesù, avviene tra l’apertura e la conclusione del capitolo. All’inizio del racconto, «lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi» (v. 2). Alla fine del capitolo solo i Dodici rimangono, professando la loro fede con Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio» (vv. 68-69). Dal seguire Gesù perché si vedono i segni operati sui malati alla fede di chi rimane perché crede in una parola di vita; dalla fame di pane al desiderio di una comunione personale con Gesù (da chi altri andare?); dalla guarigione delle malattie alla pienezza della vita eterna: questo è il passaggio molteplice che il segno operato da Gesù, e la parola che lo interpreta, sollecitano a compiere. Non per nulla l’evangelista aveva an-notato che quanto Gesù desiderava operare celava un’intenzione precisa: mettere alla prova Filippo, e insieme a lui ogni discepolo, quelli di allora come quelli di oggi. «Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere» (v. 6). La prova biblica, soprattutto quella che caratterizza il cammino nel deserto, come ci ricorda anche la prima lettura tratta da Esodo 16, non intende solo saggiare quello che c’è nel nostro cuore o la qualità della nostra relazione con il Signore, ma anche purificare la nostra fede per renderla sempre più aderente all’opera di Dio e aperta alla sua rivelazione. Gesù sapeva quello che stava per compiere; la prova è ciò che consente al discepolo di entrare sempre più profondamente in questo suo stesso sapere. I segni che Gesù compie hanno questa duplice valenza: rivelano il mistero di Dio perché nello stesso tempo purificano la fede degli uomini. Nei dialoghi del vangelo di Giovanni la rivelazione si attua sempre secondo questa dinamica, che ritorna puntualmente anche in questo racconto: «Il segno è la moltiplicazione dei pani, letta dalla folla e letta da Gesù: è nel contrasto tra queste due letture che si rivela chi è Gesù» (B. Maggioni).
La domanda che alla fine Gesù porrà ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?» (v. 67) deve essere l’interrogativo che sentiamo rivolto alla nostra stessa fede e può illuminare la lettura dell’intero dialogo, non solo delle sue battute conclusive. Certo, rispondiamo insieme a Pietro, vogliamo rimanere! Gesù ci ricorda tuttavia qual è la condizione per farlo davvero, senza andarsene altrove come accade ai più: accettare che la sua parola ci metta alla prova, ci purifichi, ci converta.
Nel testo che leggiamo in questa domenica la conversione si attua almeno a due livelli: è infatti relativa tanto al che cosa cercare quanto al come cercare. Il tema della ricerca è sollevato da Gesù stesso, che svela l’ambigua ricerca degli uomini: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati» (v. 26). È superficiale anche la domanda: «Rabbì, quando sei venuto qua?» (v. 25). Non è il quando, ma il da dove e il perché, ossia verso dove e a quale fine, che consente di capire chi sia davvero Gesù. Come mostrerà l’intero discorso, Gesù è colui che viene dal Padre per dare la vita al mondo, attraverso la sua carne offerta. «Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo» (v. 33). Solamente nell’orizzonte di questo movimento si capisce chi è Gesù. Egli discende dal cielo perché donato dal Padre, e viene per donare al mondo la vita stessa che riceve da Dio. Non è forse questo il sigillo che Dio, il Padre, ha posto sul Figlio? Il sigillo di un dono, che fa sì che il nostro desiderio di vita venga appagato non quando cerchiamo un pane che sazia la nostra fame, colmando il nostro bisogno, ma quando, nutrendoci di questo pane di vita che soltanto Gesù offre, anzi, che egli stesso è, ci lasciamo condurre da esso in una logica diversa. Quella del dono, secondo la quale saziarne il nostro desiderio di vita (la nostra sete, la nostra fame) ogni qualvolta, anziché preoccuparci di appagare i nostri bisogni, diventiamo a nostra volta capaci di prendere in mano la nostra esistenza per consegnarla nel gesto dell’offerta. La differenza che deve convenire la nostra ricerca non consiste tanto tra un pane materiale che colma una fame corporale e un altro genere di pane o di fame. La differenza sta nella logica diversa con cui ci rapportiamo alla nostra vita e a quella degli altri. Da una parte la logica vorace del possesso, dall’altra quella eucaristica e gratuita dell’offerta di sé. Per compiere il segno Gesù non aveva forse chiesto proprio questo ai discepoli? Che divenissero capaci di offrire tutto ciò che avevano, i duecento denari o quanto quel ragazzino poteva mettere a disposizione, perché la folla ricevesse tutto ciò di cui aveva bisogno? Questo è il pane che non perisce; un pane che dura perché ha la consistenza del dono di sé, che rimane, mentre al contrario presto svanisce o si imputridisce, come accadeva alla manna nel deserto, tutto ciò che tentiamo di possedere egoisticamente per noi e per il nostro vantaggio.
«Il pane della vita, sono io», afferma con decisione Gesù al v. 35, e «chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!». Andare a Gesù, entrare in comunione con lui attraverso l’unica opera che Dio ci chiede di compiere, la fede, significa per il discepolo assumere la sua logica, o meglio lasciarsi introdurre in quel movimento di consegna che Gesù vive: donato dal Padre al fine di essere dono per il mondo. La vita che, facendosi pane, Gesù ci comunica, è la vita eterna. Una vita che dura, rimane, perché condivide la qualità stessa della vita di Dio. È la vita del mondo di Dio, del suo modo di essere, tutto attraversato e contrassegnato dalla logica del dono di sé: il dono della vita che il Padre fa al Figlio, che il Figlio accoglie e non disperde per donarla a sua volta agli uomini.
Il «fate questo in memoria di me» che ripetiamo in ogni eucaristia assume in tal modo il suo spessore più vero. Ci nutriamo di questo pane di vita, che è Gesù, per divenire sua memoria vivente. Per saziarci di questo pane non dobbiamo fare molte opere o impegnare sforzi eccessivi: una sola è l’opera da compiere, la fede, come uno solo è il comandamento nuovo da vivere, l’amore (cfr. 13,34). La prospettiva di Giovanni è unitaria e unificante: c’è un solo pane di vita che ci sazia, il Signore Gesù; per entrare in comunione con lui è necessaria una sola opera, credere in lui, consentendo così alla vita che ci comunica di portare il suo unico frutto in noi, che è l’amore. In tal modo il dono che riceviamo non perisce, trattenendolo per noi stessi, ma rimane, come dono condiviso nella carità.
Preghiere e racconti
Il pane che ci unisce
Nello spezzare il pane insieme noi affermiamo la nostra condizione spezzata, anziché negare la sua realtà. Diventiamo più consapevoli che mai di essere presi, messi a parte come testimoni di Dio; di essere benedetti dalle parole e dagli atti della grazia; di essere spezzati, non per vendetta o per crudeltà, ma al fine di diventare un pane che può essere dato come cibo agli altri. Quando due, tre, dieci, cento o mille persone mangiano unite alla vita spezzata e versata di Cristo, esse scoprono che la loro stessa vita è parte di quell’unica vita e si riconoscono così a vicenda come fratelli e sorelle.
Vi sono pochi luoghi rimasti al mondo dove la nostra comune umanità può essere elevata e celebrata, ma ogni volta che ci riuniamo attorno ai semplici segni del pane e del vino noi abbattiamo molti muri e cogliamo un barlume delle intenzioni di Dio per la famiglia umana. E ogni volta che questo accade, siamo chiamati a preoccuparci maggiormente non soltanto del benessere dell’altro, ma anche del benessere di tutti nel mondo. Lo spezzare il pane dunque… ci mette in contatto con coloro il cui corpo e la cui mente è stata spezzata dall’oppressione e dalla tortura e la cui vita viene distrutta nelle prigioni di questo mondo. Ci mette in contatto con gli uomini, le donne e i bambini la cui bellezza fisica, mentale e spirituale rimane invisibile a causa della mancanza di cibo e di riparo…
Queste relazioni ci rendono davvero «uniti nel pane» e ci sfidano a operare con tutte le nostre energie per il pane quotidiano di tutti. In questo modo il nostro pregare insieme diventa un appello all’azione.
(Henri J.M. NOUWEN, Compassion, in ID., La sola cosa necessaria Vivere una vita di preghiera, Brescia, Queriniana, 2002, 197-198).
Quelli che mangiano di me avranno ancora fame
Dice la Sapienza: «Quelli che mangiano di me avranno ancora fame, quelli che bevono di me avranno ancora sete» (Sir 24,29). Cristo, Sapienza di Dio, non viene ora mangiato fino saziare il nostro desiderio, ma soltanto in una misura in cui rinnova il nostro desiderio di sazietà e più gustiamo la sua dolcezza, più il nostro desiderio viene ravvivato. Per questo quelli che lo mangiano avranno ancora fame, finché non giungeranno a sazietà. Ma quando il loro desiderio sarà stato colmato dai beni celesti, non avranno più né fame né sete (cfr. Ap 7,16). Le parole: «Quelli che mangiano di me avranno ancora fame» si possono intendere come riferite al mondo futuro perché c’è in questa sazietà eterna una specie di fame che non deriva dal bisogno, ma dalla felicità. Gli invitati al banchetto desiderano sempre mangiare e non si stancano di saziarsi. La sazietà non conosce fastidi e il desiderio sospiri. Cristo infatti, sempre ammirabile nella sua bellezza, è sempre pure desiderabile, lui «nel quale gli angeli desiderano fissare lo sguardo» (1Pt 1,12). Così pur possedendolo lo si desidera, e mentre lo si possiede lo si cerca come sta scritto: «Cercate sempre il suo volto» (Sal 104 [105],4). Si cerca sempre colui che si ama per possederlo sempre. Così quelli che lo trovano lo cercano ancora, quelli che lo mangiano ne hanno ancora fame, quelli che lo bevono ne hanno ancora sete. Ma questa ricerca elimina ogni preoccupazione, questa fame scaccia ogni fame, questa sete estingue ogni sete. Non è la fame dell’indigenza, ma della felicità raggiunta.
(BALDOVINO DI FORD, Il sacramento dell’altare 2,3, SC 93, pp. 252-254)
L’effimero non soddisfa
Che cos’è l’effimero? È ciò che il mondo produce e che offre alla tua fame, senza però poterla saziare. Sono i piaceri della vita, la gloria, il potere, la ricchezza e tutto ciò che popola la fiera delle vanità che gli uomini amano frequentare. Tuttavia non tutto ciò che è effimero è da condannare. Al contrario vi sono tante cose buone, il cui uso e possesso ci è donato dalla bontà del Creatore. La creazione stessa, benché sottoposta alla caducità, è un meraviglioso dono col quale l’Onnipotente desidera rallegrare le nostra vita qui sulla terra. Eppure le cose effimere, anche quando sono buone, possono trasformarsi in un pericolo per la nostra anima e in una illusione pericolosa nella nostra ricerca della felicità.
Come può accadere questo? Le cose effimere possono darti un’apparente sazietà e una falsa felicità. Il loro possesso ti soddisfa momentaneamente e ti illude di sentirti realizzato. Si tratta invece di una sensazione che dura poco, perché l’inquietudine, che sembrava assopita, si risveglia di nuovo e la fame riprende più vigorosa di prima. Quando ci si nutre di effimero non si è mai davvero sazi. La catena delle illusioni e delle delusioni si prolunga all’infinito, finché la corsa non si esaurisce, lasciando alla delusione l’ultima fatale parola. La bestia che è in noi «mai non empie la bramosa voglia e dopo ‘l pasto ha più fame che pria» (Dante, Inferno, I, 99). L’abilità del tentatore e quella di usare le cose finite, per quanto buone e belle possano essere, per trascinarti qua e là lungo le vie del mondo in modo tale che tu perda di vista la meta dell’eternità. Ti tiene al guinzaglio presentandoti il miraggio della felicità, senza però che tu possa assaporarne la realtà. La sua insuperabile astuzia consiste nel soffocare la tua fame di assoluto con l’abbondanza delle cose finite.
Gesù, dialogando con la donna samaritana, che aveva cercato nell’amore vagabondo di dissetare la sua sete di felicità, smaschera la tentazione e mette a nudo l’inganno del falsario: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete» (Gv 4,13) afferma mettendo il dito sulla piaga. Chi di noi potrebbe negarlo? Chi potrebbe affermare di essere felice col possesso di ciò che il mondo offre? Gesù è sicuro di quello che dice perché conosce come nessun altro il cuore dell’uomo. Lui, per mezzo del quale tutte le cose sono state fatte, sa bene che l’uomo è stato creato “capace di Dio” e che non può essere felice se non dissetandosi al suo amore. Perciò aggiunge subito dopo: «Ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete; anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente d’acqua che zampilla per la via eterna» (Gv 4,14). Dunque non l’acqua che si attinge fuori di noi, ma quella che zampilla dentro di noi è capace di dissetarci e di renderci felici. […] Sappi che non perderai affatto il piacere per le cose belle della terra. Anzi, le gusterai ancora di più, secondo la promessa del vero Maestro degli uomini: «cercate il regno di Dio, e queste cose vi saranno date in aggiunta».
(Padre Livio Fanzaga, Fa’ posto a Dio, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2009, 16-18).
Il pane vivo
Io sono il pane vivo disceso dal cielo (Gv 6,51). Vivo precisamente perché disceso dal cielo […] I fedeli dimostrano di conoscere il corpo di Cristo, se non trascurano di essere il corpo di Cristo. Diventino corpo di Cristo se vogliono vivere dello Spirito di Cristo. Dello Spirito di Cristo vive soltanto il corpo di Cristo. Fratelli miei, capite quello che vi dico? Tu sei un uomo, possiedi lo spirito e possiedi il corpo. Chiamo spirito ciò che comunemente si chiama anima, grazie alla quale sei un uomo; sei composto infatti di anima e di corpo. E così possiedi uno spirito invisibile e un corpo visibile. Ora dimmi: qual è il principio vitale del tuo essere? E il tuo spirito che vive del tuo corpo o è il tuo corpo che vive del tuo spirito? Che cosa potrà rispondere chi vive? È il mio corpo che vive del mio spirito. Vuoi tu vivere dello Spirito di Cristo? Devi essere nel corpo di Cristo. Forse che il mio corpo vive del tuo spirito? No, il mio corpo vive del mio spirito, e il tuo del tuo. Il corpo di Cristo non può vivere se non dello Spirito di Cristo. È quello che dice l’Apostolo, quando ci parla di questo pane: Poiché c’è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo (ICor 10,17) . Mistero di amore! Simbolo di unità! Vincolo di carità! Chi vuoi vivere ha dove vivere, ha di che vivere. Si avvicini, creda, entri a far parte del Corpo, e sarà vivificato. Non disdegni di appartenere alla compagine delle membra, non sia un membro infetto che si deve amputare. […] Rimanga unito al corpo, viva di Dio per Dio; sopporti ora la fatica su questa terra per regnare poi in cielo.
(AGOSTINO, Commento al vangelo di Giovanni 26,13, in Opere di sant’Agostino, pp. 608-610).
Preghiera
Grande è il tuo amore, o Dio!
Tu vuoi aver bisogno di uomini
per farti conoscere agli uomini,
e così leghi la tua azione e la tua parola divine
all’agire e al parlare di persone
né perfette né migliori degli altri.
Grande è il tuo amore, o Dio!
Non hai timore della nostra fragilità
e neppure del nostro peccato: l’hai fatto tuo,
perché fosse nostra la tua vita
che guarisce ogni male.
Grande è il tuo amore, o Dio!
Ancora rinnovi la tua alleanza
grazie a chi tra noi spezza il Pane di vita,
a chi pronuncia le parole del perdono,
a chi fa risuonare annunci di vangelo,
a chi si fa servo dei fratelli,
testimoni del tuo amore infinito
che rendono visibile il Regno.
Ti preghiamo, o Dio: fa’ che queste persone
non vengano mai meno!
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2002-2003; 2005-2006- .
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
———
– COMUNITÀ DI S. EGIDIO, La Parola e la storia. Tempo ordinario. Parte prima, Milano, Vita e Pensiero, 2012.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. II: Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011.
PER APPROFONDIRE:
XVIII DOM TEMP ORD ANNO B