
L’ascolto per il discernimento



Il secondo modulo 2012 del “laboratorio cultura e comunicazione” del Copercom, su “Anno della fede e comunicazione”, giunge a conclusione.
Mercoledì 5 dicembre, alle 21, l’ultimo appuntamento online sul tema “Fede, cultura e scienza dentro il frullatore digitale”.
Interverrà Ernesto Diaco, vice responsabile del Servizio nazionale per il Progetto culturale della Cei.Ecco la terza riflessione-guida del Papa (Lettera apostolica Porta Fidei): “La fede, infatti, si trova ad essere sottoposta più che nel passato a una serie di interrogativi che provengono da una mutata mentalità che, particolarmente oggi, riduce l’ambito delle certezze razionali a quello delle conquiste scientifiche e tecnologiche.
La Chiesa tuttavia non ha mai avuto timore di mostrare come tra fede e autentica scienza non vi possa essere alcun conflitto perché ambedue, anche se per vie diverse, tendono alla verità”.Per seguire la diretta basterà collegarsi in tempo reale al sito www.copercom.it e cliccare sul banner del laboratorio.
Per interagire con gli ospiti in chat (con domande o commenti) occorrerà inserire, quando richiesto, username e password.Per registrarsi, è sufficiente inviare un’email a info@copercom.it.
Nei giorni successivi sarà possibile rivedere l’intera puntata attraverso il Mediacenter del sito del Copercom, nella sezione dedicata ai Laboratori.

Globalizzare l’umano», cioè «far emergere la creaturalità di tutti e di ciascuno, che costituisce il fondamento di ciò che davvero può essere detto universale».
È la visione di mondializzazione proposta dalla dottrina sociale della Chiesa, per scongiurare una “ideologia” della globalizzazione, ovvero un «uso ideologico dei processi di globalizzazione».A ricordarla è il card. Angelo Bagnasco, Presidente della Cei, che ha aperto venerdì 30 novembre a Roma l’XI Forum del progetto culturale, sul tema “Processi di mondializzazione opportunità per i cattolici”.
Una «lettura unilaterale dei processi di globalizzazione» – ha affermato il Cardinale – «può essere pericolosa perché potrebbe giustificare una forma d’imposizione, a volte anche violenta, del globale sul locale», dando luogo a «un vero fraintendimento di ciò che l’umanità, grazie soprattutto all’elaborazione del pensiero cristiano, ha stabilito realmente universale: la dignità della persona, la salvaguardia della sua libertà, il rispetto della vita in ogni suo momento».«L’utile di una parte dell’umanità non può essere considerato il criterio per stabilire ciò che è bene di tutti», ha ammonito il Cardinale Presidente, secondo il quale «la globalizzazione dev’essere regolamentata secondo giustizia, evitando che si configuri come l’espressione d’interessi particolari imposti universalmente».
SCARICA DOCUMENTO:
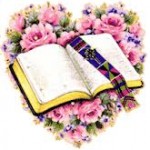
Prima lettura: Genesi 33,14-16
|
Ecco, verranno giorni – oràcolo del Signore – nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa d’Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia.
|
Il messaggio della prima lettura è più che un annuncio di calda speranza. La sua funzione è di completare la prospettiva escatologica del Vangelo e di richiamare anche il dato storico dell’incarnazione. Per noi che leggiamo la profezia di Geremia, le sue parole non sono più un semplice annuncio al futuro («verranno giorni… realizzerò… farò germo-gliare…»), ma la documentazione di un futuro che è diventato il presente della storia della salvezza. La Parola di Dio documenta che le promesse divine trovano un compimento e tale compimento è Cristo. Non sarà difficile la lettura cristologica di questo passo di Geremia.
Leggiamo di fatto in filigrana il passaggio dall’AT al NT: quello che poteva riferirsi a Davide e alla sua dinastia, appartiene in modo inequivocabile a Gesù di Nazaret, il più illustre discendente di Davide. L’oracolo rivela quindi un manifesto carattere messianico.
Il brano si trova nel contesto di un messaggio di consolazione e riprende l’oracolo di 23,5-6. Esso si compone dell’impegno di Dio a realizzare le sue promesse al popolo nel suo insieme (Israele e Giuda) e ciò avviene mediante la nascita di uno che, discendente da Davide, porterà la «salvezza».
Il termine chiave che ritorna tre volte è «giustizia». Isaia aveva dato a un bambino che doveva nascere il nome profetico di ‘Emmanuele’ (Dio con noi), Geremia quello di ‘Signore nostra giustizia’. In entrambi i casi si tratta di uno che avrà uno speciale rapporto con Dio, in quanto effettivamente realizzerà, e pienamente, la volontà divina, la ‘giustizia’. Il testo messianico prepara gli animi ad accogliere Gesù di Nazaret, colui che il NT ci dirà totalmente in comunione con Dio, da essere Lui stesso Dio in quanto Figlio.
La lettura nel suo insieme invita a coltivare la speranza, virtù non facilmente reperibile nel nostro mondo. Deve essere una speranza ‘teologale’, in quanto innervata nelle promesse divine e vissuta come gioiosa attesa dal popolo di Dio. In questo senso dà senso anche al tempo liturgico che stiamo vivendo.
Seconda lettura: 1Tessalonicesi 3,12-4,2
|
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio – e così già vi comportate –, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù.
|
La speranza e l’attesa si coniugano felicemente con l’impegno: si va incontro al Signore nell’esercizio sereno e quotidiano dei propri doveri sociali e cristiani. Tra tutti eccelle quello dell’amore.
Il brano comprende i versetti conclusivi della prima parte della lettera (capp. 1-3) e quelli iniziali della seconda (capp. 4-5). I versetti 12-13 creano un’atmosfera soffusa di preghiera e contengono due richieste per la comunità.
Nella prima Paolo domanda a Dio di appianare le difficoltà perché possa giungere a Tessalonica. È un desiderio, una sorta di augurio, bene espresso in greco dal modo ottativo che ha appunto questa sfumatura. Paolo non programma se non in comunione con la volontà divina che tutto dirige. E come precedentemente era stato Satana a bloccare il cammino verso la comunità (cf. 2,18), così ora solo Dio può concedere il raggiungimento dell’agognata meta. Il desiderio di Paolo rimane comunque aperto alle disposizioni della imperscrutabile volontà divina. È come se egli dicesse: «se, come, quando Dio vorrà». È giusto e doveroso che il missionario in servizio al Vangelo faccia dei progetti, ma è altrettanto vero che deve essere disposto a ribaltarli quando la divina Provvidenza ne proponga altri.
La seconda richiesta di preghiera tocca il cuore stesso della vita comunitaria. Paolo chiede un amore sovrabbondante, trabocchevole, perché poco amore non è ancora amore. La pienezza di amore riguarda sia l’interno, la comunità stessa, sia l’esterno, ‘rappresentato da quel «tutti» (v. 12) che abbatte inesorabilmente ogni frontiera ed ogni steccato divisorio. Solo un amore ‘a tutto campo’ permette di andare serenamente incontro al Signore. La preghiera si conclude con questa prospettiva escatologica, quasi a ricordare che solo da una visuale completa si capisce meglio la realtà.
Con una festosa immagine di luce termina la prima parte della lettera. Con 4,1 siamo in presenza di una nuova parte della lettera, come indicano chiaramente il contenuto ricco di esortazioni e il vocabolario corrispondente.
Incontro al Signore si va insieme, guidati da coloro che hanno una più matura esperienza di fede. Paolo è per la comunità di Tessalonica il padre spirituale, il maestro, il fratello e l’amico. Dato questo sottofondo, può impartire direttive del tipo «avete appreso da noi come comportarvi» (v. 1). Potrebbe sembrare presuntuoso da parte di Paolo presentarsi come modello, se non si conosce la situazione storica in cui operava. In un tempo in cui non esistevano testi scritti né tradizioni orali poiché la comunità era da poco fondata, l’unico riferimento concreto era l’apostolo con il suo insegnamento e comportamento. Egli non solo ha predicato il Vangelo, ma pure ha insegnato a incarnarlo nella vita quotidiana. Per questo motivo si offre a modello. Paolo sarebbe veramente presuntuoso se si ritenesse l’unico punto di riferimento, ma sa bene di essere solo una specie di specchio che riflette il Cristo; la formula completa compare in 1Cor 11,1: «Fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo».
La richiesta, di conseguenza, non disturba più il lettore, anzi, gli mostra una dimensione inedita dell’autorità, quella di proporsi agli altri quale esempio da imitare perché tutti insieme si possa «piacere a Dio». Ravvisiamo in questa espressione un principio fondamentale dell’agire morale che consiste nella sintonia con la volontà divina (cf. la «giustizia» della prima lettura).
Quando Paolo impartisce importanti direttive, svolge un ruolo profetico perché agisce da portavoce di Gesù Cristo; al pari della parola annunciata che era recepita come «Parola di Dio» (2,13), così ora le indicazioni comportamentali vengono «da parte del Signore Gesù» (v. 2). Paolo ha appreso dal Signore, vive la sua fede e la trasmette sotto forma di testimonianza. Egli va così incontro al Signore e sollecita a fare altrettanto.
Vangelo: Luca 21,25-28.34-36
|
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo».
|
Esegesi
Il brano è composto da due spezzoni (vv. 25-28: disastri cosmici e manifestazione gloriosa del Figlio dell’uomo; vv. 34-36: richiesta di vigilanza) del cosiddetto ‘discorso escatologico’, cioè che riguarda le ‘cose ultime’ (ta eschata in greco significa le realtà ultime, chiamate anche, alla latina, ‘novissimi’).
Il discorso si colora con tratti apocalittici. Il termine ‘apocalittico’ indica la rivelazione (dal greco apokalyptein: togliere il velo, rivelare) del giudizio divino, del mistero e della persona di Gesù. Può indicare un modo particolare di esprimersi caratterizzato dalla rivelazione di segreti riguardanti la fine dei tempi e il corso della storia. Poiché la descrizione è
spesso affidata a un linguaggio cifrato ricco di visioni e di simboli non raramente terrificanti, nel modo di esprimersi comune ‘apocalittico’ è divenuto sinonimo di ‘catastrofico’. Le espressioni devono essere capite nel loro significato, senza dimenticare la natura e gli artifici del linguaggio profetico apocalittico. Si tratta di un modo di comunicare, più che di
una precisa descrizione di eventi futuri. L’accenno agli sconvolgimenti cosmici e alle ‘guerre mondiali’ sono pezzi d’obbligo negli annunci profetici e rappresentavano le immagini più catastrofiche che la fantasia dell’uomo antico avesse a disposizione.
La distruzione ha effetto di trasformazione. A differenza del linguaggio popolare che intende ‘apocalittico’ solo come distruzione e basta, il mondo biblico intende la distruzione come il primo passo perché possa sorgere qualcosa di nuovo. È come l’abbattimento di una casa per costruirne una nuova. L’espressione «Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte» prepara ed è condizione perché si verifichi la novità che segue.
Infatti tutto il magma di angoscia e di negatività che precede (cf. anche la parte non registrata dal testo liturgico, per esempio i vv. 10-24), prepara ed è funzionale al grande annuncio dei vv. 27-28, cuore teologico del brano e principio ispiratore della odierna liturgia della Parola. Dopo aver ripreso un testo biblico di distruzione, quasi a voler cancellare un universo corrotto, si offre allo sguardo degli eletti la figura vittoriosa di Cristo: «Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria» (v. 27). Nel buio della negatività si accende la luce radiosa del Figlio dell’uomo che si manifesta «con grande potenza e gloria». È possibile una duplice lettura: quella legata al contesto del brano, di chiara matrice escatologica, e quella legata al tempo liturgico dell’Avvento che riattualizza la venuta storica di Gesù.
È un momento di grande gioia, non esplicitamente espressa, ma inclusa nelle due espressioni «risollevatevi e alzate il capo» e «la vostra liberazione è vicina». La venuta di Cristo trasforma radicalmente la storia, imprimendole il marchio positivo della novità da lui apportata. Con Lui e grazie a Lui nulla è perduto, tutto è sapientemente trasformato. Del giu-dizio e della sorte degli empi non si parla. Il discorso non culmina in una visione di giudizio, bensì in una consolante promessa per gli eletti. Si è smarrito il tono apocalittico, spesso tenebrosi e lugubre, e si è fatto spazio al tono del vangelo, lieta novella per tutti gli uomini.
All’azione di Cristo deve seguire l’impegno dei cristiani, richiamato dai vv. 34-36, il secondo spezzone del brano liturgico. Al fine di non edulcorare una realtà che rimane comunque difficile e per non lasciare gli uomini in una neghittosa attesa, il discorso vibra nella parte conclusiva sulle note dell’esortazione. Poiché la venuta di Cristo è il fatto conclusivo della storia, in quanto costituisce il termine del tempo e l’inizio definitivo dell’eternità, occorre essere saggi e vivere in operosa attesa. La saggezza sta proprio nel saper riconoscere i segni del tempo finale. L’impegno potrebbe essere riassunto nel duplice imperativo «Vegliate in ogni momento pregando». La venuta di Cristo non ci deve trovare distratti da mille cose inutili o, peggio, nocive. Vegliare è il modo storico di rispondere alla prima venuta di Gesù, la sua incarnazione. È un vegliare fatto di serena attività che rifugge dall’ansia nevrotica del futuro come pure da una dissennata irresponsabilità. È una attività in comunione con il divino, reso manifesto da quel «pregando» che Luca ama inserire con insistenza nel suo Vangelo e che anche qui mette ‘in più’ rispetto alla sua probabile fonte, il Vangelo di Marco.
Meditazione
I temi che caratterizzano la liturgia della Parola di questa prima domenica di Avvento si intrecciano simbolicamente con la prospettiva suggerita ai credenti dai testi scritturistici presentati nelle ultime domeniche del tempo ordinario. La visione che si apre al nostro sguardo è ancora quella del tempo e della storia colti nella loro fase finale, in relazione con il compimento della promessa di Dio, quella promessa di bene fondata sulla fedeltà del Signore al popolo di Israele… e gratuitamente estesa ad ogni uomo: «Ecco verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa di Israele… In quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto…» (Ger 33,14-15). Sono tempi e giorni, come ci ricorda il profeta Geremia, che verranno, e che dunque devono essere attesi nella pazienza e nella speranza, sapendo discernere fin d’ora i segni della salvezza veniente. La prospettiva che apre lo sguardo credente sugli ultimi tempi offre così una qualità singolare alla storia che l’uomo è chiamato a vivere, plasmando quegli atteggiamenti che ci permettono di camminare sul crinale del già e non ancora: la vigilanza, l’attenzione ai segni, la pazienza, il discernimento. È soprattutto la pericope di Luca ad aiutarci a focalizzare questa visione di fede sulla storia e sul suo compimento.
Pur rifacendosi al ricco immaginario apocalittico fornito dalla tradizione giudaica, la prospettiva del discorso escatologico di Gesù riportato in Luca non sembra eccessivamente preoccupata di fornire elementi di identificazione o criteri precisi di discernimento che permettano di intravedere l’approssimarsi del compimento della storia. Ciò che deve stare a cuore al discepolo è piuttosto il modo con cui si è chiamati a vivere in questa storia da credenti, tenendo sempre lo sguardo volto al compimento. Il credente può sempre cadere in due trappole: o la tentazione di una impazienza che tende ad anticipare il compimento o la rassegnazione di chi non aspetta più nulla, disimpegnandosi nella storia. Gli imperativi del discernimento (Lc 21,29-33), dell’attenzione (vv. 34-35) e della vigilanza orante (v. 36) sono un antidoto ad ogni pretesa o delusione di fronte al tempo, al suo scorrere e alle sue contraddizioni, e permettono di essere umilmente radicati e impegnati in questa storia nell’attesa di un compimento che è solo nelle mani di Dio. Si potrebbe dire che la qualità della presenza del credente nella storia è data, secondo il testo di Luca, da due movimenti. Il primo è caratterizzato dalla pazienza che permette di resistere nel tempo dell’attesa e custodire il cuore della propria vita da ciò che lo minaccia, radicati nella fedeltà di Dio alle sue promesse: «con la vostra pazienza (en te upomone) salverete la vostra vita» (Lc 21,19). Questo è l’atteggiamento che caratterizza il tempo della Chiesa, ponendo i credenti in continua tensione verso il Signore e impegnandoli a testimoniare nella storia il desiderio dell’incontro con il Veniente. Il secondo movimento, quasi contrapposto alla apparente staticità di una paziente attesa, si esprime in una sorta di liberazione, di ripresa di vita, di gioia: allora vedranno il Figlio dell’uomo venire… risollevatevi ed alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina» (vv 27-28). Di fronte agli eventi che annunciano un disfacimento di questo tempo e di questo mondo e che, generando angoscia e disperazione, rendono l’uomo incapace di guardare in faccia la storia per comprenderne il senso, colui che ha atteso il Figlio dell’uomo intuisce che tutto ciò che sta avvenendo orienta all’incontro. Il credente è chiamato a guardare con libertà e parresia, fiducia e desiderio il Volto del suo Signore che è vicino, anzi è invitato a scorgerlo già negli avvenimenti. Il tempo della pazienza è terminato; può alzarsi e riprendere la pozione dell’uomo libero. Ma ciò che permette il passaggio dalla pazienza alla liberazione, ciò che permette di comprendere questa storia è l’incontro con un Volto: il Volto di colui che «viene su una nube con grande potenza e gloria» (v. 27). È il Volto del crocifisso e risorto, del trafitto verso il quale ogni uomo è chiamato a volgere lo sguardo (cfr. Gv 19, 37), a rivelare il senso e il compimento della storia, di ogni storia: la storia, ogni storia è sanata e salvata dalle ferite di Colui che viene sulle nubi con grande potenza e gloria. È questa la promessa di bene e il germoglio giusto scorti da lontano dal profeta Geremia.
«Con la vostra pazienza salverete la vostra vita […] risollevatevi e alzate il capo… per comparire davanti al Figlio dell’uomo» (vv. 19.28.36). In queste espressioni del testo di Luca possiamo inoltre scorgere la dinamica della speranza, il faticoso cammino interiore che trasforma la vita del credente in spazio aperto, pronto all’incontro con il Veniente. È tuttavia necessario percorrere queste tappe per radicare la speranza nella propria vita, trasformarla in stile che da spessore alle relazioni e strappa l’esistenza al ripiegamento su di sé. Colui che dispera, si nega, perde la sua coesione interiore, abdica alla vita; il disperato è colui che non alza il capo, cioè non sa assumere la dignità propria dell’uomo. Nella parola di Gesù, invece, abbiamo tre volti della speranza, tre spazi che in progressione aprono all’incontro con il volto di colui che è la nostra speranza. Anzitutto la speranza permette di discernere la verità del tempo dell’attesa. È nella pazienza (nel senso etimologico del termine greco, «stare sotto un peso») che l’uomo può custodire integra e vera la propria vita; ma è la speranza a rendere l’attesa paziente tempo di discernimento, durante il quale, nonostante le contraddizioni (i colpi che tendono a spostarci e a far cambiare posizione), è possibile mettere a fuoco ciò che è veramente essenziale («le mie parole non passeranno»: v. 33). Chi sa dimorare nella pazienza, custodendo vigile la speranza, ha la forza di riprendere la posizione eretta, vincendo così ogni tentazione di ripiegamento. E questo è possibile perché all’orizzonte della propria esistenza, della storia (nonostante i segni contrari) scorge l’approssimarsi di ‘Colui che viene’. Se si è conservato sempre vigile lo sguardo del cuore sul volto luminoso del Risorto, allora si saprà riconoscerlo quando egli viene a liberarci. Infine, il frutto della speranza è la parresia, la piena fiducia, lo stare faccia a faccia con il Signore: lo sguardo del figlio che non ha più paura e sta in piedi, da persona pienamente liberata, davanti al suo Signore.
«Vegliate in ogni momento pregando…» (v. 36). Speranza e vigilanza diventano così i due percorsi essenziali su cui il credente cammina nel tempo. La speranza rende vigile la nostra vita, custodisce agile il nostro cuore, ravvivando in esso il continuo desiderio dell’incontro con il Veniente. E la vigilanza orante accresce in noi la speranza, nutrendo di essa ogni nostro desiderio. Un cuore non abitato dalla speranza e dalla vigilanza diventa pesante, ingombro di tante presenze che lo stordiscono.
E infine non si deve dimenticare che gli imperativi della pazienza, della vigilanza e della speranza assumono un orizzonte ecclesiale. Non sono rivolti semplicemente al singolo discepolo, ma alla comunità dei discepoli, alla Chiesa. E sulla qualità di testimonianza offerta da questi imperativi, la Chiesa gioca l’autenticità della sua presenza nel tempo e nella storia. Una Chiesa che sa attendere è una Chiesa viva: sa vivere in coscienza l’unicità e l’irripetibilità del tempo in cui è inserita; è capace di andare al di là di quello che fa, meno preoccupata di riempire con le sue opere gli spazi che la storia gli offre, quanto piuttosto preoccupata a far calare in essa il senso di una incompiutezza, di una speranza, di un cammino verso quella pienezza nell’incontro con il Veniente. «Ogni Chiesa deve lottare contro la tentazione di assolutizzare ciò che compie – ricorda Giovanni Paolo II nella Orientale Lumen 8 – e quindi di autocelebrarsi o abbandonarsi alla tristezza. Ma il tempo è di Dio, e tutto ciò che si realizza non si identifica mai con la pienezza del Regno, che è sempre dono gratuito… ».
Preghiere e racconti
Dio ci dona il suo tempo
Iniziamo oggi, con la prima Domenica di Avvento, un nuovo Anno liturgico. Questo fatto ci invita a riflettere sulla dimensione del tempo, che esercita sempre su di noi un grande fascino.
Tutti diciamo che “ci manca il tempo”, perché il ritmo della vita quotidiana è diventato per tutti frenetico. Anche a tale riguardo la Chiesa ha una “buona notizia” da portare: Dio ci dona il suo tempo. Noi abbiamo sempre poco tempo; specialmente per il Signore non sappiamo o, talvolta, non vogliamo trovarlo. Ebbene, Dio ha tempo per noi! Questa è la prima cosa che l’inizio di un anno liturgico ci fa riscoprire con meraviglia sempre nuova. Sì: Dio ci dona il suo tempo, perché è entrato nella storia con la sua parola e le sue opere di salvezza, per aprirla all’eterno, per farla diventare storia di alleanza. In questa prospettiva, il tempo è già in se stesso un segno fondamentale dell’amore di Dio: un dono che l’uomo, come ogni altra cosa, è in grado di valorizzare o, al contrario, di sciupare; di cogliere nel suo significato, o di trascurare con ottusa superficialità.
Tre poi sono i grandi “cardini” del tempo, che scandiscono la storia della salvezza: all’inizio la creazione, al centro l’incarnazione-redenzione e al termine la “parusia”, la venuta finale che comprende anche il giudizio universale. Questi tre momenti però non sono da intendersi semplicemente in successione cronologica. Infatti, la creazione è sì all’origine di tutto, ma è anche continua e si attua lungo l’intero arco del divenire cosmico, fino alla fine dei tempi. Così pure l’incarnazione-redenzione, se è avvenuta in un determinato momento storico, il periodo del passaggio di Gesù sulla terra, tuttavia estende il suo raggio d’azione a tutto il tempo precedente e a tutto quello seguente. E a loro volta l’ultima venuta e il giudizio finale, che proprio nella Croce di Cristo hanno avuto un decisivo anticipo, esercitano il loro influsso sulla condotta degli uomini di ogni epoca.
Il tempo liturgico dell’Avvento celebra la venuta di Dio, nei suoi due momenti: dapprima ci invita a risvegliare l’attesa del ritorno glorioso di Cristo; quindi, avvicinandosi il Natale, ci chiama ad accogliere il Verbo fatto uomo per la nostra salvezza. Ma il Signore viene continuamente nella nostra vita. Quanto mai opportuno è quindi l’appello di Gesù, che in questa prima Domenica ci viene riproposto con forza: “Vegliate!” (Mc 13,33.35.37). E’ rivolto ai discepoli, ma anche “a tutti”, perché ciascuno, nell’ora che solo Dio conosce, sarà chiamato a rendere conto della propria esistenza. Questo comporta un giusto distacco dai beni terreni, un sincero pentimento dei propri errori, una carità operosa verso il prossimo e soprattutto un umile e fiducioso affidamento alle mani di Dio, nostro Padre tenero e misericordioso. Icona dell’Avvento è la Vergine Maria, la Madre di Gesù.
InvochiamoLa perché aiuti anche noi a diventare un prolungamento di umanità per il Signore che viene.
Se andiamo alla ricerca di un motivo esemplare che possa ispirare i nostri passi, e dare agilità alle cadenze del nostro cammino in questo periodo che ci separa dal Natale, dobbiamo assolutamente rifarci alla Madonna. Lei è la Vergine dell’attesa, la Vergine dell’Avvento, la Madre dell’attesa.
Lo sapete che nel Vangelo, prima ancora che ci venga detto il suo nome, viene riferito un fremito d’attesa che ardeva nella sua anima? San Luca, prima ancora di dirci che «il suo nome era Maria» (Lc 1, 26), ci dice un’altra cosa: «In quel tempo l’angelo Gabriele venne mandato ad una ragazza promessa sposa ad un uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide» (Lc 1, 26-27).
«Promessa sposa», cioè fidanzata! Noi sappiamo che la parola fidanzata viene vissuta da ogni donna come un preludio di tenerezze misteriose, di attese. Fidanzata è colei che attende. Anche Maria ha atteso; era in attesa, in ascolto: ma di chi? Di lui, di Giuseppe! Era in ascolto del frusciare dei suoi sandali sulla polvere, la sera, quando lui, profumato di vernice e di resina dei legni che trattava con le mani, andava da lei e le parlava dei suoi sogni.
Maria viene presentata come la donna che attende. Fidanzata, cioè. Solo dopo ci viene detto il suo nome. L’attesa è la prima pennellata con cui san Luca dipinge Maria, ma è anche l’ultima. E infatti sempre san Luca il pittore che, negli Atti degli apostoli, dipinge l’ultimo tratto con cui Maria si congeda dalla Scrittura. Anche qui Maria è in attesa, al piano superiore, insieme con gli apostoli; in attesa dello Spirito (At 1, 13-14); anche qui è in ascolto di lui, in attesa del suo frusciare: prima dei sandali di Giuseppe, adesso dell’ala dello Spirito Santo, profumato di santità e di sogni.
Attendeva che sarebbe sceso sugli apostoli, sulla chiesa nascente per indicarle il tracciato della sua missione.
Vedete allora che Maria, nel Vangelo, si presenta come la Vergine dell’attesa e si congeda dalla Scrittura come la Madre dell’attesa: si presenta in attesa di Giuseppe, si congeda in attesa dello Spirito. Vergine in attesa, all’inizio. Madre in attesa, alla fine. E nell’arcata sorretta da queste due trepidazioni, una così umana e l’altra cosi divina, cento altre attese struggenti. L’attesa di lui, per nove lunghissimi mesi. L’attesa di adempimenti legali festeggiati con frustoli di povertà e gaudi di parentele. L’attesa del giorno, l’unico che lei avrebbe voluto di volta in volta rimandare, in cui suo figlio sarebbe uscito di casa senza farvi ritorno mai più. L’attesa dell’«ora»: l’unica per la quale non avrebbe saputo frenare l’impazienza e di cui, prima del tempo, avrebbe fatto traboccare il carico di grazia sulla mensa degli uomini. L’attesa dell’ultimo rantolo dell’unigenito inchiodato sul legno. L’attesa del terzo giorno, vissuta in veglia solitaria, davanti alla roccia. Attendere: infinito del verbo amare. Anzi, nel vocabolario di Maria, amare all’infinito.
E noi oggi di che cosa parliamo se non di Avvento, di attesa? Voi promettete fede al Signore e con i vostri sospiri, con i vostri sentimenti, con le vostre attese, ricevete le tenerezze misteriose che vi riserva: vigilanti, così come si vive il periodo del fidanzamento, con il tripudio interiore.
Un giorno le nozze dell’Agnello le celebreremo tutti quanti. Saremo tutti invitati, tutti protagonisti. Verrà questo giorno!
Nei tempi gelidi che stiamo vivendo, nell’appannamento dei nostri entusiasmi e nella tristezza dei nostri peccati, non possiamo sentirci mancare il coraggio, al punto da non annunciarvi queste cose con forza, per quanto possano sembrare lontane, utopiche. No, non sono utopie, sono invece i luoghi dove noi realizzeremo veramente la nostra felicità, il nostro bene. Questo vi annunciamo oggi!
Le ragazze che sono davanti a me, sono anche un po’ l’icona di quello che dovremmo essere: con l’abito bianco, con la lampada accesa, in attesa; disponibili non soltanto a tenere la lampada accesa, ma anche a conservare una riserva sufficiente di olio nei recipienti, al punto che quando qualcuno ci rivolge quella preghiera così implorante e così umana che dice: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!», noi possiamo rispondere non come le vergini prudenti: «No, perché non basta ne a noi ne a voi» (Mt 25, 9), ma: «Sì, vogliamo correre il rischio che non basti ne a noi ne a voi».
A voi che oggi non fuggite per la tangente dell’irreale, ma fate una scelta di concretezza, vorrei dire: «Amate il mondo e siate disponibili a dare l’olio alle lampade del mondo, perché anche il mondo possa attendere e possa vivere l’attesa».
Oggi non si attende più. La vera tristezza non è quando ti ritiri a casa la sera e non sei atteso da nessuno, ma quando tu non attendi più nulla dalla vita. E la solitudine più nera la soffri non quando trovi il focolare spento, ma quando non lo vuoi accendere più: neppure per un eventuale ospite di passaggio. Quando pensi, insomma, che per te la musica è finita. E ormai i giochi sono fatti. E nessun’anima viva verrà a bussare alla tua porta. E non ci saranno più ne soprassalti di gioia per una buona notizia, ne trasalimenti di stupore per una improvvisata. E neppure fremiti di dolore per una tragedia umana: tanto, non ti resta più nessuno per il quale tu debba temere. La vita, allora, scorre piatta verso un epilogo che non arriva mai, come un nastro magnetico che ha finito troppo presto una canzone, e si srotola interminabile, senza dire più nulla, verso il suo ultimo stacco. Attendere: ovvero sperimentare il gusto di vivere. Hanno detto addirittura che la santità di una persona si commisura dallo spessore delle attese. E forse è vero.
Oggi abbiamo preso, invece, una direzione un tantino barbara: il nostro vissuto ci sta conducendo a non aspettare più, a non avere neppure il fremito di quelle attese che ci riempivano la vita un tempo: quando, non so, aspettavi profumi di mosti, o il cigolare dei frantoi o il grembo di tua madre che si incurvava sotto il peso di una nuova vita, o i profumi dei pampini, degli ulivi, o il profumo di spigo, di mele cotogne. Forse sto scappando anch’io per le tangenti del sogno, però – dite la verità – è così standardizzata la nostra vita, è così incastrata nei diagrammi cartesiani che c’imprigionano e ci stringono all’angolo, che non sappiamo più aspettare. Intuiamo tutti che abbiamo una vita prefabbricata, per cui ci lasciamo vivere, invece di vivere.
Oggi l’Avvento c’impegna invece a prendere la storia in mano, a mettere le mani sul timone della storia attraverso la preghiera, l’impegno e starei per dire anche l’indignazione: indignatevi un po’, fratelli e sorelle! Indignatevi, perché abbiamo perso questa capacità; anche noi sacerdoti, anche noi vescovi, non ci sappiamo più indignare per tanti soprusi, tante ingiustizie, tante violenze… Tutto quello che viviamo ora, qui, non è solo una simbologia. Vorrei dirvi, cari fratelli, che questi ragazzi, Antonio e Stefano e poi Barbara e Francesca e Lorella e Miriam, devono diventare per noi una provocazione, uno scrupolo, una spina di inappagamento, messa nel fianco della nostra vita, un’icona, una «pro-vocazione», una chiamata da parte di chi sta un po’ più avanti. Con i gesti anche paradossali delle scelte audaci, ci stimolano ad essere uomini dell’attesa come Maria; ci spingono a non diffidare mai dei sogni, per essere capaci sempre di annunciare al mondo rovesciamenti da troni e innalzamenti dello stereo, come Maria, donna dell’attesa, che ha aspettato questa ricollocazione sui troni della giustizia per tutti coloro che, invece, vivono nel fetore delle stalle e nel sopruso degli egemoni, che schiacciano sempre la gente.
Attesa, attesa, ma di che? Che cosa aspettiamo?
Aspettiamo prima di tutto un cambio per noi, per la nostra vita spirituale, interiore, e poi avvertiamo che stiamo camminando su speroni pericolosi, su rocce che possono farci ruzzolare da un momento all’altro. Forse abbiamo assunto un modo non proprio allineato alla logica delle beatitudini.
Attesa quindi di rinnovamento per noi, attesa di rinnovamento per la storia dell’umanità. Attesa di cambi interiori della nostra mentalità: non siamo ancora capaci di pronunciare una parola forte per dire che la guerra è iniqua, che ogni guerra è iniqua! Ancora ci stiamo trastullando con i concetti della guerra giusta o ingiusta, o della difesa…
Abbiamo nelle mani il Vangelo della non violenza attiva, il codice del perdono, ma siamo ancora cristiani irresoluti, che camminano secondo le logiche della prudenza carnale e non della prudenza dello Spirito. Siamo gente che riesce a dormire con molta tranquillità, pur sapendo che nel mondo ci sono tante sofferenze. Sopportiamo facilmente che, all’interno della nostra città, col freddo che fa, le stazioni siano assediate da terzomondiali o da persone che vivono allo sbando, che non hanno più progetti.
Macché fidanzamento, che sogni, che attese di sandali, che profumi di vernice o di santità! Molta gente odora soltanto della tristezza dei propri sudari.
Fratelli e sorelle, vergini fidanzate, provocate questa gente! Oggi ci sono tante fotografie per voi, tanti lampeggiamenti di flash; sarebbe molto bello che ognuno di voi, con il suo obiettivo allargato, imprimesse la provocazione di un’attesa di cieli nuovi e terre nuove. Anche tu, Stefano, che ti accingi ad entrare nel consesso presbiterale; e tu, Antonio, che ci sei già entrato, che sei già lettore e annunci la parola di Dio e da oggi tocchi anche le patene, le pissidi: tocchi quello che sarà il corpo vivente del Signore. Questo contatto con i vasi sacri, col grano fatto pane, con l’uva fatta vino, ti mette in rapporto con il cosmo, con questa realtà materiale, toccabile, perché il regno di Dio viene costruito non con i fumi delle nostre utopie ma con le pietre che vengono scavate nelle cave della storia, della terra. Scommetto che anche il pane che si mangia nel cielo è intriso delle acque della nostra terra e del grano che viene prodotto dai nostri campi!
Buona attesa, dunque. Il Signore ci dia la grazia di essere continuamente allerta, in attesa di qualcuno che arrivi, che irrompa nelle nostre case e ci dia da portare un lieto annuncio!
(Don Tonino Bello, Avvento e Natale. Oltre il futuro, Padova, Messaggero, 2007, 45-54).
Fratelli carissimi, dovete sapere che questo tempo beato che noi chiamiamo «Avvento del Signore» evoca due realtà e, dunque, duplice deve essere la nostra gioia, poiché duplice è anche il guadagno che ci deve portare. Questo tempo evoca le due venute del nostro Signore: quella dolcissima venuta in cui il più bello dei figli dell’uomo (Sal 44 [45], 3), il desiderato da tutte le genti (Ag 2,7 Vg), vale a dire il Figlio di Dio, si manifestò visibilmente nella carne a questo mondo, lui a lungo atteso e desiderato ardentemente da tutti i padri; ciò avvenne quando egli venne in questo mondo a salvare i peccatori. Ma questo tempo evoca anche l’altra venuta che dobbiamo aspettare con una solida speranza e che dobbiamo ricordare spesso tra le lacrime, il momento, cioè, in cui il nostro Signore, che dapprima era venuto nascosto nella carne, verrà manifestamente nella sua gloria, come canta il salmo: Dio verrà manifestamente (Sal 49 [50], 3), cioè il giorno del giudizio, quando verrà manifestamente per giudicare […]. Giustamente la chiesa ha voluto che in questo tempo si leggessero le parole dei santi padri e si ricordasse il desiderio di quelli che vissero prima della venuta del Signore. Non celebriamo questo loro desiderio per un solo giorno, ma per un tempo abbastanza lungo, poiché di solito quando desideriamo e amiamo molto qualcosa, se accade che essa viene differita per un qualche tempo, ci sembra più dolce ancora quando giunge.
Seguiamo, dunque, fratelli carissimi, gli esempi dei santi padri, proviamo il loro stesso desiderio, e infiammiamo i nostri cuori con l’amore e il desiderio di Cristo. Dovete sapere che è stata stabilita la celebrazione di questo tempo per rinnovare in noi il desiderio che gli antichi santi padri avevano riguardo alla prima venuta del Signore nostro e dal loro esempio impariamo a nutrire un grande desiderio della sua seconda venuta. Dobbiamo pensare a quante cose buone ha fatto il Signore nostro nella sua prima venuta e a quelle ancor più grandi che farà nella seconda e con tale pensiero dobbiamo amare molto la sua prima venuta e desiderare molto la seconda.
(AELREDO DI RIEVAULX, Discorsi 1, PL 195,209A-210B).
Nell’antico Testamento la Bibbia parla del mondo come della creazione buona di Dio e come del mondo dell’uomo, un mondo che Dio tiene in mano e che trasformerà nel suo mondo definitivo. Tuttavia già l’Antico Testamento sa che il mondo è incrinato, che in esso è presente il peccato, che esistono l’odio e la discordia. Secondo il punto di vista pessimistico del Qohelet, il mondo si muove in un circolo di delusione e di oppressione. I profeti interpretano il mondo a partire dalla sua fragilità, ma annunciano contemporaneamente un mondo rinnovato da Dio, un mondo colmo di giustizia e di pace.
Anche nel Nuovo Testamento incontriamo questa doppia concezione. Paolo e Giovanni interpretano il mondo in modo piuttosto negativo. Per Giovanni, il mondo si è rifiutato di credere in Gesù. È, quindi, un mondo che rimane buio, non illuminato. Parla di “questo” mondo, che si chiude di fronte a Dio. Ma contro questo mondo chiuso la fede vuole erigere un mondo opposto, nel quale Dio governa e illumina ogni cosa, nel quale l’amore di Dio permea ogni cosa. Per Paolo, il mondo è connotato soprattutto dal peccato. Ed è solo un mondo temporaneo, che il cristiano deve sopportare fino a quando Cristo presenterà il nuovo mondo. Il mondo è il luogo in cui viviamo. In esso riconosciamo la bellezza della creazione. Ma contemporaneamente il mondo è il luogo in cui ci dovremmo affermare. Dovremmo vivere nel mondo, senza lasciarci condizionare dal mondo. Viviamo piuttosto nel mondo come coloro che hanno la loro vera origine in Dio e che, quindi, plasmano e organizzano il mondo in modo tale che diventi degno di essere vissuto per tutti. Abbiamo una responsabilità verso questo mondo. Non possiamo sfruttarlo, ma dovremmo averne cura in modo tale che anche le generazioni future possano vivere bene in esso.
Se il mondo sia un luogo buono è, quindi, una domanda rivolta a noi stessi. Infatti, se sia un luogo buono per le generazioni che ci seguiranno dipende, non da ultimo, dal modo in cui lo lasceremo a loro.
(Anselm GRÜN, Il libro delle risposte, Cinisello Balsamo (MI), San Paolo, 2008, 181-182).
Signore del giorno e della notte,
Dio del cielo e della terra,
si avvicina l’ora della tua venuta.
Non lasciarci intorpidire in un’attesa sonnolenta.
Desta i nostri cuori alla Parola
che non cessi di rivolgerci
attraverso i secoli dei secoli.
Padrone dello spazio e del tempo,
nostro Dio, nostro Padre,
non lasciarci riaddormentare:
rendici attenti all’occasione di salvezza che ci offri,
a questi segni incipienti del Regno del tuo Figlio
che vive presso di te e tra noi
ora e sempre.
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
———
– COMUNITÀ DI S. EGIDIO, La Parola e la storia, Milano, Vita e Pensiero, 2012.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– R. FERRIGATO (ed.), Avvento e Natale 2012. Sussidio liturgico-pastorale, Milano, San Paolo, 2012.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– Don Tonino Bello, Avvento e Natale. Oltre il futuro, Padova, Messaggero, 2007.
PER APPROFONDIRE

“Cari genitori, studenti e docenti, ci rivolgiamo a voi consapevoli che l’Irc è un’opportunità preziosa nel cammino formativo, dalla scuola dell’infanzia fino ai differenti percorsi del secondo ciclo e della formazione professionale, perché siamo convinti che si può trarre vera ampiezza e ricchezza culturale ed educativa da una corretta visione del patrimonio cristiano-cattolico e del suo peculiare contributo al cammino dell’umanità”.La Presidenza della CEI, nel messaggio in vista della “preziosa opportunità” di avvalersi dell’Irc nel prossimo anno scolastico, ricorda che “la scuola sarà se stessa se porterà le nuove generazioni ad appropriarsi consapevolmente e creativamente della propria tradizione”.
SCARICA IL TESTO DEL MESSAGGIO:

Un aiuto alle comunità a “sprigionare la forza viva della liturgia, suggerendo strumenti e modalità per una celebrazione sobria, autentica e profonda”.
Così S.E. Mons. Crociata presenta il sussidio per il tempo di Avvento e di Natale del nuovo Anno liturgico, che inizia domenica 2 dicembre. Come già lo scorso anno, si tratta di una versione soltanto digitale: “L’annuncio del Vangelo e la condivisione degli strumenti pastorali si servono anche delle nuove tecnologie: la forza creativa dello Spirito ci spinge a orientare i mezzi di cui disponiamo alla comunicazione e all’educazione, per una crescita autentica delle persone”.
Nell’introdurre il sussidio, il Segretario Generale spiega come “l’Anno della Fede ci inviti a riscoprire la gioia del credere: a questo mirano in particolare le catechesi per gli adulti, che recuperano i temi del Catechismo della Chiesa Cattolica, associandoli alla liturgia festiva”. Un’attenzione particolare è data alla pastorale familiare, all’intimo legame tra fede e carità, alla pratica della missionarietà.
Don Franco Magnani, direttore dell’Ufficio Liturgico Nazionale, rilegge a sua volta il percorso dell’Avvento a partire dal brano evangelico della Visitazione, quale filo che “ci consente di recuperare soprattutto la dimensione della gioia”.

Prima lettura: Daniele 7,13-14
|
Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d’uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto.
|
La visione del Figlio dell’uomo in Dn 7,13ss chiude la prima visione apocalittica del nostro libro. La si trova al centro del c. 7 e poi alla fine della spiegazione dei simboli (7,26s). Nella prima parte, sotto lo sguardo profetico del veggente, si svolge la paurosa attività delle 4 bestie simboliche, che salgono dalle acque del mare mosse dai 4 venti. Esse rappresentano 4 famosi re, che dalle descrizioni sembrano identificarsi con l’impero babilonese («terribile leone dal cuore d’oro»), con l’impero medo («orso che divora Babilonia»), con il persiano («leopardo» dalle 4 teste di regnanti), con il greco («mostro dai denti di ferro, che tutto
stritola» assieme al tiranno che combatte contro i Santi di Dio, probabilmente l’empio Antioco IV del 168 a.C. persecutore dei pii Giudei).
Si trattava di eventi del passato collegati alla situazione contemporanea, visti secondo la nota concezione apocalittica: l’agitarsi delle acque primordiali, da cui provengono le forze del male, sotto il vigile controllo della ruah, lo spirito di JHWH, come in Genesi 1,1-2; governanti e imperi si muovono quali strumenti dell’onnipotente Dio d’Israele.
Lo dimostra l’improvvisa apparizione di un Vegliardo che, circondato da miriadi di esseri celesti, siede sul trono a giudicare le 4 bestie, togliendo loro ogni potere e condannandole alla morte. A questo punto irrompe la scena del nuovo sovrano dei popoli.
v. 13: «ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d’uomo». Il personaggio viene dall’alto, e non più dagli abissi dell’oceano; è un essere dalle sembianze umane, non ben definite, superiori a quelle di un semplice mortale; non più sotto il simbolo di bestie mostruose e feroci… Egli è come l’angelo-principe di una grande nazione (10,13).
v. 14: «Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano». A lui sono affidati i poteri regali su tutte le nazioni della terra: un regno che non vedrà mai il tramonto. Nella prospettiva del messianismo escatologico reale rappresenta l’intervento definitivo del Dio d’Israele sulle vicende della storia, proiettato in un futuro indeterminato
(l’eschaton), l’‘ahar, il seguito degli anni nella forma di un governo collettivo, consegnato al «resto santo» del popolo prediletto, i Santi dell’Altissimo. Non si esplicita se esso sarà di tipo terreno o spirituale. Si dichiara però che sia il rappresentante ideale (il figlio dell’uomo), sia la sua sovranità vengono dall’alto, proprio come la piccola pietra che si stacca dal monte e annienta le potenze del male (Dn 2,45).
Vi si intravede la figura personale di un Inviato dal Signore Onnipotente, già delineato negli scritti dell’epoca giudaico-maccabeica (Parabole di Enoc, del 95 circa a.C.): considerato come «Re celeste, assise presso la gloria divina, che dovrà un giorno rendersi manifesto,
quale giudice del cielo e della terra, dei vivi e dei morti». È il Messia del giudizio universale, che in Mt 25,31 ss assegnerà a ogni uomo la sorte eterna in base al comandamento del sincero amore fraterno, e dirà l’ultima parola su tutta la storia dell’umanità: «gli rispose Gesù: Anzi io vi dico: d’ora innanzi vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra di Dio e venire sulle nubi del cielo» (Mt 26,64).
Seconda lettura: Apocalisse 1,5-8
|
Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, Amen! Dice il Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga, Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente!
|
Siamo all’inizio della grande rivelazione profetico-apocalittica di Giovanni. Dopo il breve prologo (1,1-3) in cui si presenta il tema di tutta l’opera: — esposizione dei mirabili eventi prossimi ad accadere, così come l’autore li ha appresi da Cristo, a utilità di chi legge e ascolta —, si entra immediatamente in dialogo con le 7 chiese della cristianità d’Asia, a cui saranno indirizzate le 7 epistole (cc. 2-3), dettate dal Figlio dell’uomo, il Vivente in eterno, apparso a Giovanni in estasi (1,9-17).
Il veggente si introduce con un saluto ai destinatari e con l’augurio di «grazia e pace» da parte di Colui che è, era e viene (il Padre divino), dei 7 Spiriti che stanno davanti al suo trono (Lo Spirito, cioè, con i suoi 7 doni, che da Lui proviene), e di Cristo Gesù. Di questi in particolare vengono esaltate le eccelse prerogative in 3a persona (vv. 6-7) e più direttamente in 1a persona (v. 8).
v. 5a: «Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra». Son i titoli della grandezza di Gesù, visto nel suo ruolo di rivelatore supremo delle realtà divine («testimone fedele»), protagonista della storia salvifica (il «primo» a risorgere), dominatore delle vicende umane (signore dei signori).
vv. 5b-6: «A Colui che ci ama e ci ha liberati… a lui la gloria e la potenza». Al richiamo di quei titoli sgorga dal cuore del profeta una elevata dossologia: — egli è colui che per amore ci ha lavati nel suo sangue, purificandoci dai nostri peccati e facendo di noi (ormai uniti vitalmente a Lui) una comunità sacerdotale di fronte al resto dell’umanità, per la lode di Dio suo Padre; a Lui si renda ogni onore e gloria per sempre…
v. 7: «Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà». Egli è il maestoso Personaggio, già contemplato da Daniele e annunziato dallo stesso Maestro divino nel processo di Caifa (MC 14,62), a cui è conferito ogni potere in cielo e in terra, dinanzi al quale compariranno un giorno tutte le genti, anche coloro che lo hanno trafitto, perché ne siano giudicati (Zc 12,9).
v. 8: «Io sono l’Alga e l’Omega… Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente!». Ora parla lo stesso Gesù: — Egli non è il trasumanato eroe esaltato dalle mitologie orientali, ma Colui che è Principio e Fine di tutte le cose, Alfa e Omega cioè Colui che comprende e supera tutto ciò che esiste o è pensabile, che è (JHWH), che era ab aeterno, che viene in ogni epoca e si presenta sempre a nuovo nelle sue manifestazioni e nelle sue gesta, mai pienamente definibile dalla mente umana; centro e ragione d’essere di tutti gli avvenimenti che seguiranno, meta gloriosa dell’umanità e dell’universo! —.
Vangelo: Giovanni 18,33b-37
|
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».
|
Esegesi
Il tratto di Gv 18,33-38a è la parte centrale del processo di Gesù dinanzi a Pilato (18,28-19,16). I capi dei Giudei che hanno deciso per conto loro di mandare a morte Gesù lo hanno condotto presso il tribunale del procuratore romano, perché sia lui a pronunziare la sentenza definitiva, quale detentore supremo del jus gladii (il diritto di vita e di morte sui sudditi di Roma). Dopo aver essi dichiarato che il Rabbì di Galilea, secondo il loro giudizio, era un trasgressore della legge e reo di morte. Pilato rientra nel pretorio per interrogare Gesù e rendersi personalmente conto della colpevolezza di Gesù (18,28-33): era nel suo diritto.
Qui l’evangelista Giovanni riporta il luminoso dialogo tra il Maestro divino e il rappresentante della potenza pagana. Il discepolo vi ha impresso qualche barlume della sua intima comprensione del Cristo: ne ha fatto l’epifania della sua Regalità divina.
v. 33: «Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» L’interrogatorio comincia con la chiara accusa dei capi giudei: Gesù avrebbe preteso di essere uno dei seducenti Messia, pretendente alla guida del suo popolo (Lc 23,3). «Gesù il nazareno, il re dei Giudei»: sarà il titolo posto sulla croce per ordine dello stesso Pilato (19,19).
v. 34: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Gesù, prima di rispondere, vuole chiarificare in che senso il governante di Roma intendeva quel titolo: nel senso del popolo giudaico che aspettava la venuta di un Messia, leader religioso inviato dall’alto, ovvero nel senso di un condottiero politico liberatore dal giogo straniero, come poteva immaginarlo un romano? Pilato parlava secondo la concezione degli ebrei, o secondo la propria mentalità?… Il procuratore respinge quasi con sdegno la prima ipotesi. Non gli interessava proprio nulla delle credenze di quella gente: «Sono forse io Giudeo?». A lui preme sapere se davvero quell’imputato ha commesso le gravi trasgressioni per cui i suoi connazionali lo hanno sottoposto al suo giudizio! E conclude: «che cosa hai fatto»? (v. 35).
v. 36: «Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo». Il divin Maestro ora può parlare liberamente e illustrare la sua reale posizione di fronte al tribunale di Roma. Egli poteva rassicurare il rappresentante dell’impero, dicendo di non aver fatto nulla, né contro l’ordine sociale, né contro l’autorità dei Cesari accettata dal suo popolo (Lc 20,20-26), ma ha preferito attirare l’attenzione di quell’uomo a qualcosa di più profondo e convincente: la caratteristica incontrovertibile della sua Persona, quella che Giovanni ha già molte volte sottolineato nel suo racconto: la trascendenza del messaggio di Cristo.
Egli promuove un regno che non appartiene all’ordinamento di questo mondo visibile (8,23), poggiato sulla forza delle armi e del consenso popolare. Il governatore lo può ben constatare: non c’è alcun suo fautore che lo difenda contro le ingiuste accuse dei suoi avversari (18,8.11).
v. 37: «Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re». All’insinuazione, sembra un po’ ironica di Pilato: «e allora saresti Re, tu?» «tu così solo e improvviso?» (trad. ad litt. dal greco), il divino accusato prosegue: — Io sono realmente Re, nel senso che ti ho indicato, e sono venuto al mondo per testimoniare quel che ho visto e conosco (3,13; 8,23; 19,35): la realtà di un altro mondo, una realtà soprasensibile, che supera tutte le cose e le concezioni di quaggiù; realtà percepibile da chi è pronto ad accettare la Verità. Chi infatti è aperto alla verità riconosce la mia voce (10,3) e mi segue (3,31-36; 1 Gv 19,18-20). Il mio sarà così un regno nuovo, senza violenza e soprusi di alcun genere, basato solo sulla libera accoglienza del Trascendente, che è presso di ognuno e si rivela attraverso la mia parola (8,26).
Siamo al centro di tutta la Rivelazione del Verbo divino fattosi uomo, così come si presenta nel quarto Vangelo: il Verbo che risplende tra le tenebre e manifesta a tutti la verità dell’Amore infinito del Creatore, e aggrega, chiunque vi aderisce, alla sua stessa vitalità eterna e consostanziale col Padre; si rimane nel mondo, ma non si è più di questo mondo (17,11.16).
Pilato, tuttavia, è ancora lontano da quella verità, e se ne esce con una battuta: «ma cos’è la verità?» (18,38a).
Meditazione
Con questa domenica si chiude l’anno liturgico. Tra sette giorni la Liturgia della Chiesa inviterà i credenti ad iniziare un nuovo tempo di preghiera e di memorie sante. Non si tratta semplicemente di un ciclo temporale che si aggiunge ad altri calendari (scolastico, solare, giudiziario, amministrativo, e così via). Il tempo liturgico è altro da quello ordinario o da quelli stabiliti dagli uomini. È, infatti, un tempo nel quale non siamo noi, o le vicende di questo mondo, a decidere le scadenze e a segnare i ritmi e gli obiettivi, come sempre accade. Nel tempo liturgico siamo noi ad essere guidati: veniamo, infatti, come sottratti alla normalità delle nostre abitudini e delle nostre preoccupazioni per essere inseriti in un altro ritmo temporale: quello di Gesù. Sono le pagine del Vangelo a scandire il tempo dell’anno liturgico perché i credenti, strappati dal tempo dei propri affari, siano trasportati dentro la storia stessa di Gesù, divenendo così suoi contemporanei. Da Natale a Pasqua sino a Pentecoste siamo chiamati a stare accanto a Gesù che nasce, che cresce, che predica e che guarisce percorrendo le strade e le piazze della sua terra, che soffre e che muore sulla croce, che però risorge, che ascende al cielo e che manda lo Spirito Santo sulla Chiesa inviando i discepoli sino agli estremi confini della terra. L’anno liturgico, insomma, è Cristo stesso («annus est Christus», diceva l’antica saggezza cristiana) che ci viene donato.
In questo singolare «anno» non si commemora un assente, ricordando magari con affetto i momenti salienti della sua vita. Si tratta, invece, di una realtà ben più profonda: la memoria liturgica rende presente in mezzo a noi il mistero stesso che celebriamo. Nell’anno liturgico trascorso di domenica in domenica siamo stati presi per mano dalla Santa Liturgia e portati appunto accanto a Gesù, dentro la sua vita, seguendolo passo dopo passo in tutto il suo itinerario verso il Padre che sta nei cieli. E così accade ogni anno. Ma non è una stanca ripetizione. Se gli «anni liturgici» continuano a ripetersi, è perché non termina mai la nostra condizione di discepoli, ossia di seguaci del Signore. Abbiamo sempre bisogno di riascoltare la Parola di Dio e di riprendere a seguire Gesù perché cresciamo con lui «in sapienza, in età e in grazia», come scrive Luca. Il Vangelo che viene annunciato in questa domenica ci porta vicino al Signore, unico pastore della nostra vita, perché noi ascoltandolo lo seguiamo e seguendolo lo amiamo.
Quest’ultima domenica dell’anno liturgico fa celebrare ai credenti la festa di Gesù Cristo, re dell’universo. È la festa della Sua signoria sul mondo, sul creato, sugli uomini, sulla storia. È una domenica che viene per così dire a coronare tutta la vicenda di Gesù e della stessa storia umana. È la festa in cui contempliamo Cristo nella pienezza della sua signoria sul creato. Ma il paradosso di questa festa sta nel fatto che mentre vediamo Cristo, come re dell’universo, il Vangelo ce lo presenta umiliato, ridicolizzato, sconfitto. Questo stridente contrasto porta a chiederci: ma che re è il nostro? Che regalità è la sua? E che regno è quello su cui governa? È lo scetticismo di Pilato di fronte all’affermazione di coloro che gliela avevano condotto perché lo condannasse. Infatti, chiede incuriosito: «Tu sei il re dei giudei?». L’aspetto arrendevole e modesto di Gesù, era ben lontano da quello di un sobillatore capace di mettersi alla testa di una banda armata. Eppure, Gesù non nega l’affermazione fatta da Pilato: «Tu lo dici, io sono re!». Ma, per chiarire il senso di questa affermazione, aggiunge immediatamente: «Il mio regno non è di questo mondo». E ne porta una prova lampante: «Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei». È tutto vero, anche se viene da pensare che quei pochi amici che pure aveva, non solo non lo hanno difeso, al contrario lo hanno abbandonato dandosi alla fuga; solo uno ha tentato la difesa con un colpo di spada, ma si è attirato una dura reprimenda da parte di Gesù. Il Maestro, il pastore resta solo. Ma che re è? Certo, non lo è alla maniera di questo mondo. E lo dice con chiarezza: «il mio regno non è di questo mondo». In quattro righe questa affermazione è ripetuta per ben due volte: «Il mio regno non è di quaggiù». La sua regalità non trae origine dal mondo, non poggia sul consenso della gente (fosse anche da un ampio consenso democratico) e non dipende dalle sue qualità; essa viene dall’alto, da Dio. I profeti avevano preannunciato l’avvento di questo nuovo re. La profezia di Daniele riportata nella prima lettura della Liturgia parla infatti di «uno, simile a figlio d’uomo» che appare sulle nubi del cielo e che riceve dal «vegliardo» il «potere, la gloria e il regno». E la visione continua con una scena grandiosa: «Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano; il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto». La visione del profeta Daniele si consuma nella sua pienezza nel regno di cui parla Gesù, un regno che viene dal cielo e per questo eterno e indistruttibile. Ma non è lontano ed estraneo alla terra.
Al contrario, pur non essendo del mondo, il potere di Cristo si esercita sulla terra e nella storia degli uomini. E Pilato a suo modo lo capisce, tanto che conclude: «Dunque, tu sei re?». È come dire che l’accusa rivolta a Gesù è giusta. Ed in effetti Gesù afferma che è venuto nel mondo proprio per «rendere testimonianza alla verità». E aggiunge: «Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce!». La verità di cui Gesù parla non sono principi logici astratti o idee belle da contemplare. La verità è una storia, ossia la storia dell’amore di Dio per gli uomini. Egli, come scrive Giovanni nel suo Vangelo: «ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui» ( Gv 3,16-17). Gesù è il volto concreto dell’amore di Dio, il volto concreto della Verità, il testimone della inimmaginabile «passione» di Dio per gli uomini. È vera regalità quella di Gesù, anche se agli occhi del mondo è davvero strana. Egli regna dal pretorio, ma stando dalla parte dello sconfitto. Egli si erge a maestro autorevole, ma stando dalla parte degli imputati. Il suo potere è la forza dell’amore, è la forza della misericordia, della compassione e della mitezza. Così Egli governa i cuori degli uomini e la loro storia. L’amore appare debole agli occhi degli uomini, ma è forte agli occhi di Dio. È una forza reale. Del resto Gesù lo ha detto fin dall’inizio della sua missione sul monte delle Beatitudini: «Beati i miti, perché erediteranno la terra» (Mt 5,5). La terra non è dei violenti, ma dei miti, dei misericordiosi. La vera grandezza, la vera regalità, il vero potere, sta nel lasciarsi conquistare dalla «verità» di Dio, ossia dal suo sconfinato amore che giunge sino a dare la vita per gli uomini. Di questo amore ha bisogno il mondo. Perché l’amore sconfigge ogni male, compresa la morte. In questa domenica che chiude l’anno liturgico, la Chiesa ci fa vedere la conclusione della storia: Gesù trionfa sul male e instaura il regno dell’amore. Giovanni, come a descrivere la liturgia celeste di questa domenica, ci apre uno spiraglio sul cielo: «Ecco, viene son le nubi del cielo e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto».
Preghiere e racconti
«Credo che la nostra maturità umana dipende dalla capacità di unificare noi stessi e il nostro sguardo sulla realtà. Altrimenti rischiamo di rimanere preda di un molteplice illusorio, di verità, libertà, parole…»
Esercizio non facile in una società multiculturale come quella in cui viviamo, dove si incrociano esperienze, tradizioni e religioni diverse e dove chi parla di una sola verità rischia di essere o di apparire un integralista. «Senza dubbio questo rischio c’è – ammette don Ignazio -, ma la verità di cui parlo io è la verità dell’indicibile. Quando la verità è dicibile c’è molta difficoltà a definirla come l’unica verità. La verità unica è quella che parla a tutti e quando non riesce a farlo bisogna essere prudenti a definirla l’unica vera verità. Quando diciamo che la parola è una noi siamo convinti di appartenere a questa verità, ma questa verità non ci appartiene, perché è molto più grande di noi e non possiamo gestirla né possiamo avere con essa un rapporto ideologico. Noi apparteniamo alla verità e all’infinito, ma l’infinito non ci appartiene».
(Dal libro di Enzo Romeo, I solitari di Dio. Separati da tutto, uniti a tutti, Catanzaro/Roma, Rubbettino/Rai-Eri, 2005, 10).
Chi ha superato la paura della morte, non ha ancora vinto tutti gli altri timori. Alcuni non temono la morte, ma hanno paura dei piccoli mali della vita. Alcuni non temono la morte, ma temono la morte delle persone care. Chi cerca la Verità, deve vincere tutti questi timori e altri ancora: bisogna essere pronti a sacrificare tutto per la Verità. La verità non si può sacrificare per nessuna ragione. La verità è come un grande albero, che più lo si coltiva, più da frutti. Colui che cerca la verità dovrebbe essere più umile della polvere.
Se conoscessimo la verità intera, che bisogno ci sarebbe di cercarla? Possedere la conoscenza perfetta della verità è possedere Dio. Poiché la verità è Dio. Dal momento che non conosciamo la verità totale, dobbiamo sentirci impegnati in una ricerca incessante, e questo è il più grande privilegio e il più grande dovere dell’uomo.
Dio-verità va incontro a quelli che lo cercano. Sono un umile cercatore della verità, e in questa ricerca ripongo la massima fiducia nei miei compagni per poter conoscere i miei errori. Sono fedele soltanto alla verità e non devo ubbidienza a nessuno salvo che alla verità. Tutta la verità, non semplicemente le idee vere, ma i visi autentici, i dipinti o le canzoni autentiche sono sommamente belli. Volete sapere quali siano le caratteristiche di un uomo che desideri realizzare la Verità che è Dio? Deve essere completamente libero dall’ira e dalla lussuria, dall’avidità e dall’attaccamento, dall’orgoglio e dal timore. Voi ed io siamo una cosa sola. Non posso farvi del male senza ferirmi. Io sono il servo di musulmani, cristiani, persi, ebrei, come lo sono degli indù. E un servo non ha bisogno di prestigio, ma di amore. L’amore è il rovescio della moneta, il cui diritto è la verità.
(Mahatma Gandhi).
Ho cercato la verità, amando
Ho cercato la verità,
con l’Innominato di Manzoni.
Ho cercato la verità
tra le lettere di don Milani.
Ho cercato la verità,
curiosando nella vita di Gandhi.
Ho cercato la verità,
nelle Confessioni di sant’Agostino.
Ho cercato la verità
nelle prediche di don Mazzolari.
Ho cercato la verità,
piangendo con Giobbe sul letamaio.
Ho cercato la verità,
fuggendo da casa, con la mia parte
di eredità, come il Figliol Prodigo.
Ho cercato la verità,
nelle poesie di Tagore.
Ho cercato la verità,
nei pensieri di Pascal.
Ho cercato la verità,
nei fioretti di san Francesco.
Ho cercato la verità,
nell’Allegretto della settima di Beethoven.
Ho cercato la verità,
vagando stralunato.
Ho cercato la verità,
negli occhi incavati
e ormai vitrei di Brambilla,
morto di Aids tra le mie braccia.
Ho cercato la verità,
nei rosari che la mia santa madre
recitava per me,
prete molto diverso dal prete
che teneva nella sua testa.
Ho cercato la verità,
nel Parco Lambro,
negli anni ottanta,
assistendo giovani in overdose.
Ho cercato la verità,
nei commenti biblici, stupendi,
del mio cardinale di Milano.
Ho cercato la verità,
nei viaggi del pellegrino Wojtyla.
Ho cercato la verità,
nella filosofia di Tommaso l’Aquinate.
Ho cercato la verità,
nelle storie degli ultimi
e dei diseredati.
Ho cercato… talvolta nell’affanno,
tal’altra nella pazienza;
talvolta nella confusione,
tal’altra nel silenzio.
Una notte inginocchiato
nella mia cameretta,
recitavo Compieta.
Ho sentito battere al mio cuore.
Ho detto: avanti.
Ero assonnato e stanco.
Solo dopo qualche minuto
mi sono accorto chi era.
«Sono la fede!
So che mi hai cercato
per tanto tempo…lo sai bene
anche tu, che la fede non si cerca
dove non è…perché
la fede è LUI…e LUI è…
l’irruzione, la gratuità,
la meraviglia…
Lui è quello che ha detto:
«Cercate la verità, amando».
Smetti di cercare. Aspetta perché arriverà.
Sono venuto a dirtelo.
Accendi la lampada e spegni
i ragionamenti nella tua testa.
Perché LUI entra dal cuore.
È l’unica porta che può riceverlo».
(Don Antonio MAZZI, Preghiere di un prete di strada).
Qualche volta noi ci crogioliamo un po’, ci lamentiamo col Signore, che non si manifesta in maniera chiara, che non ci dice come fare. Adagio adagio, però, si capisce che il Signore vuole che noi cerchiamo, che cresciamo in questa ricerca. Noi diventiamo veri ricercatori di Dio cercando la sua volontà, cercandola in questa Chiesa, in questo mondo, in questa società, in queste situazioni difficili, crescendo nel dialogo, nella pazienza, nella sopportazione, nell’ascolto.
Così cresciamo. Se no saremmo degli automi; se ogni mattina ci risvegliassimo col programma già fatto da Dio, allora non ci sarebbe più problema. Invece siamo degli operatori attivi e cresciamo responsabilmente nel Regno di Dio, ricercando umilmente la sua volontà e purificandoci in questa ricerca. Ciò vale anche per la ricerca di Dio in se stesso, che è crescita purificante, faticosa, e se molti arrivano a non credere in Dio, non è perché abbiano più o meno argomenti di noi, ma perché si sono stancati di cercarlo, cioè hanno finito di fare il vero mestiere di uomo che è mettersi di fronte alla verità.
(Carlo Maria MARTINI, Incontro al Signore risorto, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2009, 57-58).
Il mio Regno non è di questo mondo
Ascoltate, giudei e gentili; ascoltate circoncisi, ascoltate incirconcisi; ascoltate, regni tutti della terra: «Io non intralcio la vostra sovranità in questo mondo. Il mio Regno non è di questo mondo (Gv 18,36)». Non lasciatevi prendere dal vano timore da cui fu colto Erode il Grande, quando gli fu annunciato che era nato Cristo e, nell’intento di far morire Gesù, uccise così tanti bambini (cfr. Mt 2,3.16). «Il mio Regno non è di questo mondo», dice Gesù. Che volete di più? Venite nel Regno che non è di questo mondo; venite con fede e non vogliate diventare crudeli per la paura! È vero che in una profezia Cristo, parlando di Dio suo Padre, dice: «Da lui io sono stato costituito re sopra Sion, il suo monte santo» (Sal 2,6), ma quella Sion e quel monte non sono di questo mondo. Che cos’è il Regno di Cristo? Sono quelli che credono in lui, a proposito dei quali egli dice: «Voi non siete del mondo, come io non sono del mondo» (Gv 17,16), anche se egli voleva che rimanessero nel mondo, e per questo prega il Padre per essi: «Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal male» (Gv 17,15). Per questo anche qui non dice: «Il mio Regno non è in questo mondo», ma dice: «II mio Regno non è di questo mondo». E dopo aver dimostrato questo dicendo: «Se il mio Regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero per me, affinché non fossi consegnato ai giudei» (Gv 18,36), non dice: «Ora il mio Regno non si trova in questa terra», ma dice: «Il mio Regno non è di questa terra». Il suo regno, infatti, è in questa terra fino alla fine dei secoli, e porta in sé la zizzania mescolata con il grano fino al momento della mietitura, che avverrà alla fine dei tempi, quando verranno i mietitori, cioè gli angeli, e toglieranno dal suo Regno tutti gli scandali (cfr. Mt 13,38-41). E questo non potrebbe avvenire se il regno non fosse qui, sulla terra. Tuttavia, non è di questa terra, poiché è in esilio in questo mondo. A quelli che fanno parte del suo Regno egli dice: «Voi non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo» (Gv 15,19).
(AGOSTINO DI IPPONA, Commento al vangelo di Giovanni 115,2,NBA XXIV, pp. 1520-1522).
Il Regno di Dio è come un seme posto nella terra, che raggiungerà certe fasi della crescita in modo graduale, giungendo a ciascuna fase solo al momento giusto e con il passare del tempo.
Letteralmente, sappiamo che i Regno di Dio è un invito da parte di Dio e un atto di accettazione da parte del genere umano. L’invito è esteso in una serie di richieste e di eventi, come quando, nella nostra cultura, un giovane invita una donna a condividere la sua vita. C’è il primo appuntamento, l’invito ad un rapporto speciale ed esclusivo (“fare coppia fissa”), la proposta di matrimonio e il periodo di fidanzamento; infine ci sono i voti e il rito del matrimonio. Similmente, attraverso Gesù Dio ha esteso a noi non uno bensì una serie di progressivi inviti, chiamandoci in modo sempre più profondo ad un’intimità con lui. […]
Il Regno di Dio, dunque, è un invito divino che ci chiede di entrare, di dire “sì” e di partecipare al piano di condivisione di Dio.
(J. POWELL, Perché ho paura di essere pienamente me stesso, Milano, Gribaudi, 2002, 165).
Troppe volte, Signore Gesù,
abbiamo rivolto il nostro cuore ad altri sovrani,
ai vari dominatori del mondo.
Troppe volte, dominati dall’ansia del futuro
e dall’angoscia del pericolo,
ci rivolgiamo ad altri «re».
Solo l’amore e la fiducia che ne deriva
liberano l’uomo dalla fobia
e dalla tirannia della sua presunzione.
Oggi, Signore, ci inviti ad alzare il capo
e a guardare nel tuo futuro.
Tu, Re di misericordia,
ricordati di noi nel tuo Regno,
facci percepire il palpito del tuo cuore.
Un mondo disgregato dalla diffidenza,
dal dubbio e dallo scetticismo
trova solo in te la salvezza.
Il tuo Regno non è fatto
di splendido isolamento,
ma di profonda solidarietà
con l’umanità redenta.
Il tuo Regno non impone diffidenza,
ma libera, salva, assicura speranza.
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2002-2003; 2005-2006- .
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
———
– COMUNITÀ DI S. EGIDIO, La Parola e la storia. Tempo ordinario. Seconda parte, Milano, Vita e Pensiero, 2012.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
PER L’APPROFONDIMENTO:
XXXIV DOM TEMP ORD CRISTO RE ANNO B
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. II: Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011.

L’Istituto di Catechetica organizza annualmente una Giornata di Studio riservata a docenti di Pedagogia Religiosa e Catecheti, che coinvolge esperti a livello nazionale e gode del loro apprezzamento. Dedichiamo la giornata di studio alle provocazioni, cui l’Irc è chiamato a far fronte nel contesto attuale.
Ha come tema: Multireligione, linguaggio e traguardi di competenza nell’IRC. La giornata si realizzerà sabato 24 novembre 2012 presso l’Università Pontificia Salesiana dalle 9.00 alle 18.00.
Il contesto scolastico diventa sempre più vistosamente plurireligioso. L’attuale orientamento pedagogico e didattico quale consapevolezza ne prende, quale attenzione vi dedica? Le attuali ‘Indicazioni Nazionali’ offrono contributi significativi?
Inoltre la scuola va privilegiando ‘le competenze’ da identificare e promuovere in tutte le discipline. La religione ha un proprio e peculiare linguaggio difficilmente traducibile in ‘competenza’. Si profila il rischio di cogliere solo tangenzialmente la dimensione religiosa nell’elaborazione dei traguardi di competenza, che ciascuna disciplina è chiamata a perseguire.
Ci pare particolarmente urgente una riflessione e una verifica puntuale e tempestiva sulle nuove esigenze che si impongono per consentire all’IRC di stare nella scuola con un proprio apporto, senza compromettere le sue specifiche connotazioni e la sua identità.
Pensiamo ad un dialogo aperto, scandito da alcuni imputs sintetici e orientativi.
Sono previste le seguenti relazioni:
– Contesto plurireligioso e apprendimento Prof. Castegnaro A.
– Profilo religioso della studente Prof.ssa Feliziani Kannheiser F.
– Il linguaggio nell’Irc Prof. Moral J.L.
– Le Indicazioni Nazionali e i traguardi di competenza Prof. Cicatelli S.
– Nella programmazione operativa Prof. Romio R.
Naturalmente saremo onorati della tua presenza e contiamo sull’apporto che puoi offrire alla riflessione e alla migliore comprensione del tema.
Sono graditi anche eventuali contributi personali (un paio di cartelle) da inserire con le Relazioni.
Le adesioni e i contributi vanno comunicati entro il 15 novembre via E-Mail a: pastore@unisal.it.
Siamo lieti di averti ospite a pranzo.
Preghiamo quanti devono arrivare la sera di venerdì 23 novembre di segnalarlo per tempo, dal momento che non siamo sicuri di poter avere camere a disposizione nella struttura della Università.
Con viva cordialità e amicizia
Corrado Pastore don Zelindo Trenti
Direttore dell’Istituto Coordinatore
VISUALIZZA: Programma

Cari studenti e genitori,
nelle prossime settimane sarete chiamati a esprimervi sulla scelta di avvalervi dell’insegnamento della religione cattolica.
Si tratta di un appuntamento di grande responsabilità perché consente, a voi studenti, di riflettere sulla validità di tale proposta e di decidere personalmente se farne risorsa per la vostra formazione e, a voi genitori, di ponderare le possibilità educative offerte ai vostri figli.
Vogliamo dirvi che vi siamo vicini, condividiamo i dubbi e le speranze che abitano il vostro cuore di fronte alle ricadute che le contraddizioni del momento presente e le incertezze del futuro hanno sulla scuola; partecipiamo al vostro anelito di verità e di sicurezza, impegnati, insieme a tutte le persone di buona volontà, in particolare mediante lo strumento dell’insegnamento della religione cattolica, a fare della scuola uno spazio educativo autentico per le nuove generazioni, un luogo di formazione alla pacifica convivenza tra i popoli e di confronto rispettoso, sotto la guida di veri maestri e di convinti educatori.
La Chiesa è dalla vostra parte, si fa carico di ogni vostra fatica, vuole offrirvi il supporto della sua bimillenaria esperienza a servizio dell’uomo e delle sue più profonde aspirazioni, vuole aiutare voi studenti, attraverso l’opera di insegnanti professionalmente competenti e spiritualmente motivati, a leggere e interpretare la cultura letteraria, artistica e storica in cui siete nati e cresciuti, o dove siete approdati in seguito a scelte di vita o a esodi forzati. L’insegnamento della religione cattolica è una disciplina che tiene viva la ricerca di Dio, aiuta a trovare risposte di senso ai “perché” della vita, educa a una condotta ispirata ai valori etici e, facendo conoscere il cristianesimo nella tradizione cattolica, presenta il Vangelo di Gesù Cristo in un confronto sereno e ragionato con le altre religioni. Afferma a questo proposito Papa Benedetto XVI: «una cultura meramente positivista che rimuovesse nel campo soggettivo come non scientifica la domanda circa Dio, sarebbe la capitolazione della ragione, la rinuncia alle sue possibilità più alte e quindi un tracollo dell’umanesimo, le cui conseguenze non potrebbero essere che gravi. Ciò che ha fondato la cultura dell’Europa, la ricerca di Dio e la disponibilità ad ascoltarLo, rimane anche oggi il fondamento di ogni vera cultura» (Discorso all’Incontro con il mondo della cultura al Collège des Bernandins, Parigi 12 settembre 2008).
Nel cuore di una formazione istituzionalizzata come quella della scuola, in continuità con la famiglia e in preparazione alla vita sociale e professionale, l’insegnamento della religione cattolica è un valore aggiunto a cui vi invitiamo a guardare con fiducia, qualunque sia il vostro credo e la vostra estrazione culturale. In forza delle sue ragioni storiche e della sua valenza educativa, esso è di fatto capace di proporsi come significativa risorsa di orientamento per tutti e di intercettare il radicale bisogno di apertura a dimensioni che vanno oltre i limiti dell’esperienza puramente materiale.
Cari genitori e docenti, a voi rivolgiamo il caloroso invito a operare insieme perché non manchi alle giovani generazioni l’opportunità di una proposta inerente la dimensione religiosa e di una cultura umanistica e sapienziale che li abiliti ad affrontare le sfide del nostro tempo.
Roma, 15 novembre 2011
LA PRESIDENZA
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Pubblicato in G.U. il Decreto del Presidente della Repubblica 20 Agosto 2012 n. 175 (in vigore dal 31/10/2012):
E’ disponibile anche il formato PDF (1.075 Kb).
Il link al Decreto (prot. 484/2012 del 28 Giugno 2012) di promulgazione dell’Intesa del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
In data 6 Novembre 2012 il MIUR ha pubblicato la circolare 2989 inerente i profili di qualificazione professionale a regime con l’anno scolastico 2017-2018.