
“Amarsi e sposarsi nei matrimoni misti …”


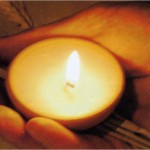
Prima lettura: Geremia 1,4-5.17-19
|
Nei giorni del re Giosìa, mi fu rivolta questa parola del Signore: «Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni. Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi, àlzati e di’ loro tutto ciò che ti ordinerò; non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti». |
La lettura di oggi contiene la chiamata e la missione del profeta Geremia in un «racconto autobiografico» (in prima persona). La pericope liturgica decurta il testo biblico di circa dieci versetti (mancano i vv. 6-16). I redattori delle letture di questa domenica hanno voluto ritenere solo quelle parti in cui si esprime il conflitto tra il profeta ed i suoi avversari, in vista del Vangelo di oggi, nel quale assistiamo ad un contrasto analogo tra Gesù ed i suoi ascoltatori nella sinagoga di Nazaret.
— vv. 4-5: «Prima di formarti nel grembo materno…». Con queste parole ben note Dio rivela al profeta la sua vocazione: esse manifestano l’assoluta, sovrana potenza di Dio nel costituire Geremia profeta in vista della sua futura missione. Il profeta venne all’esistenza proprio per realizzare la sua missione: in certo senso il suo esistere ed il suo essere mandato formano un’unica ed identica realtà. Inoltre la chiamata di Dio è come una consacrazione («ti ho consacrato»), una speciale investitura che abbraccia tutta la persona del profeta. Anche se occorre molto coraggio per essere l’inviato di Dio, la sua forza deriva da questa investitura da parte del Signore.
— vv. 18-19: «una colonna di ferro e un muro di bronzo…». Il profeta viene paragonato ad una città fortificata, che i nemici assediano senza poterla espugnare. Immagine (o metafora) marziale, impiegata per mettere in risalto anche la dura battaglia che il profeta è chiamato a sostenere.
—v. 19: «sono con te per salvarti». Ecco l’unica certezza che sorregge il profeta. Questa «formula di assistenza», con cui il Signore o il suo angelo promettono l’assistenza indefettibile di Dio agli inviati («Io sono con te…», «Il Signore è con te»), ricorre spesso nella Sacra Scrittura, ad esempio in Es 3,12; Rut 2,4; Lc 1,28, e nella nostra liturgia. È un invito, rivolto alle persona inviate, ad aver fiducia in Dio. Costoro devono affidare a Dio la loro missione, e non cercare altrove le loro certezze.
Seconda lettura: 1Corinzi 12,31-13,13
|
Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi. E allora, vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo, per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità! |
Solitamente si ama definire la lettura di oggi «l’inno alla carità», uno dei testi più celebri del Nuovo Testamento. Il brano liturgico va riposto esattamente nel contesto in cui Paolo (nella 1 Cor.) parla dei carismi. È lo stesso contesto della II Lettura di domenica scorsa.
— vv. 12-31: «desiderate intensamente i carismi più grandi». I cristiani di Corinto mostrano grande interesse per i doni o carismi, specie quelli più spettacolari, che attirano ed alimentano il loro orgoglio, rappresentando qualcosa di speciale. Paolo ristabilisce il giusto ordine nella realtà di questi doni. In tale ordine il posto centrale lo detiene il dono dell’amore. Chi ha ricevuto questo carisma dell’amore, ha ricevuto il più grande dei doni.
— vv. 1-3: «le lingue degli uomini e degli angeli, ecc.». Perché il dono dell’amore è realtà centrale rispetto ad ogni altro dono? Paolo ne spiega il motivo, affermando che esso è la condizione che garantisce l’autenticità di tutti gli altri carismi. Il parlare in lingue misteriose (v. 1), l’esercitare la profezia (v. 2), l’avere la scienza di tutte le realtà più misteriose, come pure l’aver fede e capacità di trasportare le montagne (v. 2), la stessa grazia del martirio non sono valori assoluti e a sé stanti; valgono soltanto se trovano la loro profonda motivazione nel dono dell’amore.
— vv. 4-7: «Magnanima, benevola, non è invidiosa ecc.». L’Apostolo enumera ben 15 qualità: inizia con due caratteristiche positive, continua con otto negative (ciò che l’amore non è, e non fa), e conclude con cinque positive. Questo elogio diligentemente strutturato dell’amore mira a sottolineare quelle virtù, opposte alla vanagloria ed alla ricerca di sé, che sono appunto all’origine di quelle spinte segrete che portano molti cristiani di Corinto a desiderare i carismi per sé. Vogliono avere i carismi per essere diversi e superiori agli altri.
— vv. 8-12: «La carità non avrà mai fine…». A differenza dei carismi, che prima o poi hanno fine, la carità dura per sempre. Lo stesso carisma della conoscenza, che pure è permanente, è da considerare provvisorio nel senso che nel tempo presente non può essere che parziale e frammentario, incompleto. Per questo la conoscenza è paragonata all’immagine sfocata e approssimativa che si vede in uno specchio metallico usato nell’antichità; oppure, è paragonata alla capacità conoscitiva che ha un bambino rispetto a quella di un adulto. La carità invece si prolunga nell’eternità, senza alterazioni o limitazioni di sorta. Inoltre, la carità è come un legame che ci congiunge con la vita eterna.
— v. 13: «Ma la più grande di tutte è la carità!». Fede, speranza e carità in quanto appartengono al rapporto dell’uomo con Dio, sono importanti. Ma di queste tre, è l’amore a valere di più, perché ci avvicina maggiormente a Dio, da lui verrà maggiormente stimata e ricambiata e resterà in eterno.
Vangelo: Luca 4,21-30
|
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. |
Esegesi
Il brano del vangelo odierno è la seconda parte della cosiddetta «pericope di Nazaret», ad immediato seguito della prima parte, letta domenica scorsa. Mentre nella I parte si riferiva l’accoglienza positiva di Gesù da parte dei suoi compaesani (elogi, stupore), nella II parte ci troviamo invece di fronte all’aspetto negativo di tale accoglienza: rifiuto e ostilità. L’evangelista Luca ha voluto fare di questo episodio un momento emblematico della missione di Gesù, presentando fin d’ora la divisione degli spiriti che si opera di fonte a lui, sempre.
— v. 22: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». La meraviglia si traduce in delusione e ostilità. In realtà la sua persona «delude» le aspettative dei presenti, perché egli socialmente non appare diverso da loro. Ma anche il suo messaggio li delude, in quanto non prospetta alcun benessere terreno, alcun cambiamento politico e neanche l’esaltazione di Israele. Inoltre a Nazaret Gesù non compie i miracoli che ha compiuto altrove, specie a Cafarnao.
— v. 23: «Medico, cura te stesso». Cosciente di tale delusione, dovuta in particolare all’assenza di segni spettacolari, Gesù mette in bocca ai compaesani il proverbio, noto anche presso i rabbini: « Medico, cura te stesso ». La sua potenza taumaturgica, Gesù avrebbe dovuto metterla in mostra specialmente nella sua patria, e non lontano da essa.
— v. 24: «Nessun profeta è bene accetto nella sua patria». Al proverbio che rispecchia il pensiero dei suoi ascoltatori, Gesù ne contrappone un altro, che spiega perché egli non compia miracoli a Nazaret. Se, come tutti i profeti, non è riconosciuto e accettato nella sua patria, non può compiere prodigi semplicemente per avvalorare la sua identità e indurli a credere. La fede che esige miracoli non è vera fede.
— vv. 25-27: «C’erano molte vedove… molti lebbrosi». Con i due esempi veterotestamentari, la vedova di Zarepta e Naaman il Siro, Gesù esprime due dimensioni essenziali della sua missione: a) la sua patria, per volere divino, passa in secondo ordine di fronte agli stranieri; b) la elezione di Dio non si ferma a vincoli di patria o familiari, ma è rivolta a tutti.
— vv. 28: «Si riempirono di sdegno». Gli esempi addotti da Gesù, con l’universalismo che dichiarano, determinano sdegno e rifiuto ostile da parte dei compaesani. Se quel profeta non compie nulla per la sua patria, anzi mostra di offrire agli stranieri i suoi benefici, non appartiene più ad essa: va ripudiato. Stando al testo del Dt. 13,2, un profeta che non vuole garantire la sua missione con segni, merita la morte. Perciò lo conducono fuori, per ucciderlo.
— v. 30: «si mise in cammino». Come spesso il Vangelo di Giovanni sottolinea il fatto che i Giudei non poterono catturare Gesù «perché non era ancora giunta la sua ora» (Gv 7,30; 8,20:10,39), così qui Luca vuol dire che Gesù passa liberamente in mezzo a coloro che lo hanno condotto fuori della città non tanto per fare un miracolo (che finora ha rifiutato) quanto per affermare la sua sovrana libertà di fronte alla morte. Tale «momento» arriverà, non per fatalità, per effetto di complotti umani o sdegno di popolo, ma per sua libera scelta. Alla luce di ciò, acquista particolare spessore teologico il verbo finale: «si mise in cammino». Respinto e rifiutato dalla sua patria, Gesù a sua volta se ne va, le volta le spalle, la ripudia, per portare altrove l’annuncio di salvezza.
Meditazione
La liturgia ci fa ascoltare in due domeniche successive quanto avviene nella sinagoga di Nazaret. Domenica scorsa abbiamo interrotto la narrazione di Luca nel momento in cui Gesù, dopo aver proclamato la lettura dal rotolo del profeta Isaia, ne afferma il suo compimento oggi. In questa domenica leggiamo la seconda parte del racconto, che si sofferma sulla reazione dei suoi concittadini presenti alla preghiera sinagogale. La meraviglia iniziale si trasforma presto in sdegno, sino al punto di cacciarlo fuori dalla città e tentare di ucciderlo buttandolo giù da precipizio (cfr. v. 29). La meraviglia dei nazaretani diventa così lo stupore di noi ascoltatori: come mai questo diverso e addirittura contrapposto atteggiamento? Cosa fa passare dalla meraviglia allo sdegno? Diversamente da quanto accade nel racconto degli altri Sinottici, in Luca queste contrastanti reazioni nascono entrambe dall’ascolto della parola di Gesù. Descrivono due opposte conseguenze dell’ascoltare, o meglio due differenti modi di ascoltare. Non soltanto la meraviglia per le parole di grazia che escono dalla bocca di Gesù, ma anche lo sdegno nasce «all’udire queste cose» (v. 28). C’è dunque un aspetto di questa parola che affascina e stupisce, e che siamo disposti ad accogliere volentieri; ma c’è anche un altro taglio più duro da accettare, che esige una conversione delle nostre attese, perché la Parola si compie sempre nel modo che non immaginavamo. Di conseguenza, o siamo disposti a lasciarci sorprendere e convertire, o altrimenti ne restiamo scandalizzati.
Gesù discerne cosa c’è nel cuore dei suoi concittadini, lo intuisce e lo porta in piena luce. «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”» (v. 23). Innanzitutto tra i tuoi, per quelli della tua casa. Tu che sei il figlio di Giuseppe, uno di noi, guarda anzitutto ai nostri bisogni. Nel cuore dei nazaretani c’è la tentazione di requisire e circoscrivere l’azione di Gesù. Ciò che si manifesta in questa pretesa non è soltanto il rifiuto del carattere universale della salvezza. Che Gesù compia prodigi a Cafarnao o altrove ai nazaretani sta anche bene, purché li compia anzitutto ‘nella sua patria’. La tentazione più grave consiste nel non riconoscere i segni della salvezza là dove germogliano perché essi non sono il soddisfacimento immediato del proprio bisogno personale. Occorre invece rallegrasi per i segni della salvezza anche se sono per altri perché comunque testimoniano la vicinanza di Dio al suo popolo; annunciano che la misericordia del Signore diviene un oggi nella nostra storia.
Gesù cita due proverbi: «Medico, cura te stesso» e subito dopo «Nessun profeta è ben accetto nella sua patria». Vi risuonano due appellativi, entrambi riferiti a Gesù: ‘medico’ e ‘profeta’. Il primo sembra più esprimere il punto di vista dei nazaretani e l’idea che hanno maturato di Gesù, o l’attesa che nutrono nei suoi confronti. Il secondo indica piuttosto come Gesù interpreta la propria missione e desidera compierla. Per i cittadini di Nazareth Gesù è il medico che deve curare le loro infermità e colmare i loro bisogni. Gesù invece afferma di essere anzitutto un profeta, vale a dire un uomo che compie sì segni e guarigioni, ma non semplicemente per appagare un bisogno, ma per rivelare che la promessa di Dio, custodita dalla sua Parola, ha iniziato ad attuarsi nella storia. Per il profeta il segno rinvia alla Parola, la quale a sua volta esige un affidamento e un atto di fede che oltrepassa il segno stesso. Si riconosce il segno, ma per credere nella Parola.
I nazaretani, al contrario, hanno saputo dei segni già operati da Gesù, ma essi, anziché nutrire la fede nella sua persona, li conducono a pretendere altri segni che risolvano i loro problemi. Questa è la tua casa, la tua patria, qui c’è la tua gente e i tuoi parenti: tutto ciò ci offre un diritto e una pretesa nei tuoi confronti. Fa’ anche qui, nella tua patria, quanto vai facendo altrove. Tra questi nazaretani ci sono certamente molti bisogni veri, numerose infermità da guarire e oppressioni da liberare, le stesse che Gesù incontrerà e sanerà altrove; il problema è che tutto ciò viene vissuto nella forma della pretesa e non in quella dell’affidamento. Con l’atteggiamento dei ricchi, dunque, e non con il cuore dei poveri. Ma è ai poveri che viene annunciato l’evangelo della salvezza, come Gesù ha appena affermato citando il profeta Isaia.
Gesù legge nei cuori dei nazaretani l’invito a compiere «anche qui, nella tua patria, quanto hai fatto a Cafarnao» (cfr. v. 23). Luca, in verità, non lo ha ancora raccontato, lo racconterà nei capitoli seguenti del suo vangelo. Ma forse questa non è tanto una svista narrativa, quanto un modo raffinato per invitare il suo lettore ad andare a vedere ciò che Gesù opera a Cafarnao. Tra i vari miracoli si staglia la guarigione del servo del centurione narrata all’inizio del capitolo settimo (vv. 1-10). Un episodio che aiuta a capire, in un gioco di contrasti, proprio ciò che accade nella sinagoga di Nazaret. Il centurione è un pagano che si riconosce indegno di ricevere Gesù nella sua casa. Il suo è un atteggiamento completamente diverso da quello dei concittadini di Gesù. Questi ultimi vantano dei diritti su Gesù, perché era uno di loro. Questo pagano non solo non avanza pretese, ma per ben due volte, con insistenza, afferma di non essere degno, mentre al contrario i Giudei presentano a Gesù le sue credenziali: «egli merita che tu gli conceda quello che chiede – dicevano – perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga» (vv. 4-5). «Egli merita» – «Io non sono degno»: davvero forte è il contrasto tra il punto di vista dei Giudei e quello di questo centurione che, oltre a non vantare diritti e a non pretendere il segno, non attende neppure che il segno si compia per credere alla parola di Gesù. Si affida a essa subito, radicalmente, come un povero che sa di dover dipendere in tutto da quella parola, così come un soldato dipende dalla parola del suo superiore: «di’ una parola e il mio servo sarà guarito» (v. 7). L’episodio si conclude con lo stupore di Gesù: «All’udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande!» (v. 9).
Neppure in Israele, neanche nella mia patria! Come i nazaretani erano ammirati dalle parole di grazia che uscivano dalla bocca di Gesù, così ora è Gesù ad ammirare le parole di fede che escono dalla bocca di questo centurione. Egli ha infatti compreso che la parola della grazia si compie per chi non ha meriti da vantare, ma può soltanto riconoscersi indegno davanti alla gratuità della salvezza, come un povero che sa accoglierla nella propria casa e nella propria vita. Ai poveri è annunciato l’evangelo della salvezza, che è gratuito e universale, non fa differenze sulla base dei meriti e dei diritti presunti o acquisiti, ma ha comunque un destinatario privilegiato nei poveri, in chi sa accoglierlo nell’umiltà del non riconoscersene degno.
Noi ripetiamo la parola del centurione in ogni celebrazione eucaristica: «Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dì soltanto una parola e io sarò salvato». La parola della salvezza, per diventare davvero un oggi nella nostra vita, ha bisogno di questo atteggiamento e di questa accoglienza.
Preghiere e racconti
Il maestro non amava i discorsi eruditi che gli altri chiamavano invece “perle di saggezza”. I discepoli gli chiesero: Se sono parole perché le disprezzi? Il maestro replicò: Avete mai visto perle che crescono se seminate in un campo?
Furono riempite dodici ceste. Questo fatto è mirabile per la sua grandezza, utile per il suo carattere spirituale. Quelli che erano presenti si entusiasmarono, mentre noi, al sentirne parlare, rimaniamo freddi. Questo è stato compiuto affinché quelli lo vedessero ed è stato scritto affinché noi lo ascoltassimo. Quello che essi poterono vedere con gli occhi, noi possiamo vederlo con la fede. Noi contempliamo spiritualmente ciò che non abbiamo potuto vedere con gli occhi. Noi ci troviamo in vantaggio rispetto a loro, perché a noi è stato detto: Beati quelli che non vedono e credono (Gv 20,29). Aggiungo che forse a noi è concesso di capire ciò che quella folla non riuscì a capire. Ci siamo così veramente saziati, in quanto siamo riusciti ad arrivare al midollo dell’orzo. Insomma, come reagì la gente di fronte al miracolo? Quelli, vedendo il miracolo che Gesù aveva fatto, dicevano: Questi è davvero il profeta (Gv 6,14). […] Ma Gesù era il Signore dei profeti, l’ispiratore e il santificatore dei profeti, e tuttavia un profeta, secondo quanto a Mosè era stato annunciato: Susciterò per loro un profeta simile a te (Dt 18,18). Simile secondo la carne, superiore secondo la maestà. E che quella promessa del Signore si riferisse a Cristo, noi lo apprendiamo chiaramente dagli Atti degli apostoli. Lo stesso Signore dice di se stesso: Un profeta non riceve onore nella sua patria (Gv 4,44). Il Signore è profeta, il Signore è il Verbo di Dio e nessun profeta può profetare senza il Verbo di Dio; il Verbo di Dio profetizza per bocca dei profeti, ed è egli stesso profeta. Cristo è profeta e Signore dei profeti, così come è angelo e Signore degli angeli. Egli stesso è detto angelo del grande consiglio (cfr. Is 9,6). E del resto, che dice altrove il profeta? Non un inviato né un angelo, ma egli stesso verrà a salvarci (cfr. Is 35,4); cioè a salvarci non manderà un messaggero, non manderà un angelo, ma verrà egli stesso.
(AGOSTINO, Omelie sul vangelo di Giovanni 24,6-7, in Opere di sant’Agostino, pp. 564-566).
Il profeta, Signore, non è un depositario di verità,
ma un testimone di bene.
Non sa dire cose sublimi, ma le compie.
Annuncia la speranza nella disperazione,
la misericordia nel peccato,
l’intervento di Dio dove tutto sembra morto.
Il profeta è consapevole dei suoli limiti, delle sue debolezza,
dei suoi dubbi, delle sue incapacità, della sua inesperienza,
ma è anche sereno e coraggioso,
perché Dio lo ha scelto e amato.
Il profeta fa la scelta di Dio,
vive la comunione intima con lui.
Essere profeti oggi, significa passare da una pastorale di conversazione
ad una pastorale missionaria,
significa essere presenti là dove la gente
vive, lavora, soffre, gioisce.
Tu, Signore, sei il profeta per eccellenza
che dobbiamo ascoltare e accogliere.
Tua chiesa erano le piazze, le rive dei fiumi,
i monti, le strade.
Ogni cristiano è profeta,
è la tua bocca che evangelizza,
che parla davanti agli uomini, al mondo, alla storia.
Signore, aiutaci ad essere profeti di frontiera
là dove scorre la vita della gente.
(A. Merico)
Tu ci parli. Signore, attraverso profeti pienamente inseriti nelle vicende del loro popolo e del loro tempo e insieme capaci di restare in solitudine o di andare nel deserto per fare riascoltare la tua Parola a coloro che li seguono.
Tu ci parli, Signore, attraverso testimoni in grado di condividere le angosce dei loro fratelli, le paure e i drammi degli uomini e insieme pieni di fede nell’indicare la tua presenza già operante, la tua promessa suscitatrice di vita.
Tu ci parli, Signore, attraverso uomini che sanno contestare coraggiosamente le mode, le abitudini, i pregiudizi, i luoghi comuni dei loro contemporanei e insieme profondamente solidali con loro nel ricercare il tuo volto che salva, nel parlare al cuore di chi dispera.
Guarda, ti preghiamo, alla tua Chiesa, alla Chiesa del nostro tempo, a noi che siamo il tuo popolo, costituiti per tua grazia profeti e testimoni della tua verità: donaci di essere mediatori della tua consolazione nel momento stesso in cui denunciamo le nostre e le altrui ipocrisie. Nei deserti della nostra società fa’ risuonare la tua Parola, perché anche noi ‘usciamo’, confessando i nostri peccati per essere di nuovo immersi nella grazia del tuo Spirito.
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
———
– M. FERRARI, «Oggi di è adempiuta questa scrittura». Avvento, Tempo di Natale e Tempo ordinario (prima parte), Milano, Vita e Pensiero, 2012.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.

Di fronte alle innumerevoli crisi che stanno colpendo l’Italia e l’Europa, il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), ha indicato la dottrina sociale e la testimonianza cristiana come la via per trovare pace, sviluppo e gioia.
Nel corso della prolusione svolta al Consiglio Permanente della CEI, il Porporato ha spiegato che benché nessuno possa negare che siamo dentro a un travaglio storico delicatissimo e intricato, “noi sappiamo di poterci affidare alla gioia”.
L’arcivescovo di Genova ha precisato la Gioia dei cristiani “non è solo un sentimento, una fragile emozione: è una Persona” Gesù!
“Non è vero che a noi interessa far politica, – ha sottolineato il cardinale – noi vogliamo dire Gesù”, cioè “l’Infinito fatto bambino” che “è entrato nella nostra umanità”.
Il Presidente della CEI ha illustrato quanto è ancora difficile essere cristiani oggi nel mondo, con centomila cristiani delle varie confessioni uccisi nel 2012.
Nonostante sia la religione più diffusa al mondo – ha rilevato – “in troppi Paesi ai cristiani non è consentito alcun segno di appartenenza religiosa, salvo mimetizzarsi, nascondersi, dislocarsi”.
Secondo l’arcivescovo di Genova i cristiani devono testimoniare che non hanno un prodotto da imporre, ma “una Persona, una presenza, un’amicizia che cambia la vita”.
In questo contesto il Presidente della CEI ha invitato le comunità cristiane a rispondere “alla nostalgia di Dio”, con “il clima necessario alla pietà, al senso di stupore, all’interiorizzazione” e che la nuova evangelizzazione coincida con la carità, cosicchè il Vangelo, “non sia più solo parola, ma realtà vissuta”.
In merito al peso economico e sociale della crisi, il cardinale Bagnasco ha affermato che “il popolo italiano si è mostrato ancora una volta solido nella capacità di dedizione e di sacrificio ha rivelato forza di tenuta e di speranza”.
“Ma nessuno s’illuda o cerchi spiegazioni ideologiche e parziali: – ha precisato – se ciò è accaduto, prima che ai risparmi, alle autoriduzioni, alla revisione di stili di vita, ciò è dovuto al naturale e insostituibile moltiplicatore di ogni più piccola risorsa: la famiglia!”.
In merito alla crisi politica, il presidente della CEI ha detto chiaramente che “La gente vuole che la politica cessi di essere una via indecorosa per l’arricchimento personale”
Per il presidente della CEI “alla radice del bene comune troviamo le realtà primarie della vita, della famiglia e della libertà, che si intrecciano e si richiamano universalmente perché sono valori fondativi e quindi irrinunciabili dell’umano”.
In questa cornice, il cardinale Bagnasco ha sostenuto l’importanza della campagna “Uno di noi”, milioni di firme per fare dell’Europa il continente che riconosce la vita fina dal concepimento.
L’arcivescovo di Genova ha concluso ricordando le parole del venerabile Paolo VI il quale parlò del Concilio Vaticano II come “un potente e amichevole invito all’umanità d’oggi a ritrovare […] quel Dio ‘dal Quale allontanarsi è cadere, al Quale rivolgersi è risorgere, nel Quale rimanere è stare saldi, al Quale ritornare è rinascere, nel Quale abitare è vivere’ (Sant’Agostino, Soliloqui, I,1 3)(7 dicembre 1965)”.

Riprendiamo il testo del dépliant fatto stampare da monsignor RaffaelloMartinelli, vescovo della diocesi di Frascati, nel quale sono sintetizzati alcuni principali motivi per la scelta di tale insegnamento. Nei prossimi giorni, genitori ed alunni sono infatti chiamati a fare le loro scelte al riguardo.
***
Perché scegliere l’insegnamento della religione cattolica nella scuola?
Per almeno 7 motivi:
1) approfondire la specificità, l’originalità, l’unicità della religione cattolica, attraverso la Bibbia e le modalità specifiche della scuola;
2) conoscere meglio Gesù Cristo, venuto perché “tutti abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”(Gv 10,10), Colui che “svela pienamente l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione” (Gaudium et spes n. 22);
3) sviluppare maggiormente la mia dimensione religiosa, connaturale e complementare con le altre dimensioni, così da maturare una personalità completa, felice e libera;
4) ricercare le risposte profonde alle domande fondamentali della mia esistenza, ai “perché” delle persone e del mondo;
5) comprendere meglio la cultura del passato e del presente, in particolare quella italiana ed europea, che ha nella fede cristiana la matrice e la chiave di lettura;
6) avere un confronto sereno e ragionato con le altre religioni;
7) usufruire, nel mio cammino formativo, di un qualificato servizio, di un’opportunità preziosa, offertami dallo Stato, dalla Scuola e dalla Chiesa Cattolica.

Cari studenti e genitori,
nelle prossime settimane sarete chiamati a esprimervi sulla scelta di avvalersi dell’Insegnamento della religione cattolica (Irc).
L’appuntamento si colloca in un tempo di crisi che investe la vita di tutti. Anche la scuola e i contesti educativi, come la famiglia e la comunità ecclesiale, sono immersi nella medesima congiuntura. Noi Vescovi italiani, insieme e sotto la guida di Benedetto XVI, animati dallo Spirito Santo che abita e vivifica ogni tempo, vogliamo ribadire con convinzione che la «speranza non delude» (Rm 5,5).
Sono proprio i giovani – ricorda a tutti il Santo Padre – che «con il loro entusiasmo e la loro spinta ideale, possono offrire una nuova speranza al mondo… Essere attenti al mondo giovanile, saperlo ascoltare e valorizzare, non è solamente un’opportunità, ma un dovere primario di tutta la società, per la costruzione di un futuro di giustizia e di pace. Si tratta di comunicare ai giovani l’apprezzamento per il valore positivo della vita, suscitando in essi il desiderio di spenderla al servizio del Bene» (BENEDETTO XVI, Messaggio per la XLV Giornata Mondiale della Pace, 8 dicembre 2011).
Noi Vescovi vogliamo anzitutto ascoltare le domande che vi sorgono dal cuore e dalla mente e insieme con voi operare per il bene di tutti. Lo abbiamo fatto nel redigere le nuove indicazioni per l’Irc nella scuola dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo, con l’impegno di sostenere una scuola a servizio della persona. Siamo persuasi, infatti, che la scuola sarà se stessa se porterà le nuove generazioni ad appropriarsi consapevolmente e creativamente della propria tradizione. L’Irc, oggi come in passato, aiuterà la scuola nel suo compito formativo e culturale facendo emergere, “negli” e “dagli” alunni, gli interrogativi radicali sulla vita, sul rapporto tra l’uomo e la donna, sulla nascita, sul lavoro, sulla sofferenza, sulla morte, sull’amore, su tutto ciò che è proprio della condizione umana. I giovani domandano di essere felici e chiedono di coltivare sogni autentici. L’Irc a scuola è in grado di accompagnare lo sviluppo di un progetto di vita, ispirato dalle grandi domande di senso e aperto alla ricerca della verità e alla felicità, perché si misura con l’esperienza religiosa nella sua forma cristiana propria della cultura del nostro Paese.
Cari genitori, studenti e docenti, ci rivolgiamo a voi consapevoli che l’Irc è un’opportunità preziosa nel cammino formativo, dalla scuola dell’infanzia fino ai differenti percorsi del secondo ciclo e della formazione professionale, perché siamo convinti che si può trarre vera ampiezza e ricchezza culturale ed educativa da una corretta visione del patrimonio cristiano-cattolico e del suo peculiare contributo al cammino dell’umanità.
Riteniamo nostro dovere di Pastori ricordare, a tutti coloro che sono impegnati nel mondo della scuola, le parole del Papa per questo Anno della fede: «Ciò di cui il mondo oggi ha particolarmente bisogno è la testimonianza credibile di quanti, illuminati nella mente e nel cuore dalla Parola del Signore, sono capaci di aprire il cuore e la mente di tanti al desiderio di Dio e della vita vera, quella che non ha fine» (BENEDETTO XVI, Porta fidei, n. 15).
Roma, 26 novembre 2012
PRESIDENZA DELLA CEI
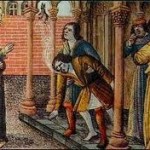
Prima lettura: Geremia 1,4-5.17-19
|
Nei giorni del re Giosìa, mi fu rivolta questa parola del Signore: «Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni. Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi, àlzati e di’ loro tutto ciò che ti ordinerò; non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti». |
La lettura di oggi contiene la chiamata e la missione del profeta Geremia in un «racconto autobiografico» (in prima persona). La pericope liturgica decurta il testo biblico di circa dieci versetti (mancano i vv. 6-16). I redattori delle letture di questa domenica hanno voluto ritenere solo quelle parti in cui si esprime il conflitto tra il profeta ed i suoi avversari, in vista del Vangelo di oggi, nel quale assistiamo ad un contrasto analogo tra Gesù ed i suoi ascoltatori nella sinagoga di Nazaret.
— vv. 4-5: «Prima di formarti nel grembo materno…». Con queste parole ben note Dio rivela al profeta la sua vocazione: esse manifestano l’assoluta, sovrana potenza di Dio nel costituire Geremia profeta in vista della sua futura missione. Il profeta venne all’esistenza proprio per realizzare la sua missione: in certo senso il suo esistere ed il suo essere mandato formano un’unica ed identica realtà. Inoltre la chiamata di Dio è come una consacrazione («ti ho consacrato»), una speciale investitura che abbraccia tutta la persona del profeta. Anche se occorre molto coraggio per essere l’inviato di Dio, la sua forza deriva da questa investitura da parte del Signore.
— vv. 18-19: «una colonna di ferro e un muro di bronzo…». Il profeta viene paragonato ad una città fortificata, che i nemici assediano senza poterla espugnare. Immagine (o metafora) marziale, impiegata per mettere in risalto anche la dura battaglia che il profeta è chiamato a sostenere.
—v. 19: «sono con te per salvarti». Ecco l’unica certezza che sorregge il profeta. Questa «formula di assistenza», con cui il Signore o il suo angelo promettono l’assistenza indefettibile di Dio agli inviati («Io sono con te…», «Il Signore è con te»), ricorre spesso nella Sacra Scrittura, ad esempio in Es 3,12; Rut 2,4; Lc 1,28, e nella nostra liturgia. È un invito, rivolto alle persona inviate, ad aver fiducia in Dio. Costoro devono affidare a Dio la loro missione, e non cercare altrove le loro certezze.
Seconda lettura: 1Corinzi 12,31-13,13
|
Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi. E allora, vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo, per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità! |
Solitamente si ama definire la lettura di oggi «l’inno alla carità», uno dei testi più celebri del Nuovo Testamento. Il brano liturgico va riposto esattamente nel contesto in cui Paolo (nella 1 Cor.) parla dei carismi. È lo stesso contesto della II Lettura di domenica scorsa.
— vv. 12-31: «desiderate intensamente i carismi più grandi». I cristiani di Corinto mostrano grande interesse per i doni o carismi, specie quelli più spettacolari, che attirano ed alimentano il loro orgoglio, rappresentando qualcosa di speciale. Paolo ristabilisce il giusto ordine nella realtà di questi doni. In tale ordine il posto centrale lo detiene il dono dell’amore. Chi ha ricevuto questo carisma dell’amore, ha ricevuto il più grande dei doni.
— vv. 1-3: «le lingue degli uomini e degli angeli, ecc.». Perché il dono dell’amore è realtà centrale rispetto ad ogni altro dono? Paolo ne spiega il motivo, affermando che esso è la condizione che garantisce l’autenticità di tutti gli altri carismi. Il parlare in lingue misteriose (v. 1), l’esercitare la profezia (v. 2), l’avere la scienza di tutte le realtà più misteriose, come pure l’aver fede e capacità di trasportare le montagne (v. 2), la stessa grazia del martirio non sono valori assoluti e a sé stanti; valgono soltanto se trovano la loro profonda motivazione nel dono dell’amore.
— vv. 4-7: «Magnanima, benevola, non è invidiosa ecc.». L’Apostolo enumera ben 15 qualità: inizia con due caratteristiche positive, continua con otto negative (ciò che l’amore non è, e non fa), e conclude con cinque positive. Questo elogio diligentemente strutturato dell’amore mira a sottolineare quelle virtù, opposte alla vanagloria ed alla ricerca di sé, che sono appunto all’origine di quelle spinte segrete che portano molti cristiani di Corinto a desiderare i carismi per sé. Vogliono avere i carismi per essere diversi e superiori agli altri.
— vv. 8-12: «La carità non avrà mai fine…». A differenza dei carismi, che prima o poi hanno fine, la carità dura per sempre. Lo stesso carisma della conoscenza, che pure è permanente, è da considerare provvisorio nel senso che nel tempo presente non può essere che parziale e frammentario, incompleto. Per questo la conoscenza è paragonata all’immagine sfocata e approssimativa che si vede in uno specchio metallico usato nell’antichità; oppure, è paragonata alla capacità conoscitiva che ha un bambino rispetto a quella di un adulto. La carità invece si prolunga nell’eternità, senza alterazioni o limitazioni di sorta. Inoltre, la carità è come un legame che ci congiunge con la vita eterna.
— v. 13: «Ma la più grande di tutte è la carità!». Fede, speranza e carità in quanto appartengono al rapporto dell’uomo con Dio, sono importanti. Ma di queste tre, è l’amore a valere di più, perché ci avvicina maggiormente a Dio, da lui verrà maggiormente stimata e ricambiata e resterà in eterno.
Vangelo: Luca 4,21-30
|
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. |
Esegesi
Il brano del vangelo odierno è la seconda parte della cosiddetta «pericope di Nazaret», ad immediato seguito della prima parte, letta domenica scorsa. Mentre nella I parte si riferiva l’accoglienza positiva di Gesù da parte dei suoi compaesani (elogi, stupore), nella II parte ci troviamo invece di fronte all’aspetto negativo di tale accoglienza: rifiuto e ostilità. L’evangelista Luca ha voluto fare di questo episodio un momento emblematico della missione di Gesù, presentando fin d’ora la divisione degli spiriti che si opera di fonte a lui, sempre.
— v. 22: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». La meraviglia si traduce in delusione e ostilità. In realtà la sua persona «delude» le aspettative dei presenti, perché egli socialmente non appare diverso da loro. Ma anche il suo messaggio li delude, in quanto non prospetta alcun benessere terreno, alcun cambiamento politico e neanche l’esaltazione di Israele. Inoltre a Nazaret Gesù non compie i miracoli che ha compiuto altrove, specie a Cafarnao.
— v. 23: «Medico, cura te stesso». Cosciente di tale delusione, dovuta in particolare all’assenza di segni spettacolari, Gesù mette in bocca ai compaesani il proverbio, noto anche presso i rabbini: « Medico, cura te stesso ». La sua potenza taumaturgica, Gesù avrebbe dovuto metterla in mostra specialmente nella sua patria, e non lontano da essa.
— v. 24: «Nessun profeta è bene accetto nella sua patria». Al proverbio che rispecchia il pensiero dei suoi ascoltatori, Gesù ne contrappone un altro, che spiega perché egli non compia miracoli a Nazaret. Se, come tutti i profeti, non è riconosciuto e accettato nella sua patria, non può compiere prodigi semplicemente per avvalorare la sua identità e indurli a credere. La fede che esige miracoli non è vera fede.
— vv. 25-27: «C’erano molte vedove… molti lebbrosi». Con i due esempi veterotestamentari, la vedova di Zarepta e Naaman il Siro, Gesù esprime due dimensioni essenziali della sua missione: a) la sua patria, per volere divino, passa in secondo ordine di fronte agli stranieri; b) la elezione di Dio non si ferma a vincoli di patria o familiari, ma è rivolta a tutti.
— vv. 28: «Si riempirono di sdegno». Gli esempi addotti da Gesù, con l’universalismo che dichiarano, determinano sdegno e rifiuto ostile da parte dei compaesani. Se quel profeta non compie nulla per la sua patria, anzi mostra di offrire agli stranieri i suoi benefici, non appartiene più ad essa: va ripudiato. Stando al testo del Dt. 13,2, un profeta che non vuole garantire la sua missione con segni, merita la morte. Perciò lo conducono fuori, per ucciderlo.
— v. 30: «si mise in cammino». Come spesso il Vangelo di Giovanni sottolinea il fatto che i Giudei non poterono catturare Gesù «perché non era ancora giunta la sua ora» (Gv 7,30; 8,20:10,39), così qui Luca vuol dire che Gesù passa liberamente in mezzo a coloro che lo hanno condotto fuori della città non tanto per fare un miracolo (che finora ha rifiutato) quanto per affermare la sua sovrana libertà di fronte alla morte. Tale «momento» arriverà, non per fatalità, per effetto di complotti umani o sdegno di popolo, ma per sua libera scelta. Alla luce di ciò, acquista particolare spessore teologico il verbo finale: «si mise in cammino». Respinto e rifiutato dalla sua patria, Gesù a sua volta se ne va, le volta le spalle, la ripudia, per portare altrove l’annuncio di salvezza.
Meditazione
La liturgia ci fa ascoltare in due domeniche successive quanto avviene nella sinagoga di Nazaret. Domenica scorsa abbiamo interrotto la narrazione di Luca nel momento in cui Gesù, dopo aver proclamato la lettura dal rotolo del profeta Isaia, ne afferma il suo compimento oggi. In questa domenica leggiamo la seconda parte del racconto, che si sofferma sulla reazione dei suoi concittadini presenti alla preghiera sinagogale. La meraviglia iniziale si trasforma presto in sdegno, sino al punto di cacciarlo fuori dalla città e tentare di ucciderlo buttandolo giù da precipizio (cfr. v. 29). La meraviglia dei nazaretani diventa così lo stupore di noi ascoltatori: come mai questo diverso e addirittura contrapposto atteggiamento? Cosa fa passare dalla meraviglia allo sdegno? Diversamente da quanto accade nel racconto degli altri Sinottici, in Luca queste contrastanti reazioni nascono entrambe dall’ascolto della parola di Gesù. Descrivono due opposte conseguenze dell’ascoltare, o meglio due differenti modi di ascoltare. Non soltanto la meraviglia per le parole di grazia che escono dalla bocca di Gesù, ma anche lo sdegno nasce «all’udire queste cose» (v. 28). C’è dunque un aspetto di questa parola che affascina e stupisce, e che siamo disposti ad accogliere volentieri; ma c’è anche un altro taglio più duro da accettare, che esige una conversione delle nostre attese, perché la Parola si compie sempre nel modo che non immaginavamo. Di conseguenza, o siamo disposti a lasciarci sorprendere e convertire, o altrimenti ne restiamo scandalizzati.
Gesù discerne cosa c’è nel cuore dei suoi concittadini, lo intuisce e lo porta in piena luce. «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”» (v. 23). Innanzitutto tra i tuoi, per quelli della tua casa. Tu che sei il figlio di Giuseppe, uno di noi, guarda anzitutto ai nostri bisogni. Nel cuore dei nazaretani c’è la tentazione di requisire e circoscrivere l’azione di Gesù. Ciò che si manifesta in questa pretesa non è soltanto il rifiuto del carattere universale della salvezza. Che Gesù compia prodigi a Cafarnao o altrove ai nazaretani sta anche bene, purché li compia anzitutto ‘nella sua patria’. La tentazione più grave consiste nel non riconoscere i segni della salvezza là dove germogliano perché essi non sono il soddisfacimento immediato del proprio bisogno personale. Occorre invece rallegrasi per i segni della salvezza anche se sono per altri perché comunque testimoniano la vicinanza di Dio al suo popolo; annunciano che la misericordia del Signore diviene un oggi nella nostra storia.
Gesù cita due proverbi: «Medico, cura te stesso» e subito dopo «Nessun profeta è ben accetto nella sua patria». Vi risuonano due appellativi, entrambi riferiti a Gesù: ‘medico’ e ‘profeta’. Il primo sembra più esprimere il punto di vista dei nazaretani e l’idea che hanno maturato di Gesù, o l’attesa che nutrono nei suoi confronti. Il secondo indica piuttosto come Gesù interpreta la propria missione e desidera compierla. Per i cittadini di Nazareth Gesù è il medico che deve curare le loro infermità e colmare i loro bisogni. Gesù invece afferma di essere anzitutto un profeta, vale a dire un uomo che compie sì segni e guarigioni, ma non semplicemente per appagare un bisogno, ma per rivelare che la promessa di Dio, custodita dalla sua Parola, ha iniziato ad attuarsi nella storia. Per il profeta il segno rinvia alla Parola, la quale a sua volta esige un affidamento e un atto di fede che oltrepassa il segno stesso. Si riconosce il segno, ma per credere nella Parola.
I nazaretani, al contrario, hanno saputo dei segni già operati da Gesù, ma essi, anziché nutrire la fede nella sua persona, li conducono a pretendere altri segni che risolvano i loro problemi. Questa è la tua casa, la tua patria, qui c’è la tua gente e i tuoi parenti: tutto ciò ci offre un diritto e una pretesa nei tuoi confronti. Fa’ anche qui, nella tua patria, quanto vai facendo altrove. Tra questi nazaretani ci sono certamente molti bisogni veri, numerose infermità da guarire e oppressioni da liberare, le stesse che Gesù incontrerà e sanerà altrove; il problema è che tutto ciò viene vissuto nella forma della pretesa e non in quella dell’affidamento. Con l’atteggiamento dei ricchi, dunque, e non con il cuore dei poveri. Ma è ai poveri che viene annunciato l’evangelo della salvezza, come Gesù ha appena affermato citando il profeta Isaia.
Gesù legge nei cuori dei nazaretani l’invito a compiere «anche qui, nella tua patria, quanto hai fatto a Cafarnao» (cfr. v. 23). Luca, in verità, non lo ha ancora raccontato, lo racconterà nei capitoli seguenti del suo vangelo. Ma forse questa non è tanto una svista narrativa, quanto un modo raffinato per invitare il suo lettore ad andare a vedere ciò che Gesù opera a Cafarnao. Tra i vari miracoli si staglia la guarigione del servo del centurione narrata all’inizio del capitolo settimo (vv. 1-10). Un episodio che aiuta a capire, in un gioco di contrasti, proprio ciò che accade nella sinagoga di Nazaret. Il centurione è un pagano che si riconosce indegno di ricevere Gesù nella sua casa. Il suo è un atteggiamento completamente diverso da quello dei concittadini di Gesù. Questi ultimi vantano dei diritti su Gesù, perché era uno di loro. Questo pagano non solo non avanza pretese, ma per ben due volte, con insistenza, afferma di non essere degno, mentre al contrario i Giudei presentano a Gesù le sue credenziali: «egli merita che tu gli conceda quello che chiede – dicevano – perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga» (vv. 4-5). «Egli merita» – «Io non sono degno»: davvero forte è il contrasto tra il punto di vista dei Giudei e quello di questo centurione che, oltre a non vantare diritti e a non pretendere il segno, non attende neppure che il segno si compia per credere alla parola di Gesù. Si affida a essa subito, radicalmente, come un povero che sa di dover dipendere in tutto da quella parola, così come un soldato dipende dalla parola del suo superiore: «di’ una parola e il mio servo sarà guarito» (v. 7). L’episodio si conclude con lo stupore di Gesù: «All’udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande!» (v. 9).
Neppure in Israele, neanche nella mia patria! Come i nazaretani erano ammirati dalle parole di grazia che uscivano dalla bocca di Gesù, così ora è Gesù ad ammirare le parole di fede che escono dalla bocca di questo centurione. Egli ha infatti compreso che la parola della grazia si compie per chi non ha meriti da vantare, ma può soltanto riconoscersi indegno davanti alla gratuità della salvezza, come un povero che sa accoglierla nella propria casa e nella propria vita. Ai poveri è annunciato l’evangelo della salvezza, che è gratuito e universale, non fa differenze sulla base dei meriti e dei diritti presunti o acquisiti, ma ha comunque un destinatario privilegiato nei poveri, in chi sa accoglierlo nell’umiltà del non riconoscersene degno.
Noi ripetiamo la parola del centurione in ogni celebrazione eucaristica: «Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dì soltanto una parola e io sarò salvato». La parola della salvezza, per diventare davvero un oggi nella nostra vita, ha bisogno di questo atteggiamento e di questa accoglienza.
Preghiere e racconti
Il maestro non amava i discorsi eruditi che gli altri chiamavano invece “perle di saggezza”. I discepoli gli chiesero: Se sono parole perché le disprezzi? Il maestro replicò: Avete mai visto perle che crescono se seminate in un campo?
Furono riempite dodici ceste. Questo fatto è mirabile per la sua grandezza, utile per il suo carattere spirituale. Quelli che erano presenti si entusiasmarono, mentre noi, al sentirne parlare, rimaniamo freddi. Questo è stato compiuto affinché quelli lo vedessero ed è stato scritto affinché noi lo ascoltassimo. Quello che essi poterono vedere con gli occhi, noi possiamo vederlo con la fede. Noi contempliamo spiritualmente ciò che non abbiamo potuto vedere con gli occhi. Noi ci troviamo in vantaggio rispetto a loro, perché a noi è stato detto: Beati quelli che non vedono e credono (Gv 20,29). Aggiungo che forse a noi è concesso di capire ciò che quella folla non riuscì a capire. Ci siamo così veramente saziati, in quanto siamo riusciti ad arrivare al midollo dell’orzo. Insomma, come reagì la gente di fronte al miracolo? Quelli, vedendo il miracolo che Gesù aveva fatto, dicevano: Questi è davvero il profeta (Gv 6,14). […] Ma Gesù era il Signore dei profeti, l’ispiratore e il santificatore dei profeti, e tuttavia un profeta, secondo quanto a Mosè era stato annunciato: Susciterò per loro un profeta simile a te (Dt 18,18). Simile secondo la carne, superiore secondo la maestà. E che quella promessa del Signore si riferisse a Cristo, noi lo apprendiamo chiaramente dagli Atti degli apostoli. Lo stesso Signore dice di se stesso: Un profeta non riceve onore nella sua patria (Gv 4,44). Il Signore è profeta, il Signore è il Verbo di Dio e nessun profeta può profetare senza il Verbo di Dio; il Verbo di Dio profetizza per bocca dei profeti, ed è egli stesso profeta. Cristo è profeta e Signore dei profeti, così come è angelo e Signore degli angeli. Egli stesso è detto angelo del grande consiglio (cfr. Is 9,6). E del resto, che dice altrove il profeta? Non un inviato né un angelo, ma egli stesso verrà a salvarci (cfr. Is 35,4); cioè a salvarci non manderà un messaggero, non manderà un angelo, ma verrà egli stesso.
(AGOSTINO, Omelie sul vangelo di Giovanni 24,6-7, in Opere di sant’Agostino, pp. 564-566).
Il profeta, Signore, non è un depositario di verità,
ma un testimone di bene.
Non sa dire cose sublimi, ma le compie.
Annuncia la speranza nella disperazione,
la misericordia nel peccato,
l’intervento di Dio dove tutto sembra morto.
Il profeta è consapevole dei suoli limiti, delle sue debolezza,
dei suoi dubbi, delle sue incapacità, della sua inesperienza,
ma è anche sereno e coraggioso,
perché Dio lo ha scelto e amato.
Il profeta fa la scelta di Dio,
vive la comunione intima con lui.
Essere profeti oggi, significa passare da una pastorale di conversazione
ad una pastorale missionaria,
significa essere presenti là dove la gente
vive, lavora, soffre, gioisce.
Tu, Signore, sei il profeta per eccellenza
che dobbiamo ascoltare e accogliere.
Tua chiesa erano le piazze, le rive dei fiumi,
i monti, le strade.
Ogni cristiano è profeta,
è la tua bocca che evangelizza,
che parla davanti agli uomini, al mondo, alla storia.
Signore, aiutaci ad essere profeti di frontiera
là dove scorre la vita della gente.
(A. Merico)
Tu ci parli. Signore, attraverso profeti pienamente inseriti nelle vicende del loro popolo e del loro tempo e insieme capaci di restare in solitudine o di andare nel deserto per fare riascoltare la tua Parola a coloro che li seguono.
Tu ci parli, Signore, attraverso testimoni in grado di condividere le angosce dei loro fratelli, le paure e i drammi degli uomini e insieme pieni di fede nell’indicare la tua presenza già operante, la tua promessa suscitatrice di vita.
Tu ci parli, Signore, attraverso uomini che sanno contestare coraggiosamente le mode, le abitudini, i pregiudizi, i luoghi comuni dei loro contemporanei e insieme profondamente solidali con loro nel ricercare il tuo volto che salva, nel parlare al cuore di chi dispera.
Guarda, ti preghiamo, alla tua Chiesa, alla Chiesa del nostro tempo, a noi che siamo il tuo popolo, costituiti per tua grazia profeti e testimoni della tua verità: donaci di essere mediatori della tua consolazione nel momento stesso in cui denunciamo le nostre e le altrui ipocrisie. Nei deserti della nostra società fa’ risuonare la tua Parola, perché anche noi ‘usciamo’, confessando i nostri peccati per essere di nuovo immersi nella grazia del tuo Spirito.
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
———
– M. FERRARI, «Oggi di è adempiuta questa scrittura». Avvento, Tempo di Natale e Tempo ordinario (prima parte), Milano, Vita e Pensiero, 2012.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
PER L’APPROFONDIMENTO:


Prima lettura: Neemia 8,2-4.5-6.8-10
|
In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all’assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci d’intendere; tutto il popolo tendeva l’orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno, che avevano costruito per l’occorrenza. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: «Amen, amen», alzando le mani; si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. I levìti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemìa, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: «Questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio; non fate lutto e non piangete!». Infatti tutto il popolo piangeva, mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemìa disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro; non vi ratristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza». |
Il libro di Neemia può essere diviso in tre parti: la prima (cc. 1-7) narra la ricostruzione delle mura di Gerusalemme, la riforma sociale e l’organizzazione della città; la seconda (cc.
8-9) presenta la promulgazione della legge giudaica a cui fa seguito la festa dei tabernacoli, la preghiera penitenziale e l’impegno assunto dalla comunità nei confronti della legge; la terza parte (cc. 10-13) contiene alcuni dati statistici e informa sulle ultime azioni di Neemia. Il brano della nostra lettura si trova nella seconda parte, di cui è un momento culminante.
Il tratto dà il quadro grandioso e solenne dell’avvenimento costitutivo della comunità giudaica, e cioè della promulgazione della legge. Esdra e i leviti leggono alcune parti della legge; è il giorno della nascita del giudaismo. L’assemblea del popolo ascolta in piedi la proclamazione della legge; il popolo viene direttamente interpellato e posto di fronte alle sue responsabilità e ai suoi doveri nei confronti di Dio quale comunità dell’alleanza. Avviene una liturgia vera e propria; Esdra benedice il Signore, i presenti rispondono: amen, compiendo il gesto rituale di alzare le mani; poi tutti si inginocchiano e adorano il Signore. Questi aspetti liturgici della descrizione sono molto simili alla celebrazione del culto giudaico nel periodo sinagogale.
Nella liturgia della Chiesa questo testo biblico che, nell’annuncio e nell’accoglienza della legge di Dio, pone l’atto di nascita della comunità del popolo eletto dopo l’esilio, assume il significato di indicare che nella presente celebrazione l’ascolto della parola di Dio e l’adesione ad essa nella fede crea e mantiene la comunità dei credenti in Cristo; attorno alla parola di Dio la chiesa viene costituita in assemblea liturgica cultuale. Si ha così una visualizzazione dell’insegnamento del concilio ecumenico Vaticano secondo: «Il popolo di Dio viene adunato anzitutto per mezzo della parola del Dio vivente (…), in virtù della parola salvatrice la fede si accende e si alimenta nel cuore dei credenti, e con la fede ha inizio e cresce la comunità dei credenti» (Presbyterorum Ordinis n. 4). L’evento raccontato nella lettura è anticipazione della costituzione della Chiesa viva e la Chiesa viva è compimento e realizzazione della prefigurazione profetica descritta nella lettura.
Seconda lettura: 1Corinzi 12,12-30
|
Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse: «Poiché non sono mano, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. E se l’orecchio dicesse: «Poiché non sono occhio, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato? Ora, invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; oppure la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». Anzi proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie; e le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? |
Il brano della lettura, che fa seguito immediato a quello della domenica precedente, si trova nella seconda parte della lettera, nel punto in cui l’apostolo risolve i quesiti che gli sono stati posti. Qui continua a trattare il tema dei carismi, esponendo l’immagine dell’unico corpo di Cristo.
In questo tratto l’autore insiste sulla necessità che tutti, dotati di doni diversi, collaborino alla missione dell’unica Chiesa. Si serve dell’esempio delle membra e del corpo, esempio allora classico. Tutte le membra hanno una funzione indispensabile per il bene di tutto. In tale unità e solidarietà non c’è posto per i complessi di inferiorità o di superiorità, tutti portano un contributo tutti compiono una funzione. Ma la Chiesa unita e solidale a modo del corpo fisico forma realmente il corpo di Cristo, animato dalla vita dello Spirito Santo. È una delle grandi idee sul mistero della Chiesa. Essa non è una società nata dalle varie iniziative degli uomini, diretta da loro; esprime invece e attua una unità mistica che è Cristo nell’atto di riunire i credenti. Con il battesimo tutti i cristiani sono incorporati in Cristo per opera dello Spinto Santo; tutti fummo abbeverati di uno stesso Spirito, cioè ricevemmo l’abbondanza del suo dono. Dal battesimo sorgono le diverse funzioni elencate per il bene della chiesa. Il termine «apostoli» non comprende soltanto il gruppo dei Dodici, ma tutti i predicatori del vangelo, favoriti di carismi divini; i dottori sono coloro che con il dono della scienza e della sapienza istruiscono i fedeli nelle verità della religione; il dono di assistere è quello di compiere opere di misericordia soccorrere i poveri, i malati bisognosi. Il brano della lettura si conclude con l’esortazione ad aspirare ai carismi migliori; segue ad esso infatti l’elogio della carità.
Vangelo: Luca 1,1-4;4,14-21
|
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». |
Esegesi
Il vangelo di Luca dopo il prologo (1,1-4) si articola nel racconto dell’infanzia di Giovanni e di Gesù (1,5-2,52), nella descrizione del ministero di Gesù in Galilea (3,1-9,50), nella narrazione del grande viaggio verso Gerusalemme (9,51;19,28), nel ministero di Gesù a Gerusalemme (20-21) e nel mistero finale di morte e risurrezione (22-24). Il brano della lettura evangelica della terza domenica del tempo ordinario nel ciclo C congiunge due tratti evangelici staccati, e cioè l’inizio, il prologo (Lc 1,1-4) e la inaugurazione del ministero pubblico di Gesù in Galilea nella sinagoga di Nazaret (Lc 4).
Aspetti di esegesi
Prologo: Questo prologo di Luca al suo vangelo composto con arte e con armonia di parti, ha un’andatura classica e attesta il proposito dell’evangelista di comporre un’opera storica coscienziosa. Molti avevano già scritto intorno alla vita e agli insegnamenti di Gesù. Luca vuole servirsi di fonti scritte, interrogare le fonti orali più accreditate, cioè i testimoni oculari, specialmente gli apostoli. Dopo questa indagine accurata e universale l’evangelista scriverà tutto con ordine, disponendo i fatti in un vasto disegno e quadro storico e cronologico non trascurando la connessione logica. L’opera è dedicata a Teofilo, personaggio di famiglia elevata, appartenente alla nobiltà. Luca scrive infatti: «Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto» (Lc 1,1-4).
Inaugurazione del ministero di Gesù a Nazaret. All’inizio dell’attività di Gesù la scena qui descritta costituisce un momento programmatico. In un solo tratto Luca mette in evidenza le grandi idee dell’opera di Gesù; Gesù agisce mosso e guidato dallo Spirito: «In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode» (Lc 4,14-15); lo Spirito, che era disceso su Gesù nel battesimo ora agisce in lui ispirandolo, conducendolo, e rendendo efficace il suo ministero; lo Spirito e Cristo sono inseparabili; Gesù incomincia ad insegnare ed è ammirato e lodato dalle folle; il seguito del racconto infatti informa che «Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca» (Lc 4,22); l’affermazione secondo cui la sua fama si diffuse in tutta la regione è come un ritornello nel vangelo di Luca, che lo ripete dopo l’insegnamento a Cafarnao (Lc 4,37), dopo la guarigione del lebbroso (Lc 5,15) e dopo la risurrezione del figlio della donna di Naim (Lc 7,17).
In Gesù si compie la vocazione espressa nell’antico Testamento nel libro di Isaia nel testo profetico 61,1-2 che egli legge nella sinagoga di Nazaret ove inaugura il suo ministero: «Secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore» (Lc 4,16-19; Is 61,1-2).
Il testo descrive la chiamata e la missione del profeta come annuncio e messaggio di consolazione; Gesù applica a sé il testo profetico: «Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» (Lc 4,20-21). Gesù è unto da Dio Padre con lo Spirito Santo per la missione; il compito di tale missione consiste nell’annunziare il lieto messaggio ai poveri, nel proclamare la liberazione ai prigionieri, nel dare la vista ai ciechi, nel rimettere in libertà gli oppressi, nel predicare l’anno di grazia. Si tratta di una funzione che ha carattere profetico e insieme messianico; a tale compito egli è abilitato dallo Spirito Santo a lui donato da Dio Padre come unzione per la consacrazione. Il brano evangelico risulta così una presentazione che Gesù fa di se stesso inaugurando il suo ministero.
Meditazione
Erano stati il battesimo ricevuto al Giordano (cfr. Lc 3,21-22) e lo scontro con Satana nel deserto (cfr. Lc 4,1-13) a dargli quell’energia incontenibile. Il dono dello Spirito Santo e la vittoriosa lotta contro lo spirito del male gli avevano dato una carica e una lucidità profetica uniche. Gesù ormai girava insegnando tra le genti e queste «gli rendevano lode» (Lc 4,15). Assistiamo incantati allo sbocciare della vocazione travolgente di Gesù. La tradizione monastica definisce questo momento del cammino ‘fervore novizio’, dove ogni ostacolo è vinto dalla passione di un’ardente adesione all’evangelo.
Gesù torna al luogo delle sue origini, tra i suoi famigliari, a Nazaret. E anche qui, una volta ancora, pone al centro della sua vita e delle relazioni con i suoi conoscenti la parola di Dio, secondo una metodologia tanto antica – ce ne viene fatta una precisa descrizione nella prima lettura, tratta dal libro di Neemia – quanto attuale anche per noi, essendo quella che ancor oggi viene seguita nelle nostre liturgie: scelta una sezione dal Libro, questa viene proclamata con chiarezza e autorità, facendovi seguire un commento esplicativo e attualizzante, al fine di mostrare la pertinenza del testo con la vita di chi ascolta e provocare la meditazione, la conversione, la preghiera.
Il brano scelto da Gesù è uno dei più luminosi di tutto il Primo Testamento. Narra di un personaggio che, rinnovato dall’unzione dello Spirito Santo, viene incaricato dal Signore di recare una esaltante comunicazione: «mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore» (Lc 4,18-19).
Dopo la lettura, è certo che deve essere sceso un silenzio perfetto in quell’assemblea. Ancor oggi è forse il momento della celebrazione in cui l’attenzione è massima, perché ci si prepara ad ascoltare il commento che verrà tenuto (e a valutare il predicatore…). Se poi a svolgere questo incarico è un ragazzo del paese, di cui si sente dire un gran bene, è facile immaginare la scena: un’assemblea quasi in ‘apnea’, con gli occhi fissi su di un unico punto… (cfr. Lc 4,20).
Personalmente, sono intrigato dal tentativo di ipotizzare cosa potesse passare in quel frangente per il cuore e per la mente di Gesù. Il seguito del racconto, non riportato dal brano liturgico, ci fa sapere che il suo stato d’animo non era affatto assalito da vergogna, timidezza o da una qualche forma di soggezione verso i suoi conterranei (cfr. Lc 4,23-27). Ho invece il sospetto che Gesù stesse rapidamente rendendosi conto che, a partire da quanto aveva vissuto precedentemente e da quanto aveva appena letto, il misterioso personaggio, datore dell’universale messaggio di liberazione, potesse essere… lui stesso. Come ogni altro essere umano, seppur secondo una specialissima esperienza, Gesù è andato ricercando quale potesse essere il miglior modo per rendere onore a Dio, è andato ricercando segni storici per contribuire ad attuare il sogno di Dio.
Non sappiamo quanti secondi o minuti sia durato il silenzio in cui l’assemblea e Gesù erano immersi. Certo è che la prima parola risuonata dalla bocca del «figlio di Giuseppe» (Lc 4,22) ha proprio dell’incredibile: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» (Lc 4,21). In modo ancor più suggestivo, il testo originale greco afferma: «che si è compiuta nei vostri orecchi». Ora, non era la prima volta che le parole del profeta Isaia risuonavano in una sinagoga. Ma in Gesù si realizzano in modo assolutamente unico, perché in lui vanno a coincidere. Lui è la Parola, che realizza tutte le attese e le profezie. Tutta la sua esistenza sarebbe stata lo ‘svolgimento’ del messaggio di liberazione annunciato e atteso. Detto in altre parole, Gesù sta dicendo di essere il Messia e che avrebbe portato una svolta decisiva al Regno di Dio.
Non credo che noi potremo mai renderci conto di quello che devono aver provato gli ascoltatori presenti in quel luogo di culto. Forse tra costoro c’erano alcuni che sono poi diventati, secondo la testimonianza dell’evangelista Luca, «testimoni oculari» (Lc 1,2) della vicenda di Gesù. Comunque sia, non abbiamo da rimpiangere nulla: ogni volta che ascoltiamo e celebriamo la parola evangelica, possiamo entrare in relazione con il Signore Gesù in modo certamente più profondo ed esistenziale di quanto hanno potuto fare gli abitanti di Nazaret; anche perché siamo meglio a conoscenza del destino e della speranza che Gesù
ha inaugurato. Ascoltatori della Parola per vivere della Parola!
Preghiere e racconti
C’è un profondo bisogno di amore in ciascuno di noi, così spesso prigionieri delle nostre solitudini. È il bisogno di una parola di vita che vinca le nostre paure e ci faccia sentire amati. Il profeta Amos descrive con efficacia questa situazione: “Ecco, verranno giorni oracolo del Signore Dio – in cui manderò la fame nel paese; non fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare le parole del Signore” (8,11). E sant’Agostino – che quella Parola ha incontrato, fino a farne la ragione di tutta la sua vita – così presenta la risposta del Dio vivente al nostro bisogno: “Da quella città il Padre nostro ci ha inviato delle lettere, ci ha fatto pervenire le Scritture, onde accendere in noi il desiderio di tornare a casa” (Commento ai Salmi, 64, 2-3).
Se si arriva a comprendere – come è capitato a tanti credenti di ieri e di oggi – che la Bibbia è questa “lettera di Dio”, che parla proprio al nostro cuore, allora ci si avvicinerà a essa con la trepidazione e il desiderio con cui un innamorato legge le parole della persona amata. Allora, Dio, che è insieme paterno e materno nel suo amore, parlerà proprio a ciascuno di noi e l’ascolto fedele, intelligente e umile di quanto egli dice sazierà poco a poco il nostro bisogno di luce, la tua sete d’amore. Imparare ad ascoltare la voce di Dio che parla nella Sacra Scrittura è imparare ad amare: perciò, l’ascolto delle Scritture è ascolto che libera e salva.
(Bruno FORTE, Lettera ai cercatori di Dio, EDB, Bologna, 2009, 63-64).
«Quanto avrei voluto essere sacerdote per poter predicare sulla Madonna! Una sola volta sarebbe stata sufficiente per dire tutto quello che penso a questo proposito. Prima avrei fatto capire quanto poco conosciamo la sua vita. Non occorre dire cose inverosimili o che non sappiamo; per esempio che, da piccola, a tre anni, la Madonna ha offerto se stessa a Dio nel Tempio con sentimenti ardenti di amore e del tutto straordinari ; mentre forse ci é andata semplicemente per obbedire ai suoi genitori… Perché una omelia sulla Madonna possa piacermi e farmi del bene, occorre che io veda la sua vita reale, non la sua vita supposta ; e sono certa che la sua vita reale era molto semplice. Ce la mostrano inabbordabile, mentre bisognerebbe mostracela imitabile, fare vedere le sue virtù, dire che viveva di fede come noi, dare delle prove di questo per mezzo del Vangelo in cui leggiamo : « Non compresero le sue parole » (Lc 2,50). E questa parola molto misteriosa : « I suoi genitori si stupivano delle cose che si dicevano di lui » (Lc 2,33). Questo stupirsi suppone un certo meravigliarsi, non è vero? Sappiamo bene che la Madonna è Regina del Cielo e della terra, eppure è più madre che regina, e non occorre dire a motivo delle sue prerogative, che lei eclissi la gloria di tutti i santi, come il sole al suo sorgere fa scomparire le stelle. Mio Dio! quanto questo mi appare strano! Una madre che fa scomparire la gloria dei suoi figli! Io penso tutto il contrario, ritengo che essa farà crescere molto lo splendore degli eletti. È bene parlare delle sue prerogative, ma non occorre dire soltanto questo… Forse qualche anima andrà fino al punto di sentire allora una certa lontananza con una tale creatura talmente superiore e dirà : «Se le cose stanno così, ci accontenteremo di andare a brillare in un angolino».Ciò che la Madonna aveva in più rispetto a noi, era il fatto che non poteva peccare, che era esente dalla macchia originale, ma d’altra parte, è stata meno fortunata di noi, poiché non ha avuto la Madonna da amare, e questa è una tale dolcezza per noi».
(Santa Teresa del Bambino Gesù (1873-1897), carmelitana, dottore della Chiesa, in Ultimi colloqui, 21/08/1897).
«Chi non risponde alla Parola diventa sordo» (Martin Buber). L’accompagnamento non può che portare alla consapevolezza che, come ci ricorda NVNE, «tutta la vita è una risposta» (26/e) e, quindi, a saper scorgere le continue chiamate di Dio in ogni stagione della propria esistenza. È il faticoso passaggio dal cavallo al cammello.
Un cavallo va bene per la bellezza, la forza, la velocità e la razza, per godersi una cavalcata, gareggiare e vincere un premio. Tutto molto bello. Ma poi nella vita ci sono anche i deserti, e là il migliore dei cavalli è inutile e la velocità non serve. Il cavallo si spazientirà, diverrà irrequieto, gli zoccoli affonderanno nella sabbia. Il suo respiro brucerà nel calore e la bestia s’imbizzarrirà, cadrà e morirà nelle sabbie spietate. I cavalli non sono per il deserto.
I cammelli sì! Il cammello s’incamminerà e andrà avanti. Anche senza cibo, senz’acqua, senza redini, senza direzione, andrà avanti costantemente, fedelmente, sicuramente, manterrà la rotta, attraverserà il deserto, raggiungerà l’acqua e salverà se stesso e il suo cavaliere. La tenace perseveranza di mantenere fermamente la rotta nelle circostanze peggiori è una dote preziosa per sopravvivere in questo mondo. Noi tutti abbiamo bisogno di un cammello nelle nostre stalle.
(Antonio LADISA, La direzione spirituale oggi: perché?, in CENTRO REGIONALE VOCAZIONI (PIEMONTE-VALLE D’AOSTA), Corso di avvio all’accompagnamento spirituale. Atti, a cura di Gian Paolo Cassano, Casale Monferrato, Portalupi, 2007, 30).
La tua parola, Signore, mi porta a meditare,
perché è una parola dal senso inesauribile,
che non ha mai finito di offrire i suoi segreti
a colui che li cerca.
Più che alla riflessione, la tua parola m’invita
alla contemplazione, perché sei tu che mi parli
e mi fai scoprire la tua personalità,
in tutto quello che dici.
Leggendo il Vangelo per accogliere
tutta la verità che ci hai insegnato,
vorrei unirmi con più chiarezza
a tutto quello che sei.
Trasforma la mia lettura in uno sguardo profondo
che cerchi la tua presenza e raggiunga,
attraverso la tua parola, un volto d’amico
dal sorriso divino.
Arricchendosi di un testo che è vita,
il mio spirito e il mio cuore possano trovare in te
un riposo che li apra ad una conoscenza
carica d’amore.
(JEAN GALOT, Contemplazione, Benedettine, S. Agata sui due Golfi, 1987).
Nella sua Parola è Dio stesso a raggiungere e trasformare il cuore di chi crede: “La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore” (Ebrei 4,12). Affidiamoci, allora, alla Parola: essa è fedele in eterno, come il Dio che la dice e la abita. Perciò, chi accoglie con fede la Parola, non sarà mai solo: in vita, come in morte, entrerà attraverso di essa nel cuore di Dio: “Impara a conoscere il cuore di Dio nelle parole di Dio” (San Gregorio Magno).
Alla Parola del Signore corrisponde veramente chi accetta di entrare in quell’ascolto accogliente che è l’obbedienza della fede. Il Dio, che si comunica al nostro cuore, ci chiama ad offrirgli non qualcosa di nostro, ma noi stessi. Questo ascolto accogliente rende liberi: “Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Giovanni 8,31-32).
Per renderci capaci di accogliere fedelmente la Parola di Dio, il Signore Gesù ha voluto lasciarci – insieme con il dono dello Spirito – anche il dono della Chiesa, fondata sugli apostoli. Essi hanno accolto la parola di salvezza e l’hanno tramandata ai loro successori come un gioiello prezioso, custodito nello scrigno sicuro del popolo di Dio pellegrino nel tempo. La Chiesa è la casa della Parola, la comunità dell’interpretazione, garantita dalla guida dei pastori a cui Dio ha voluto affidare il suo gregge. La lettura fedele della Scrittura non è opera di navigatori solitari, ma va vissuta nella barca di Pietro.
(Bruno FORTE, Lettera ai cercatori di Dio, EDB, Bologna, 2009, 63-64).
O Gesù, ti sei presentato al tuo paese
per annunciare i tempi messianici,
per proclamare
ai poveri il lieto messaggio,
ai prigionieri la liberazione,
ai ciechi la vista,
agli oppressi la libertà,
per predicare un anno di grazia.
Grazie per tutti coloro che si adoperano per questo.
Grazie per quanti proclamano la tua Parola,
con la parola e con la vita,
con popolarità o nel silenzio.
Mandaci sempre uomini pazzi di te,
pronti a testimoniare con la vita.
Fino a quando la tua Parola viene proclamata,
è ancora tempo di speranza e di salvezza.
Solo chi si pare alla verità
e alla conoscenza della tua legge,
esperimenta gioia e riconoscenza.
(A. Merico)
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
———
– M. FERRARI, «Oggi di è adempiuta questa scrittura». Avvento, Tempo di Natale e Tempo ordinario (prima parte), Milano, Vita e Pensiero, 2012.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
PER L’APPROFONDIMENTO:

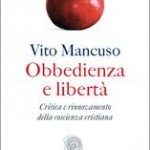
Ci va giù duro, Mancuso, quando serve. Non è la prima volta che il teologo enumera gli aspetti che non gli piacciono della sua chiesa, ma non l’aveva mai fatto dedicando un apposito saggio all’argomento.
Questo testo, incentrato sulla distinzione tra principio di autorità e principio di autenticità, riesce a toccare molti argomenti sui quali la chiesa cattolica si è pronunciata senza rispettare la libertà dell’essere umano e le più basilari verità. Per citare solo quelli più recenti, nomino la fecondazione assistita, la ricerca sulle cellule staminali embrionali, il testamento biologico, i finanziamenti statali alle scuole private…
Ma l’analisi va oltre la contemporaneità per risalire indietro nel tempo ai crimini dell’inquisizione o all’inaccettabilità di certi dogmi (come, ad esempio, il peccato originale) o alle commistioni tra religione e politica di cui siamo ancora testimoni. La libertà si può manifestare in molti modi, può aumentare la relazione e il Bene generale, o può dividere e incrementare il caos; la chiesa cattolica non ha sempre adottato le scelte giuste nel corso della sua esistenza:
Duole constatare come nel sistema prodotto dal cattolicesimo dottrinale siano spesso gli spiriti servili, miopi, conservatori (…) a fare carriera.
Pubblicato da Fazi nel 2012, questo libro è un appello alla propria chiesa, una richiesta di apertura dogmatica e di dialogo. Se una volta il cattolicesimo ricorreva ai roghi per far prevalere la sua autorità, ora deve usare la forza degli argomenti per discutere sulla Verità. L’alternativa è che l’istituzione, scollata dai fedeli che usano la ragione, imploda in se stessa.