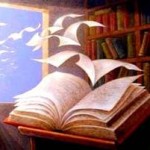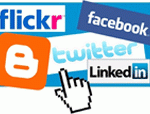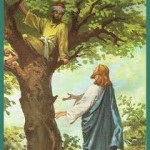Prima lettura: Atti 15,1-2.22-29
|
In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate circoncidere secondo l’usanza di Mosè, non potete essere salvati». Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono dai pagani, salute! Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d’accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi, a voce, queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agl’idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene!».
|
La liturgia della Parola di questo tempo di Pasqua (anno C) sceglie solitamente per la Prima Lettura brani degli Atti degli Apostoli. Ciò perché in questi brani sono raccontati fatti della chiesa primitiva: così nel tempo di Pasqua si ri-presenta — a livello della liturgia — la nascita della chiesa. Questa nascita è frutto e risultato della risurrezione del Signore. Siccome Egli è risorto, i dodici discepoli e le donne si radunano di nuovo attorno a Lui. Alla fine del tempo pasquale, la solennità di Pentecoste ci fa rivivere la discesa dello Spirito Santo, che realizza e guida la Chiesa.
Rilievi storico-esegetici
— Nel brano odierno si fa riferimento ad una grave crisi che sta scuotendo la chiesa primitiva. I cristiani che provengono dal mondo giudaico mettono ancora in pratica la legge giudaica e praticano la liturgia del mondo giudaico (la Torah). Il motivo di questa linea di condotta era duplice: primo, il fatto che Gesù stesso aveva ottemperato alla Torah e partecipato alle celebrazioni liturgiche del giudaismo, dato che era un Ebreo: lo stesso avevano fatto gli Apostoli e le donne insieme a Maria Madre di Gesù; secondo, la legge era stata anche rivelata da Dio: era parola e comandamento di Dio. Come la si poteva disattendere? Ecco perché i cristiani venuti dal giudaismo sostenevano che anche i cristiani che provenivano dal mondo pagano fossero tenuti ad osservare la legge giudaica (divina!).
— I primi cristiani, provenienti da ambito non giudaico vivevano ad Antiochia (nella Siria attuale), nella Cilicia (sud-est della Turchia attuale) ed un’altra area dell’Oriente. Essi avvertivano una certa perplessità davanti al fatto di dover osservare precetti biblici del giudaismo: Paolo e Barnaba, infatti, che li avevano portati alla fede cristiana, non ne avevano proprio parlato.
— L’importanza della nostra lettura (decurtata fortemente e privata di una parte notevole: mancano i vv. 3-21) è la seguente: Pietro, Paolo e Barnaba, alla luce della loro fede in Gesù Cristo, ritenevano che ad eccezione di alcune direttive importanti (ad es. il Decalogo), molti comandamenti non avevano se non valore provvisorio, limitato al mondo giudaico, ed erano sostituiti dalla fede in Gesù (Paolo aveva mostrato ciò specialmente nella Lettera ai Galati). Ma questo punto di vista non era chiaro per tutti. Molti lo rifiutavano, specie tra i cristiani della Chiesa Madre di Gerusalemme. Nella lettura noi vediamo come la Chiesa sia
concorde nell’esprimere il suo giusto punto di vista. Certo, Luca ha semplificato le lunghe e dure controversie nel racconto degli Atti. È probabile che ci fosse un clima animato e teso, più che una pacifica, lineare discussione.
Ma l’importante, qui, è il fatto che emerge: sin dall’inizio alla chiesa si presentarono questioni nuove e imprevedibili, alle quali nessuno sapeva dare subito una risposta. Tuttavia, lo Spirito Santo, l’impegno degli Apostoli e di tutta quanta la Chiesa fecero sì che si approdasse ad una vera e giusta soluzione.
Seconda lettura: Apocalisse 21,10-14.22-23
|
L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. A oriente tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte. Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello. In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna: la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello.
|
Com’è noto, la struttura del libro dell’Apocalisse è caratterizzata dalla serie di sette settenari (7 chiese, 7 sigilli, 7 trombe, 7 visioni, 7 coppe e ancora 7 visioni…). La nostra pericope si colloca all’interno dell’ultimo settenario, che rappresenta, in certo senso, la conclusione di tutta la vicenda della Parola di Dio, da Abramo agli eventi finali. In questo settenario, il cap. 21 descrive la settima visione, quella in cui Giovanni contempla il realizzarsi della profezia di Is 65,17: «Ecco io creo nuovi cieli e nuova terra; non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente». In realtà, Giovanni vede una creazione trasfigurata, si direbbe in continuità con l’antica creazione, dove però non c’è più il mare (simbolo del male e della forza che fa resistenza alla liberazione dell’esodo…). Nel brano di questa domenica si riportano solo alcuni versetti di questa visione conclusiva, quelli che riguardano la Gerusalemme celeste.
Chiavi di lettura
È estremamente arduo entrare nei dettagli simbolici della visione e spiegarli singolarmente. Preferiamo offrire al lettore alcune chiavi di lettura, che chiariscano il senso teologico della descrizione.
— Prima chiave di lettura: il compimento delle profezie. Ezechiele, nei cc. 40-48 descrive dettagliatamente il Tempio nuovo che sorgerà nella Gerusalemme escatologica. Questa città avrà un nome emblematico: «Il Signore è là» (Ez 48,35). Inoltre Isaia 60 rivolge una promessa a Gerusalemme: «Alzati, rivestiti di luce, perché… su di te risplende il Signore la sua Gloria appare su di te» (vv. 1-2). Quanto era promesso e annunciato come realtà futura dai profeti, ora Giovanni lo contempla come realtà presente. Questa Gerusalemme rappresenta la nuova umanità redenta, intimamente legata a Gesù Cristo, essendo la sposa dell’Agnello (21,9).
— Seconda chiave di lettura: ecclesiologica. I fondamenti di questa città celeste sono 12, come in Ezechiele, ma Giovanni precisa che sono i nomi dei dodici Apostoli dell’Agnello. I Dodici prolungano e realizzano l’unità del popolo di Dio formato dalle dodici tribù. Nel realizzare il suo disegno di salvezza. Dio vuole un accordo profondo ed un progresso all’insegna della continuità. La Chiesa non è che il punto di approdo del cammino del popolo di Israele. La chiesa non è massa di umanità anonima e priva di relazioni. La città ha la sua compattezza e le sue strutture; in essa gli individui sono legati da vincoli, conoscenze, interessi comuni, formando una comunità gioiosa e fraterna.
— Terza chiave di lettura: ecumenica. La struttura della città è orientata, in mirabile simmetria, secondo i quattro punti cardinali: oriente, occidente, settentrione e meridione (tre porte per ogni punto cardinale, v. 13). La Chiesa di Dio non è una società chiusa, ripiegata sulla fruizione dei suoi privilegi (la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello, v. 23). La salvezza di cui essa gode si apre a tutta l’umanità e a tutto l’universo. Si potrebbe inoltre osservare che le iniziali dei quattro punti o coordinate universali (anatolé, dysis, àrktos, mesembría) formano esattamente il nome Adam il capostipite di tutta quanta l’umanità. Tutto il genere umano, fino agli estremi confini della terra, è chiamato ad accedere attraverso quelle porte e integrarsi nella luminosa società dei santi.
Vangelo: Giovanni 14,23-29
|
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».
|
Esegesi
La pericope è desunta dai cosiddetti «Discorsi di addio» di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Si tratta di un complesso di insegnamenti (cc. 13-17) che l’Evangelista avrebbe raccolti da vari momenti del ministero di Gesù e posti sulle sue labbra nel momento più solenne della sua missione terrena (quando passa dalla sua esistenza terrena a quella celeste), una specie di testamento spirituale che illumina in retrospettiva tutto il senso della vita e dell’opera di Gesù. Nella nostra lettura è presentato lo Spirito Consolatore, inviato dal Padre, in preparazione alla ormai vicina Pentecoste.
Annotazioni
— «Se uno mi ama, osserverà la mia parola… (v. 23). Questa verità, qui enunciata in termini positivi, viene poi ribadita in termini negativi («Chi non mi ama, non osserva le mie parole», v. 24) e ripresa più avanti: «Se mi amaste, vi rallegrereste…» (v. 28). Questo amore, di cui parla Gesù, deve possedere due condizioni o prove di autenticità: 1. chi ama Gesù, osserva le sue parole, vale a dire vive di esse; 2. chi ama Gesù si rallegra che Gesù vada al Padre, cioè sia nella gloria, perché lì Egli si trova nella «casa del Padre» anche in quanto uomo.
— «Vedremo a lui e prenderemo dimora presso di lui» (v. 23). Chi ama Gesù e vive, cioè realizza pienamente, le sue parole, diventa un tempio, nel quale dimora Dio. L’inabitazione di Dio nell’anima degli uomini costituisce uno dei doni più grandi che Dio possa elargire a noi sulla terra. In modo misterioso l’anima diventa «cielo sulla terra».
— «Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome…» (vv. 25-26). Dal greco (paráclétos): non solo nel senso dell’avvocato che difende gli uomini, ma anche nel senso di colui che parla e intercede in loro favore. «Paraclito» nel senso che noi siamo sostenuti e protetti da lui.
— «Vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto» (v. 26). Lo Spirito Santo ci proteggerà perché ci farà capire la parola di Gesù, che non è altro che la parola stessa del Padre (v. 24). Svolgerà questo compito dando calore, forza e intelligibilità a tale parola nella nostra vita. Riporta alla memoria quella parola, non come qualcosa di dimenticato, ma come realtà riscoperta a livello più profondo di fede e di gioia cristiana.
— «Vi lascio la pace, vi do la mia pace» (v. 27). Il prezioso bene della pace è dono di Gesù, è lui che ce lo lascia. Dove c’è Dio, ivi è la pace. Questa pace, intimamente commessa con la presenza di Dio, può sussistere anche in mezzo agli assalti o alle insidie del male, anche in mezzo alle sofferenze. Spesso i Santi parlano dell’esperienza di questa pace profonda, che nessuno al mondo può toglierci.
—«Vado e tornerò da voi…» (vv. 28-29). Gesù non si sottrae che al contatto materiale, corporeo con noi. Ma egli ritornerà in due modi: primo, con lo Spirito Santo; secondo, alla fine dei tempi come Risorto nella sua gloria.
Meditazione
La prima e la seconda lettura di questa sesta domenica di Pasqua ci offrono due immagini simboliche di Gerusalemme. Nel racconto degli Atti è la sede di un incontro, che la tradizione successiva definirà ‘concilio di Gerusalemme’, attraverso il quale la prima comunità cristiana dovrà assumere una decisione fondamentale per la sua storia successiva: se imporre o meno ai cristiani provenienti dal mondo pagano l’obbligo della circoncisione e dell’osservanza integrale della legge mosaica. Il brano dell’Apocalisse ci porta invece a contemplare già la Gerusalemme celeste, che viene da Dio e risplende della sua gloria. Una
città perfetta, aperta a tutte le tribù di Israele (ma è un linguaggio simbolico per affermare che tutti i popoli della terra vi trovano ospitalità come nella loro vera patria). Anche le me-diazioni di ogni tipo – quelle religiose come il tempio, quelle cosmiche come il sole e la luna – vengono meno, poiché cedono il passo all’immediatezza della presenza di Dio e dell’Agnello, simbolo con il quale l’Apocalisse allude sempre al Signore Gesù crocifisso e risorto. Dio e l’Agnello sono il suo tempio e la sua luce. Se ora noi abbiamo bisogno di segni per incontrare il mistero di Dio e percepire la sua presenza nella nostra storia, allora potremo contemplare Dio faccia a faccia, senza più mediazioni. Se ora abbiamo bisogno di essere illuminati per camminare verso Dio, allora sarà Dio stesso a farsi nostra luce. Se ora
viviamo la nostra appartenenza ecclesiale come luogo di distinzione tra coloro che credono e coloro che non credono o vivono altre appartenenze religiose, allora scopriremo Gerusalemme come luogo di incontro di tutti i popoli. La città, infatti, ha porte aperte verso ogni punto cardinale; da ogni confine della terra i popoli vi giungeranno e potranno accedervi, come ricorda anche il salmo responsoriale:
Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
La terra ha dato il suo frutto.
Ci benedica Dio, il nostro Dio,
ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra (Sal 66,6-8).
L’Apocalisse stessa, nei versetti che seguono immediatamente quelli proclamati dal lezionario liturgico, insiste nel descrivere queste porte sempre aperte e verso tutti: «le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra a lei porteranno il loro splendore. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più notte. E porteranno a lei la gloria e l’onore delle nazioni» (vv. 24-26). Nella città non potrà entrare niente di falso e di impuro, ma «solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell’Agnello» (v. 27). È lui, infatti, l’Agnello, la vera porta, in virtù del suo mistero pasquale. La sua mediazione salvifica si rende presente nella storia attraverso la comunità cristiana, fondata sulla testimonianza apostolica dei Dodici, che porta a compimento l’elezione di Israele e delle sue tribù. I nomi delle Dodici tribù sono infatti scritti sopra le dodici porte, così come i nomi dei Dodici apostoli sui dodici basamenti della città santa. Il simbolismo è ricco, complesso, ma affascinante: la salvezza di Dio, attraverso l’elezione di Israele e della Chiesa, si apre – come queste porte rivolte a oriente e a settentrione, a mezzogiorno e a occidente – per accogliere tutti i popoli, secondo la promessa di Gesù custodita nei vangeli: «Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio» (Lc 13,29).
Proprio perché la vera porta è l’Agnello, e nella sua Pasqua la salvezza di Dio può essere annunciata a tutte le genti, la comunità storica di Gerusalemme giunge a decidere, nel discernimento guidato dallo Spirito Santo (cfr. At 15,28), che non è necessario imporre la circoncisione ai convertiti dal paganesimo. Infatti, afferma Pietro nella riunione di Gerusalemme (in un passo che la lettura liturgica omette): «Noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, così come loro» (v. 11). Per la sua grazia, non per altro.
Queste due immagini di Gerusalemme, che le prime due letture dell’eucaristia ci offrono, evocano in fondo la Chiesa in tutto il suo mistero. È una comunità che cammina nella storia, come ci ricordano gli Atti, e in questa sua dimensione è attraversata da tensioni e visioni differenti, sempre impegnata in un faticoso discernimento spirituale della volontà di Dio, chiamata a decisioni che possono anche mutare nel tempo e adattarsi a differenti contesti storici e culturali. Nello stesso tempo, annuncia l’Apocalisse, c’è una dimensione misterica della Chiesa, un suo scendere dall’alto e dal mistero di Dio, che già la abita e la trasfigura nella sua luce, per renderla «una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino» (Ap 21,11). È soprattutto per farne sacramento di salvezza per tutti i popoli, nonostante tutti i suoi l imiti storici.
Noi siamo in cammino verso la Gerusalemme celeste per scoprire – ma solo a condizione di essere già per via, protesi verso la meta – che è Gerusalemme stessa a scendere verso di noi in tutta la sua bellezza, per compiere il nostro desiderio e il nostro pellegrinaggio. In questo cammino, come ci ricorda Gesù nell’evangelo di Giovanni, dobbiamo portare con noi un bagaglio sobrio, essenziale ma indispensabile. Innanzitutto una parola da osservare e custodire, o meglio, quella parola che è Gesù stesso come rivelazione definitiva del Padre. Dimorando in lui e nel suo amore siamo certi di essere già in comunione con il Padre, anche nel tempo del nostro pellegrinaggio. A consentirci di rimanere nella Parola c’è il dono dello Spirito Santo – il secondo bene essenziale da portare con sé – che ci insegna ogni cosa ricordando tutto ciò che il Signore Gesù ci ha detto. Quello dello Spirito è un insegnare ricordando, consentendoci di approfondire la rivelazione di Gesù e anche di discernere nella sua luce le decisioni da assumere di volta in volta, di fronte ai problemi che man mano insorgono lungo il cammino. Appunto come accade nel concilio di Gerusalemme, quando le decisioni vengono prese sulla base di quanto «è parso bene allo Spirito Santo e a noi» (v. 28). Un terzo bene da portare con sé è la pace donata dal Signore, che vince ogni turbamento e timore.
Non mancano infatti lungo la via rischi, pericoli, ostilità, scelte coraggiose da assumere. Tutto può però essere affrontato senza paura, nella pace che è dono del Signore e non del mondo, e che dunque possiamo accogliere se siamo disponibili a una comunione con il Signore che ci converte dalle logiche mondane per farci aderire sempre di più al suo stesso ‘sentire’.
Preparando in questo modo il bagaglio per il viaggio ci si accorge tuttavia che si porta con sé un bene infinitamente più grande: la presenza stessa di Dio che cammina con noi e in noi. «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui» (Gv 14,23). Già lungo il cammino si gusta anticipatamente ciò che ci attende al suo compimento: il Padre e il Figlio abitano in noi così come il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello abitano nel cuore della Gerusalemme celeste.
Preghiere e racconti
«Quando lo Spirito Santo verrà, v’insegnerà ogni cosa» (Gv 14,26).
Cari figli, non si tratta qui di come questa o quella guerra sarà composta, o se il grano crescerà bene. No, no, figli, non così. Ma quell’«ogni cosa» significa tutte le cose che ci sono necessario per una vera vita divina e per una segreta conoscenza della verità e della malvagità della natura. Seguite Dio e camminate per la santa e retta via, cosa che certe persone non fanno: quando Dio le vuole dentro, esse escono e quando le vuole fuori, entrano; ed è tutta una cosa a rovescio. Queste sono «tutte le cose», tutte le cose che ci sono necessarie interiormente ed esteriormente, sono il conoscere profondamente e intimamente, puramente e chiaramente i nostri difetti, l’annientamento di noi stessi, grandi rimproveri per come restiamo lontani dalla verità e dannosamente ci attacchiamo alle piccole cose.
Lo Spirito Santo c’insegna a inabissarci in una profonda umiltà e a raggiungere una totale sottomissione a Dio e a tutte le creature. Questa è una scienza in cui sono racchiuse tutte le scienze di cui si ha bisogno per la vera santità. Questa sarebbe vera umiltà, senza commenti, non a parole o in apparenza, ma reale e profonda. Possiamo noi disporci in tal modo che ci venga dato in verità lo Spirito Santo! In ciò Dio ci aiuti. Amen.
(GIOVANNI TAULERO, I sermoni, Milano, 1997, 233s.).
Lo Spirito di Dio
Senza lo Spirito Santo, se, cioè, lo Spirito non ci plasma interiormente e noi non ricorriamo a lui abitualmente, praticamente può darsi che camminiamo al passo di Gesù Cristo, ma non con il suo cuore. Lo Spirito ci rende conformi nell’intimo al vangelo di Gesù Cristo e ci rende capaci di annunziarlo esternamente (con la vita). Il vento del Signore, lo Spirito Santo, passa su di noi e deve imprimere ai nostri atti un certo dinamismo che gli è proprio, uno stimolo cui la nostra volontà non rimane estranea, ma che la trascende. Dio ci donerà lo Spirito Santo nella misura in cui accoglieremo la Parola, ovunque la sentiremo.
Dovrebbe esserci in noi una sola realtà, una sola verità, uno Spirito onnipotente che si impossessi di tutta la nostra vita, per agire in essa, secondo le circostanze, come spirito di carità, spinto di pazienza, spirito di dolcezza, ma che è l’unico Spirito, lo Spirito di Dio. Tutti i nostri atti dovrebbero essere la continuazione di una medesima incarnazione. Bisognerebbe che consegnassimo tutte le nostre azioni allo Spirito che è in noi, in modo tale che si possa riconoscere in ciascuna di esse il suo volto. Lo Spirito non chiede che questo. Non è venuto in noi per riposarsi; egli è infaticabile, insaziabile nell’agire; una sola cosa può impedirglielo: il fatto che noi, con la nostra cattiva volontà, non glielo permettiamo, oppure non gli accordiamo abbastanza fiducia e non siamo fino in fondo convinti che egli ha una sola cosa da fare: agire. Se lo lasciassimo fare, lo Spirito sarebbe assolutamente instancabile e di tutto si servirebbe. Basta un nulla a spegnere un focherello, mentre un fuoco avvampante consuma ogni cosa. Se noi fossimo gente di fede, potremmo consegnare allo Spirito tutte le azioni della giornata, qualunque siano: le trasformerebbe in vita.
(M. DELBRÊL, Indivisibile amore. Frammenti di lettere, Casale Monferrato, 1994, 43-45, passim).
Preghiera per la pace
Signore, noi abbiamo ancora le mani insanguinate dalle ultime guerre mondiali, così che non ancora tutti i popoli hanno potuto stringerle fraternamente fra loro;
Signore, noi siamo oggi tanto armati come non lo siamo mai stati nei secoli prima d’ora, e siamo così carichi di strumenti micidiali da potere, in un istante, incendiare la terra e distruggere forse anche l’umanità;
Signore, noi abbiamo fondato lo sviluppo e la prosperità di molte nostre industrie colossali sulla demoniaca capacità di produrre armi di tutti i calibri e tutte rivolte a uccidere e a sterminare gli uomini nostri fratelli; così abbiamo stabilito l’equilibrio crudele della economia di tante Nazioni potenti sul mercato delle armi alle Nazioni povere, prive di aratri, di scuole e di ospedali;
Signore, noi abbiamo lasciato che rinascessero in noi le ideologie, che rendono nemici gli uomini fra loro: il fanatismo rivoluzionario, l’odio di classe, l’orgoglio nazionalista, l’esclusivismo razziale, le emulazioni tribali, gli egoismi commerciali, gli individualismi gaudenti e indifferenti verso i bisogni altrui;
Signore, noi ogni giorno ascoltiamo angosciati e impotenti le notizie di guerre ancora accese nel mondo;
Signore, è vero! Noi non camminiamo rettamente! Signore, guarda tuttavia ai nostri sforzi, inadeguati, ma sinceri, per la pace nel mondo! Vi sono istituzioni magnifiche e internazionali; vi sono propositi per il disarmo e la trattativa;
Signore, vi sono soprattutto tante tombe che stringono il cuore, famiglie spezzate dalle guerre, dai conflitti, dalle repressioni capitali; donne che piangono, bambini che muoiono; profughi e prigionieri accasciati sotto il peso della solitudine e della sofferenza; e vi sono tanti giovani che insorgono perché la giustizia sia promossa e la concordia sia legge delle nuove generazioni;
Signore, Tu lo sai, vi sono anime buone che operano il bene in silenzio, coraggiosamente, disinteressatamente e che pregano con cuore pentito e con cuore innocente; vi sono cristiani, e quanti, o Signore, nel mondo che vogliono seguire il Tuo Vangelo e professano il sacrificio e l’amore;
Signore, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
(Paolo VI)
Porremo la nostra dimora presso di lui
Io e il Padre, dice il Figlio, verremo a lui, cioè all’uomo santo, e porremo la nostra dimora presso di lui (Gv 14,23) […] E l’Apostolo dice chiaramente che Cristo abita per la fede nei nostri cuori (Ef 3,l7). Non fa meraviglia se il Signore Gesù è lieto di abitare [nell’anima], che è come un cielo per la cui conquista ha lottato e per la quale non si è limitato, come per gli altri cieli, a dire una parola perché essi fossero creati. Dopo le sue fatiche, manifestò il suo desiderio e disse: Questo è il mio riposo per sempre; qui abiterò poiché l’ho scelto [Sal 131 (132),14]. E beata colei alla quale è detto: Vieni, mia eletta, e porrò in te il mio trono (Ct 2,10-13).
Perché ora sei triste, anima mia, e perché gemi su di me? Pensi di trovare anche tu un posto per il Signore dentro di te? [cfr. Sal 41 (42),6] E quale posto in noi è degno di una tale gloria ed è in grado di accogliere la sua maestà? Potessi almeno adorarlo nel luogo dove si sono fermati i suoi passi! Chi mi darà di poter almeno seguire le tracce di un’anima santa che si è scelta come sua dimora? Se potesse degnarsi di infondere nella mia anima l’unzione della sua misericordia e così stenderla come una tenda, la quale quando viene unta, si dilata, perché anch’io possa dire: Ho corso per la via dei tuoi comandamenti quando tu hai dilatato il mio cuore [Sal 118 (119), 32], potrò forse anch’io mostrare in me stesso se non una grande sala tutta pronta, dove possa mettersi a tavola con i suoi discepoli, almeno un posticino ove possa adagiare la testa (cfr. Mt 8,20). Guardo da lontano quelli veramente beati di cui è detto: Abiterò in loro e con loro camminerò (2Cor 6,16) […]
È necessario che l’anima cresca e si dilati per poter contenere Dio. Ora, la sua larghezza corrisponde al suo amore, come dice l’Apostolo: Dilatatevi nella carità (2Cor 6,13). Infatti, poiché l’anima, essendo spirito, non ha affatto quantità, tuttavia la grazia le dona ciò che non ha la natura. Essa infatti cresce, ma spiritualmente; cresce non nella sostanza, ma nella virtù; cresce anche nella gloria; cresce, infine, e progredisce fino a formare l’uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo (cfr. Ef 4,13); cresce anche come tempio santo del Signore. La quantità di ciascuna anima corrisponde alla misura della sua carità in modo tale che è grande quando ha una grande carità, piccola quando ne ha poca, se non ne ha affatto è nulla, come dice Paolo: Se non ho la carità, non sono niente (ICor 13,12).
(BERNARDO DI CHIARAVALLE, Discorsi sul Cantico 27,8-10, PL 183,918-919).
Preghiera
Signore Gesù, tu chiedi l’amore
come condizione
per l’inabitazione della Trinità,
l’amore che è adesione alla tua Parola.
Ma come possiamo amarti
se non siamo dentro la logica del tuo amore?
Se non sentiamo in noi il fuoco
di questo amore grande e misterioso
che supera ogni limite
e sa affrontare ogni avversità?
Noi non possiamo produrre tale amore,
possiamo solo accoglierlo come dono.
Aiutaci a saperci guardare dentro,
per scorgere in noi la presenza del tuo amore.
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
———
– M. FERRARI, monaco di Camaldoli, «Oggi di è adempiuta questa scrittura». Tempo di Quaresima e Tempo di Pasqua, Milano, Vita e Pensiero, 2013.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. Seconda parte: Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla Risurrezione, Città del Vaticano, Liberia Editrice Vaticana, 2011.
– C.M. MARTINI, Incontro al Signore risorto. Il cuore dello spirito cristiano, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009.
PER L’APPROFONDIMENTO:
PASQUA VI DI PASQUA C