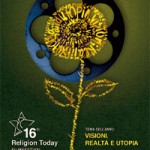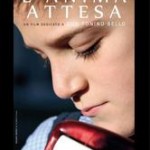Prima lettura: Sapienza 9,13-18
|
Quale, uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l’anima e la tenda d’argilla opprime una mente piena di preoccupazioni. A stento immaginiamo le cose della terra, scopriamo con fatica quelle a portata di mano; ma chi ha investigato le cose del cielo? Chi avrebbe conosciuto il tuo volere, se tu non gli avessi dato la sapienza e dall’alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito? Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra; gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza». |
È un brano della preghiera di Salomone per ottenere la sapienza. Lo spunto è preso dai testi di 1Re 3,6-9 e 2Cr 1,8-10, in cui il Signore invita Salomone a fargli delle richieste che egli avrebbe esaudite e questi non chiede lunga vita, né ricchezza, né la morte dei suoi nemici, ma domanda solo la saggezza per governare bene il suo popolo. Questa richiesta piace al Signore, che l’esaudisce donandogli il discernimento.
La strofa della preghiera che viene letta in questa domenica insiste sul tema della debolezza umana e ha al suo centro ancora la richiesta della sapienza (v. 17). I progetti del Signore infatti per la vita dell’uomo sono celesti e si possono comprendere solo con uno spirito che viene dall’alto. Solo con il dono del discernimento l’uomo può percorrere la via che lo conduce alla salvezza. Senza il dono della sapienza e dello spirito, considerato come fonte di rinnovamento e di vita interiore, non è possibile per l’uomo conoscere la volontà di Dio e trovare la vita.
Questo tipo di sapienza non si ottiene con i propri sforzi: può essere solo invocata dall’alto.
Seconda lettura: Filemone 1,9-10.12-17
|
Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così come sono, vecchio, e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per Onèsimo, figlio mio, che ho generato nelle catene. Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore. Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario. Per questo forse è stato separato da te per un momento: perché tu lo riavessi per sempre; non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo sia come fratello nel Signore. Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso. |
La lettera a Filemone conta in tutto 25 versetti: è la più breve dell’epistolario paolino. Paolo parla di se stesso come prigioniero per Gesù Cristo. Forse si trova a Roma, perché la sua situazione non è molto dissimile all’arresto domiciliare romano descritto in Atti 28. L’apostolo chiede a Filemone di accogliere lo schiavo Onesimo, che era fuggito dal padrone — forse per malefatte — non più come schiavo ma come fratello nel Signore. Dice di averlo generato, perché Onesimo era diventato cristiano per opera sua durante la prigionia. Paolo non contesta la validità giuridica e sociale della schiavitù. Inserendo però in quella tremenda struttura lo spirito del vangelo, la faceva scoppiare dal suo interno.
Vangelo: Luca 14,25-33
|
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. |
Esegesi
Gesù sta parlando alle folle e indica loro quali siano le condizioni per seguirlo e per essere suoi discepoli. Egli vuole essere scelto come l’assoluto e determinante nella vita del discepolo.
Chi vuole seguire la vita di Cristo deve «non amare» il padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli e le sorelle. Gesù ha spiegato con la vita che cosa significhi. Ecco le sue parole alla madre e al padre quand’era ancora ragazzo: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» (Lc 2,49). E durante la vita pubblica: «mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica» (Lc 8,21). Solo chi è veramente libero da ogni affetto che lo trascini a adorare gli idoli dei genitori, dei parenti e degli amici, può mettersi in cammino con Gesù Cristo.
Una seconda condizione è odiare la «propria vita». I progetti di Gesù sulla vita del discepolo sono sempre sorprendenti. Solo chi è disposto a lasciare che i propri progetti vengano sconvolti può mettersi in cammino con lui.
La terza condizione è «portare la propria croce». La croce è il simbolo della storia concreta e personale di ogni uomo e donna chiamati a seguire Gesù. Significa vincere ogni giorno la seconda tentazione che Gesù ha avuto all’inizio della vita pubblica, quella di chiedere miracoli a Dio, perché si è scontenti della propria situazione familiare, sociale, ecclesiale. Non è possibile seguire Gesù mormorando continuamente nel proprio cuore come la generazione testarda del deserto.
Quarta condizione: «rinunciare a tutti i propri averi». Gesù è il vero figlio d’Israele che ha compiuto le esigenze del credo ebraico recitato ogni giorno, lo shemà, in cui si dice di amare Dio con tutte le forze, o meglio — secondo traduzione aramaica del tempo — con tutto mammona. Anche il discepolo, che vuole seguire Gesù, diventerà un vero figlio d’Israele, se amerà Dio rinunziando a tutti i propri averi. Si farà così un tesoro nel cielo e allora anche il suo cuore sarà nel cielo, ma solo da lì discende la vita vera, e la felicità piena.
Meditazione
La sapienza come coscienza della alterità del volere di Dio rispetto al volere umano per poter abitare la distanza fra uomo e Dio (I lettura) e rendere praticabile l’«impossibile sequela» del Cristo (vangelo): questa può essere colta come tematica unificante le letture odierne. La sapienza evangelica consiste nel calcolare ciò che non è calcolabile e predisporsi con libertà e amore alla rinuncia radicale che sola consente la sequela Christi.
«In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: …» (Lc 14,25 ss.). La quantità, il numero, non incanta Gesù, anzi lo preoccupa. Gesù non esita a mettere in guardia i tanti che lo seguono ponendoli di fronte alle esigenze dure della sequela e quasi scoraggiandoli. Dovrebbe preoccuparci il fatto che questa preoccupazione di Gesù non sia la nostra e che noi ci preoccupiamo proprio del contrario, del numero basso, della scarsità dei praticanti. A costo di perdere aderenti, Gesù non esita a proclamare con vigore la durezza delle esigenze della sequela. L’esigenza non va edulcorata illudendo circa la facilità della sequela. Seguire Gesù forse è semplice, ma certamente non è facile. Anzi, Gesù per tre volte (Lc 14,26.27.33) parla di una impossibilità: «Non può essere mio discepolo». Vi sono condizioni da ottemperare, pena il fallimento della sequela, la sua impraticabilità.
Anzi, in fondo non vi è che una esigenza imprescindibile che si situa sul piano della relazione con Gesù, il Signore («viene a me», «mio discepolo», «viene dietro a me») e non sul piano delle prestazioni. La sequela richiede, come istanza basilare, di rivolgere al Signore tutto il cuore: essa è un evento nell’ordine dell’amore, e l’amore è un lavoro, una fatica, un’ascesi. Evento di amore, la sequela è, simultaneamente, evento di libertà. Le esigenze della sequela che Gesù pone al discepolo sono la necessaria pedagogia verso la libertà e l’amore.
I legami famigliari (Lc 14,26), il possesso di beni (Lc 14,33), l’attaccamento stesso alla «propria vita» (Lc 14,26) sono chiamati a vedere regnare il Signore su di essi. Si tratta di amare il Signore con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze. E se l’amore è questione di spazio interiore, di far spazio all’altro, allora esso si nutre della preziosità del vuoto, della ricchezza della mancanza, della grazia della carenza. Al contrario, il possesso, colmandoci, ci ottura interiormente, ci sazia, ci chiude in noi stessi, ci rende preoccupati di noi stessi, impedendoci di riconoscere la povertà profonda che è lo spazio aperto all’accoglienza dell’amore. Il carattere esigente della sequela di Gesù è connesso alla difficoltà di apprendere l’arte di amare, ed è connesso al nostro preferire la facilità del possedere cose alla fatica della libertà e dell’amore. Gesù chiede ai suoi seguaci di porre al cuore delle relazioni con le persone a loro care la relazione con lui. Ma questo significa porre al cuore del nostro cuore la relazione con il Signore. Insomma, le esigenze della sequela sono le esigenze dell’amore.
La sequela è esigente perché il discepolo è chiamato non solo a iniziare, ma anche a portare a compimento (Lc 14,28.30). Come per costruire una torre o affrontare una battaglia vi è un indispensabile, così anche per la sequela. Ma l’indispensabile per la sequela è la disponibilità a perdere tutto, non solo i beni, ma anche «la propria vita» (Lc 14,26). Il bene da possedere è la rinuncia ai beni e l’arte da imparare è l’arte di perdere, di diminuire, di non cadere nelle maglie del possesso, della logica dell’avere. Gesù «svuotò se stesso» (Fil 2,7); «Dio è Dio perché non ha niente» (Barsanufio). Occorre libertà e leggerezza per condurre a termine il lungo cammino della vita percorso come sequela di Cristo. L’amore è chiamato a divenire responsabilità e la libertà perseveranza: lì si situa la necessaria rinuncia, purificazione, spogliazione. Le esigenze della sequela hanno dunque a che fare con il tutto della persona (il suo cuore) e con il tutto del suo tempo, con la durata della sua vita. E ci mettono in guardia dal rischio di lasciare a metà l’opera intrapresa.
Preghiere e racconti
Seguire Gesù
Chi è animato da un imperioso desiderio di seguire il Cristo non può più tener conto di nulla in questa vita: né dell’affetto di parenti e amici, quando si oppone ai comandamenti del Signore, poiché è proprio allora che si applicano le parole: «Se uno viene a me senza odiare suo padre e sua madre…»; né del timore degli uomini, quando distoglie dal vero bene, come hanno fatto in modo eccellente i santi, i quali hanno detto: «È meglio obbedire a Dio piuttosto che agli uomini»; né, infine, degli scherni con cui i malvagi tormentano i buoni, poiché non bisogna lasciarsi vincere dal disprezzo.
(Basilio, Le mole monastiche)
L’avvenire
Se il credere in lui è l’essenza stessa della vita cristiana, ne consegue che questa vita consiste nel rischiare ogni cosa sulla parola di Cristo: tutto ciò che abbiamo per ciò che non abbiamo, nobilmente e generosamente, senza impulsività né leggerezza, senza sapere esattamente ciò che facciamo, a che cosa rinunciamo, e neppure ciò che ne avremo in cambio. Senza certezza della ricompensa, dell’ampiezza del sacrifico che ci sarà richiesto, basandoci su di lui con un totale rispetto, fidandoci di lui, aspettando da lui il compimento della sua promessa. Mettendo in lui la nostra speranza di riuscire a soddisfare i nostri impegni. E così, avanzando sotto ogni aspetto, senza timore né ansia, verso l’avvenire.
(J.H. Newman, Parochial and Plain Sermons, IV 220)
Il bambino e il re
Un bel bambino nudo si recò un giorno a trovare Maestro Eckart. Questi gli chiese da dove venisse. Rispose: Vengo da Dio. —Dove lo hai lasciato? — Nei cuori, sorgenti di virtù. — Dove stai andando? — Da Dio. — Dove lo troverai? — Dove mi sono spogliato di tutto il creato. —Chi sei? — Un re. — Dov’è il tuo regno? —Nel mio cuore. — Fa’ attenzione che nessuno lo condivida con te. — Faccio attenzione. Allora lo fece entrare nella sua cella e gli disse: Rivestiti con il saio che vuoi. —Così non sarò più re! E scomparve. Era Dio che aveva passato un istante con lui.
(J. Chuzeville, I mistici tedeschi dal XIII al XIX secolo)
La risposta
Noi balliamo un po’ al mattino nella nostra vita
come un dito dimagrito nell’anello di un tempo.
Siamo diventati più piccoli, più umili
a causa dei sogni? Più liberi in ogni caso
che non lungo una vita in cui il tempo ci stringe
ed ecco che occorrerebbe scegliere di nuovo
la moglie, i figli, la professione, la casa.
Togliamo o conserviamo l’anello?
Ognuno attorno al letto attende una risposta
e il Cristo silenzioso che ci ha risvegliati
è l’ultimo a porre la domanda.
(J.P. Lemaire, La rotta)
La rinuncia a se stessi
Quando una situazione umana ci chiede una totale rinuncia a noi stessi, istintivamente cerchiamo il compromesso o semplicemente imbocchiamo la strada della fuga; ci accomuniamo agli apostoli, che anch’essi sono fuggiti di fronte al realismo della Passione di Gesù.
A tanti livelli e su tanti piani dobbiamo cercare di smascherare le forme di fuga che caratterizzano il nostro preteso “servizio agli altri”.
Quante volte a livello della famiglia, ci lasciamo andare alla ricerca soltanto della gratificazione, dell’affermazione di noi stessi e non accettiamo le persone che ci sono vicine, così come sono, nella loro realtà; le vorremmo sempre diverse e ci arrovelliamo?
Quante volte nell’ambito professionale ci lasciamo trascinare solo dall’interesse e non cerchiamo di rendere un servizio fino in fondo, servizio che ci chiede di uscire da noi stessi, di prendere parte in qualche modo alla croce e di partecipare alla sua forza rivelatrice?
Quante volte di fronte alle richieste che i nostri fratelli avanzano, noi manifestiamo disagio, stizza, rifiuto?
Ecco: tante realtà semplici della nostra vita quotidiana in cui Gesù dalla croce ci chiede di operare una profonda conversione, di metterci davvero in ginocchio davanti alla croce per coglierne il realismo e la fedeltà che cambiano la vita.
Donarsi a tutti non appartenendo a nessuno
Il sacerdote deve amare tutti non appartenendo a nessuno. Un modo di sentire che non rientra nella percezione comune. Si tratta di amore che prevede di darsi senza ricevere un amore simmetrico, perché la mercede egli la ottiene non dall’amore umano ma da quello divino. Sembra una scissione innaturale dell’amore, che prevede nella dinamica umana la partecipazione simultanea. Io ti amo perché mi ami, e sento di doverti amare sempre più, perché tu possa voler bene ancora di più.
Quello del sacerdote è invece un amore gratuito, che manca della parte che proviene dall’altro. E per questo egli giunge ad amare anche chi non lo ama, chi lo ignora, persino chi lo detesta.
Si tratta di un paradosso che però è ben rappresentato nella figura di Cristo, che non solo ha detto di amare anche i nemici e di perdonare chi ci ha procurato danno e dolore, ma addirittura di porgere l’altra guancia per essere pronti a ricevere un altro affronto, un’altra mortificazione.
Del danno ingiustamente subito si offre il pieno perdono e la totale comprensione fino a stabilire che la violenza non fa parte mai della risposta del sacerdote, perché egli non fa altro che imitare Cristo, che così ha detto e così ha mostrato di fare. […]
Non vi è dubbio che questa condizione d’amore è difficile, ma il sacerdote è anche consapevole di potersi fondare sulla forza di un amore ideale, di un amore verso Dio. La parola “ideale” è probabile che sia inadatta, ma interpreta il concetto psicologico di sublimazione dell’amore in idee e in immagini astratte e dunque il trasferimento di un amore carnale in uno puramente spirituale, si potrebbe dire platonico. Una dimensione che nel sacerdote raggiunge però espressioni concrete (incarnate), perché il Dio a cui si lega, parla, quel Dio è presente, quel Dio vive con lui quotidianamente. È importante che tutto ciò sia reale e non una congettura, non uno spostamento, non solo una sublimazione, che rimanderebbe sempre al problema della mancanza d’amore umano. I meccanismi di difesa non permettono mai di risolvere il bisogno d’amore di cui il sacerdote deve essere consapevole, ma anche esperimentare che l’amore che riceve dalla comunità e da Dio valgono la rinuncia insita nella scelta sacerdotale.
Del resto Cristo ha mostrato di essersi dedicato tutto all’amore per gli uomini sostenuto dall’amore grandissimo del Padre.
(Vittorino ANDREOLI, Preti, Milano, Piemme, 2009, 82-83; 86).
Svuotamento
Un maestro di sapienza e di spiritualità, noto per la saggezza delle sue dottrine, ricevette la visita di un professore universitario, che era andato da lui per interrogarlo sul suo pensiero.
Il saggio servì del tè: colmò la tazza del suo ospite e poi continuò a versare, con espressione serena e sorridente. Il professore guardò traboccare il tè, tanto stupefatto da non riuscire a chiedere spiegazione di una distrazione così contraria alle norme più elementari della buona educazione. Ma a un certo punto non poté più contenersi: «È ricolma! Non ce ne sta più», gridò con agitazione.
«Come questa tazza», disse il saggio imperturbabile, «tu sei ricolmo della tua cultura, delle tue opinioni e congetture erudite e complesse. Come posso parlarti della mia dottrina, che è comprensibile solo agli animi semplici e aperti, se prima non vuoti la tua tazza?».
(L. Vagliasindi (ed.), La morale della favola, Milano, Gribaudi, 1983, 11-12).
Esci dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre
Dobbiamo ora parlare delle rinunce. Esse sono tre, come attesta la tradizione patristica e l’autorità delle Scritture, e le dobbiamo adempiere con ogni nostro impegno. La prima è materiale; con essa rinunciamo a tutte le ricchezze e a tutti i beni di questo mondo; con la seconda rinunciamo alle abitudini della vita passata, ai vizi e alle passioni dello spirito e della carne. Con la terza richiamiamo il nostro spirito da tutte le realtà presenti e visibili, contempliamo unicamente le realtà future e non desideriamo se non le realtà invisibili. È necessario compierle tutte e tre; leggiamo che questo il Signore l’aveva comandato anche ad Abramo quando gli disse: Esci dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre (Gen 12,1). Esci dalla tua terra, cioè: rinuncia ai beni di questo mondo e alla ricchezze terrene. In secondo luogo: dalla tua parentela, cioè: rinuncia alla tua vita e alle abitudini di un tempo che sono unite a noi fin dalla nascita a motivo di una specie di affinità o di parentela di natura e di consanguineità. In terzo luogo: dalla casa di tuo padre, cioè da ogni ricordo di questo mondo visibile ai tuoi occhi. Abbiamo infatti due padri: uno è quello che dobbiamo abbandonare, l’altro lo dobbiamo cercare. Davide fa dire a Dio queste parole: Ascolta, figlia, e guarda; porgi l’orecchio e dimentica la tua gente e la casa di tuo padre [Sal 44 (45),11]. Colui che dice: Ascolta, figlia indubbiamente è padre, eppure attesta che è padre della propria figlia anche colui che convince a dimenticare la casa paterna e il popolo a cui appartiene. Ora, questo oblio si realizza quando, morti con Cristo agli elementi di questo mondo, contempliamo, secondo le parole dell’Apostolo, non più le cose che si vedono, ma quelle che non si vedono poiché le cose visibili sono temporanee, quelle invisibili sono eterne (2Cor 4,18); quando uscendo con il cuore dalla casa di questo mondo visibile, volgiamo lo sguardo verso quella in cui abiteremo per l’eternità.
(CASSIANO, Conferenze 3,6, SC 42, pp. 145-146).
La lotta spirituale
La lotta spirituale è innanzi tutto ascesi, esercizio. Chiunque scelga un fine, deve sottomettersi alle fatiche che questo fine richiede per essere raggiunto: negli studi, nella vita morale, nella vita spirituale. La necessità dell’ascesi si pone dunque sul piano prettamente umano, ancor prima che su quello della vita cristiana. Ha scritto Dietrich Bonhoeffer:
«Se parti alla ricerca della libertà, impara innanzitutto disciplina dei sensi e dell’anima, affinché i desideri e le membra non ti portino a caso qua e là.
Casti siano lo spirito e il corpo, sottomessi e obbedienti nel cercare la meta assegnata.
Nessuno penetra il mistero della libertà, se non con la disciplina»
(Dietrich BONHOEFFER, Stazioni sulla via della libertà, in Resistenza e resa, Bompiani, Milano 1969, p. 270).
Rinnega se stesso chi ama se stesso
Che cosa significano le parole: «Se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua»? (Mt 16,24). Comprendiamo che cosa vuol dire: «Prenda la sua croce»; significa: «Sopporti la sua tribolazione»; prenda equivale a porti, sopporti. Vuol dire: «Riceva pazientemente tutto ciò che soffre a causa mia. «E mi segua». Dove? Dove sappiamo che se ne è andato lui dopo la risurrezione. Ascese al cielo e siede alla destra del Padre. Qui farà stare anche noi. […] «Rinneghi se stesso».
In che modo si rinnega chi si ama? Questa è una domanda ragionevole, ma umana. L’uomo chiede: «In che modo rinnega se stesso chi ama se stesso?» Ma Dio risponde all’uomo: «Rinnega se stesso chi ama se stesso». Con l’amore di sé, infatti, ci si perde; rinnegandosi, ci si trova. Dice il Signore: «Chi ama la sua vita la perderà» (Gv 12,25). Chi da questo comando sa che cosa chiede, perché sa deliberare colui che sa istruire e sa risanare colui che ha voluto creare. Chi ama, perda. È doloroso perdere ciò che ami, ma anche l’agricoltore perde per un tempo ciò che semina. Trae fuori, sparge, getta a terra, ricopre. Di che cosa ti stupisci? Costui che disprezza il seme, che lo perde è un avaro mietitore. L’inverno e l’estate hanno provato che cosa sia accaduto; la gioia del mietitore ti dimostra l’intento del seminatore.
Dunque chi ama la propria vita, la perderà. Chi cerca che essa dia frutto la semini. Questo è il rinnegamento di sé, per evitare di andare in perdizione a causa di un amore distorto. Non esiste nessuno che non si ami, ma bisogna cercare un amore retto ed evitare quello distorto. Chiunque, abbandonato Dio, avrà amato se stesso e per amore di sé avrà abbandonato Dio, non dimora in sé, ma esce da se stesso. […] Abbandonando Dio e preoccupandoti di te stesso, ti sei allontanato anche da te e stimi ciò che è fuori di te più di te stesso. Torna a te e poi di nuovo, rientrato in te, volgiti verso l’alto, non rimanere in te. Prima ritorna a te dalle cose che sono fuori di sé e poi restituisci te stesso a colui che ti ha fatto e che ti ha cercato quando ti sei perduto, ti ha trovato quando sei fuggito, ti ha convertito a sé quando gli volgevi le spalle. Torna a te, dunque, e va’ a colui che ti ha fatto.
(AGOSTINO DI IPPONA, Discorsi 330,2-3 NBA XXXIII, pp. 818-822).
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana.
– Messalino festivo dell’assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
———
– M. FERRARI, monaco di Camaldoli, «Oggi si è adempiuta questa scrittura», Milano, Vita e Pensiero, 2013.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. Seconda parte: Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla Risurrezione, Città del Vaticano, Liberia Editrice Vaticana, 2011.
– C.M. MARTINI, Incontro al Signore risorto. Il cuore dello spirito cristiano, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009.