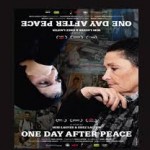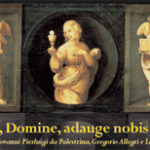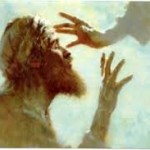
Prima lettura: Siracide 35,15-17.20-22
|
Il Signore è giudice e per lui non c’è preferenza di persone. Non è parziale a danno del povero e ascolta la preghiera dell’oppresso. Non trascura la supplica dell’orfano, né la vedova, quando si sfoga nel lamento. Chi la soccorre è accolto con benevolenza, la sua preghiera arriva fino alle nubi. La preghiera del povero attraversa le nubi né si quieta finché non sia arrivata; non desiste finché l’Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l’equità. |
Il libro del «Siracide» (detto così dal nome del suo autore Gesù Ben Sirach) fa parte non del canone ebraico, ma della bibbia greca. Fu scritto in ebraico (se ne sono trovati frammenti in una grotta di Qumran), ma è arrivato a noi nella traduzione greca, che risale agli inizi del II secolo avanti Cristo. Non siamo lontanissimi dall’epoca del N.T., ed il pensiero sapienziale di Israele si esprime in un’opera di grande maturità.
Il cap. 35 rappresenta una profonda meditazione sapienziale sul senso del culto, ma anche una sua relativizzazione. Da una parte si esalta la bontà delle offerte e dei sacrifici (vv. 1-10), dall’altra parte si ribadisce che Dio non si lascia corrompere da vittime ingiuste e preferisce le preghiere povere ma sincere degli umili (vv. 11-24). È da questa seconda sezione del cap. 35 che sono attinti i versetti di cui si compone la nostra lettura.
Annotazioni esegetiche
— «Il Signore è giudice…» (v. 12). Alla pretesa, o illusione, di valersi delle offerte cultuali per «corrompere» Dio (si legga il v. 11), questo v. 12 costituisce una risposta chiara: il Signore è al di sopra dei doni che gli offriamo come giudice imparziale. Vana è l’illusione dell’uomo religioso di poter tirare Dio dalla propria parte semplicemente offrendo gli omaggi.
— «Ascolta la preghiera dell’oppresso» (vv. 13-14). L’oppresso, la vedova e l’orfano sono — nell’ambito sociale — coloro che non hanno alcun peso, perché privi di sostegni e di possibilità economiche: è gente che non conta, alla quale nessuno dà importanza. A differenza delle autorità romane, è proprio a costoro che Dio rivolge la propria attenzione quando esprimono la loro infelicità («lamento»).
— «La sua preghiera arriva fino alle nubi » (v. 17). L’efficacia della preghiera (penetrare le nubi significa giungere al cielo, ossia presso Dio, ottenendo ciò che chiede) è proprio nella debolezza di chi la fa, o meglio nella consapevolezza di tale debolezza («umiltà»). Qui si crea un importante legame col Vangelo di oggi.
—«Abbia reso soddisfazione ai giusti» (v. 22). I «giusti» si identificano qui chiaramente con coloro che si riconoscono deboli e confidano unicamente nella protezione di Dio. Proprio perché fiduciosa, tale preghiera «non desiste» e finisce con l’ottenere da Dio il ristabilimento di un’equità che i criteri umani hanno ignorato o sovvertito cioè: i deboli e gli umili trovano davanti a Dio quel favore che gli uomini negano loro.
Seconda lettura: 2Timoteo 4,6-8.16-18
|
Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito; tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti, non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno; a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen |
La situazione in cui viene scritta questa seconda lettera a Timoteo è quella della prigionia romana. Paolo scrive alla vigilia della sua morte, per cui questa lettera al caro discepolo assume il tono del testamento spirituale. Nella parte finale di questo testamento (4,6-18) si aprono le prospettive future accompagnate dalle ultime istruzioni dell’Apostolo a Timoteo. La nostra lettura fa parte di questa sezione. Anche se (come tendono ad affermare molti critici) questa lettera è da attribuire non a Paolo, ma ad un suo discepolo o epigono, ritroviamo comunque le idee-madri e la testimonianza sostanziale dell’Apostolo, segno che la sua paternità spirituale ha profondamente segnato la tradizione paolina successiva.
Appunti esegetici. – Proponiamo di concentrare la nostra attenzione sulle immagini che vengono usate per descrivere la realtà presente vissuta dall’Apostolo e applicabile alla realtà di ogni credente.
a) La vita dell’Apostolo, che giunge verso la conclusione, è paragonata:
— con immagini atletiche, a una corsa tesa ad un traguardo («ho terminato» v. 7), ma anche in attesa di un premio («corona», v. 8), non da fruire personalmente ma da condividere con quanti hanno preso parte alla corsa (v. 8);
— con immagini strategiche: la vita del credente è battaglia buona e nobile, bella (kalos), per cui vale la pena combattere (v. 6);
— con metafora sacrificale: la vita giunge alla morte non come a epilogo oscuro ma come vittima il cui sangue si spande in libagione, è momento prezioso, al cospetto di Dio ed in favore degli uomini (propiziazione) (v. 6);
— con immagine marinara, la morte è come «sciogliere le vele», salpare per un lungo viaggio; non è fine, ma inizio.
b) Il rapporto dell’Apostolo con il Signore si configura come rapporto tra imputato e avvocato difensore. Il ruolo di questo difensore assume però dimensioni più vaste di quelle di un difensore giuridico. Sottolineiamo tre dimensioni teologiche: la prima, di liberazione dal nemico («dalla bocca del leone», v. 17: cf. Dan 6,17); la seconda, di potenza evangelizzatrice, per cui la forza di Dio si traduce in proclamazione e annunzio del Vangelo a tutti i pagani; la terza è di liberazione e salvezza escatologica: «nel suo regno» (v. 18).
Mediante queste ricche immagini, la vita, l’apostolato e la stessa morte di Paolo vengono trasfigurate alla luce di Dio, assumendo un valore molto più grande e teologico di quello che appare ad un semplice osservatore umano delle cose.
Vangelo: Luca 18,9-14
|
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». |
Esegesi
All’inizio del cap. 18 del Vangelo di Luca leggiamo due parabole riguardanti la preghiera. Ciascuna delle due parabole mette in luce le caratteristiche particolari della preghiera cristiana: la continuità incessante (parabola del giudice iniquo e della vedova, vv. 1-8; Vangelo letto la domenica scorsa) e l’umiltà (il fariseo e il pubblicano, vv. 9-14, Vangelo odierno). Il dittico delle due parabole va preso nel suo insieme: la preghiera incessante dev’essere caratterizzata da grande umiltà; la preghiera umile va continuata con perseveranza e insistenza.
Annotazioni esegetico-teologiche
Come ogni parabola, anche in questa abbiamo due storie o situazioni: l’una fittizia (due uomini salirono al tempio…), l’altra reale (alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri). La parabola raggiunge il suo scopo quando la situazione fittizia si «trasferisce» (para-ballo, in greco significa appunto «trasferire») a quella reale, sicché il superbo che disprezza gli altri si riconosce nel fariseo che si esalta e viene umiliato.
— «L’intima presunzione di essere giusti» (v. 9), «giusto» è l’uomo che si mette in sintonia con la «giustizia» di Dio, ossia con la sua santità e volontà di salvezza. La «giustizia» dei farisei, pur basandosi essenzialmente su opere buone (elemosina, preghiera e digiuno, cf. Mt 6,2-18) era inficiata da due deviazioni di base: prima, la pretesa di essere giusti in base ai propri meriti, seconda, l’esibizionismo che mentre li portava a «ritenersi» giusti davanti agli uomini (Lc 16,15), suscitava in loro disprezzo per gli altri.
Uno era fariseo e l’altro pubblicano (vv. 10-13). I due tipi di oranti sono scelti intenzionalmente, per preparare l’effetto della parabola. In comune essi hanno l’intenzione (pregare) e lo spazio (il tempio). La differenza è nell’atteggiamento e nel contenuto della preghiera:
a) l’atteggiamento di ognuno esprime il rispettivo modo di porsi di fronte a Dio presente nel tempio:
— il fariseo sta in piedi (così come si prega nel tempio) e inizia con un solenne atto di ringraziamento. In un certo senso egli rappresenta l’ideale della pietà giudaica;
— il pubblicano non osa avvicinarsi all’altro e levare lo sguardo al cielo, perché è consapevole della propria miseria e del proprio peccato.
Secondo la concezione comune dei giudei, per un pubblicano non c’era salvezza: sia perché si arricchiva col denaro che esigeva per le tasse, sia perché collaboratore delle forze romane, e quindi dei pagani, ponendosi contro il popolo. Il battersi il petto esprime non solo la coscienza che egli ha della propria situazione religiosamente disperata, ma anche e soprattutto il desiderio di cambiare la vita, e dunque di penitenza.
b) Il contenuto della preghiera di ognuno corrisponde esattamente al senso dell’atteggiamento esterno:
— il fariseo ringrazia Dio sostanzialmente per il fatto di essere un campione di pietà. Oggettivamente le opere in cui si impegna sono lodevoli ed eccellenti: nessuno era obbligato a digiunare se non nel giorno della grande espiazione, mentre egli generosamente lo fa due volte alla settimana, e chiaramente lo fa per espiare non i suoi, ma i peccati degli altri; inoltre, mentre era tenuto, a rigore, a pagare le decime solo dei principali frutti della terra (Dt 12,17ss), egli supera abbondantemente questo limite, pagando le decime di tutta la sua proprietà. Non si tratta di una caricatura, come spesso si dice: realmente il fariseo incarna l’ideale di colui che adempie le opere più fulgide della pietà giudaica. Ma a tale consapevolezza si accompagna il disprezzo degli altri (v. 11) e quindi manifesta la sua sufficienza davanti a Dio e l’orgoglio di fronte agli altri uomini, in particolare rispetto al pubblicano;
— il pubblicano non ha nessun merito da esibire; ha solo la chiara consapevolezza del suo peccato, e la esprime con le parole del Sal 51,1: Abbi misericordia di me o Dio. Siamo agli antipodi della chiara coscienza che ha il fariseo della sua percezione spirituale.
— «Io vi dico…» (v. 14). Il giudizio di Gesù interviene con pesante autorità («io vi dico») a capovolgere lo schema delineatosi con le due preghiere. Iniziando dal secondo, anziché dal primo, Gesù ha già introdotto il ribaltamento: costui ritorna a casa «giustificato», ovvero: Dio ha esaudito la sua preghiera e quindi ha perdonato il suo peccato; mentre l’altro (il fariseo) malgrado i grandi suoi meriti non lo è, cioè rimane col peso del suo peccato davanti a Dio. In questo modo Gesù infierisce un duro colpo alla presunzione di quel fariseo, e quindi alla concezione «ufficiale» che gli esponenti del giudaismo avevano della religiosità. La vera religiosità non è legata al peso delle opere, non stabilisce confronti con gli altri, ma si pone unicamente davanti al giudizio di Dio, dal quale implora misericordia. D’altra parte, Gesù mette in chiaro il perché del suo atteggiamento benevolo e accogliente rispetto a due grandi gruppi di peccatori pubblici: gli esattori delle tasse e le prostitute.
Meditazione
Preghiera e autenticità: questo il rapporto posto in luce dal brano dell’Antico Testamento e dal Vangelo. Il Signore gradisce la preghiera del bisognoso e dell’oppresso (I lettura) e accoglie la preghiera del pubblicano che si proclama peccatore davanti a lui (vangelo).
Vi e una fiducia in se stessi, un credersi giusti, che rende non accetta la preghiera del fariseo al tempio (Lc 18,14), così come vi è la possibilità di un culto che è solo una farsa, una burla, perché commisto a ingiustizia e empietà (cfr. Sir 34,18-19; 35,11). Nella preghiera si riflette e si svela l’autenticità o la falsità di ciò che si vive.
La preghiera dei due uomini al tempio, così vicini e così lontani al tempo stesso, ci pone la questione di cosa significhi pregare insieme, fianco a fianco, l’uno accanto all’altro in uno stesso luogo, in una liturgia. È possibile pregare accanto ed essere separati dal confronto, dal paragone e dal disprezzo («non sono come gli altri uomini,….. e neppure come questo pubblicano»: Lc 18,11). L’autenticità della preghiera, dell’offerta fatta al Signore nel culto, passa attraverso la qualità buona delle relazioni con i fratelli che pregano con me e che formano con me il corpo di Cristo.
Nella preghiera emerge anche quale sia la nostra immagine di Dio e la nostra immagine di noi stessi. Il fariseo prega «rivolto a se stesso» (pròs heautòn: Lc 18,11 ) e la sua preghiera sembra dominata dal suo ego. Egli formalmente compie un ringraziamento, ma in verità ringrazia non per ciò che Dio ha fatto per lui, bensì per ciò che lui fa per Dio. Il senso del ringraziamento viene così completamente sconvolto: il suo «io» si sostituisce a «Dio». La sua preghiera è in realtà un elenco delle sue prestazioni pie e un compiacimento del suo non essere «come gli altri uomini» (Lc 18,11 ). L’immagine alta di sé offusca quella di Dio e gli impedisce di vedere come un fratello colui che prega accanto a lui. La sua è la preghiera di chi si sente a posto con Dio: Dio non può che confermarlo in ciò che è e fa. È un Dio che non gli chiede alcun cambiamento e conversione perché tutto ciò che egli fa, va bene. Il fatto che lo sguardo di Dio non gradisca la sua preghiera (Lc 18,14: «questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato») smentisce la sua presunzione, ma afferma anche che noi possiamo pregare con ipocrisia e continuare a pregare senza pervenire ad autenticità e verità.
La differenza di atteggiamento dei due uomini è visibile anche dalla postura del corpo da loro assunta: il fariseo esprime la sua sicurezza, il suo essere un habitué del luogo sacro, stando in piedi, a fronte alta, mentre il pubblicano esprime la sua contrizione stando a distanza, quasi intimorito, a testa bassa, e battendosi il petto. Sempre noi preghiamo con il corpo e le posture del corpo rivelano la qualità della relazione con il Signore e il senso (o meno) del nostro stare alla sua presenza.
La preghiera richiede umiltà. E umiltà è adesione alla realtà, alla povertà e piccolezza della condizione umana, all’humus di cui siamo fatti. Umiltà non è falsa modestia, non equivale a un io minimo, ma è autenticità, verità personale. Essa è coraggiosa conoscenza di sé di fronte al Dio che ha manifestato se stesso nell’umiltà e nell’abbassamento del Figlio. Dove c’è umiltà, c’è apertura alla grazia e c’è carità; dove c’è orgoglio, c’è senso di superiorità e disprezzo degli altri.
Nella preghiera noi facciamo riferimento a immagini di Dio, ma il cammino della preghiera altro non è che un processo di continua purificazione delle immagini di Dio a partire dal Cristo crocifisso, vera immagine rivelata di Dio che contesta tutte le immagini mano fatte del divino.
L’atteggiamento del fariseo è emblematico di un tipo religioso che sostituisce la relazione con il Signore con prestazioni quantificabili: egli digiuna due volte alla settimana e paga la decima di tutto quanto acquista. Alla relazione con il Signore sotto il segno dello Spirito e della gratuità dell’amore, si sostituisce una forma di ricerca di santificazione mediante il controllo (la contabilità delle azioni meritorie) e che richiede il distacco dagli altri.
Preghiere e racconti
L’elemosina della santità
«Disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di esser giusti e disprezzavano gli altri “Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano…”» (Lc 18, 9-14).
Mettendo in scena il primo personaggio, Gesù vuole denunciare due disposizioni sbagliate e opposte al comportamento evangelico: la presunzione di essere giusti di fronte a Dio e il sentirsi superiori agli altri tanto da disprezzarli. I due atteggiamenti sono legati e il secondo dipende dal primo.
Lc 18,11 andrebbe meglio reso in italiano così: «Il fariseo stando ritto presso se stesso, queste cose pregava…». Il fariseo, dunque, è tutto preso di sé, è rivolto non a Dio ma a se stesso, recita delle parole pensando di pregare ma in realtà fa un autoelogio.
Il fariseo presume di sé ed è sicuro della propria santità, si presenta così quale giudice zelante e spietato nei confronti del suo prossimo: «Ti ringrazio che non sono come gli altri uomini… e neppure come questo pubblicano» (Lc 18, 11).
Il pubblicano, invece, non si preoccupa di quello che gli altri sono e fanno; è lontano dalla sua mente il giudicare il fariseo o altri. Egli è consapevole dei suoi tradimenti e delle sue colpe e non tenta di mascherarli davanti a Dio: «Stando a molta distanza non voleva neppure alzare gli occhi al cielo, ma batteva il suo petto dicendo: “O Dio, fai elemosina a me peccatore”» (Lc 18, 13). Si presenta con quelle che dovrebbe essere la «carta d’identità» di ogni cristiano: peccatore!
La parabola presenta due atteggiamenti di preghiera, ma poi finisce con il descrivere due modi di vivere. La preghiera così rivela la vita dei due personaggi. Di conseguenza ciò che va corretto non è la preghiera ma l’idea che si ha di Dio, di se stessi e del prossimo. Il fariseo e il pubblicano incarnano un modo diverso di porsi di fronte a Dio e agli altri, un modo opposto di guardare a se stessi, un modo opposto di concepire la santità.
Parole senza preghiera… la perfezione del presuntuoso
II fariseo entra nel tempio e rimane «in piedi»: è sicuro e fiero di sé. Formula una preghiera di ringraziamento a Dio non per i doni ricevuti, non per la vita o la fede; ma perché non è come gli altri. Egli si «distingue» per il suo impegno e avanza dei meriti dinanzi a Dio: «Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo» (Lc 18,12). È più che scrupoloso nell’osservare i suoi doveri religiosi. La sua «santità» sarebbe frutto unicamente del suo sforzo e del suo impegno. Ma in fondo il fariseo dice la verità, perché è vero che osserva fedelmente la legge e fa grandi sacrifici; è vero che il suo zelo lo spinge a fare più di quanto la legge richiede: non digiuna soltanto un giorno alla settimana, come era prescritto, ma due. Che cosa allora non va nella sua vita? Perché la sua preghiera non è gradita a Dio?
Tutto il suo impegno lo ha realmente portato all’autorealizzazione nella santità? Il «difetto» del fariseo non è l’ipocrisia, ma il riporre la fiducia unicamente in se stesso. La sua preghiera è un monologo: «Stando ritto presso se stesso queste cose pregava… » (Lc 18, 11). Egli sta «in piedi», non ha nulla da chiedere a Dio, anzi ritiene che Dio debba qualcosa a lui: nella sua preghiera non chiede misericordia, non aspetta il dono della salvezza, ma attende da Dio il premio che gli è dovuto per il bene fatto. Nel suo monologo orante esordisce dicendo: «O Dio, ti ringrazio… »: fa risalire in un certo modo la sua santità a Dio. Ma questa originaria consapevolezza di dipendenza da Dio per la sua autorealizzazione si perde lungo la strada, perché il suo sguardo è tutto ripiegato in se stesso. La sua santità non deriva da Dio e il suo modo di giudicare con disprezzo il prossimo non ha nulla a che vedere con la preghiera: è solo un autocompiacimento.
Uscirà come era entrato: con il suo orgoglio, il suo disprezzo, per gli altri, la sua presunta santità… Nella Casa di Dio era entrato da «santo», ne esce da fallito!
II coraggio di piegarsi… l’umiltà del peccatore
Il pubblicano, ebreo «rinnegato», è iscritto nell’elenco ufficiale dei «senza Dio» insieme ai ladri, alle prostitute e agli adulteri. Consapevole che la sua vita è in forte dissonanza con la fede e la santità, «stando a molta distanza, non voleva nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma batteva il suo petto…» (Lc 18, 13). Entra nel tempio con la coscienza di porre dinanzi a Dio tutta la sua vita, senza maschere e in tutta la sua nudità. Il suo atteggiamento di preghiera è esattamente opposto a quello del fariseo. La sua preghiera non è un monologo ma un dialogo; egli non parla a se stesso ma a Dio: «O Dio, fai elemosina a me peccatore». Dice la verità: è peccatore! A Dio presenta con coraggio la sua carta di identità e, cosciente della sua fragilità, piega le ginocchia, tiene abbassato lo sguardo perché si vergogna di se stesso, resta in fondo al tempio perché non osa avvicinarsi alla santità di Dio.
La sua umiltà, tuttavia, non consiste nell’abbassarsi perché egli è realmente ciò che dice di essere, ma nel coraggio di presentarsi con verità a Dio e a se stesso, così com’è. Al coraggio unisce il bisogno di cambiamento, consapevole di non poter pretendere nulla da Dio. Non ha nulla di cui vantarsi e non ha nulla da esigere. Può solo chiedere: «O Dio, fai elemosina a me», in greco: ilàstheti moi! Chiede l’elemosina di Dio, implora cioè il chinarsi misericordioso del Signore sulla sua fragilità, sul suo essere peccatore. E si rimette a Lui, si affida completamente allo sguardo compassionevole di Dio, non a se stesso. È questa l’umiltà, è questo l’atteggiamento che Gesù loda. Nella Casa di Dio era entrato da peccatore, ne esce da santo!
Cogliersi dallo sguardo di Dio
Gesù non elogia la vita del pubblicano e non disprezza le opere del fariseo; apprezza la verità con la quale il pubblicano si pone dinanzi a Dio e a se stesso; del fariseo condanna l’atteggiamento orgoglioso e arrogante e l’inutilità della sua vuota preghiera.
L’unico modo di porsi di fronte al Signore, nella preghiera e nella vita, è essere se stessi nella coscienza della propria fragile creaturalità… liberata e redenta e perciò bella! Il fariseo considera la sua santità come frutto del suo impegno e non come dono di Dio; è lontana dalla sua mentalità di misericordia e la «prossimità» con chi è diverso da lui, con il pubblicano.
Gesù non rimprovera perciò il fariseo di ipocrisia, ma evidenzia che è sbagliato l’intero suo modo di rapportarsi a Dio: «Disse questa parabola per alcuni che presumevano di esser giusti e disprezzavano gli altri» (Lc 18, 9). Gesù smaschera nel fariseo la sua «radice inquinata», il sistema religioso del quale è intriso e non una semplice incoerenza. La parabola non afferma che il fariseo avrebbe dovuto vivere come il pubblicano: non sono le sue opere ad essere contestate ma egli stesso e il suo modo di essere.
L’errore sta nel guardare a Dio alla luce delle proprie opere. Per Gesù invece è importante e necessario che l’uomo guardi a se stesso a partire da Dio, che l’uomo impari a cogliersi dallo sguardo di Dio e ad essere «vero» di fronte a Lui. «Io vi dico: questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell’altro» (Lc 18, 14); la «giustificazione» è permettere a Dio di farci dono del suo perdono, lasciare che Dio ci ami così come siamo, senza paura e senza infingimenti. E allora la fragilità umiliata si trasforma in forza e coraggio, ci rimette nuovamente in strada da santi verso la pienezza della vita, «perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato» (Lc 18,14).
Santi perché peccatori
La lezione della parabola è stata molto chiara. La santità è iscritta nella nostra creaturalità, ci restituisce al nostro essere uomini. La santità, però, inizia dove finisce l’umana presunzione perché è riconoscimento, accoglienza e offerta di ciò che si è: peccatori! È questa la nostra carta d’identità, questa la coscienza della nostra creaturalità esposta al bacio della graziosa tenerezza di Dio. Possiamo allora dire che noi siamo santi perché peccatori. Chi non ha la profonda consapevolezza di essere peccatore non potrà mai essere santo!
(M. RUSSOTTO, Santità come autorealizzazione? Spunti di riflessione in compagnia della Parola, in CISM, La relazione con Dio: fondamento dell’autorealizzazione del vivere con i fratelli, della passione apostolica. «Protesi verso il futuro» (Fil 3,12)… per essere santi, Roma, Il Calamo, 2003, 55-59).
Preghiera e valutazione degli altri
La valutazione degli altri, ecco l’altro parametro che bisogna accettare per riscoprirsi. Specie se quest’altro è Dio e per lui Cristo.
Un giorno si presentano al tempio per pregare un fariseo ed un pubblicano. Il primo prega cosi: “Dio, ti ringrazio che non sono come il resto degli uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, oppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima di tutto ciò che acquisto”. L’altro invece: “Dio, sii clemente al peccatore che io sono”. Gesù sentenzia: “Vi dico, il pubblicano se ne tornò giustificato a casa sua, a differenza dell’altro” (Lc 18,11-14).
Evidentemente il primo si è valutato da sé e lo ha fatto paragonandosi agli altri. E chi è disposto a considerarsi peggiore degli altri? Non giudichiamo forse gli altri con estrema facilità e molto spesso con spietata severità? Il fariseo ha finito con il sopravvalutarsi, con l’essere ingiusto con sé e soprattutto con gli altri; perciò continua Gesù: “Chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato” (Lc 18,14). Il pubblicano s’è messo di fronte a Dio e ne ha visto l’immensa distanza, l’incolmabile differenza, ha chiesto aiuto ed è stato restituito al suo posto di uomo “giusto”.
Un giorno (scrive Francesco Alberoni) rabbi Jochanan ben Zaccai domandò ai suoi discepoli quale è la retta via da seguire. Elazar gli diede la risposta esatta: “un cuore buono”. Ottima risposta, eppure noi riusciamo a manipolare anche l’intenzione. A poco a poco, attraverso una sottile azione di propaganda su noi stessi, arriviamo a nasconderci i veri motivi della nostra azione: l’ambizione, l’interesse, l’odio, la vendetta. Ci convinciamo di essere mossi soltanto dal desiderio di fare del bene, dall’altruismo. Sartre la chiamava falsa coscienza. Anche il grande inquisitore Torquemada pensava di essere buono, in quanto cercava di salvare l’anima immortale di coloro che condannava al rogo. Qualsiasi virtù è automaticamente distrutta dal compiacimento di possederla.
O Dio, abbi pietà di me, peccatore
«Veglia su di te, dice la Scrittura (Dt 15,9). Credo che colui che ha dato la legge sia ricorso a tale ammonimento anche per sradicare un’altra passione; poiché ciascuno di noi è più facilmente incline a interessarsi delle cose altrui invece che meditare sulle proprie, affinché non abbiamo ad ammalarci di questa malattia, il Signore ci dice: «Smetti di interessarti della cattiveria del tale o del tal altro; non dar tempo ai tuoi pensieri di esaminare le debolezze altrui, ma veglia su di te, cioè volgi l’occhio dell’anima a scrutare tè stesso».
Molti, infatti, secondo la parola del Signore, osservano la pagliuzza nell’occhio del fratello e non vedono la trave che è nel proprio (cfr. Mt 7,3). Non cessare, dunque, di scrutare te stesso, se vuoi vivere secondo il comandamento. Non stare a guardare fuori di te se ti riesce di trovare qualcosa da rimproverare agli altri, come faceva quel fariseo presuntuoso e vanaglorioso che innalzava se stesso giustificandosi e disprezzava il pubblicano (cfr. Lc 18,10-14); non smettere di esaminare te stesso chiedendoti se hai peccato nei tuoi pensieri o se la tua lingua, più veloce del pensiero, non ha detto qualcosa di troppo, se con le opere delle tue mani non hai compiuto qualcosa al di là delle tue intenzioni. E se trovi nella tua vita un gran numero di peccati – sei uomo e dunque ne troverai di certo – ripeti le parole del pubblicano: “O Dio, abbi pietà di me peccatore” (Lc 18,13).
Veglia su di te. Se godi di grande pace, se i tuoi giorni scorrono felici, queste parole ti saranno utili come un buon consigliere che ti ricorda la realtà delle cose umane. Se invece sei oppresso da vicende avverse, le stesse parole cantate nel cuore ti riusciranno utili per non elevarti orgogliosamente a un’insolenza eccessiva o per non cadere per disperazione in un meschino scoraggiamento».
(BASILIO DI CESAREA, Veglia su di te 5, Bose, 1993, pp. 19-20).
L’umiltà
Un’ulteriore energia dello Spirito è l’abbassamento. Non uso volutamente la parola «umiltà» perché il significato abituale che attribuiamo a quest’ultima comporta una certa dose di autodeterminazione, il che in realtà è un’impressione a posteriori. L’umiltà è una condizione prima di essere un giudizio su noi stessi. È una situazione di abbassamento sulle tracce di Cristo: «Chi si umilia sarà esaltato». Un abbassamento che ha valore solo se è opera dello Spirito santo. È indubbiamente a questo punto che entra in gioco l’obbedienza religiosa, nella misura in cui tale obbedienza consiste nel rimanere sottomessi, soggetti ad altri uomini, per amore del Signore e seguendo il suo esempio.
(Tatto da A. Louf, La vita spirituale, Edizioni Qiqajon – Comunità di Bose, Magnano, 2001, pp. 9-20).
Preghiera
Il fariseo si riteneva giusto perché non uccideva.
Gesù insegna ad amare i propri nemici.
E noi cristiani pensiamo di essere giusti
perché non abbiamo ucciso?
Il fariseo si riteneva giusto perché non commetteva adulterio.
Gesù ci chiede di non guardare la donna altrui con desiderio.
E noi cristiani ci riteniamo giusti
quando commettiamo adulterio di fatto o di desiderio?
Il fariseo si riteneva giusto pur praticando il divorzio.
Gesù insegna che chi ripudia sua moglie e ne sposa un’altra,
commette adulterio contro di lei.
E noi cristiani ci riteniamo giusti perché non abbiamo divorziato?
Il fariseo si riteneva giusto perché giurava e manteneva i giuramenti.
Gesù dice di non giurare affatto.
E noi cristiani ci riteniamo giusti pur giurando e giurando il falso?
Il fariseo si riteneva giusto perché digiunava e pagava le decime.
Gesù dice che quando abbiamo fatto tutto, siamo servi inutili.
E noi cristiani crediamo di essere giusti perché osserviamo le leggi?
La preghiera del fariseo
non fu accetta a Dio perché stimò e lodò se stesso,
non si ritenne peccatore,
non chiese perdono a Dio,
tornò a casa non giustificato.
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana.
– Messalino festivo dell’assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
———
– M. FERRARI, monaco di Camaldoli, «Oggi si è adempiuta questa scrittura», Milano, Vita e Pensiero, 2013.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. Seconda parte: Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla Risurrezione, Città del Vaticano, Liberia Editrice Vaticana, 2011.
– C.M. MARTINI, Incontro al Signore risorto. Il cuore dello spirito cristiano, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009.
PER L’APPROFONDIMENTO: