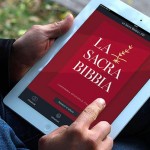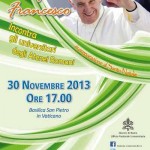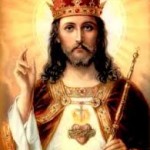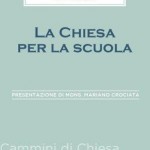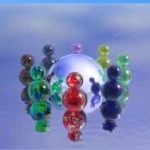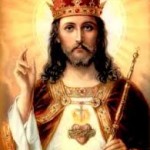
Prima lettura: 2Samuele 5,1-3
|
In quei giorni, vennero tutte le tribù d’Israele da Davide a Ebron, e gli dissero: «Ecco noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: “Tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo d’Israele”». Vennero dunque tutti gli anziani d’Israele dal re a Ebron, il re Davide concluse con loro un’alleanza a Ebron davanti al Signore ed essi unsero Davide re d’Israele.
|
Cristo re dell’universo ha una prefigurazione in Davide che riunisce tutto il popolo in un unico regno. La breve lettura proposta dalla liturgia odierna contiene le tre motivazioni che spingono gli anziani a chiedere l’unificazione del regno (vv. 1-2) e quindi il fatto dell’unificazione con l’unzione regale di Davide (v. 3).
Le tre motivazioni sono rispettivamente: una certa familiarità con Davide che era loro ‘fratello’ di razza perché membro dello stesso popolo; Davide di fatto aveva già assunto il comando militare e quindi era loro capo; infine, un oracolo divino aveva manifestato la predilezione per lui.
Troviamo qui alcuni tratti perché ci sia un buon regno. Si parte da un consenso di adesione e da un riconoscimento nella figura del re che diventa una ‘persona corporativa’. La frase «ecco noi siamo tue ossa e tua carne», riecheggia il grido osannante del primo uomo che si ‘specchiava’ nella sua donna (cf. Gn 2,23). Si crea una sintonia che si avvicina molto all’identità. Davide ha, dal canto suo, il compito di essere pastore, di pascere il suo popolo. Quella del pastore è una delle più remote e simpatiche denominazioni del re, forse già presente al tempo dell’antico re babilonese Hammurabi (XVIII secolo a.C.). Il termine esprime la responsabilità e la cura indefessa che il re esercita a vantaggio della sua gente. Egli è lì per loro.
L’unzione sancisce un’alleanza che è impegno reciproco di fedeltà e di amore. Si stabilisce nel medesimo tempo un’alleanza in orizzontale, con tutti i mèmbri del popolo, di cui il re, come pastore, è il primo responsabile. Oggi diremmo, con un linguaggio a noi più familiare, che egli è il ‘padre’ di tutti. Poi sussiste un’alleanza in verticale, in quanto il re è il rappresentante di tutto il popolo presso Dio.
La figura di Davide, re ideale e prefigurazione del re messia, non ha avuto buoni imitatori nei suoi successori. Le delusioni causate dal comportamento scorretto di tanti re che si sono avvicendati sul trono, non ha affievolito la speranza messianica, perché questa si fondava essenzialmente sulla sovranità divina e sulla sua promessa. Sempre di più i giudei hanno atteso qualcuno che sarebbe venuto dall’alto e avrebbe avuto tutte le qualità necessario all’avvento del tempo messianico. Gesù mostra di avere le qualità richieste, deludendo però i suoi contemporanei che attendevano un paradiso in terra.
Seconda lettura: Colossesi 1,12-20
|
Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli.
|
Il primato di Cristo o, se si preferisce, la sua eccellenza che lo incorona re, è mirabilmente scolpita nel famoso inno che la lettura propone. Siamo in presenza di una composizione semplicemente stupenda, anche se irta di difficoltà per gli studiosi. Tralasciando le questioni tecniche e le spinose problematiche connesse, ci limitiamo ad alcuni accenni in sin-tonia con la liturgia odierna.
L’inno presenta due strofe che celebrano Cristo come il primogenito di tutta la creazione (vv. 15-18a) e come il primogenito dei morti (vv. 18b-20): alla cristologia cosmica della prima strofa corrisponde la soteriologia cosmica della seconda. Creazione e redenzione sono rapportate reciprocamente. Cristo in quanto esaltato nella redenzione totale è pensato anche come il detentore di una sovranità cosmica, quella che presiede, dirige e orienta tutta la creazione. L’inno è un canto di lode al Cristo trionfatore che ha fatto della sua risurrezione una nuova creazione, più completa della prima. La nuova creazione, riconciliata in Cristo, riceve la pienezza, quella che la prima non possedeva. Senza trovare il termine, vi ravvisiamo una celebrazione della regalità di Cristo, signore dell’universo.
Il fondamento di tutto sta nella sua divinità, che lo rende uguale a Dio, e nella sua umanità, attraverso la quale può esprimere il suo amore che arriva fino al dono della vita.
L’inno parla sempre di Cristo, senza mai nominarlo. Egli viene presentato al v. 15 come «immagine del Dio invisibile». Qui per «immagine» non si intende una creazione (come in Gn 1,26), ma la riproposizione della stessa natura, come tutto l’inno si impegnerà a dimostrare. Egli è superiore al creato perché «generato prima di ogni creatura» (lett. «primogenito di tutta la creazione»), indicando più una preminenza che una precedenza nel tempo (cf. Sl 89,28). Il primogenito, nel diritto familiare palestinese, godeva di alcune prerogative (cf. Gn 43,33; Dt 21,17). In base a questo sottofondo, si comprende meglio il titolo dato a Cristo, primogenito in senso di eccellenza, e non in senso di anteriorità, come il testo italiano potrebbe lasciar intendere.
Oltre che la preminenza sul creato, Cristo è presentato come il principio vitale nascosto in «tutte le cose». Egli è causa effettiva di tutto e anche fine ultimo, è il punto di riferimento necessario. Per ogni cosa egli è la possibilità di continuare ad esistere, una specie di fondamento universale. Se tutto è riferito a Cristo, egli è celebrato come il mediatore della signoria di Dio, veramente la sua icona.
Dopo il Cristo creatore, la seconda parte dell’inno (vv. 18b-20) celebra Cristo come salvatore. Se non è presente il termine, chiara ne è l’idea. È sempre in vista di una celebrazione della superiorità di Cristo che continua l’inno, riprendendo il concetto che egli è «principio, il primogenito». Come la creazione aveva dato la vita a chi non l’aveva, così ora l’opera di Cristo dà la vita a chi l’ha persa. Cristo dà vita. Sta qui uno dei concetti principali del primato: essere ‘fonte di vita’. Occupa il primo posto, non perché ha bisogno di essere salvato, ma perché ha sperimentato per primo il morire-risorgere: «il primogenito di quelli che risorgono dai morti». Cristo porta la comunità dei credenti, la Chiesa, a formare la ‘sua’ Chiesa. Sottomessi a lui, ma anche intimamente legati a lui, i fedeli prendono parte alla sua vita, entrano in un ordine nuovo, più alto, soprannaturale. Così diventa principio e primogenito dei morti, sia perché si trova alla testa, sia, soprattutto, perché gli altri senza di lui non esisterebbero: nella sua risurrezione è garantita quella degli altri. Ecco perché ottiene «il primato su tutte le cose».
Ora Paolo passa a presentare un altro motivo di primato: la pienezza di Cristo. Non si parla di dimensioni, ma di capacità di dominare ogni cosa. «Pienezza» (in greco pléroma) richiama ai Colossesi l’idea che Cristo è in se stesso totalmente ricco; non ha quindi bisogno di nessuna integrazione.
La redenzione è presentata in tutta la sua tragica storicità, «avendo pacificato con il sangue della sua croce», per ricordare al lettore un dato che ancora alla concretezza di un avvenimento e al dono personale di un individuo che ama. Il richiamo al sangue conserva un ricordo storico di impressionante realismo (cf. il Vangelo di oggi).
Cristo è il re universale perché ha creato tutto e tutto ha ricreato con l’amore di una vita totalmente donata.
Vangelo: Luca 23,35-43
|
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».
|
Esegesi
Siamo alle battute finali della passione. Il clima di ostilità è surriscaldato al massimo. La scelta del presente brano è motivata dalla presenza del titolo di re, dato a Gesù, che ben si intona alla festa di oggi. Si gioca su questo titolo; per qualcuno di dileggio, per altri esprimente una costitutiva qualità di Gesù. Due realtà opposte si fronteggiano: da una parte sono schierate, in forza massiccia, le potenze del male (vv. 35-39), dall’altra, in forza esigua, quelle del bene (vv. 40-43). La theologia crucis sta proprio nel fatto che il piccolo sconfigge il grande, come Davide ha vinto il gigante. Il negativo è impersonato dal triplice scherno: quello dei capi, quello dei soldati e quello di uno dei malfattori. Sono in tanti a credere che siamo alla fine di un’avventura, alimentata da vuota speranza: «Ha salvato altri! Salvi se stesso… Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso… Salva te stesso e noi!» Rimane solo il tempo per l’esecuzione capitale.
Il fatto ostico di un condannato che muore, suscita, paradossalmente, uno sconfinato interesse. In una situazione di per sé ripugnante, fiorisce una attenzione che lascia presagire una novità. Quella morte riveste un medito valore, quasi di pubblicità. Il mistero pasquale è già abbozzato, o meglio, già definito in questa morte così carica di promessa.
Sul Calvario, la sofferenza e la morte di Gesù diventano uno spartiacque che divide gli uomini: alcuni troveranno motivo per negare in lui la presenza di Dio, altri vi vedranno una misteriosa, anche se non facilmente comprensibile, presenza divina. La morte di Gesù è uguale e anche diversa dalle altre. Con la morte di tutti gli uomini condivide la tragica impotenza, il senso di fine, il dramma della separazione da tutto e da tutti. Diversamente da quella degli altri, la morte di Cristo porta i germi di trionfo. Lo attestano la scritta che campeggia sul cartiglio: «Costui è il re dei Giudei», le parole del buon ladrone e, soprattutto, la sentenza finale di Gesù: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso» (v. 43). Davvero strano questo condannato che, sul punto di morire, determina la vita degli altri con un’autorità che assomiglia molto a quella divina. Consideriamo la cosa più da vicino.
Gesù reagisce con potere sovrano ad una felice provocazione. Il ladrone che si era rivolto a lui, forse in un ultimo, disperato S.O.S., non si rende pienamente conto del tenore delle sue parole. Egli chiede un ricordo (forse una ‘raccomandazione’) nel regno. Senza che egli ne abbia lucida coscienza, il regno invocato è quello che cresce in terra, ma che si radica in cielo, quello che avviene nel tempo, ma che ha caratteri di eternità. È il regno che Gesù sta meritando con il sacrificio della sua vita. È il regno che potrebbe avere il suo archetipo in quel giardino, un tempo luogo di incontro amoroso tra Dio e la sua creatura (cf. Gn 2), e ora sigillato dal peccato. Gesù si appresta a riaprirlo. Non servono chiavi. Occorre un atto di amore infinito che può compiere solo il Figlio dell’uomo che è altresì Figlio di Dio.
La risposta di Gesù si apre con la solennità della grandi dichiarazioni: «In verità io ti dico». C’è da aspettarsi qualche parola che farà storia. Infatti, giunge una solenne e inaspettata promessa: «oggi con me sarai nel paradiso». Il giardino è riaperto. La comunione con il Padre è ripristinata, un nuovo abbraccio lega l’uomo al suo Creatore. Questo abbraccio è Cristo crocifisso. Tutti gli uomini sono compresi nelle sue braccia allargate; veramente tutti sono ‘abbracciati’. La scena della morte, tratteggiata con colori drammatici, mai funerei, si illumina improvvisamente con il bagliore della vita. È subito apoteosi.
Il brano liturgico si interrompe qui, senza passare a descrivere la morte. Interessava, nel presente contesto, individuare e ribadire la regalità di Cristo. Ora sì, è possibile morire. Ma non è più vera morte. È solo passaggio. Veramente la morte è vinta dalla croce e s’inaugura il tempo finale profetizzato da Ezechiele (cf Ez 37,12), da Daniele (cf Dn 12,1-2) e da tanti altri. Gesù realizza le profezie e la sua morte è già principio di vita. L’atto finale della vita di Gesù è di per sé redentore ed è il motivo del suo trionfo sulla morte. Con Cristo s’inaugura un’umanità nuova. Dopo la sua morte non è più concessa la scelta tra il dolore e la felicità, ma tra il dolore senza senso e senza compenso e la felicità raggiunta attraverso il dolore; non tra la morte e la vita senza morte, ma tra la morte senza vita di gloria e la gloria nella quale la morte è diventata premessa indispensabile di vita eterna.
La vicenda di Gesù anticipa e rende possibile quella di ogni uomo. Lo documenta la pagina evangelica odierna: il ‘collega’ di supplizio diventa il ‘collega’ nel regno. Del regno Gesù aveva detto qualcosa in precedenza: «Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove; e io preparo per voi un regno, come il Padre l’ha preparato per me, perché
possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno e sederete in trono a giudicare le dodici tribù di Israele» (Lc 22,28-30). La citazione richiama elementi analoghi al passo liturgico odierno: il regno è dono del Padre e di Cristo, lo si ottiene ‘contribuendo’ personalmente e uno dei migliori contributi è la sofferenza (idea racchiusa nel concetto di ‘perseverare’). Il regno è comunione e condivisione con la divinità: la prima è espressa con l’immagine classica del banchetto (cf. Is 25,6ss), l’altra con l’immagine del governare (cf. Mt 19,28). Nel regno vige un’unica regola, quella della comunione di amore. Il banchetto e la condivisione del potere, sono mirabilmente riassunte nel «con me sarai», una succosa sin-tesi teologica di ‘paradiso’.
Essere con Gesù, il Crocifisso di questo momento, presto il Risorto, equivale ad essere con il Padre e con lo Spirito. Il paradiso è comunione con la Trinità.
Meditazione
Le letture di questa domenica finale dell’anno liturgico, che celebra Cristo quale Signore e re dell’universo, presentano la regalità nella sua dimensione comunionale, corporativa. Nella prima lettura le tribù di Israele riconoscono Davide come re e mostrano di sentire il messia come figura corporativa. Esse si affidano a lui quasi incorporandosi simbolicamente a lui: «Noi ci consideriamo come tue ossa e tua carne» (1Sam 5,1). Nel vangelo siamo di fronte a Gesù quale messia debole, inerme, che, sulla croce, mentre si affida radicalmente a Dio (Lc 23,46), vede affidarsi a lui un malfattore crocifisso accanto a lui. E Gesù promette comunione a costui, incorpora a sé quest’uomo promettendogli comunione: «Oggi sarai con me nel paradiso» (Lc 23,43). La seconda lettura esprime la fede ormai sviluppata della chiesa che celebra l’incorporazione cosmica nel Cristo Risorto: tutto è stato creato in Cristo, per mezzo di lui, ma anche in vista di lui, per essere ricapitolato in lui (Col 1,12-20).
Per tre volte Gesù viene deriso come Messia e per tre volte i suoi avversari gli rivolgono l’invito a salvare se stesso, quasi che proprio la capacità di sottrarsi alla croce, di salvare la propria vita sia per loro il sigillo dell’autenticità della messianicità (Lc 23,35.37.39). Invece, è esattamente l’autosalvezza ciò che è impossibile nello spazio cristiano, ciò che contraddice radicalmente la salvezza cristiana. Gesù aveva annunciato: «Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per me, la salverà» (Lc 9,24). Ma prima di annunciare che chi perderà la vita a causa sua, la salverà, egli stesso è passato attraverso l’esperienza del perdere la propria vita, del perdere se stesso. Mettere in salvo la propria vita è la grande tentazione, a cui Gesù si è opposto già durante le tentazioni inaugurali del suo ministero (Lc 4,1-13). Ed è la tentazione perenne del cristiano e della chiesa. Infatti, vale anche per la chiesa il detto di Gesù per cui chi cerca se stesso, chi vuole salvare se stesso, ovvero chi fa di se stesso un fine, il proprio fine, perde se stesso.
La regalità di Gesù è derisa (Lc 23,35-37) o insultata (Lc 23,39); di essa ci si fa beffe (Lc 23,35-37) o si cerca di sfruttarla a proprio vantaggio (Lc 23,39). Gesù abita lo scandalo del Messia perduto che può così raggiungere chiunque si trovi in situazioni di perdizione. Del resto, noi sappiamo che condizione indispensabile per incontrare e aiutare l’altro nella sua sofferenza, è condividere qualcosa della sua impotenza e debolezza. Scrive Bonhoeffer: «Cristo non aiuta in forza della sua onnipotenza, ma in forza della sua debolezza e della sua sofferenza […] La Bibbia rinvia l’uomo all’impotenza e alla sofferenza di Dio; solo il Dio sofferente può aiutare». La regalità di Gesù capovolge dunque la logica di potenza e forza che regge le regalità umane.
Gesù mostra la sua signoria manifestando la sua capacità di giudizio e di divisione: egli è segno di contraddizione e di fronte a lui ci si divide, si manifestano i pensieri dei cuori. Dei due crocifissi con lui uno lo insulta, l’altro lo prega. In particolare, il cosiddetto «buon ladrone» appare tipo del discepolo cristiano. Egli innanzitutto opera la correzione fraterna «rimproverando» (Lc 23,40) l’altro condannato che insulta Gesù, e mettendo così in atto la parola di Gesù: «Se tuo fratello pecca, rimproveralo» (Lc 17,9) ; inoltre egli appare simbolo della responsabilità: riconosce il male che ha commesso e ne accetta le conseguenze (Lc 23,41a); quindi esprime una confessione di fede riconoscendo l’innocenza di Gesù (Lc 23,41b); infine si rivolge a Gesù con la preghiera, la supplica, e riconoscendone la regalità escatologica: «Gesù, ricordati di me, quando verrai [non «entrerai», come traduce la Bibbia CEI] nel tuo regno» (Lc 23,42). Immagine dei credenti e della chiesa che, nella storia, sono chiamati a testimoniare la regalità di Cristo condividendo le sofferenze del Crocifisso, invocando la venuta del Regno, e attendendo il Veniente nella gloria.
Preghiere e racconti
Il Buon ladrone
Coloro ch’egli ama, si accalcano, montano la guardia. Intorno al suo corpo esposto, ricoprendo, velando col loro amore la sua nudità, troppo sanguinante, troppo dolorosa per offendere qualsiasi sguardo. A traverso il sangue e il pus, egli vede la propria pena riflessa sui volti cari: quelli di Maria sua madre, di Maria Maddalena, d’una delle sue zie, moglie di Cleofa. Giovanni ha forse gli occhi chiusi. Ed ecco l’episodio sublime, l’ultima invenzione dell’Amore, innocente e crocifisso, che Luca solo riporta: L’uno dei malfattori appiccati lo ingiuria dicendo: – Se tu sei il Cristo, salva te stesso e noi. Ma l’altro lo riprendeva dicendo: – Non hai tu timore di Dio, che sei nel medesimo supplizio? Per noi è giustizia, perché riceviamo la pena degna dei nostri misfatti: ma costui non ha commesso nulla di male. E tosto che ha parlato, una grazia immensa gli piove in cuore: quella di credere che quel suppliziato, quel miserevole rifiuto che i cani schiferebbero, è il Cristo, il Figlio di Dio, l’Autore della vita, il Re del cielo. E dice a Gesù: «Signore, ricordati di me, quando sarai entrato nel tuo regno».
« Oggi stesso tu sarai con me in paradiso ».
Un solo moto di puro amore, e un’intera vita criminale è cancellata. Buon ladrone, santo operaio dell’ultima ora, inebriaci di speranza.
(E. MAURIAC, Vita di Gesù, Milano, Mondadori, 1950, 149-150).
Voglio che sia una regina
«C’era una volta, tanti secoli fa, una città famosa. Sorgeva in una prospera vallata e, siccome i suoi abitanti erano decisi e laboriosi, in poco tempo crebbe enormemente. Era insomma una città felice nella quale tutti vivevano in pace. Ma un brutto giorno, i suoi abitanti decisero di eleggere un re. Suonate le trombe, gli araldi li riunirono tutti davanti al Municipio. Non mancava nessuno. Lo squillo di una tromba impose il silenzio su tutta l’assemblea. Si fece avanti allora un tipo basso e grasso, vestito superbamente. Era l’uomo più ricco della città. Alzò la mano carica di anelli scintillanti e proclamò: “Cittadini! Noi siamo già immensamente ricchi. Non ci manca il denaro. Il nostro re deve essere un uomo nobile, un conte, un marchese, un principe, perché tutti lo rispettino per il suo alto linguaggio”.
“No! Vattene! Fatelo tacere’ Buuu”. I meno ricchi della città cominciarono una gazzarra indescrivibile. “Vogliamo come re un uomo ricco e generoso che ponga rimedio ai nostri problemi!”.
Nello stesso tempo, i soldati issarono sulle loro spalle un gigante muscoloso e gridarono: “Questo sarà il nostro re! Il più forte!”.
Nella confusione generale, nessuno capiva più niente. Da tutte le parti scoppiavano grida, minacce, applausi, armi che s’incrociavano.
Suonò di nuovo la tromba. Un anziano, sereno e prudente, sali sul gradino più alto e disse: “Amici, non commettiamo la pazzia di batterci per un re che non esiste ancora. Chiamiamo un innocente e sia lui ad eleggere un re tra di noi”.
Presero un bambino e lo condussero davanti a tutti. L’anziano gli chiese: “Chi vuoi che sia il re di questa città così grande?”.
Il bambinetto li guardò tutti, si succhiò il pollice e poi rispose: “I re sono brutti. Io non voglio un re. Voglio che sia una regina: la mia mamma”».
(B. Ferrero, C’è qualcuno lassù, Torino, LDC, 1993, 12-13).
Il Cristo di Velázquez
A che pensi Tu, morto, Cristo mio?
Perché qual vel di tenebrosa notte
la ricca chioma tua di nazareno
ricade cupa giù su la tua fronte?
Entro di te Tu guardi ove sta il regno di Dio;
dentro di te, là dove albeggia,
l’eterno sol dell’anime viventi.
Bianco è il suo corpo, sì com’è la sfera del sol,
padre di luce, che dà vita;
bianco è il tuo corpo al modo della luna
che morta ruota intorno alla sua madre,
la nostra stanca vagabonda terra;
bianco è il tuo corpo, bianco come l’ostia
del cielo nella notte sovrumana,
di quel cielo ch’è nero come il velo
della chioma tua ricca e cupa e folta
di nazareno.
Chè sei, Cristo, il solo
Uomo che di sua scelta soccombesse,
trionfando della morte, che fu resa
da te verace vita. E sol da allora
per Te codesta morte tua dà vita;
per Te la morte è fatta madre nostra;
per Te la morte è il dolce nostro anelo
che placa l’amarezza della vita.
Per te, l’Uomo che è morto e che non muore,
bianco siccome luna nella notte…
(M. DE UNAMUNO, II Cristo di Velázquez, Brescia, Morcelliana, 1948, 28-29).
«Non sono così».
Si racconta, fra i Padri del deserto, la storia di un misero calzolaio di Alessandria che un angelo aveva presentato al grande sant’Antonio come un uomo più avanti di lui, malgrado gli sforzi eroici dell’eremita appassionato, fortemente preoccupato di fare progressi. Sconcertato non poco da questa rivelazione, Antonio si recò subito nella città di perdizione per imparare dalle labbra del calzolaio il segreto della sua perfezione: «Cosa fai di straordinario per santificarti in un simile ambiente?», «Io? Faccio le scarpe!». «Senza dubbio. Ma devi avere un segreto. Come vivi?». «Suddivido la mia vita in tre ambiti: la preghiera, il lavoro, ed il sonno», «Io prego sempre, quello che fai tu non va bene! E la povertà?». «Anche in questo caso tre parti: una per la chiesa, una per i poveri e una per me». «Ma io ho dato tutto quello che avevo… Deve esserci qualcos’altro. Non credi?».
«No». «E tu riesci a sopportare queste persone che non sanno più distinguere il bene dal male, che vanno chiaramente all’inferno?». «Ah, lì, non lo faccio, non lo sopporto! Chiedo a Dio di farmi scendere vivo all’inferno purché essi siano salvati!». Sant’Antonio si ritirò in punta dei piedi confessando: «Non sono così».
Signore, Misericordia…
Signore, sono davanti a Te da povero tuo amico, debole, peccatore… Signore, io mi abbandono a Te, ti amo davvero, ma resto debole, resto peccatore. Signore, ti invoco in ogni momento: medito giorno e notte la tua Parola ma i miei fallimenti mi sono sempre davanti. Signore, sei il mio vero e unico padrone, ma la mia forza diventa spesso debolezza. Signore, misericordia per il tuo povero amico.
(E. OLIVERO, L’amore ha già vinto – Pensieri e lettere spirituali, Cinisello Balsamo (MI), San Paolo, 2005, 54).
Aiutami a dire “sì”
Ho paura a di “sì”, Signore.
Dove mi porterai?
Ho paura del “sì” che comporta altri “sì”.
Ho paura a mettere la mia mano nella tua;
perché tu possa stringerla […]
O, Signore, ho paura delle tue richieste,
ma chi può opporti resistenza?
Che venga il tuo regno, non il mio,
che sia fatta la tua volontà e non la mia,
Aiutami a dire “sì”».
(Michel QUOIST)
La determinazione del tempo del Regno: una spiegazione
Il Regno di Dio è come un seme posto nella terra, che raggiungerà certe fasi della crescita in modo graduale, giungendo a ciascuna fase solo al momento giusto e con il passare del tempo.
Letteralmente, sappiamo che i Regno di Dio è un invito da parte di Dio e un atto di accettazione da parte del genere umano. L’invito è esteso in una serie di richieste e di eventi, come quando, nella nostra cultura, un giovane invita una donna a condividere la sua vita. C’è il primo appuntamento, l’invito ad un rapporto speciale ed esclusivo (“fare coppia fissa”), la proposta di matrimonio e il periodo di fidanzamento; infine ci sono i voti e il rito del matrimonio. Similmente, attraverso Gesù Dio ha esteso a noi non uno bensì una serie di progressivi inviti, chiamandoci in modo sempre più profondo ad un’intimità con lui. […]
Il Regno di Dio, dunque, è un invito divino che ci chiede di entrare, di dire “sì” e di partecipare al piano di condivisione di Dio.
(J. POWELL, Perché ho paura di essere pienamente me stesso, Milano, Gribaudi, 2002, 165).
Lo proclamo re perché ha dato la sua vita
Nessuno costrinse il ladrone, nessuno lo forzò, ma lui stesso disse all’altro: Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, ma lui non ha fatto nulla di male (Lc 23,40-41). E poi dice: Ricordati di me, nel tuo regno (Lc 23,42). Non ha osato dire: Ricordati di me, nel tuo regno prima di aver deposto attraverso la confessione il fardello dei suoi peccati. Vedi, cristiano, qual è il potere del riconoscimento del proprio peccato? Ha confessato di essere peccatore e ha aperto il paradiso; ha confessato e ha trovato il coraggio di chiedere il paradiso dopo tutti i suoi latrocini. Vedi quanti beni ci procura la croce? Pensi al regno? Che cosa vedi che gli sia simile? Vedi i chiodi e la croce, ma proprio questa croce, dice la Scrittura, è simbolo del regno. Per questo, quando vedo Gesù crocifisso, lo proclamo re. E proprio di un re morire per i suoi sudditi. Egli stesso ha detto: Il buon pastore da la sua vita per le pecore (Gv 10,11). Anche un buon re da la sua vita per i suoi sudditi. Io lo proclamo re perché ha dato la sua vita.
Ricordati di me, nel tuo regno. Vedi come la croce è simbolo del regno? Desideri un’altra prova? Il Signore non ha lasciato la sua croce sulla terra, ma l’ha presa e portata con sé in cielo. Come lo sappiamo? Perché l’avrà con sé quando ritornerà nella sua gloria. Impara quanto è degna di venerazione la croce che egli ha chiamato sua gloria […] Quando il Figlio dell’uomo verrà, il sole si oscurerà e la luna perderà il suo splendore (Mt 24,29). Il suo splendore sarà tale da oscurare anche gli astri più luminosi. Allora anche le stelle cadranno, allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell’uomo (Mt 24,29-30). Vedi quant’è potente il segno della croce!
[…] Quando un re entra in una città, i soldati lo precedono portando sulle loro spalle gli stendardi e annunciando il suo arrivo. Così quando il Signore discenderà dai cieli, lo precederà una schiera di angeli portando sulle loro spalle il segno della croce e annunciando la venuta del nostro re.
(GIOVANNI CRISOSTOMO, Sulla croce e sul ladrone 1,3-4, PG 49,403-404).
Preghiera
Troppe volte, Signore Gesù,
abbiamo rivolto il nostro cuore ad altri sovrani,
ai vari dominatori del mondo.
Troppe volte, dominati dall’ansia del futuro
e dall’angoscia del pericolo,
ci rivolgiamo ad altri «re».
Solo l’amore e la fiducia che ne deriva
liberano l’uomo dalla fobia
e dalla tirannia della sua presunzione.
Oggi, Signore, ci inviti ad alzare il capo
e a guardare nel tuo futuro.
Tu, Re di misericordia,
ricordati di noi nel tuo Regno,
facci percepire il palpito del tuo cuore.
Un mondo disgregato dalla diffidenza,
dal dubbio e dallo scetticismo
trova solo in te la salvezza.
Il tuo Regno non è fatto
di splendido isolamento,
ma di profonda solidarietà
con l’umanità redenta.
Il tuo Regno non impone diffidenza,
ma libera, salva, assicura speranza.
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana.
– Messalino festivo dell’assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
———
– M. FERRARI, monaco di Camaldoli, «Oggi si è adempiuta questa scrittura», Milano, Vita e Pensiero, 2013.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Seconda parte: Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla Risurrezione, Città del Vaticano, Liberia Editrice Vaticana, 2011.
– C.M. MARTINI, Incontro al Signore risorto. Il cuore dello spirito cristiano, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009.
PER L’APPROFONDIMENTO:
XXXIV DOM TEMP ORD (C) CRISTO RE (C)