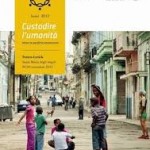Per Approfondire |
|||
|

Per Approfondire |
|||
|
Traguardi di competenza nell’IRC: progettazione e valutazione

Il Corso che l’Istituto di Catechetica dell’Università Pontificia Salesiana propone tende a mettere a fuoco le nuove dinamiche educative che si impongono nel rinnovamento della Scuola, nell’accentuazione delle competenze, secondo le Indicazioni Nazionali.
Una progettazione in grado di integrare correttamente le molteplici sollecitazioni educative che attraversano la scuola è la condizione dell’efficacia e della legittimazione dell’IRC attuale.
Il Corso, vuole garantire consapevolezza e padronanza al Docente di Religione nell’eser- cizio sereno della sua professionalità.
L’Incontro è organizzato ai sensi delle Direttive Ministeriali n. 305 (art. 2 comma 7) del 1 luglio 1996, n. 156 (art. 1 comma 2) del 26 marzo 1998.
Ai sensi dell’art. 14 comma 1, 2 e 7 del CCNL, rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento progettate e realizzate dalle Agenzie di Formazione riconosciute dal MIUR.
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Il Corso è finanziato dal MIUR.
Programma
Lunedì 16 dicembre
Pomeriggio
Martedì 17 dicembre
Pomeriggio
Mercoledì 18 dicembre
Pomeriggio
Dopo Cena
Giovedì 19 dicembre
Pomeriggio
Venerdì 20 dicembre
Pomeriggio
Sabato 21 dicembre
Note
Cf. www.rivistadipedagogiareligiosa.unisal.it
Vice-Direttore: Prof. Miroslaw Wierzbicki
SCARICA: SCHEDA DI ISCRIZIONE
Informazioni
Segreteria Istituto di Catechetica
Università Pontificia Salesiana
Piazza Ateneo Salesiano, 1
00139 ROMA
Tel 06 87290.651; 06 87290408
Fax 06 87290.354
Cell. 3898805612.
e-mail: catechetica@unisal.it
orario di ufficio:
9.00 -12.30 da Lunedì a Venerdì
Sede del Corso
Casa Domus Urbis
Opera don Guanella
Via della Buffalotta, 550
00139 Roma
Per giungere a Domus Urbis
1. Dalla Stazione Termini linea 90 – scendere fermata Adriatico/Lampedusa . Alla stessa fermata prendere la linea 86 (7 fermate) e scendere alla fermata Castellani/Bufalotta (Centro Commerciale Carrefour). A piedi 50 metri fino a Domus Urbis.
2. Dalla Stazione Termini prendere la Metro B1 e scendere a Piazza Conca d’Oro (fine corsa), uscire dalla parte di Via Martana. Prendere la linea 86 (Marmorale) per 13 fermate e scendere alla fermata Castellani/Bufalotta (Centro commerciale Carrefour).
Arrivo a Domus Urbis
Coloro che arrivano da fuori Roma possono giungere alla Sede del Corso domenica 15 dicembre nel pomeriggio.

La mafia uccide solo d’estate
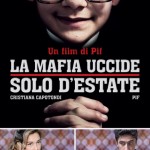
Le stragi di mafia? Ve le racconto io!
di Ermanno Giuca
Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, è noto al pubblico televisivo (in particolare quello giovanile) per il Testimone, programma televisivo in onda su Mtv, che lui stesso conduce. Con una semplice telecamera ed una massiccia dose di irriverenza, Pif realizza inchieste giornalistiche, intervistando personaggi celebri, intrufolandosi in eventi ufficiali o raccontando semplicemente storie che non sempre trovano spazio nelle prime pagine dei quotidiani.
Stavolta, però, il salto è stato decisamente ambizioso. Il conduttore siciliano decide di scrivere, dirigere e interpretare un film tutto suo perché, come racconta lui, «era necessario raccontare una mafia che non si identificasse solo nella figura tarchiata di Totò Riina, ma una mafia che abita nel nostro stesso condominio! Una mafia che frequentava anche la Palermo per bene».
“La mafia uccide solo d’estate“, è una sorta di autobiografia, dove Pif prova a raccontarsi con gli occhi del piccolo Arturo che vive la sua giovinezza nella Palermo degli anni ottanta, la stagione delle stragi di mafia. Mentre lui cerca di farsi notare da Flora, la compagna di classe di cui è innamorato, attorno a sé saltano in aria le vite del generale Dalla Chiesa, di Boris Giuliano, di Pio La Torre fino alle bombe di Capaci e di via d’Amelio del 1992.
Dopo l’incontro con un giornalista, affittuario della casa del nonno, decide che da grande vuole fare proprio quel mestiere. Chiede, cerca, indaga, ma l’unica risposta che riceve da chi lo circonda è che quelle morti sono solo “questione di femmine”. Ben presto, però, riuscirà a conquistare Flora e a baciarla, mentre attorno a loro si celebrano i funerali di Falcone e Borsellino.
Ironizzare sui mafiosi e umanizzare i giudici è stato uno dei primi obiettivi che il regista si è posto, perché «Paolo Borsellino non era un santo ma era uno come noi». E su questa scìa, carta vincente del film sono le crude scene degli attentati corredate da una colonna sonora rilassata, divertente, quasi da commedia. Una forma di racconto che rende ancora più drammatico tutto ciò a cui lo spettatore assiste.
Riuscire a trasmettere alle nuove generazioni la tragicità di quegli anni e farlo nel modo più leggero possibile: Pif c’è riuscito raccontando agli italiani parte della sua storia di palermitano. La storia di un bambino che non fa altro che guardarsi attorno. Per fortuna, però, è ancora inverno.
TRAILER
III DOMENICA DI AVVENTO

Prima lettura: Isaia 35,1-6a.8a.10
|
Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi». Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno via santa. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo; felicità perenne splenderà sul loro capo; gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. |
Il brano riporta uno dei più significativi oracoli messianici citati da Gesù per capire il senso delle sue “opere”. Appartiene alla così detta “piccola apocalisse” di Is 34-35 (la “grande apocalisse” è in Is 24-27), databile al tempo del ritorno dalla deportazione a Babilonia e della ricostruzione. Per rinfrancare i rimpatriati, alle prese con tante difficoltà materiali e ancora tentennanti nella fede e nella speranza, il profeta, col linguaggio allegorico proprio dell’apocalittica, descrive la sorte disastrosa di chi va contro Dio e la sorte gloriosa invece di chi sta nella sua alleanza: Is 34 annuncia la rovina di tutti i popoli ribelli a Dio, in particolare di Edom, complice dei distruttori (cf. Is 34,8 e Sal 136,7); Is 35 invece invita i reduci a esultare, per la nuova e meravigliosa realtà che stanno per sperimentare. Il brano liturgico riporta tutto Is 35, eccetto due versetti, e si può suddividere in due parti.
1. Splendida ripresa dell’ambiente, per opera di Dio (vv. 1-4). Al quadro desolante dei castighi al paese di Edom (Is 34), il profeta contrappone quest’altro gioioso, mirabilmente florido e bello, per Sion. Prima dipinge la ripresa rigogliosa della terra promessa, coi paragoni proverbiali del Libano e del Carmelo, allora splendidi e lussureggianti di vegetazione, gloria di Dio creatore. Poi prospetta la ripresa fisica e morale dei rimpatriati in tale ambiente: mani e gambe irrobustite, per lavorare sicuri e muoversi spediti, e superamento delle idee e dei sentimenti ancora incerti e timorosi per gli «smarriti di cuore». Dio stesso sta per tornare fra loro (cf. Is 40,10-11), conclude l’oracolo. Viene a “salvare”, nel duplice senso della liberazione e della salute piena. In questo modo viene con lui la “vendetta”, che è punizione per i deportatori e ricompensa per i liberati che tornano a lui. Essa a noi ripugna tanto, perché la pensiamo acida e sproporzionata come la nostra. Ma la vendetta divina, sia pure con linguaggio crudo, l’Antico Testamento la attende e la invoca da Dio onnisciente e infinitamente giusto e misericordioso (cf. Ger 1,20), intendendo sempre la sua giustizia. A compierla ora è il Dio dell’alleanza, il “Santo di Israele” che interviene come vindice (go’el) del suo popolo, per tirarlo fuori dalle difficoltà in cui è caduto e rimetterlo sulla strada della salvezza.
2. Ripresa interiore profonda del popolo di Dio (vv. 5-10). L’opera di salvezza nelle persone è preannunciata in tre momenti. Anzitutto una nuova vitalità: si apriranno gli occhi dei ciechi e le orecchie dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo e griderà di gioia il muto… Non più solo mani e ginocchia, ma tutte le membra e i sensi dell’uomo tornano integri. Si tratta in primo luogo dell’uscita dallo scoraggiamento e dal pessimismo, nel quale sono caduti i deportati (Is 42,18-23), e della capacità di percepire il germoglio della nuova realtà (Is 43,19): quindi una ripresa interiore, profonda, spirituale, prima che fisica. Ad essa soprattutto fa riferimento la risposta di Gesù al Battista, ampliandola ai lebbrosi guariti e addirittura ai morti risuscitati. Secondo momento è il riconoscimento della “Via santa”, quella da appianare nel deserto per il rimpatrio, rapido e sicuro, sulla quale si rivelerà la «gloria» di Dio liberatore (Is 40,3-5), frutto però di quella spirituale che riporta a camminare con Dio nella vita. Su questa il Battista riconosceva la sua missione (cf. Mt 3,3; Gv 1,23). E anche Gesù vi allude, con la buona novella ai poveri e la beatitudine per chi non trova inciampo nella sua proposta messianica (Vangelo). Terzo momento sarà la felicità perenne in Sion, per il popolo uscito dalla tristezza e dal pianto e ristabilito nella sua regalità.
Gli annunci profetici e le “opere” di Gesù dunque si pongono come “segni” di una realtà che sta nei risvolti più profondi dell’uomo e che si sviluppa nel futuro messianico della “salvezza”.
Seconda lettura: Giacomo 5,7-10
|
Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l’agricoltore: egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati; ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. |
Alla fine ormai della lettera, Giacomo fa le raccomandazioni per l’attesa della venuta del Signore, che già arriva in quanto va succedendo alle «dodici tribù in diaspora» (Gc 1,1 ), cioè al nuovo popolo di Dio pellegrino nella storia. Cerchiamo di cogliere questi aspetti di escatologia immanente.
1. L’imperativo iniziale «siate costanti», alla lettera sarebbe “siate magnanimi”, allargate la mente, e così sarete pazienti e tolleranti.
Vedi l’agricoltore (v. 7). La sua pazienza è tutt’altro che inerte e passiva: egli attende il prezioso frutto della terra dalle cure che vi prodiga, ma rafforza la sua speranza con la fiducia nelle piogge stagionali, dono di Dio.
Così i cristiani allarghino l’animo e irrobustiscano i cuori, riconoscendo che il Signore viene già quando affrontano le persecuzioni, vivono le rinunce e testimoniano la fede. E non si perdano in lagnanze reciproche, per non essere giudicati da colui che, dopo la prima venuta nella misericordia, torna piuttosto come giudice in quella intermedia e in quella finale: Ecco, vedi il giudice è alle porte (v. 9).
2. Un secondo imperativo invita a prendere come modelli di sopportazione dei mali e di grandezza d’animo i profeti. Il loro esempio non è generico, ma fatto di comportamenti e di motivazioni date dalla fede: per questo Giacomo specifica: «che hanno parlato nel nome del Signore». Sempre la pazienza cristiana è frutto della grandezza d’animo data dalla parola di Dio e della forza di sopportare, comunicata dalla grazia.
Vangelo: Matteo 11,2-11
|
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose Loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». Mentre quelli se ne andavano. Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Si, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». |
Esegesi
Il riconoscimento dell’identità di Gesù come Messia, da parte dei discepoli, avviene a Cesarea di Filippo, nei Sinottici, e verso di esso tende tutta la prima parte del loro racconto. Matteo e Luca inseriscono una tappa importante con l’episodio che si legge oggi, nel quale Gesù stesso indica gli elementi per riconoscerlo e a sua volta delinea l’identità dell’interlocutore Giovanni, che gli ha preparato la strada, come farà poi a Cesarea anche con Pietro, che continuerà la sua opera.
Il discorso sulle identità divide il brano in due parti.
1. La identità di Gesù (vv. 2-6). È o non è lui “il Veniente”? Il titolo accomuna il Messia con Dio (cf. Ap 1,4-5). Sono le sue “opere” a provocare la domanda del Battista. Lui lo aveva annunciato alla gente con la scure posta alla radice e il ventilabro in mano, per raccogliere nel granaio il suo grano e bruciare la pula nel fuoco inestinguibile, cioè come giudice ultimo di tutta la iniquità umana (cf. Mt 3,10-13). Gesù invece compie gesti pieni di misericordia, verso i malati e i peccatori, e fa discorsi tutti ispirati all’amore e alla condivisione, in particolare sulla montagna (Mt 5-7) e ai missionari (Mt 10).
Gesù non da una risposta diretta, ma invita i discepoli del Battista a fare discernimento sui prodigi che compie, con riferimenti al libro di Isaia, dove sono ricorrenti i temi del “vedere” e “ascoltare”. In esso, mentre il profeta dell’VII sec. a.C. era stato disilluso da Dio, sull’esito del ministero presso un popolo superficiale che non vede con gli occhi, non ode con gli orecchi e non comprende con il cuore (cf. Is 6,10), gli oracoli messianici dei suoi continuatori, nel VI sec. a.C., annunciano una prodigiosa riapertura degli occhi e degli orecchi (cf. Prima lettura). Usando le loro espressioni, Gesù vuole dire che sta realizzando i loro annunci e invita i discepoli del Battista a riferire quanto essi stessi avranno saputo ascoltare e vedere.
In questo modo egli presenta le sue “opere” non fine a se stesse, ma come “segni” di quanto va compiendo nella realtà più profonda. L’aveva già indicata nei singoli prodigi con le richieste della fede, che fa risorgere la vita dello spirito, e con la remissione dei peccati, che toglie l’ostacolo più grosso. Adesso l’ha sintetizzata con la frase «ai poveri è annunciato il vangelo», che un po’ riassume i prodigi elencati e i riferimenti a Isaia (cf. Is 61,1), ma più ancora indica il suo programma, proclamato sul monte con le beatitudini. Egli evangelizza i poveri (Mt 5,3-10), nel senso che valorizza loro, e non i ricchi e sazi, come base per costruire il regno di Dio. A quelle beatitudini ora ne aggiunge un’altra: beato chi non trova inciampo (scandalo) in lui per questa valorizzazione.
2. La identità del Battista (vv. 7-11). A scanso dell’equivoco possibile che sia anche lui a trovare inciampo, Gesù stesso prende l’iniziativa di delinearne la identità, tutt’altro che estranea alla propria. Fra tre ipotesi, ripetendo per tre volte la domanda: «che cosa siete andati a vedere nel deserto?». La prima ipotesi, una canna sbattuta dal vento, cioè un opportunista folle, è smentita dalla verità della terza. La seconda, un uomo in morbide vesti, cioè un facoltoso in cerca di potere, è smentita dallo stile del personaggio e dalle sue contestazioni agli uomini di palazzo.
La terza ipotesi, un profeta, non solo è vera ma dice ancora troppo poco. Assai più che profeta egli è il precursore del Messia, ne ha preparato la venuta. Non è quindi inciampo o scandalo il suo, ma bisogno di capire meglio l’intendimento di Gesù, sentito nel battesimo al Giordano, di adempiere «ogni giustizia» (Mt 3,14-15) cioè ogni disposizione divina sul Messia. Gli viene risposto che, per provocare le scelte fondamentali, egli usa la misericordia e la condivisione e non ancora il giudizio definitivo: sono criteri di discernimento per l’appartenenza a Dio assai più taglienti e profondi della scure, del ventilabro e di qualsiasi discriminazione violenta, perché costituiscono e non solo annunciano il regno dei cieli. In questo senso, chi entra nella costruzione del regno con lui è più grande del Battista, che pure supera tutti i profeti dell’umanità. In questo senso pure si può dire che le attese del Battista non sono smentite, ma portate a guardare più in profondità.
Meditazione
L’annuncio della venuta del Signore, la difficile arte dell’attesa del Veniente, la gioia che Colui che viene suscita: questi i temi salienti della III domenica di Avvento. Che affermano anche la non-evidenza della venuta del Signore. L’annuncio isaiano della venuta liberatrice del Signore raggiunge i figli d’Israele in una situazione di «tristezza e pianto» (Is 35,10); le opere che attestano che Gesù è il Messia, il Veniente, sembrano trascurare la «liberazione dei prigionieri» (Is 61,1; Lc 4,18) e sono narrate a Giovanni che è in prigione e vi troverà la morte (Mt 14,3-12); la comunità cristiana è confrontata con l’annuncio di una venuta del Signore che chiede un atteggiamento di sopportazione, fede, pazienza, simile a quello dell’agricoltore o dei profeti (II lettura), o di Giobbe (Gc 5,11). L’agricoltore attende un frutto che dipende da piogge che possono anche non venire; i profeti hanno parlato e agito in nome di Dio suscitando spesso ostilità e rifiuto; Giobbe ha perseverato nei dolori, nel non-senso, facendo della sua attesa una lotta drammatica. Così, l’attesa del Signore si tinge della tinta della pazienza.
La pazienza è l’arte di vivere l’incompiutezza e la parzialità. La preghiera ebraica che recita: «Io credo con fede piena e perfetta alla venuta del Messia e, benché tardi, io l’attendo ogni giorno» esprime bene l’idea di pazienza insita nell’attesa. Dietro quel «benché tardi» vi è la drammaticità dell’incompiuto e dell’irredento sperimentati nel quotidiano. La pazienza è necessaria per chi vive nella storia l’attesa del Regno: essa si declina come pazienza nei confronti di Dio, della chiesa e di se stessi. Nei confronti di Dio, perché Dio non ha ancora adempiuto, per sempre e per tutti, le promesse di guarigione dei ciechi e degli zoppi, dei muti e dei sordi, le promesse di salvezza dal male, dal peccato, dalla morte; nei confronti della chiesa, perché la comunità cristiana spesso si mostra inadempiente rispetto alle esigenze evangeliche; nei confronti nostri, perché scopriamo in noi inadeguatezze e difformità rispetto alla nostra vocazione. La pazienza è «forza nei confronti di se stessi» (Tommaso d’Aquino), capacità di non lasciarsi andare all’abbattimento, alla tristezza, alla disperazione. E questo grazie al fatto che la pazienza è sguardo in grande (makrothymía) sulla realtà, su Dio, sulla chiesa, su noi stessi. La pazienza è grandezza d’animo e si concretizza nell’amore: «l’amore pazienta» (1 Cor 13,4).
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro?» (Mt 11,3). La domanda del Battista indica non solo che la fede è traversata dal dubbio, ma che il dubbio può affinare la fede e ridurre la distanza tra l’immagine del Signore che il credente nutre e il Signore stesso nel suo rivelarsi. Per il Battista la fede in Gesù Messia cessa di essere una verità evidente e, da certezza granitica predicata a gran voce, diviene domanda sussurrata. Anche la fede, la nostra personale fede, ha una storia. E anche la nostra fede non è solo luce, ma luce e buio, luce nel buio, e conosce zone grigie.
Certamente significativo è il fatto che il Battista si rivolga a Gesù stesso ed esponga a lui la sua domanda. La domanda di fede non spegne l’amore, anzi, Giovanni si rimette a ciò che Gesù stesso gli dirà: «Sei tu…?». Più che mai la fede appare qui come affidamento personale. L’amore purifica la fede, la rende sempre più relazione tra viventi.
Nel deserto come nella prigione, nella predicazione autorevole come nella domanda umile, Giovanni continua ad attendere il Veniente. Giovanni è l’uomo dell’attesa, ovvero l’uomo che vive sotto il segno della grazia: la vita che ha ricevuto per grazia da Dio nel passato (Giovanni significa «il Signore fa grazia»; cfr. Lc 1), egli la attende come grazia dal futuro attenendo nell’oggi il Messia veniente. E proprio la sua attesa apre i luoghi di morte e di chiusura che sono il deserto e la prigione, alla vita e alla libertà. La sua attesa diviene speranza per le folle che andavano a lui nel deserto e per i discepoli che andavano a trovarlo in prigione. L’attesa cristiana della venuta del Signore è dono di speranza per gli uomini.
Preghiere e racconti
La fede è possedere quello che si spera soltanto
Nelle mie riflessioni sulla fede ho incontrato una pagina di un documento che i cristiani riconoscono come “parola di Dio”: il capitolo 11 della Lettera che un autore anonimo ha scritto due mila anni fa agli Ebrei per mostrare che Gesù di Nazaret è proprio quel salvatore che loro stavano aspettando. […] Il capitolo si apre con una definizione di fede, tanto originale quanto simpatica: “La fede è un modo di possedere già le cose che si sperano, di conoscere già le cose che non si vedono” (Eb 11,1).
Nei fatti della nostra vita ci sono delle cose che si vedono e ce ne sono molte altre che invece restano nascoste. Di solito, è facile distinguere tra ciò che si vede. Vedo l’amico che è fisicamente presente vicino a me. Posso sentire la sua voce, gioire (o rammaricarmi) della sua presente. Questa non è l’unica possibile. Altre persone sono vicine anche se, in questo momento, non lo sono fisicamente. Non le possiamo vedere, se non con gli occhi dell’amore e della fantasia. In questi casi è chiaro ciò che si vede e ciò che non si vede.
Il gioco tra ciò che si vede e ciò che non si vede, suggerito dalla definizione di fede della Lettera agli Ebrei, non va inteso come la differenza tra un amico che sta fisicamente vicino a te ed un altro, egualmente simpatico, che non è in questo momento vicino fisicamente.
In un avvenimento e in una persona, possiamo vedere ciò che, in qualche modo, può essere toccato con mano. Riconoscimento però che non finisce tutto lì. In una persona amara c’è un mistero, grande e profondo, che tutta l’avvolge. Questa realtà invisibile e misteriosa è tanto decisiva da avvertire la persona stessa in un modo specialissimo.
Quello che non si vede diventa la categoria attraverso cui impostiamo il nostro giudizio e il nostro rapporto con quello che si vede. […]
La definizione di fede che ho riportato dalla Lettera agli Ebrei parte da questa situazione e aggiunge: la fede è quell’atteggiamento che permette di vedere anche quello che non si vede, fino al punto di valutare ed esprimere quello che si vede dalla parte di quello che non si vede.
Un piccolo particolare non dovrebbe sfuggirci. La definizione di fede riportata contiene una ripetizione. Apparentemente le due frasi dicono, con parole diverse, la stessa cosa. C’è però una sottolineatura originale: le cose che non si vedono sono “sperate”… e cioè attese, desiderate, ricercate. La voglia di verità porta a scavare in quello che si vede per arrivare a mettere le mani, con gioia, sul mistero che si portano dentro.
(Riccardo TONELLI, Vivere di Fede in una stagione come è la nostra, Roma, LAS, 2013, 17-19)
Bellezza oltre ogni descrizione
Uno dei romanzi più noti di André Gide (1869-1951) s’intitola La sinfonia pastorale. Il libro è ambientato nella Svizzera di lingua francese negli anni Novanta (1890) e narra la storia di una complessa relazione fra un pastore protestante e Gertrude, una ragazza cieca dalla nascita.
Di particolare interesse è il modo in cui il pastore prova a comunicare a Gertrude cose come la bellezza dei prati alpini, trapuntati di fiori dai colori sgargianti, e la maestà delle montagne dalle cime innevate. Egli prova a descrivere i fiori azzurri che crescono sulla riva del fiume paragonandoli al colore del cielo, ma deve rendersi subito conto che lei non può vedere il cielo per apprezzare il paragone. In questo suo lavoro egli si sente continuamente frustrato dalla limitatezza del linguaggio che usa per far conoscere la bellezza e lo stupore della natura alla giovane cieca. Ma le parole sono il solo strumento di cui dispone. Non può che perseverare sapendo di poter comunicare solo a parole una realtà che non può mai essere completamente espressa con parole.
Allora ecco un nuovo e insperato sviluppo. Un oculista della vicina città di Losanna ritiene che la ragazza possa essere operata agli occhi in modo da ottenere la vista. Dopo tre settimane trascorse nella casa di cura, ella torna a casa, dal pastore. Adesso può vedere e sperimentare da sola le immagini che il pastore aveva cercato di comunicarle solo attraverso le parole.
“Appena ho acquistato la vista – ella disse – i miei occhi si sono aperti su un mondo più stupendo di come avrei mai potuto sognare che fosse. Sì, davvero, non mi sarei mai immaginata che la luce del giorno fosse così brillante, l’aria così limpida e il cielo così vasto”.
La realtà sorpassa di gran lunga la descrizione verbale. La pazienza del pastore e le sue goffe parole non avrebbero mai potuto descrivere adeguatamente il mondo che la ragazza non poteva vedere da sola, il mondo che chiedeva di essere sperimentato piuttosto che meramente descritto.
Per il cristiano, il mondo presente contiene indizi e segnali di un altro mondo, un mondo che possiamo cominciare a sperimentare ora, ma che conosceremo nella sua pienezza solo alla fine.
(Alister Mc Grafth, Il Dio sconosciuto, Cinisello Balsamo, 2002, 35-37)
È buio dentro di me,
ma presso di te c’è la luce;
sono solo, ma tu non mi abbandoni;
sono impaurito, ma presso di te c’è l’aiuto;
sono inquieto, ma presso di te c’è la pace;
in me c’è amarezza, ma presso di te c’è la pazienza;
io non comprendo le tue vie, ma la mia via tu la conosci.
(Dietrich Bonhoeffer)
Il luogo dell’appuntamento
Dio e l’umanità sono come due amanti che hanno sbagliato il luogo dell’appuntamento. Tutti e due arrivano in anticipo sull’ora fissata ma in due luoghi diversi. E aspettano, aspettano, aspettano. Uno è in piedi inchiodato sul posto per l’eternità dei tempi. L’altra è distratta e impaziente. Guai a lei se si stanca e se ne va!
(Simone Weil)
Nell’attesa paziente
No, non è in tuo potere far aprire il bocciolo; scuotilo, sbattilo,
non riuscirai ad aprirlo.
Le tue mani lo guastano,
ne strappi i petali e li getti nella polvere,
ma non appare nessun colore e nessun profumo.
Ah! A te non è dato di farlo fiorire.
Colui che invece fa sbocciare il fiore, lavora semplicemente,
vi getta uno sguardo all’alba e la linfa della vita scorre nelle vene del fiore.
Al suo alito il fiore dispiega lentamente i suoi petali
e si culla lentamente al soffio del vento.
Come un desiderio del cuore, il suo colore erompe,
e il suo profumo tradisce un dolce segreto.
Colui che fa sbocciare veramente il fiore lavora sempre solo
semplicemente e silenziosamente.
(Poesia indiana)
La fede è speranza
Paolo […] dice ai Tessalonicesi: Voi non dovete “affliggervi come gli altri che non hanno speranza” (1 Ts 4,13).
Anche qui compare come elemento distintivo dei cristiani il fatto che essi hanno un futuro: non è che sappiamo nei particolari ciò che li attende, ma sanno nell’insieme che la loro vita non finisce nel vuoto. Solo quando il futuro è certo come realtà positiva, diventa vivibile anche il presente. Così possiamo ora dire: il cristianesimo non era soltanto una “buona notizia” – una comunicazione di contenuti fino a quel momento ignoti. Nel nostro linguaggio si direbbe: il messaggio cristiano non era solo “informativo”, ma “performativo”. Ciò significa: il Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose che si possono sapere, ma una comunicazione che produce fatti e cambia la vita. La porta oscura del tempo, del futuro, è stata spalancata. Chi ha speranza vive diversamente; gli è stata donata una vita nuova».
(BENEDETTO XVI, Spe Salvi, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2007, n.2).
L’incontro con Dio
«Per noi che viviamo da sempre con il concetto cristiano di Dio e ci siamo assuefatti ad esso, il possesso della speranza, che proviene dall’incontro reale con questo Dio, quasi non è più percepibile. L’esempio di una santa del nostro tempo può in qualche misura aiutarci a capire che cosa significhi incontrare per la prima volta e realmente questo Dio. Penso all’africana Giuseppina Bakhita, canonizzata da Papa Giovanni Paolo II. Era nata nel 1869 circa – lei stessa non sapeva la data precisa – nel Darfur, in Sudan. All’età di nove anni fu rapita da trafficanti di schiavi, picchiata a sangue e venduta cinque volte sui mercati del Sudan. Da ultimo, come schiava si trovò al servizio della madre e della moglie di un generale e lì ogni giorno veniva fustigata fino al sangue; in conseguenza di ciò le rimasero per tutta la vita 144 cicatrici. Infine, nel 1882 fu comprata da un mercante italiano per il console italiano Callisto Legnani che, di fronte all’avanzata dei mahdisti, tornò in Italia. Qui, dopo “padroni” così terribili di cui fino a quel momento era stata proprietà, Bakhita venne a conoscere un “padrone” totalmente diverso – nel dialetto veneziano, che ora aveva imparato, chiamava “paron” il Dio vivente, il Dio di Gesù Cristo. Fino ad allora aveva conosciuto solo padroni che la disprezzavano e la maltrattavano o, nel caso migliore, la consideravano una schiava utile. Ora, però, sentiva dire che esiste un “paron” al di sopra di tutti i padroni, il Signore di tutti i signori, e che questo Signore è buono, la bontà in persona. Veniva a sapere che questo Signore conosceva anche lei, aveva creato anche lei – anzi che Egli la amava. Anche lei era amata, e proprio dal “Paron” supremo, davanti al quale tutti gli altri padroni sono essi stessi soltanto miseri servi. Lei era conosciuta e amata ed era attesa. Anzi, questo padrone aveva affrontato in prima persona il destino di essere picchiato e ora la aspettava “alla destra di Dio Padre”. Ora lei aveva “speranza” – non più solo la piccola speranza di trovare padroni meno crudeli, ma la grande speranza: io sono definitivamente amata e qualunque cosa accada – io sono attesa da questo Amore. E così la mia vita è buona. Mediante la conoscenza di questa speranza lei era “redenta”, non si sentiva più schiava, ma libera figlia di Dio».
(BENEDETTO XVI, Spe Salvi, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2007, n.3).
«Il tempo si è fatto breve»
È scritto: «La speranza prolungata fa male al cuore»; ma benché sia stanca per la dilazione del desiderio, tuttavia è sicura della promessa. Sperando in essa e ponendo in essa ogni mia attesa, aggiungerò speranza a speranza (…).
Signore Gesù, ti siano rese grazie. Io, una volta per tutte, ho fatto affidamento alle tue promesse. Tuttavia «vieni in aiuto alla mia incredulità», perché, dimorando là, immobile, io ti attenda sempre, finché veda ciò che credo. Sì, io credo di «poter contemplare la bontà del Signore nella terra dei vivi». E tu, lo credi? Allora il tuo cuore si fortifichi ed attenda con pazienza il Signore. Se egli richiede una lunga pazienza, altrove promette di tornare presto. Da una parte vuole educarci alla pazienza, dall’altra confortare gli scoraggiati.
«Il tempo si è fatto breve», soprattutto per ciascuno di noi, benché sembri lungo a chi si consumi, sia per il dolore, sia per l’amore».
(GUERRICO D’IGNY, Sermoni per l’avvento del Signore, 1, 3-4).
Preghiera
«Beato chi non si scandalizzerà di me»: sostieni la nostra fede, Signore Gesù, quando è tentata di scandalizzarsi per la tua ‘debolezza’.
Donaci la convinzione e la sapienza che animava il tuo apostolo Giacomo: egli, che ben conosceva le grandiose promesse di Isaia, ha creduto che tu le hai realizzate, anche se nulla sembrava apparentemente cambiato nel mondo, dopo il tuo passaggio.
Dona anche a noi la pazienza dell’agricoltore, per seminare speranza.
Fa’ che accogliamo con riconoscenza il tuo vangelo di gioia, la buona notizia per i poveri e insegnandoci la pazienza; edifica in noi una fede forte.
Donaci la beatitudine di essere tuoi discepoli, la tua stessa gioia, la gioia del Padre nel fare del bene, anche quando ci toccasse di apparire perdenti.
Ravviva in noi la memoria dei benefici ricevuti, perché possiamo deciderci ancora oggi per il tuo vangelo e perché, anche quando non riconosciamo le tue vie, continuino come il Battista ad esserti fedeli.
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione. Omelie. Ciclo A, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2004- .
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– Sussidio Avvento-Natale 2013: «È tempo di svegliarvi dal sonno», a cura dell’Ufficio Liturgico Nazionale della CEI, 2013.
– Avvento-Natale 2010, a cura dell’ULN della CEI, Milano, San Paolo, 2010.
– E. Bianchi et al., Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche di Avvento e Natale, in «Allegato redazionale alla Rivista del Clero Italiano» 88 (2007) 10, 69 pp.
– J. Ratzinger/Benedetto XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.
– J. Ratzinger/Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– Don Tonino Bello, Avvento e Natale. Oltre il futuro, Padova, Messaggero, 2007.
PER L’APPROFONDIMENTO:
IMMACOLATA CONCEZIONE
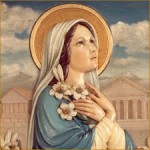
Prima lettura: Genesi 3,9-15.20
|
[Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frutto dell’albero,] il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici! Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. |
Poiché oggi è ammesso da tutti che i primi capitoli della Genesi non ci forniscono una cronaca di avvenimenti, ma contengono una professione di fede circa i rapporti dell’uomo e della sua storia con Dio, dobbiamo cercare di cogliere il messaggio religioso contenuto nella nostra lettura.
Essa contiene soprattutto l’annunzio di una prospettiva di salvezza per l’umanità rappresentata dalla prima coppia umana. L’annunzio è preceduto da un dialogo in cui Dio mette in evidenza l’effetto distruttore del peccato (la rottura del vincolo di dipendenza da Dio, suggerita dal serpente, che prometteva di far diventare gli uomini come Dio, se si fossero ribellati alle sue leggi): perdita del rapporto amicale con Dio, inizio della diffidenza reciproca tra l’uomo e la donna, ingresso della fatica e del dolore nella vita umana, necessità di lottare sempre contro l’insidia perenne del peccato.
L’annunzio apre la prospettiva che, nel futuro, il seme dell’uomo avrebbe sconfitto il seme del serpente. Il sentimento cristiano, guidato da una interpretazione libera di questo testo documentata dalla Volgata, ha capito che, in questa prospettiva di futura vittoria, un posto speciale spettava a Maria.
Seconda lettura: Romani 15,4-9
|
Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione, perché, in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull’esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri; le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: «Per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome». |
Le parole di Paolo sono improntate al tema dell’accettazione reciproca (v. 7) e sono rivolte ai cristiani di origine pagana per insegnare loro la vicendevole accoglienza con quelli di origine giudaica. Egli sta parlando a una comunità in cui convivono ‘forti’ e ‘deboli’ nella fede e ammonisce che tutto quanto il cristiano fa deve essere improntato all’accoglienza e all’edificazione reciproca.
Egli vuole che ci si impegni ad incrementarla per tre motivi, il primo dei quali è la parola delle antiche Scritture, la quale è nutrimento che sostiene la vita ordinaria del credente, le dona solidità e rende possibile la perseveranza nella speranza. Paolo sembra suggerire che chi è saldo nella speranza sa anche accettare i limiti propri e degli altri, con pazienza.
In secondo luogo bisogna sempre tenere presente l’esempio di Cristo: il principio ispiratore della sua vita non è il suo personale piacere; fedele invece alla missione di rivelare l’amore del Padre, non si è sottratto ad essa quando si è trattato di sopportare le reazioni violente degli uomini che lo hanno crocifisso. Come ultima ragione non si deve dimenticare che i pagani sono stati accolti da Cristo stesso. Ebreo, figlio del suo popolo, egli è stato il segno vivente della fedeltà di Dio alle promesse, ma insieme ha manifestato la misericordia di Dio anche ai non ebrei perché tutti potessero unirsi nella sua lode.
Vangelo: Luca 1,26-38
|
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. |
Esegesi
Tra i testi del Nuovo Testamento che ci parlano di Maria, la madre del Salvatore, il racconto dell’Annunciazione di Gesù è certamente il più ricco di teologia, sicché ad esso si è sempre ispirato lo speciale settore dell’approfondimento teologico che è detto mariologia. Cerchiamo di cogliere questa ricchezza, partendo dall’analisi esegetica dei singoli versetti.
Nei vv. 26-27, l’evangelista stabilisce un rapporto di netta continuità tra il già descritto annuncio della nascita del precursore (Lc l,5ss) e la scena che si accinge a descrivere: ogni singolo avvenimento della storia della salvezza si inquadra perfettamente in un disegno generale concepito e realizzato da Dio. In questo disegno si fronteggiano la grandezza insondabile di Dio, che manda come suo messaggero l’angelo Gabriele (un personaggio a cui nel libro di Daniele era stata affidata una missione riguardante gli avvenimenti messianici), e la piccolezza apparentemente insignificante di Nazareth di Galilea e di una oscura fanciulla che si chiama Maria, promessa sposa di un certo Giuseppe (solo in quest’ultimo personaggio c’è un barlume di riconosciuta nobiltà, perché discende dalla cosa di Davide).
Di Maria è qui sottolineato per ben due volte lo stato di verginità. Per Giuseppe è richiamata la sua appartenenza alla cosa di Davide, da cui doveva venire il Messia.
— Nel v. 28, il saluto dell’angelo, chàire, non è un semplice sinonimo del comune shalom (pace), ma sembra voglia evocare l’accenno alla gioia messianica a cui nei profeti è invitata la figlia di Sion (che significa la nazione ebraica), nell’imminenza dei tempi messianici (Sof 3.14; Gl 2,21.23; Zac 9.9). Il titolo kecharitoméne, con cui Maria è gratificata dall’angelo, non ha certamente il senso di un gentile appellativo (equivalente a una bella fanciulla!), ma sembra si voglia riferire alla missione che a lei Dio vuole affidare e si può ben tradurre: trasformata dal favore divino; la traduzione della Volgata, piena di grazia, rende giustizia alla densità teologica del vocabolo e ha indotto il popolo cristiano a trovare qui incluso un accenno alla verità dell’immacolata concezione. A quella stessa missione sembra debba riferirsi la frase il Signore è con tè; era questa infatti la formula con cui si dava incoraggiamento, nei libri dell’Antico Testamento, ai personaggi scelti da Dio per una qualche missione speciale (Isacco, in Gn 26,3.24; Giacobbe in Gn 28,15; Mosè, in Es 3,12; Gedeone, in Gdc 6,12; ecc.).
— Nel v. 29, il turbamento di Maria, diversamente da quanto è detto per Zaccaria in 1,12, non deriva dalla visione dell’angelo, ma dal senso delle sue parole: Maria dimostra così la sua iniziale consapevolezza di trovarsi davanti a qualcosa di misterioso.
— Nei vv. 30-31, l’angelo, dopo averle rivolto un incoraggiamento, rivela a Maria la missione che Dio vuole affidarle: con parole che richiamano alla mente il testo di Is 7,14, le è detto che essa dovrà dare alla luce un figlio del quale Dio stesso ha già stabilito il nome. L’importanza di questo figlio è già oscuramente accennata nell’implicito riferimento al testo di Isaia e nel fatto che il suo nome è direttamente scelto da Dio.
— Nei vv. 32-33, è dichiarata apertamente la straordinaria identità del futuro figlio di Maria. Questo figlio è descritto con chiaro riferimento al testo di 2Sam 7,8-16: da lì sono presi i termini grande… figlio (di Dio) …cosa… regno (i Davide) …regno senza fine. Il figlio di Maria è qui qualificato come il Messia atteso dai Giudei, ma già il senso delle parole adoperate in ambiente giudaico sembra dilatarsi per accogliere la nuova prospettiva cristiana.
— I vv. 34-35 difficilmente potrebbero spiegarsi, se si intendessero come battute stenografiche di un dialogo tra l’angelo e Maria. Sono però chiarissimi nel trasmetterci il messaggio rivelato che il figlio di Maria è stato concepito verginalmente, cioè senza il contributo di un padre terreno, e che questo stesso figlio di Maria è propriamente figlio di Dio fin dalla sua origine, cioè non in conseguenza della sua elezione alla dignità messianica, ma, grazie alla potenza creatrice dello Spirito Santo, fin dal momento della sua prodigiosa concezione.
— Nei vv. 36-37, l’angelo conferma l’eccezionalità dell’avvenimento annunziato, fornendo un segno capace di renderlo credibile: rivela a Maria la notizia ancora sconosciuta da tutti, che la sterile Elisabetta è diventata feconda nella sua vecchiaia, a dimostrazione che nulla è impossibile a Dio.
— Nel v. 38, che conclude il racconto, l’evangelista ci fa capire che Maria ha pienamente inteso l’alta missione che le è stata affidata, al punto che mette sulle sue labbra parole evocanti alte personalità dell’Antica Alleanza (Abramo, Mosè, Davide, il misterioso Servo di JHWH), che avevano meritato il titolo onorifico di servi del Signore. Proclamandosi serva di Dio, Maria è ben lontana dall’esprimere una semplice rassegnazione a oscuri disegni divini, dichiara piuttosto di essere gioiosamente pronta a collaborare alla imminente salvezza del mondo portata dal suo figlio Gesù.
Dall’esame analitico dei singoli versetti emerge la conclusione che il racconto di Luca ha come scopo principale quello di rivelarci l’identità messianica del figlio di Maria, che però è anche, a titolo specialissimo, figlio di Dio sin dalla sua concezione. In secondo luogo, il racconto ci parla della missione affidata a Maria, sottolineando soprattutto due cose: che l’iniziativa di quanto dovrà accadere appartiene esclusivamente a Dio; che lo stesso Dio ha reso Maria idonea all’assolvimento del compito affidatele mediante la pienezza di grazia. In questa pienezza, il popolo cristiano ha sentito che doveva starci anche l’Immacolata Concezione.
Meditazione
La liturgia della Parola di questa solennità ci offre nel versetto al salmo responsoriale (Sal 97) una particolare angolatura contemplativa per accostare il mistero celebrato: «Abbiamo contemplato o Dio le meraviglie del tuo amore». L’atteggiamento suscitato da questa parola ci invita a rileggere i testi della Scrittura, e in particolare il racconto di Lc 1,26-38, collocandoci in uno spazio di meraviglia, che nello stesso tempo è spazio di silenzio, di sguardo, di riconoscenza, di gioia. Di fronte a Colui che «ha compiuto meraviglie… ha fatto conoscere la sua salvezza. .. si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele» (Sal 97,1-3), il credente non può che stupirsi e con questo atteggiamento accostarsi a quel momento misterioso della storia di salvezza che rivela e porta a compimento il dise-gno di amore di Dio su tutta l’umanità.
È l’evento che si realizza in una ragazza di Nazaret, Maria, che dal messaggero di Dio è salutata con queste inaudite parole: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te» (Lc 1,28). In questa donna trovano così spazio gioia, sovrabbondanza e totalità di grazia, presenza di un Dio che salva e usa misericordia. E tutto questo è adombrato in un silenzioso dialogo tra quel Dio che si rivela nella sua Parola e quella umile donna che fa spazio, in un ascolto di fede radicale, a quella Parola che finalmente in lei può prendere un volto. Noi conosciamo qualcosa di questo miste-rioso incontro nel racconto dell’evangelista Luca. Forse ciò che ci viene trasmesso da questa narrazione è troppo poco per decifrare un mistero, ma sicuramente è molto per lasciarci stupire da esso.
E un primo tratto di questo racconto che in noi desta meraviglia, è il fatto che Dio dialoga con Maria. «Maria non è la semplice destinataria passiva della rivelazione riguardante il Figlio. Il suo è un ruolo attivo, di partner, nel contesto immediato, partner dell’angelo del Signore, ma, in realtà, partner di Dio stesso, che ha voluto far dipender la realizzazione del suo progetto dal libero consenso che Egli sollecitava dalla sua fede» (J. Dupont). Maria dialoga con l’angelo, intervenendo per capire e per maturare nell’adesione a ciò che le viene detto. La forza di questa parola dia-logica, che apre allo sguardo di Maria il mistero di un Dio che sceglie di parlare all’uomo, coinvolge completamente questa donna e, entrando in lei, si trasforma in carne: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38).
Ma è sorprendete il fatto che anche all’inizio della storia della salvezza, quella storia drammaticamente segnata da una rottura (cfr. Gen 3,1-16), permanga intatto un dialogo tra Dio e l’uomo. E nelle parole che Dio rivolge al primo uomo e alla prima donna rimangono misteriosamente uniti la sofferenza di una fiducia tradita e il desiderio di continuare ‘diversamente’ una relazione di amore e di alleanza. È come se Dio, in questo dialogo, guardasse molto lontano, ad un compimento: «Io porrò inimicizia – dice al serpente – tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno» (Gen 3,15).
E la liturgia, nella sua sapiente lettura della storia sacra, accosta, proprio per questa festa, questi due dialoghi ‘originari’: il dialogo tra Dio e il primo uomo, dialogo profondamente segnato dal dramma del rifiuto, e il dialogo tra l’angelo e una donna, Maria, nell’orizzonte di un cammino carico di novità e di pienezza. E si rimane colpiti dalle risonanze tra questi due dialoghi, pur lontani e diversi, ma racchiusi ambedue dalla nostalgia di un Dio che cerca nell’uomo un volto in cui riflettere tutta la sua bellezza e la sua misericordia, che non si rassegna a perdere la sua creatura più preziosa, che gli va incontro con volto amico. Questa parola che Dio rivolge all’uomo è l’unica che può strappare l’uomo dal nulla, creandolo e chiamandolo alla vita, ed è l’unica che può rompere il silenzio e il mutismo in cui l’umanità si è racchiusa, ridando ad essa la possibilità di un dialogo. «Dove sei?» (Gen 3,9): ecco la parola rivolta all’uomo dopo che egli ha distolto il volto dal suo Dio. E solo Dio può porre questa domanda che certamente brucia come una ferita nel cuore dell’uomo che la ode, ma che permette all’uomo di riprender quel cammino, faticoso e doloroso, alla ricerca del volto di Dio. «Dove sei?»: Quale è il luogo in cui l’uomo ha scelto di abitare nella sua libertà? Dove lo ha condotto il suo cammino, la sua pretesa di possedere, di usurpare il luogo in cui solo Dio può abitare? «Cerca Dio – ammonisce un anziano monaco del deserto – ma non cercare dove dimora». L’uomo ha cercato il volto di Dio, si è collocato con umiltà davanti al suo sguardo, ha accettato che Dio solo potesse dargli un luogo dove dimorare, oppure ha preteso di invadere la dimora stessa di Dio, sostituirsi a lui nel suo luogo santo? «Dove sei?… Ho udito la tua voce nel giardino: avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto» (Gen 3,10). La risposta di Adamo è la risposta dell’uomo, dell’umanità, che non sa più dove si trova: ha cacciato Dio dalla sua dimora, si è messo al suo posto e ora è senza fissa dimora, fugge, non riesce più a collocarsi e a leggersi in uno spazio donato (quel simbolico giardino in cui tutto gli era offerto gratuitamente). Il suo disagio, la sua fragilità e il suo smarrimento di fronte ad un luogo che sente di aver violato, si trasformano in paura. Sente quel passo di Dio che si avvicina come minaccioso, ingombrante, oppressivo, come il passo di un conquistatore che viene a riprendere il luogo del suo possesso. E quel luogo, in cui l’uomo abitava con Dio, quel luogo di Dio in cui l’uomo era chiamato ad entrare per pura grazia, e non per diritto e possesso, da spazio di prossimità e comunione, si trasforma in abisso di lontananza, pieno di incognite e di angoscia. L’unico luogo in cui l’uomo sente di poter ricevere sollievo è quello in cui può nascondere il suo volto, la sua nudità. L’uomo ha perso la sua vicinanza con Dio, ma ha anche perso la vicinanza con se stesso. Il volto di Dio riflesso nel suo stesso volto provoca all’uomo l’angoscia del fallimento e della fine: «Ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto» (v. 10).
«Dove sei?». Questa domanda rivolta da Dio al primo uomo e alla prima donna è come una eco che attraversa tutta la storia dell’umanità, risuonando nel cuore di ciascuno. Con essa Dio misteriosamente continua a chiamare l’uomo a sé, suscitandogli il desiderio e la nostalgia di un ritorno. Finché, in una casa della Galilea, questa domanda riceve finalmente la risposta che Dio si attendeva: «Dove sei?» […] «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38). La risposta di Maria è la riposta di una umanità libera, che ha accolto radicalmente la sua nudità e l’ha collocata davanti a Colui che ha la delicatezza di avvolgere con il suo sguardo di compassione tutto ciò che l’uomo sente come fragilità e debolezza (cfr. Lc 1,48).
«Dove sei?… Eccomi…»: è la risposta di chi non teme più nulla, di chi, disarmato, si presenta davanti a Colui al quale nulla è impossibile (cfr. Lc 1,37); la risposta di chi accetta un cammino di obbedienza a quella parola che, sola, conosce il mistero dell’uomo e che richiede la radicalità della fede. -Eccomi- è la risposta dell’uomo che getta tutte le maschere dietro le quali vuol nascondere il suo volto e si scopre vero davanti a Colui che è prossimità: «il Signore è con te» (1,28).
«Dove sei?». La risposta di Adamo è quella dell’uomo che fugge e si nasconde da Dio, dell’uomo che si nascondono di fronte a se stesso ed alla sua responsabilità; la risposta di Maria è quella di chi accetta di stare vicino a Dio così come si è, assumendo in pieno la propria libertà, sapendo che tutta la propria esistenza è oggetto di pura grazia; e stando vicino a Dio, in questo luogo, e non altrove, scopre la misura di quella pace che annulla ogni timore ed angoscia, la misura di quel passo leggero che come soffio trasforma e rende nuova ogni creatura. Maria non ha paura del passo di Dio; sa che esso ha il ritmo dello Spirito, il ritmo dell’amore.
«Dove sei?… Eccomi sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto».
Preghiere e Racconti
Il mistero dell’Immacolata Concezione di Maria, che oggi solennemente celebriamo, ci ricorda due verità fondamentali della nostra fede: il peccato originale innanzitutto, e poi la vittoria su di esso della grazia di Cristo, vittoria che risplende in modo sublime in Maria Santissima.
L’esistenza di quello che la Chiesa chiama “peccato originale” è purtroppo di un’evidenza schiacciante, se solo guardiamo intorno a noi e prima di tutto dentro di noi. L’esperienza del male è infatti così consistente, da imporsi da sé e da suscitare in noi la domanda: da dove proviene? Specialmente per un credente, l’interrogativo è ancora più profondo: se Dio, che è Bontà assoluta, ha creato tutto, da dove viene il male? Le prime pagine della Bibbia (Gn 1-3) rispondono proprio a questa domanda fondamentale, che interpella ogni generazione umana, con il racconto della creazione e della caduta dei progenitori: Dio ha creato tutto per l’esistenza, in particolare ha creato l’essere umano a propria immagine; non ha creato la morte, ma questa è entrata nel mondo per invidia del diavolo (cfr Sap 1,13-14; 2,23-24) il quale, ribellatosi a Dio, ha attirato nell’inganno anche gli uomini, inducendoli alla ribellione. E’ il dramma della libertà, che Dio accetta fino in fondo per amore, promettendo però che ci sarà un figlio di donna che schiaccerà la testa all’antico serpente (Gn 3,15).
Fin dal principio, dunque, “l’eterno consiglio” come direbbe Dante ha un “termine fisso” (Paradiso, XXXIII, 3): la Donna predestinata a diventare madre del Redentore, madre di Colui che si è umiliato fino all’estremo per ricondurre noi alla nostra originaria dignità. Questa Donna, agli occhi di Dio, ha da sempre un volto e un nome: “piena di grazia” (Lc 1,28), come la chiamò l’Angelo visitandola a Nazareth. E’ la nuova Eva, sposa del nuovo Adamo, destinata ad essere madre di tutti i redenti. Così scriveva sant’Andrea di Creta: “La Theotókos Maria, il comune rifugio di tutti i cristiani, è stata la prima ad essere liberata dalla primitiva caduta dei nostri progenitori” (Omelia IV sulla Natività, PG 97, 880 A). E la liturgia odierna afferma che Dio ha “preparato una degna dimora per il suo Figlio e, in previsione della morte di Lui, l’ha preservata da ogni macchia di peccato” (Orazione Colletta).
Carissimi, in Maria Immacolata, noi contempliamo il riflesso della Bellezza che salva il mondo: la bellezza di Dio che risplende sul volto di Cristo. In Maria questa bellezza è totalmente pura, umile, libera da ogni superbia e presunzione. Così la Vergine si è mostrata a santa Bernadette, 150 anni or sono, a Lourdes, e così è venerata in tanti santuari. Oggi pomeriggio, secondo la tradizione, anch’io Le renderò omaggio presso il monumento a Lei dedicato in Piazza di Spagna.
(LE PAROLE DEL PAPA, BENDETTO XVI, ALLA RECITA DELL’ANGELUS, 08.12.2008).
«Rimase con lei circa tre mesi. Poi tornò a casa sua».
Il vangelo stavolta non dice se vi tornò «in fretta», come fu per il viaggio di andata. Ma c’è da supporlo. Da Nazaret era quasi scappata di corsa, senza salutare nessuno. Quell’incredibile chiamata di Dio l’aveva sconvolta. Era come se, improvvisamente, all’interno della sua casetta si fosse spalancato un cratere e lei vi camminasse sul ciglio in preda alle vertigini. E allora, per non precipitare nell’abisso, si era aggrappata alla montagna.
Ma ora bisognava tornare. Quei tre mesi di altura le erano bastati per placare i tumulti interiori. Vicino a Elisabetta aveva portato a compimento il noviziato di una gestazione di cui cominciava lentamente a dipanare il segreto. Ora bisognava scendere in pianura e affrontare i problemi terra terra a cui va incontro ogni donna in attesa. Con qualche complicazione in più. Come dirglielo a Giuseppe? E alle compagne con cui aveva condiviso fino a poco tempo prima i suoi sogni di ragazza innamorata, come avrebbe spiegato il mistero che le era scoppiato nel grembo? Che avrebbero detto in paese?
Sì, anche a Nazaret voleva giungere in fretta. Perciò accelerava l’andatura, quasi danzando sui sassi. Oltretutto, su quei sentieri di campagna, vi si sentiva sospinta come dal vento, di cui, però, le foglie degli ulivi e i pampini delle viti non lasciavano percepire la brezza, nell’immota calura dell’estate di Palestina.
Per placare il batticuore, che pure tre mesi prima non aveva provato in salita, si sedette sull’erba.
Solo allora si accorse che il ventre le si era curvato come una vela. E capì per la prima volta che quella vela non si issava sul suo fragile scafo di donna, ma sulla grande nave del mondo per condurla verso spiagge lontane. Non fece in tempo a rientrare in casa, che Giuseppe, senza chiederle neppure che rendesse più esaurienti le spiegazioni fornitegli dall’angelo, se la portò subito con se. Ed era contento di starle vicino. Ne spiava i bisogni. Ne capiva le ansie. Ne interpretava le improvvise stanchezze. Ne assecondava i preparativi per un natale che ormai doveva tardare.
Una notte, lei gli disse: «Senti, Giuseppe, si muove».
Lui, allora, le posò sul grembo la mano, leggera come battito di palpebra, e rabbrividì di felicità.
Maria non fu estranea alle tribolazioni a cui è assoggettata ogni comune gestante. Anzi, era come se si concentrassero in lei le speranze, sì, ma anche le paure di tutte le donne in attesa. Che ne sarà di questo frutto, non ancora maturo, che mi porto nel seno? Gli vorrà bene la gente? Sarà contento di esistere? E quanto peserà su di me il versetto della Genesi: «Partorirai i figli nel dolore»?
Cento domande senza risposta. Cento presagi di luce. Ma anche cento inquietudini. Che si intrecciavano attorno a lei quando le parenti, la sera, restavano a farle compagnia fino a tardi. Lei ascoltava senza turbarsi. E sorrideva ogni volta che qualcuna mormorava: «Scommetto che sarà femmina».
Santa Maria, donna gestante, creatura dolcissima che nel tuo corpo di vergine hai offerto all’Eterno la pista d’atterraggio nel tempo, scrigno di tenerezza entro cui è venuto a rinchiudersi Colui che i cieli non riescono a contenere, noi non potremo mai sapere con quali parole gli rispondevi, mentre te lo sentivi balzare sotto il cuore, quasi volesse intrecciare anzi tempo colloqui d’amore con te.
Forse in quei momenti ti sarai posta la domanda se fossi tu a donargli i battiti, o fosse lui a prestarti i suoi.
Vigilie trepide di sogni, le tue. Mentre al telaio, risonante di spole, gli preparavi con mani veloci pannolini di lana, gli tessevi lentamente, nel silenzio del grembo, una tunica di carne. Chi sa quante volte avrai avuto il presentimento che quella tunica, un giorno, gliel’avrebbero lacerata. Ti sfiorava allora un fremito di mestizia, ma poi riprendevi a sorridere pensando che tra non molto le donne di Nazaret, venendoti a trovare dopo il parto, avrebbero detto: «Rassomiglia tutto a sua madre». Santa Maria, donna gestante, fontana attraverso cui, dalle falde dei colli eterni, è giunta fino a noi l’acqua della vita, aiutaci ad accogliere come dono ogni creatura che si affaccia a questo mondo. Non c’è ragione che giustifichi il rifiuto. Non c’è violenza che legittimi violenza. Non c’è programma che non possa saltare di fronte al miracolo di una vita che germoglia.
Mettiti, ti preghiamo, accanto a Marilena, che, a quarant’anni, si dispera perché non sa accettare una maternità indesiderata. Sostieni Rosaria, che non sa come affrontare la gente, dopo che lui se n’è andato, lasciandola col suo destino di ragazza madre. Suggerisci parole di perdono a Lucia, che, dopo quel gesto folle, non sa darsi pace e intride ogni notte il cuscino con lacrime di pentimento.
Riempi di gioia la casa di Antonietta e Marco, la quale non risuonerà mai di vagiti, e di’ ad essi che l’indefettibilità del loro reciproco amore è già una creatura che basta a riempire tutta l’esistenza.
Santa Maria, donna gestante, grazie perché, se Gesù l’hai portato nel grembo nove mesi, noi, ci stai portando tutta la vita. Donaci le tue fattezze. Modellaci sul tuo volto. Trasfondici i lineamenti del tuo spirito.
Perché, quando giungerà per noi il dies natalis, se le porte del cielo ci si spalancheranno dinanzi senza fatica sarà solo per questa nostra, sia pur pallida, somiglianza con te.
(Don Tonino Bello, Maria , donna dei nostri giorni, Cinisello Balsamo, San Paolo, 132000, 25-27)
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione. Omelie. Ciclo A, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2004- .
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– Sussidio Avvento-Natale 2013: «È tempo di svegliarvi dal sonno», a cura dell’Ufficio Liturgico Nazionale della CEI, 2013.
– Avvento-Natale 2010, a cura dell’ULN della CEI, Milano, San Paolo, 2010.
– E. Bianchi et al., Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche di Avvento e Natale, in «Allegato redazionale alla Rivista del Clero Italiano» 88 (2007) 10, 69 pp.
– J. Ratzinger/Benedetto XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.
– J. Ratzinger/Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– Don Tonino Bello, Avvento e Natale. Oltre il futuro, Padova, Messaggero, 2007.
PER L’APPROFONDIMENTO PERSONALE:

“Vivere, mai vivacchiare”. Lo ha chiesto il Papa incontrando gli universitari per i vespri di Avvento. Una “mente aperta” non si lascia “condizionare dall’opinione dominante” e nel “mondo globalizzato” .
Non spettatori ma protagonisti” nelle “sfide” del mondo contemporaneo. Non mediocri o annoiati, non omologati. “Non si può vivere senza guardare le sfide”, “non state al balcone, lottate per dignità e contro la povertà”. Questo lo stile di vita che il papa latinoamericano ha proposto ai giovani, celebrando nella basilica vaticana i vespri di Avvento, primo incontro con gli universitari degli atenei romani del suo pontificato.
“Vivere, mai vivacchiare”, ha detto, e “non lasciatevi rubare l’entusiasmo giovanile”. Gli studenti delle università romane, in particolare quelle pontificie, sono uno spaccato di giovani da diverse parti del mondo. Incontrandoli oggi, in un contesto liturgico e di preghiera, papa Bergoglio ha lanciato alcuni messaggi, sulla linea di altri incontri con i ragazzi, come, tra gli altri, quello con i giovani argentini, a Rio, nell’ambito della Giornata mondiale della gioventù. Tra l’altro, a braccio, ha inserito il richiamo a non vivere stando al balcone.
Erano presenti in basilica anche rettori e docenti di altri atenei italiani, cardinali, diverse autorità, tra cui il sindaco di Roma, Ignazio Marino. Papa Francesco ha chiesto agli universitari di ispirarsi non alla “sfera” che “livella sporgenze e differenze”, ma al “poliedro”, che rispetta la “molteplicità” e “l’unità nella varietà”. Non fatevi “rubare l’entusiasmo giovanile”, ha esortato, dovete “vivere, mai vivacchiare”, come disse Piergiorgio Frassati, ragazzo piemontese di una buona famiglia del Novecento, che per la Chiesa è oggi un beato.
“Il pensiero – ha spiegato il Pontefice – è fecondo quando è espressione di una mente aperta, che discerne, sempre illuminata dalla verità, dal bene e dalla bellezza: se non vi lascerete condizionare dall’opinione dominante, ma rimarrete fedeli ai principi etici e religiosi cristiani, troverete il coraggio di andare anche contro-corrente”. “La pluralità di pensiero e di individualità – ha affermato papa Francesco – riflette la multiforme sapienza di Dio quando si accosta alla verità con onestà e rigore intellettuale, così che ognuno può essere un dono a beneficio di tutti”.
Nel vivere coerentemente con il Vangelo, ha suggerito, “può essere di aiuto la bella testimonianza del beato Pier Giorgio Frassati, il quale diceva: ‘Vivere senza una fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere in una lotta continua la verità, non è vivere ma vivacchiare. Noi non dobbiamo mai vivacchiare, ma vivere'”. “Sapete cari giovani universitari – ha detto il Papa in un inserto a braccio – che non si può vivere senza guardare le sfide, senza rispondere alle sfide”. “Per favore, – ha raccomandato – non guardate la vita dal balcone, mischiatevi lì dove ci sono le sfide, la vita, lo sviluppo, la lotta per la dignità delle persone, la lotta contro la povertà, la lotta per i valori, e tante lotte che troviamo ogni giorno”.
Prima di iniziare i vespri, il Papa ha ascoltato con molta attenzione il saluto di un rettore – del quale non è stato fornito il nome nè l’ateneo di provenienza – che ha denunciato il fallimento della “meritocrazia” di fronte alla “legge del più forte”, ai “tagli” decretati dalla dittatura delle “agenzie di rating, della obbedienza alla finanza”. Il professore ha raccontato anche il caso di studenti che lavorano in nero per pagare gli studi all’unico fratello che la famiglia può mantenere all’università, e ha denunciato la “morte di un ceto medio”. In tale contesto, ha detto il rettore, è vitale il richiamo del Papa ai “valori”: “abbiamo bisogno – ha detto – del suo richiamo alla speranza e alla carità” e “ci verrà chiesto come abbiamo usato i talenti” senza cedere all'”utilitarismo immediato”.
Papa Francesco è sceso nella basilica vaticana intorno alle 17,30, ma prima del suo arrivo, a partire dalle 16, il vicario di Roma card. Agostino Vallini ha accolto la icona di Maria Sedes Sapientiae, patrona degli studenti universitari. Al termine dei vespri, l’icona di Maria Sedes Sapientiae viene consegnata dagli universitari brasiliani, – che l’avevano custodita per la celebrazione della Gmg di Rio durante l’anno della fede – a una delegazione di universitari francesi.
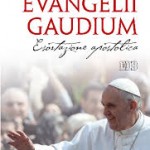
Questo documento è caratterizzato da un impeto missionario. Cosa la colpisce di più?
Innanzitutto lo stile: nuovo, immediato, profetico, che esprime una visione positiva della realtà. Poi l’invito molto bello alla gioia, termine che ricorre più volte nel testo. Negli orientamenti pastorali <+corsivo>Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia<+tondo> i nostri vescovi sottolineavano la necessità di dare a ogni azione una chiara connotazione missionaria. Ora il Papa ci sollecita a leggere tutto in chiave missionaria, anche le strutture stesse della Chiesa.
Questo significa che la missione oggi non ha che fare solo con i missionari…
Papa Francesco chiama in causa ogni battezzato, a prescindere dalla funzione che ha nella Chiesa e dal grado di istruzione della sua fede. La Chiesa tutta è chiamata a essere missionaria, a evangelizzare. Nel documento, che riprende le parole della <+corsivo>Redemptoris missio<+tondo> di Giovanni Paolo II l’attività missionaria è definita la «massima sfida». Bisogna prendere sul serio questo appello, che suona come un richiamo a un nuovo protagonismo di ogni cristiano.
Come si traduce in pratica la conversione pastorale di cui parla il Papa?
Tutto ciò che la Chiesa fa deve essere compiuto con un atteggiamento missionario. Con lo stile cioè di una Chiesa che va incontro, esce, si fa compagna di viaggio, testimonia, annuncia la misericordia di Dio, cerca di comunicare la bellezza del Vangelo. Senza proselitismi, senza imporre, ma portando agli altri ciò che è vero. Ricordando che in ogni azione bisogna partire dai poveri, che devono essere sempre privilegiati.
Come va cambiato il nostro modo di essere Chiesa?
L’annuncio deve concentrarsi su ciò che è essenziale, su ciò che è vero, più grande e più necessario. Il Papa chiede di avere uno stile semplice, quello descritto negli Atti degli Apostoli, tipico delle prime comunità cristiane. È questa la strada indicata da Francesco che ricorda come la pastorale in chiave missionaria non sia ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di insistere.
Francesco ci indica un esempio preciso: quello dei nostri missionari…
Dobbiamo imparare dal dinamismo e dall’audacia dei missionari. A più riprese il testo ricorda che nella Chiesa siamo tutti discepoli e missionari. La regola è quella benedettina dell’<+corsivo>ora et labora<+tondo>, della preghiera unita all’azione affinché la Chiesa sia sempre più madre. Che accoglie, si prende cura, annuncia la sovrabbondante misericordia di Dio.
Un’altra indicazione chiave è l’inculturazione…
L’annuncio deve essere espresso secondo le tradizioni e le culture in cui il Vangelo deve incarnarsi. Non a caso il Papa insiste molto sull’inculturazione, ed è bello che l’immagine scelta sia quella della sposa adornata di gioielli, come ricorda Isaia. Sia questa figura che il richiamo, fatto suo da Francesco, lanciato dai vescovi dell’Oceania ai missionari perché operino in armonia con gli indigeni ci ricordano la necessità di non dimenticare il contesto. L’esortazione mette poi in evidenza il valore della pietà popolare, cui abbiamo guardato forse con troppa diffidenza. Il Papa ne parla invece come del frutto di un Vangelo inculturato. Questo è un aspetto nuovo, da tenere in considerazione.
Il Papa ribadisce che è meglio avere una Chiesa accidentata piuttosto che aggrappata alle sue sicurezze…
Ci viene chiesto di osare. La Chiesa in uscita va incontro ai lontani, con più coraggio, prendendo l’iniziativa. Abbiamo tante testimonianze di missionari che hanno osato nuove strade per portare il Vangelo, anche a rischio della loro vita, e sono molti i martiri che hanno dato se stessi per annunciare Cristo. Il Papa ci invita a guardare a chi ha osato, per prendere l’iniziativa con audacia e dare maggior fervore all’evangelizzazione.