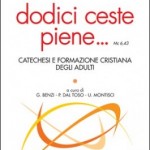Prima lettura: Isaia 42,1-4.6-7
|
Così dice il Signore: «Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole attendono il suo insegnamento. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano; ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre».
|
2 I Carmi del Servo di JHWH, di cui Is 42,1-4,67 è il primo, rappresentano una svolta nel messianismo biblico.
Le speranze d’Israele erano riposte, fino dall’esilio, nei successi, nelle conquiste, nei trionfi del discendente di David che avrebbe un giorno rialzate le sorti della nazione. Ma la dinastia davidica era finita a Babilonia e se n’erano perse le tracce; invece di far leva su un re, un conquistatore occorreva far tesoro della situazione disastrosa in cui ci si era venuti a trovare, accettando l’umiliazione come inviata da JHWH e tornare a lui, piegarsi, convertirsi. Bisognava lasciare a Dio la realizzazione dei suoi progetti e non affidarsi alle mani dell’uomo.
Il «Servo» è una figura totalmente nuova. Innanzitutto apolitica. È sempre un incaricato di Dio, uno cioè che egli ha scelto e al quale ha affidato un compito che non è quello di ristabilire le sorti d’Israele, ma far conoscere il diritto e le vie del Signore alle nazioni, alle genti, oltre che ai figli di Abramo.
Egli non avrà forze, armi; non lancerà bandi di guerra (sulle piazze), non calpesterà i deboli, ma sarà giusto e farà trionfare l’equità tra gli uomini. Non sarà un conquistatore ma un predicatore che farà pervenire la sua parola, i suoi messaggi di salvezza fino agli ultimi confini della terra (le isole più lontane).
Dio, il creatore del cielo e della terra, che ha tutto nelle sue mani, ha anche chiamato il suo Servo e l’ha colmato dei suoi doni, innanzitutto del suo Spirito e l’ha costituito «alleanza», cioè punto d’incontro tra JHWH e Israele, e «luce», cioè fonte di chiarezza di verità per i gentili, in modo che anch’essi escano dalle tenebre in cui si trovano avvolti.
Il I canto del Servo di JHWH è la pagina più evangelica dell’Antico Testamento.
Seconda lettura: Atti 10,34-38
|
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti.
Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui».
|
2 Il libro degli Atti allinea la conversione di Saulo, «chiamato a portare il nome del Signore ai popoli, ai re», oltre che ai «figli d’Israele» (9,15), con la «visione» a Pietro del lenzuolo con ogni sorta di animali, puri e impuri, diventati miracolosamente tutti commestibili (10,11-15).
Pietro è invitato a capire e ad accettare che il separatismo giudaico era finito e che i privilegi d’Israele erano cessati. Tutti gli uomini sono uguali davanti a Dio e chiunque pratica la giustizia è accetto a lui e fa parte del suo popolo. L’imparzialità divina era appena accennata nell’Antico Testamento (cf. Dt 10,17; Sap 6,8). È speciale messaggio proprio del Nuovo. Gesù è passato in mezzo ai propri simili facendo del bene a quanti ne avevano bisogno prescindendo dalla loro estrazione razziale.
L’esperienza profetica di Gesù è riportata al suo inizio, al momento del battesimo conferitegli da Giovanni. In quella circostanza egli è stato consacrato, alla lettera «unto con l’olio», in greco chriein (costituito «Cristo»), quindi «messo» scelto da Dio. Si tratta in pratica di una incombenza profetica ma che è stata accompagnata e convalidata dal potere dei miracoli che Gesù distribuirà indistintamente a quanti ricorreranno a lui.
Il battesimo è stato per Gesù un’investitura dello Spirito di Dio, l’abilitazione a promulgare la parola di salvezza (pace) per tutti, la capacità a riversare sugli uomini i doni del cielo, la salute del corpo e dell’anima.
Gesù, secondo l’autore degli Atti, nel battesimo non solo ha preso piena coscienza della sua vocazione, ma è stato insignito dei poteri o carismi necessari a farla valere e accogliere. È stato dichiarato, ma soprattutto si è trovato costituito messo di Dio sia a Israele che alle genti.
Vangelo: Matteo 3,13-17
|
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».
|
Esegesi
Il battesimo nel Giordano da parte di Giovanni è un evento significativo nella vita di Gesù. È il primo atto pubblico che egli compie da quando avverte la voce dello Spirito che lo chiama ad annunziare la buona novella ai poveri, a predicare a quanti attendevano l’anno di grazia del Signore (cf. Lc 4,18). Forse è anche la prima volta che si allontana dal suo villaggio, dalla Galilea e arriva fin alle foci del Giordano.
Lo scopo era far visita o conoscenza con un predicatore di penitenza che faceva tanto parlare di sé in tutta la regione. Matteo lo dice espressamente: «compare da Giovanni» (3,5). Marco «venne da Giovanni». Tutto fa pensare che Gesù aveva fatto tanta strada per ascoltare il profeta del deserto se non proprio per mettersi alla sua scuola. La frase «da Giovanni» è molto più significativa di quanto appaia.
Gesù aveva ascoltato la parola dei profeti nella sinagoga di Nazaret (cf. Lc 4,16). Era diverso però riascoltarla direttamente da un profeta vivente. Si dovrebbe pensare che anche Gesù è in ricerca della volontà di Dio o almeno di un approfondimento, di una chiarificazione della sua chiamata profetica. Infatti poco dopo l’evangelista ricorda il suo ritiro nel deserto, i quaranta giorni di digiuno e di preghiera, il confronto-scontro con il diavolo sempre per determinare la linea da percorrere nell’adempimento del suo mandato nel piano di Dio. Si può perciò ipotizzare che anche questa visita al predicatore del deserto, e forse agli altri asceti che sembra popolassero la zona (vedi i monaci di Qumràn), sia stata motivata dal desiderio o necessità di trovare una conferma alla «spinta» che sentiva nel suo animo a lasciare il lavoro di carpentiere e dedicarsi all’annunzio della parola di Dio.
Il soggiorno nel Giordano non fu un’esperienza inutile. Gesù non sceglierà né la strada di Giovanni, un predicatore chiuso nel suo recinto tutto proteso a intimorire o a spaventare la gente, né quella dei vicini esseni, pure essi ben segregati dal popolo; ma si metterà in cammino per le contrade della Galilea, insegnando, predicando e guarendo gli infermi che ricorrevano a lui. Sono i quattro verbi con cui Matteo caratterizza la sua attività missionaria (4,23). Gesù non starà ad aspettare la gente ma si muoverà incontro ad essa non per terrorizzarla, ma per liberarla dalle proprie afflizioni e soprattutto dalla paura di Dio, che non era tanto un giudice quanto un «padre» (Mt 6,9).
L’esperienza di Gesù nel Giordano, il confronto con Giovanni, ha creato qualche difficoltà ai predicatori cristiani delle origini, in particolare alla comunità di Matteo che si è sentita in dovere di correre ai ripari inserendo nel racconto tradizionale di Mc 1,9 un dialogo tra Gesù e Giovanni che ridimensiona la portata del battesimo di Gesù.
La notizia «Per essere battezzato» poteva far sembrare che Gesù si fosse trovato subordinato a Giovanni, come al di sotto di lui, ciò che non era ammissibile. Era invece vero il contrario. Era Giovanni che avrebbe dovuto inginocchiarsi davanti all’«ospite» venuto dalla Galilea e ricevere la remissione dei peccati. Ma i fatti non si potevano cambiare. Gesù aveva ricevuto il battesimo e Giovanni l’aveva amministrato. Bisognava allora appellarsi a una motivazione teologica che giustificasse l’accaduto e acquietasse gli animi dei lettori. L’evangelista non ha trovato altra risposta plausibile che richiamarsi a un «ordinamento divino» di cui non era dato conoscere la ragione, ma a cui bisognava rimettersi.
Il battesimo di Gesù da parte di Giovanni era un dato irrinunciabile, ma rientrava in una disposizione («giustizia») divina a cui i protagonisti dovevano attenersi, pur non comprendendone le ragioni. Gli uomini non debbono tanto capire quello che Dio dispone, solo eseguirlo. E così avviene anche per Gesù che si fa battezzare da Giovanni.
Ma non basta il richiamo alla superiore volontà di Dio per cancellare le obiezioni insite nel battesimo di Gesù da parte di Giovanni; c’è anche una «teofania», cioè una manifestazione soprannaturale che si verifica nel corso del rito: si aprono i cieli, si vede lo Spirito di Dio, in forma di colomba, si ode una voce che proclama Gesù «figlio prediletto» di Dio, oggetto del suo compiacimento. Sono le massime credenziali che Gesù può far valere a favore della sua missione.
Gesù era sceso nel Giordano per trovare una risposta alle sue perplessità presso gli uomini più qualificati del suo tempo, dai profeti e gli spiritualisti che si trovavano nella terra d’Israele, ma questa gli giunge miracolosamente da Dio. Una convalida che doveva togliere qualsiasi dubbio nei credenti.
Il battesimo di Gesù nel Giordano è la promulgazione della vocazione messianica di Gesù. Forse i fatti sono stati meno evidenti, forse anche Gesù ha dovuto accontentarsi di conferme più modeste, ma nell’una e nell’altra eventualità egli riparte dal Giordano con le idee e le convinzioni più chiare sul suo mandato in Israele e si accorgerà presto anche su quello sulle genti. Il Carme del Servo di JHWH che l’evangelista cita (Is 42,1) ne faceva già menzione.
Meditazione
L’evento del battesimo di Gesù nel Giordano a opera di Giovanni, evento in seguito al quale lo Spirito di Dio viene su Gesù (vangelo), è preannunciato dalla figura del Servo del Signore su cui Dio pone il suo Spirito (I lettura) e proclamato da Pietro nella sua predicazione come atto con cui Dio ha «unto» in Spirito santo Gesù (II lettura). Lo Spirito di Dio che rimane su Gesù significa la comunione piena tra il Padre e il Figlio, tra Dio e Gesù.
La comunione di Gesù con Dio (vangelo) si esprime orizzontalmente, cioè nelle relazioni umane, da un lato come rifiuto di condannare e di giudicare (I lettura), dall’altro come attivo fare il bene e guarire chi si trova nel bisogno (II lettura). Infatti, le azioni di spezzare la canna incrinata e di spegnere lo stoppino fumigante che il Servo del Signore non compie, si riferiscono ai gesti che invece compiva l’araldo del Gran Re babilonese quando decretava una condanna a morte: il senso è che il Servo del Signore non viene per condannare, ma per dare vita (I lettura). E nella predicazione di Pietro, Gesù appare colui che «passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui» (II lettura). Gesù si reca dalla Galilea al Giordano al preciso fine di farsi immergere nel Giordano da Giovanni (Mt 3,13), anche contro la volontà del Battista che «voleva impedirglielo» (Mt 3,14). L’incontro tra i due uomini diviene così un esempio di obbedienza e sottomissione reciproca: Gesù si sottomette all’immersione di Giovanni e Giovanni rinuncia al proprio bisogno spirituale («Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te»: Mt 3,14) e accetta di immergere Gesù. L’obbedienza reciproca diviene obbedienza a Dio: la giustizia adempiuta dai due è infatti la realizzazione della volontà di Dio. La giustizia, biblicamente, è la conformità alla volontà divina. L’obbedienza viene qui colta nel suo aspetto adulto e maturo di azione comune e reciproca, non come atto infantile o mortificazione individuale o abdicazione che uno fa alla propria volontà per adempiere quella di un altro, con i rischi di abuso, di giochi di potere e di sopraffazione che questo comporta. L’obbedienza qui è evento di comunione e di carità che consente l’adempiersi del disegno divino. È un atto libero, non impersonale, né immotivato, ma relazionale, e che avviene nel riconoscimento reciproco e nell’amore.
Questo incontro tra due uomini, due celibi, è particolarmente intenso perché i due uomini di Dio riconoscono la vocazione peculiare l’uno dell’altro. Se Giovanni riconosce di aver bisogno di essere immerso in Spirito santo da Gesù (Mt 3,11.14), Gesù riconosce che l’immersione di Giovanni viene da Dio (Mt 21,25) e che il Battista è venuto nella via della giustizia (Mt 21,32). Il criterio che rende libera la relazione è il fare la volontà di Dio. Gesù non si sottomette all’immersione di Giovanni per compiacerlo o per amor di sottomissione e nemmeno per amicizia, ma perché solo così viene realizzata la volontà di Dio. Questo è anche il criterio che deve regnare nella comunità cristiana perché i rapporti siano limpidi, casti, autentici (Mt 7,21; 12,50).
Giovanni è precursore del Messia lasciando fare, acconsentendo a Gesù (Mt 3,15). C’è una forma di efficacia che non è affatto connessa all’intraprendenza o all’agire, ma al non agire, al lasciar fare al Signore, all’acconsentire al Signore. Giovanni fa spazio a Gesù. La fede, come lasciar fare al Signore, è l’attivo e faticoso fare spazio al Signore. È azione su di sé e questo tipo di azione è la più difficile. L’azione obbediente di Giovanni è a servizio dell’esperienza di filialità che Gesù vive al momento dell’immersione nel Giordano. Se simbolicamente l’uscire dalle acque rinvia a un evento di nascita, la scena del battesimo allude alla paternità di Dio manifestata dalla parola dall’alto, dalla voce dal cielo, ma allude anche alla maternità di Dio, simbolizzata dalla ruach, lo Spirito, lo spazio vitale da cui l’uomo trae la vita. Ha scritto il teologo François Xavier Durwell: «Lo Spirito è il seno in cui Dio è fecondo come una madre».
Preghiere e racconti
Cristo è battezzato, scendiamo con lui per risalire con lui
Abbiamo degnamente celebrato la Natività. Siamo corsi con la stella, abbiamo adorato con i magi, siamo stati avvolti dalla luce con i pastori, abbiamo reso gloria con gli angeli. Con Simeone abbiamo tenuto tra le braccia il Signore; con Anna, anziana e casta, abbiamo reso grazie. Siano rese grazie a colui che è venuto nella propria terra come in un paese straniero e ha glorificato chi l’ospitava. Ora, altra è l’azione di Cristo e altro è il mistero. Non posso contenere la mia gioia, mi sento ispirato e, un po’ come Giovanni, annuncio la buona notizia se non come precursore, almeno come uno che viene dal deserto. Cristo è illuminato, risplendiamo con lui. Cristo è battezzato, scendiamo con lui per risalire con lui. […] Giovanni sta battezzando, Gesù si avvicina forse per santificare il Battista, di certo per seppellire tutto intero il vecchio Adamo, ma prima di loro e grazie a loro santifica il Giordano. Lui che era spirito e carne, consacra con Spirito e acqua. Il Battista non accetta, Gesù insiste: «Sono io che devo essere battezzato da te» (Mt 3,14); la lampada (cfr. Gv 5,35) si rivolge al sole (cfr. Mal 3,20), la voce al Verbo, l’amico allo Sposo, colui che è al di sopra di tutti i nati da donna (cfr. Mt 11,11) al primogenito di ogni creatura (cfr. Col 1,15), colui che ha sussultato fin dal seno di sua madre (cfr. Lc 1,41) a colui che è adorato nel seno della propria, il Precursore presente e futuro a colui che si manifesta e si manifesterà. […] Ma poi Gesù risale dall’acqua. Fa risalire con lui il mondo e vede aprirsi i cieli (cfr. Lc 3,21) che Adamo aveva chiuso per sé e i suoi discendenti, così come aveva chiuso anche il paradiso con una spada fiammeggiante (cfr. Gen 3,24). E lo Spirito rende testimonianza alla divinità perché accorre verso colui che gli è simile; e dai cieli viene la voce poiché è dai cieli che viene colui al quale è resa testimonianza, e lo si vede come una colomba. Lo Spirito, infatti, si mostra in forma corporea rendendo onore al corpo, poiché anch’esso è Dio attraverso la divinizzazione. E nello stesso tempo la colomba è solita da lungo tempo annunciare la buona notizia della fine del diluvio.
(GREGORIO DI NAZIANZO, Discorsi 39,14-16, SC 358,pp. 178-186).
Il Battesimo di Gesù
«Il Battesimo suggerisce molto bene il senso globale delle Festività natalizie, nelle quali il tema del diventare figli di Dio grazie alla venuta del Figlio unigenito nella nostra umanità costituisce un elemento dominante. Egli si è fatto uomo perché noi possiamo diventare figli di Dio. Dio è nato perché noi possiamo rinascere. Questi concetti ritornano continuamente nei testi liturgici natalizi e costituiscono un entusiasmante motivo di riflessione e di speranza. Pensiamo a ciò che scrive san Paolo ai Galati: “Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli” (Gal 4,4-5); o ancora san Giovanni nel Prologo del suo Vangelo: “A quanti l’hanno accolto / ha dato potere di diventare figli di Dio” (Gv 1,12). Questo stupendo mistero che è la nostra “seconda nascita” la rinascita di un essere umano dall’”alto”, da Dio (cfr Gv 3,1-8) si realizza e si riassume nel segno sacramentale del Battesimo.
Con tale sacramento l’uomo diventa realmente figlio, figlio di Dio. Da allora, il fine della sua esistenza consiste nel raggiungere in modo libero e consapevole ciò che fin dall’inizio è la destinazione dell’uomo. “Diventa ciò che sei” rappresenta il principio educativo di base della persona umana redenta dalla grazia. Tale principio ha molte analogie con la crescita umana, dove il rapporto dei genitori con i figli passa, attraverso distacchi e crisi, dalla dipendenza totale alla consapevolezza di essere figli, alla riconoscenza per il dono della vita ricevuta e alla maturità e alla capacità di donare la vita. Generato dal Battesimo a vita nuova, anche il cristiano inizia il suo cammino di crescita nella fede che lo porterà ad invocare consapevolmente Dio come “Abbà Padre”, a rivolgersi a Lui con gratitudine e a vivere la gioia di essere suo figlio.
Dal Battesimo deriva anche un modello di società: quella dei fratelli. La fraternità non si può stabilire mediante un’ideologia, tanto meno per decreto di un qualsiasi potere costituito. Ci si riconosce fratelli a partire dall’umile ma profonda consapevolezza del proprio essere figli dell’unico Padre celeste. Come cristiani, grazie allo Spirito Santo ricevuto nel Battesimo, abbiamo in sorte il dono e l’impegno di vivere da figli di Dio e da fratelli, per essere come “lievito” di un’umanità nuova, solidale e ricca di pace e di speranza. In questo ci aiuta la consapevolezza di avere, oltre che un Padre nei cieli, anche una madre, la Chiesa, di cui la Vergine Maria è il perenne modello. A lei affidiamo i bambini neo-battezzati e le loro famiglie, e chiediamo per tutti la gioia di rinascere ogni giorno “dall’alto”, dall’amore di Dio, che ci rende suoi figli e fratelli tra noi».
(LE PAROLE DEL PAPA ALLA RECITA DELL’ANGELUS, 10.01.2010).
Tu sei il mio figlio diletto, la mia figlia diletta
Nella meditazione ho sperimentato la realtà di questo amore quando ho riferito la frase: “Sei il mio figlio diletto”, proprio alla mia paura, alla mia oscurità, al mio rifiuto, alla mia mediocrità, alle menzogne della mia vita. Ho tentato di scendere nell’acqua del mio inconscio, nel regno delle tenebre, nel quale ho rimosso tutto quanto teme la luce del giorno, tutto quanto io di giorno non guardo volentieri. Per me questa è una bella immagine del battesimo di Gesù: il cielo si è aperto proprio quando egli è sceso nella profondità del Giordano. Il cielo si aprirà anche sopra l’abisso della mia psiche, ma io devo avere coraggio di scendere in questo abisso interiore, per udirvi nel profondo quella frase, con un suono nuovo: “Tu sei il mio figlio diletto, tu sei la mia figlia diletta”. Solo quando io ho riferito alla mia vita concreta la parola che mi dice che sono un figlio amato, essa mi ha toccato nel più profondo e mi ha donato pace interiore. Tutti i discorsi sull’amore di Dio ci scorrono sopra, se non toccano le esperienze della nostra vita di ogni giorno. Il monito nel mio sogno sembra dire: “Conduci gradualmente le persone all’amore del Dio trinitario!”.
(A. GRÜN, Abitare nella casa dell’amore, Brescia, Queriniana, 2000, 51-52)
Battesimo di Gesù
Del Battesimo di Gesù Cristo parlano tutti i quattro vangeli canonici. Ecco come lo presenta il Vangelo di Matteo (3,13-17):
“In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito Santo scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto“.
Il battesimo di Gesù manifesta la sua natura divina: nel mondo è apparso il Figlio di Dio incarnato nella forma umana. Questa è l’Epifania.
Dio appare nello stesso tempo sotto tre ipostasi: Dio-Figlio – Gesù, Dio-Spirito Santo – è sceso su Gesù in forma di colomba, Dio-Padre – si è manifestato attraverso la sua voce. Ecco l’epifania della Santissima Trinità (Trinità “novotestamentaria”).
Ricevuto il battesimo, Gesù andò nel deserto e lì digiunò per quaranta giorni. E il demonio per tre volte lo tentò. Ma Gesù vinse le tentazioni e, tornato in Galilea, iniziò il suo insegnamento. “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista… (Lc 4,18).
Da questo momento Gesù appare come Messia (dall’ebraico mashijah – “unto”, in greco “Cristo”). Inizia il suo grande servizio.
Le immagini del Battesimo del Signore, chiamate anche l’Epifania (del nostro Signore Gesù Cristo), erano molto popolari nella Rusia. Uno degli esempi delle icone di questo tipo è l’immagine dell’Epifania di Novgorod, fine del XV – inizio XVI secolo.
Il centro logico e composizionale dell’icona è la figura di Cristo. Gesù Cristo, spogliato, riceve il battesimo di purificazione nel Giordano: secondo l’iconografia fissata, nella riva sinistra del fiume Giordano è presentato Giovanni Battista, nella riva destra degli angeli (il loro numero sulle icone dell’Epifania varia da tre a quattro).
Giovanni Battista compie l’atto del battezzare, mettendo il palmo della mano destra sulla testa di Gesù Cristo; nella mano sinistra ha la croce, simbolo della missione salvifica di Cristo e simbolo del Nuovo Testamento, della Nuova Alleanza, conclusa tra Dio e gli uomini.
Le due sorgenti che scendono dalla montagna si uniscono in un solo fiume, il Giordano. Gli spazi acuti e fini sullo sfondo di tonalità rosso-bruna delle rive, creano l’illusione di un allontanamento delle montagne che si alzano verso il cielo; già qui si può vedere un raro e ben riuscito tentativo di trasmettere la profondità dello spazio.
Ai piedi di Gesù Cristo nell’acqua si possono distinguere due piccole figure. Quella maschile simbolizza il fiume Giordano, quella femminile il mare. Queste figure sono sorprendenti resti dell’antichità pagana, che sono penetrati e si sono consolidati nell’iconografia dell’immagine ortodossa dell'”Epifania”. È fissata anche la loro provenienza, sono chiamati per illustrare le parole del Salmo 114,3: “Il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro“. Questo fatto, nelle prime e più antiche rappresentazioni del Battesimo, è stato raffigurato in un modo tradizionale e abituale per l’antichità: il mare e il fiume erano rappresentati con piccole figure antropomorfiche. La loro “ritirata” ed il “volgersi indietro” diventavano vaghi.
A volte, insieme a queste piccole figure è raffigurato anche il serpente, che corrisponde al versetto 13 del Salmo 74: “Hai schiacciato la testa dei draghi sulle acque“.
Gli angeli, rappresentati nelle immagini del Battesimo di Gesù Cristo, personificano i padrini, il cui compito è di accogliere i “battezzandi”, quando escono dall’acqua.
Nell’icona troviamo anche la simbolica immagine della colomba, che personifica lo Spirito Santo, e la nube dalla quale è uscita la voce di Dio-Padre.
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione. Omelie. Ciclo A, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2004.2007- .
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– Sussidio Avvento-Natale 2013: «È tempo di svegliarvi dal sonno», a cura dell’Ufficio Liturgico Nazionale della CEI, 2013.
– Avvento-Natale 2010, a cura dell’ULN della CEI, Milano, San Paolo, 2010.
– E. Bianchi et al., Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche di Avvento e Natale, in «Allegato redazionale alla Rivista del Clero Italiano» 88 (2007) 10, 69 pp.
– J. Ratzinger/Benedetto XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.
– J. Ratzinger/Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– Don Tonino Bello, Avvento e Natale. Oltre il futuro, Padova, Messaggero, 2007.
– Carlo Maria Martini – Pietro Messa, L’infinito in una culla. San Francesco e la gioia del Natale, Assisi, Porziuncola, 2009.
– D. Ghidotti, Icone per pregare. 40 immagini di un’iconografia contemporanea, Milano, Ancora, 2003.
PER L’APPROFONDIMENTO:
NATALE BATTESIMO DEL SIGNORE