Intervista al Prof D’Agostino
Intervista al Prof D’Agostino

LA RECENSIONE
Nonostante sia assai denso, questo libro si legge per intero senza interruzioni. Percorrendone i nove capitoli e le prospettive finali, il lettore è trasportato per sentieri scoscesi verso l’avvincente incontro con Gesù, una figura familiare che si rivela ancor più vicina nella sua umanità come nella sua divinità. Completata la lettura, si vorrebbe proseguire il dialogo, non soltanto con l’autore ma con Colui del quale egli parla. Gesù di Nazaret è più di un libro, è una testimonianza commovente, affascinante, liberatrice. Quanto interesse susciterà tra gli esperti e tra i fedeli!
Oltre l’interesse d’un libro su Gesù, è il libro del Papa che si presenta in umiltà al foro degli esegeti, per confrontarsi con loro sui metodi e sui risultati delle loro ricerche. Lo scopo del Santo Padre è quello di andare con loro più lontano, in stretto rigore scientifico, certo, ma anche nella fede nello Spirito Santo che scandaglia le profondità di Dio nella Sacra Scrittura. In questo foro, gli scambi fecondi predominano di molto sugli accenti critici, e ciò contribuisce a far meglio conoscere e riconoscere l’essenziale contributo degli esegeti.
 Non c’è forse da trarre grande speranza da questo riavvicinamento tra l’esegesi rigorosa dei testi biblici e l’interpretazione teologica della Sacra Scrittura? Io non posso fare a meno di scorgere in questo libro l’aurora d’una nuova era dell’esegesi, una promettente era di esegesi teologica.
Non c’è forse da trarre grande speranza da questo riavvicinamento tra l’esegesi rigorosa dei testi biblici e l’interpretazione teologica della Sacra Scrittura? Io non posso fare a meno di scorgere in questo libro l’aurora d’una nuova era dell’esegesi, una promettente era di esegesi teologica.
Il Papa dialoga in primo luogo con l’esegesi tedesca ma non ignora importanti autori che appartengono alle aree linguistiche francofona, anglofona e latina. Eccelle nell’individuare le questioni essenziali e i nodi decisivi, costringendosi a evitare le discussioni sui dettagli e le dispute di scuola che pregiudicherebbero il suo proposito, che è quello di “trovare il Gesù reale”, non il “Gesù storico” proprio del filone dominante dell’esegesi critica, ma il “Gesù dei Vangeli” ascoltato in comunione con i discepoli di Gesù d’ogni tempo, e così “giungere anche alla certezza della figura veramente storica di Gesù”.
Questa formulazione del suo obiettivo manifesta l’interesse metodologico del libro. Il Papa affronta in modo pratico ed esemplare il complemento teologico auspicato dall’Esortazione Apostolica Verbum Domini per lo sviluppo dell’esegesi. Nulla stimola di più dell’esempio dato e dei risultati ottenuti. Gesù di Nazaret offre una magnifica base per un fruttuoso dialogo non solo tra esegeti, ma anche tra pastori, teologi ed esegeti! Prima di illustrare con alcuni esempi i risultati di questa esegesi di Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, aggiungo ancora un’osservazione sul metodo. L’autore si sforza di applicare in maggior profondità i tre criteri d’interpretazione formulati al concilio Vaticano II dalla Costituzione sulla Divina Rivelazione Dei Verbum: tener conto dell’unità della Sacra Scrittura, del complesso della Tradizione della Chiesa e rispettare l’analogia della fede. Come buon pedagogo che ci ha abituati alle sue omelie mistagogiche, degne di san Leone Magno, Benedetto XVI, a partire dalla figura – quanto centrale ed unica – di Gesù, mostra la pienezza di senso che promana dalla Sacra Scrittura “interpretata alla luce dello stesso Spirito mediante il quale è stata scritta” (Dei Verbum, 12).
Anche se l’autore si preclude d’offrire un insegnamento ufficiale della Chiesa, è facile immaginare che la sua autorità scientifica e la ripresa in profondità di certe questioni disputate saranno di grande aiuto per confermare la fede di molti. Serviranno inoltre a far progredire dei dibattiti rimasti insabbiati a motivo dei pregiudizi razionalisti e positivisti che hanno intaccato il prestigio dell’esegesi moderna e contemporanea. Tra la comparsa del primo volume nell’aprile 2007 e quella del secondo in questa Quaresima 2011, un gran numero di eventi felici ma anche di penose esperienze ha segnato la vita della Chiesa e del mondo. Ci si chiede come il Papa sia riuscito a scrivere quest’opera molto personale e molto impegnativa, di cui l’attualità del tema e l’audacia del progetto balzano agli occhi di chiunque s’interessi al cristianesimo. Come teologo e come pastore, ho la sensazione di vivere un momento storico di grande portata teologica e pastorale. È come se in mezzo alle onde che agitano la barca della Chiesa, Pietro avesse ancora una volta afferrato la mano del Signore che ci viene incontro sulle acque, per salvarci (cfr. Matteo, 14, 22-33).
Detto ciò che riguarda il carattere storico, teologico e pastorale dell’evento, veniamo al contenuto del libro che vorrei riassumere assai a grandi linee attorno ad alcune questioni cruciali. Innanzitutto la questione del fondamento storico del cristianesimo che attraversa i due volumi dell’opera; poi la questione del messianismo di Gesù, seguita da quella dell’espiazione dei peccati da parte del Redentore, che costituisce un problema per molti teologi; allo stesso modo la questione del sacerdozio di Cristo in rapporto alla sua Regalità e al suo Sacrificio che tanta importanza rivestono per la concezione cattolica del sacerdozio e della Santa Eucaristia; da ultimo la questione della risurrezione di Gesù, il suo rapporto alla corporeità ed il suo legame con la fondazione della Chiesa.
Non occorre dire che l’elenco non è esaustivo e molti troveranno altre questioni più interessanti, a esempio il suo commento del discorso escatologico di Gesù o ancora della preghiera sacerdotale in Giovanni, 17. Io identifico le questioni qui esposte come nodi da sciogliere in esegesi come in teologia, allo scopo di ricondurre la fede dei fedeli alla Parola stessa di Dio, compresa in tutta la sua forza e la sua coerenza, nonostante i condizionamenti teologici e culturali che a volte impediscono l’accesso al senso profondo della Scrittura.
La questione del fondamento storico del cristianesimo impegna Joseph Ratzinger fin dagli anni della sua formazione e del suo primo insegnamento, come appare dal suo volume Introduzione al cristianesimo (Einführung in das Christentum), pubblicato oltre quarant’anni or sono, e che ebbe all’epoca un notevole impatto sugli uditori e i lettori. Dal momento che il cristianesimo è la religione del Verbo incarnato nella storia, per la Chiesa è indispensabile stare ai fatti e agli avvenimenti reali, proprio in quanto essi contengono dei “misteri” che la teologia deve approfondire utilizzando chiavi d’interpretazione che appartengono al dominio della fede.
In questo secondo volume che tratta degli avvenimenti centrali della passione, della morte e della risurrezione di Cristo, l’autore confessa che il compito è particolarmente delicato. La sua esegesi interpreta i fatti reali in maniera analoga al trattato su “i misteri della vita di Gesù” di san Tommaso d’Aquino, “guidato dall’ermeneutica della fede, ma tenendo conto nello stesso tempo e responsabilmente della ragione storica, necessariamente contenuta in questa stessa fede” (9).
Sotto questa luce, si comprende l’interesse del Papa per l’esegesi storico-critica ch’egli ben conosce e da cui trae il meglio per approfondire gli avvenimenti dell’Ultima Cena, il significato della preghiera del Getsemani, la cronologia della passione e in particolare le tracce storiche della risurrezione.
Non manca di porre in evidenza di passaggio il difetto d’apertura di un’esegesi esercitata in modo troppo esclusivo secondo la “ragione”, ma il suo principale intendimento rimane quello di far luce teologicamente sui fatti del Nuovo Testamento con l’aiuto dell’Antico Testamento e viceversa, in modo analogo ma più rigoroso rispetto all’interpretazione tipologica dei Padri della Chiesa. Il legame del cristianesimo con l’ebraismo appare rafforzato da questa esegesi che si radica nella storia di Israele ripresa nel suo orientamento verso il Cristo. Ecco allora, per esempio, che la preghiera sacerdotale di Gesù, che sembra per eccellenza una meditazione teologica, acquisisce in lui una dimensione del tutto nuova grazie alla sua interpretazione illuminata dalla tradizione ebraica dello Yom Kippur.
Un secondo nodo riguarda il messianismo di Gesù. Certi esegeti moderni hanno fatto di Gesù un rivoluzionario, un maestro di morale, un profeta escatologico, un rabbi idealista, un folle di Dio, un messia in qualche modo a immagine del suo interprete influenzato dalle ideologie dominanti.
L’esposizione di Benedetto XVI su questo punto è diffusa e ben radicata nella tradizione ebraica. Egli s’inserisce nella continuità di questa tradizione che unisce il religioso e il politico, ma sottolineando a qual punto Gesù operi la rottura tra i due domini. Gesù dichiara davanti al Sinedrio d’essere il Messia, ma non senza chiarire la natura esclusivamente religiosa del proprio messianismo. È d’altra parte per questo motivo che è condannato come blasfemo, poiché si è identificato con “il Figlio dell’uomo che viene sulle nubi del cielo”. Il Papa espone con forza e chiarezza le dimensioni regale e sacerdotale di questo messianismo, il cui senso è quello d’instaurare il culto nuovo, l’adorazione in Spirito e in Verità, che coinvolge l’intera esistenza, personale e comunitaria, come un’offerta d’amore per la glorificazione di Dio nella carne. Un terzo nodo da sciogliere riguarda il senso della redenzione e il posto che vi deve o meno occupare l’espiazione dei peccati. Il Papa affronta le obiezioni moderne a questa dottrina tradizionale. Un Dio che esige una espiazione infinita non è forse un Dio crudele la cui immagine è incompatibile con la nostra concezione d’un Dio misericordioso? Come conciliare le nostre moderne mentalità sensibili all’autonomia delle persone con l’idea di un’espiazione vicaria da parte di Cristo? Questi nodi sono particolarmente difficili da sciogliere.
L’autore riprende q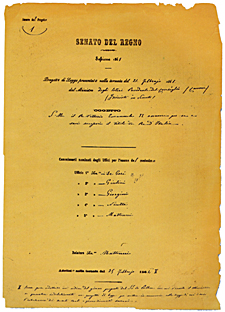 ueste domande più volte, a diversi livelli, e mostra come la misericordia e la giustizia vadano di pari passo nel quadro dell’Alleanza voluta da Dio. Un Dio che perdonasse tutto senza preoccuparsi della risposta che deve dare la sua creatura avrebbe preso sul serio l’Alleanza e soprattutto l’orribile male che avvelena la storia del mondo? Quando si guardano da vicino i testi del Nuovo Testamento, domanda l’autore, non è Dio a prendere su se stesso, nel suo Figlio crocifisso, l’esigenza d’una riparazione e d’una risposta d’amore autentico? “Dio stesso “beve il calice” di tutto ciò che è terribile e ristabilisce così il diritto mediante la grandezza del suo amore che, attraverso la sofferenza, trasforma il buio” (258-259).
ueste domande più volte, a diversi livelli, e mostra come la misericordia e la giustizia vadano di pari passo nel quadro dell’Alleanza voluta da Dio. Un Dio che perdonasse tutto senza preoccuparsi della risposta che deve dare la sua creatura avrebbe preso sul serio l’Alleanza e soprattutto l’orribile male che avvelena la storia del mondo? Quando si guardano da vicino i testi del Nuovo Testamento, domanda l’autore, non è Dio a prendere su se stesso, nel suo Figlio crocifisso, l’esigenza d’una riparazione e d’una risposta d’amore autentico? “Dio stesso “beve il calice” di tutto ciò che è terribile e ristabilisce così il diritto mediante la grandezza del suo amore che, attraverso la sofferenza, trasforma il buio” (258-259).
Tali questioni sono poste e risolte in un senso che invita alla riflessione e in primo luogo alla conversione. Non si può infatti veder chiaro in tali questioni ultime rimanendo neutrali o a distanza. Occorre investirvi la propria libertà per scoprire il senso profondo dell’Alleanza che giustamente impegna la libertà d’ogni persona. La conclusione del Santo Padre è perentoria: “Il mistero dell’espiazione non dev’essere sacrificato a nessun razionalismo saccente” (267).
Un quarto nodo concerne il Sacerdozio di Cristo. Secondo le categorie ecclesiali del giorno d’oggi, Gesù era un laico investito d’una vocazione profetica. Non apparteneva all’aristocrazia sacerdotale del Tempio e viveva al margine di questa fondamentale istituzione del popolo d’Israele. Questo fatto ha indotto molti interpreti a considerare la figura di Gesù come del tutto estranea e senza alcun rapporto con il sacerdozio. Benedetto XVI corregge quest’interpretazione appoggiandosi saldamente sull’Epistola agli Ebrei che parla diffusamente del Sacerdozio di Cristo, e la cui dottrina ben si armonizza con la teologia di san Giovanni e di san Paolo. Il Papa risponde ampiamente alle obiezioni storiche e critiche mostrando la coerenza del sacerdozio nuovo di Gesù con il culto nuovo ch’egli è venuto a stabilire sulla terra in obbedienza alla volontà del Padre. Il commento della preghiera sacerdotale di Gesù è d’una grande profondità e conduce il lettore a pascoli che non aveva immaginato.
L’istituzione dell’Eucaristia appare in questo contesto d’una bellezza luminosa che si ripercuote sulla vita della Chiesa come suo fondamento e sua sorgente perenne di pace e di gioia. L’autore si attiene strettamente alle più approfondite analisi storiche ma dipana egli stesso delle aporie come solo un’esegesi teologica può farlo. Si giunge al termine del capitolo sull’Ultima Cena non senza emozione e restandone ammirati. Un ultimo nodo da me considerato riguarda infine la risurrezione, la sua dimensione storica ed escatologica, il suo rapporto alla corporeità e alla Chiesa. Il Santo Padre comincia senza giri di parole: “La fede cristiana sta o cade con la verità della testimonianza secondo cui Cristo è risorto dai morti” (269).
Il Papa insorge contro le elucubrazioni esegetiche che dichiarano compatibili l’annuncio della risurrezione di Cristo e la permanenza del suo cadavere nel sepolcro. Egli esclude queste assurde teorie osservando che il sepolcro vuoto, anche se non è una prova della risurrezione, di cui nessuno è stato diretto testimone, resta un segno, un presupposto, una traccia lasciata nella storia da un evento trascendente. “Solo un avvenimento reale d’una qualità radicalmente nuova era in grado di rendere possibile l’annuncio apostolico, che non è spiegabile con speculazioni o esperienze interiori, mistiche” (305).
Secondo lui, la risurrezione di Gesù introduce una sorta di “mutazione decisiva”, un “salto di qualità” che inaugura “una nuova possibilità d’essere uomo”. La paradossale esperienza delle apparizioni rivela che in questa nuova dimensione dell’essere “egli non è legato alle leggi della corporeità, alle leggi dello spazio e del tempo”. Gesù vive in pienezza, in un nuovo rapporto con la corporeità reale, ma è libero nei confronti dei vincoli corporei quali noi li conosciamo.
L’importanza storica della risurrezione si manifesta nella testimonianza delle prime comunità che hanno dato vita alla tradizione della domenica come segno identificativo d’appartenenza al Signore. “Per me – dice il Santo Padre – la celebrazione del Giorno del Signore, che fin dall’inizio distingue la comunità cristiana, è una delle prove più forti del fatto che in quel giorno è successa una cosa straordinaria, la scoperta del sepolcro vuoto e l’incontro con il Signore risorto” (288).
Nel capitolo sull’Ultima Cena, il Papa affermava: “Con l’Eucaristia, la Chiesa stessa è stata istituita”. Qui aggiunge un’osservazione di grande portata teologica e pastorale: “Il racconto della risurrezione diviene per se stesso ecclesiologia: l’incontro con il Signore risorto è missione e dà alla Chiesa nascente la sua forma” (289). Ogni volta che noi partecipiamo all’Eucaristia domenicale andiamo all’incontro con il Risorto che torna verso di noi, nella speranza che noi rendiamo così testimonianza ch’Egli è vivente e ch’Egli ci fa vivere. Non c’è in tutto questo di che rifondare il senso della messa domenicale e della missione? Dopo aver citato questi nodi senza che mi sia possibile estendermi in modo adeguato sulla loro soluzione, mi preme concludere questa sommaria presentazione facendo un poco più spazio al significato di questa grande opera su Gesù di Nazaret.
È evidente come mediante quest’opera il successore di Pietro si dedichi al suo ministero specifico che è di confermare i suoi fratelli nella fede. Ciò che qui colpisce in sommo grado, è il modo con cui lo fa, in dialogo con gli esperti in campo esegetico, e in vista di alimentare e fortificare la relazione personale dei discepoli con il loro Maestro e Amico, oggi.
Una tal esegesi, teologica quanto al metodo, ma che include la dimensione storica, si riallaccia effettivamente al modo di interpretare dei Padri della Chiesa, senza tuttavia che l’interpretazione s’allontani dal senso letterale e dalla storia concreta per evadere in artificiose allegorie.
Grazie all’esempio che dà e ai risultati che ottiene, questo libro eserciterà una mediazione tra l’esegesi contemporanea e l’esegesi patristica, da un lato, come anche nel necessario dialogo tra esegeti, teologi e pastori, da un altro. In quest’opera vedo un grande invito al dialogo su ciò che è essenziale del cristianesimo, in un mondo in cerca di punti di riferimento, in cui le differenti tradizioni religiose faticano a trasmettere alle nuove generazioni l’eredità della saggezza religiosa dell’umanità.
Dialogo dunque all’interno della Chiesa, dialogo con le altre confessioni cristiane, dialogo con gli Ebrei il cui coinvolgimento storico in quanto popolo nella condanna a morte di Gesù viene una volta di più escluso. Dialogo infine con altre tradizioni religiose sul senso di Dio e dell’uomo che emana dalla figura di Gesù, così propizia alla pace e all’unità del genere umano.
Al termine d’una prima lettura, avendo maggiormente gustato la Verità di cui con umiltà e passione è testimone l’autore, sento il bisogno di dar seguito a questo incontro di Gesù di Nazaret sia con l’invitare altri a leggerlo che riprendendone la lettura una seconda volta come meditazione del tempo liturgico di Quaresima e di Pasqua. Credo che la Chiesa debba rendere grazie a Dio per questo libro storico, per quest’opera cerniera tra due epoche, che inaugura una nuova era dell’esegesi teologica. Questo libro avrà un effetto liberatorio per stimolare l’amore della Sacra Scrittura, per incoraggiare la lectio divina e per aiutare i preti a predicare la Parola di Dio.
Alla fine di questo rapido volo su un’opera che avvicina il lettore al vero volto di Dio in Gesù Cristo, non mi rimane che dire: Grazie, Santo Padre! Consentitemi tuttavia di aggiungere ancora un’ultima parola, una domanda, poiché un simile servizio reso alla Chiesa e al mondo nelle circostanze che si conoscono e con i condizionamenti che si possono intuire, merita più d’una parola o d’un gesto di gratitudine. Il Santo Padre tiene la mano di Gesù sulle onde burrascose e ci tende l’altra mano perché insieme noi non facciano che uno con Lui. Chi afferrerà questa mano tesa che ci trasmette le parole della Vita eterna?
di M Aarc Ouellet
L’osservatore Romano 11 03 2011

Esegesi Meditazione Preghiere Racconti
Prima lettura: Genesi 2,7-9; 3,1-7
|
Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di alcun albero del giardino”?». Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete”». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. |
La pericope di Genesi, che la liturgia ci presenta come prima lettura in questa prima domenica di Quaresima, accosta due brani distinti quello della creazione dell’uomo con la sua collocazione nel giardino dell’Eden e quello della prima tentazione che riuscì ad ingannare l’uomo e la donna, che fungono insieme da «figura» al brano del Vangelo di Matteo. Gesù è tentato, come fin dall’origine furono tentati l’uomo e la donna: il Messia resiste alla tentazione e vince, mentre la coppia umana cede e soccombe.
Il tentatore è sempre lo stesso: astuto, intelligente e furbo, capace di creare suggestioni e immaginazioni, abile artista e regista che pretende di dirigere il corso degli eventi.
Due scene per due significati che si legano insieme. Nella prima la sottolineatura della condizione dell’uomo, in tutto dipendente da Dio (v.7a: «Il Signore Dio plasmò… »), fragile e debole (v. 7b: «… con polvere del suolo…»), ma in qualche modo partecipe della condizione divina (v. 7c: «…soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente… »); nella seconda il tragico racconto della tentazione e della caduta con i tre protagonisti (serpente, donna, uomo) sui quali incombe, in modo possente, il giudizio tremendo di Dio.
Spettacolare la presentazione del tentatore: una forza seduttrice che giunge all’uomo dall’esterno, una forza corruttrice e parlante, personale e bugiarda.
Serpente antico, il tentatore manipola la parola di Dio: con un’esegesi distorta (3,1 c: «…Non dovete mangiare di alcun albero…») che riesce a sbilanciare la donna e a farla uscire fuori dal suo silenzio e ad accettare il dialogo che la porterà a cadere: con un’insinuazione sottile che getta ombra su Dio (3,5: «Anzi, Dio sa…»), quasi che il Creatore avesse timore e paura, e mette in crisi definitiva la donna.
La donna cede convinta dal serpente; l’uomo cede avviato dalla donna: tutti e due peccano nel tentativo di realizzare la propria vita indipendentemente da Dio, nell’illusione di volersi ergere arbitri sul bene e sul male e nella vaga speranza di sentirsi padroni della propria e dell’altrui vita.
Seconda lettura: Romani 5,12-19
| Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e, con il peccato, la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel mondo e, anche se il peccato non può essere imputato quando manca la Legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire.
Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio, e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti. E nel caso del dono non è come nel caso di quel solo che ha peccato: il giudizio infatti viene da uno solo, ed è per la condanna, il dono di grazia invece da molte cadute, ed è per la giustificazione. Infatti se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l’abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l’opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione, che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l’obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti.
|
Cristo, contrapposto ad Adamo, ci ha procurato la giustizia di Dio liberandoci dal peccato e dalla morte. L’Apostolo Paolo presenta il doppio «destino» che spetta all’umanità: la «morte» o la «vita».
Paolo dimostra che la salvezza è legata alla solidarietà a Cristo, alla sua obbedienza e al suo amore oblativo, presentando la sua argomentazione con il fenomeno letterario del parallelismo antitetico tra l’intervento di Adamo e quello di Cristo nella storia dell’umanità.
Il richiamo di Adamo è però secondario per mettere in evidenza l’opera di salvezza portata da Cristo. È Cristo, infatti, il vero protagonista, è lui che costituisce il centro d’interesse. L’attenzione infatti è posta sull’azione liberatrice di Cristo, sulla sua obbedienza e sul suo «dono di grazia».
L’efficacia positiva di Cristo supera di gran lunga quella negativa di Adamo. Non si tratta dunque di un vero e proprio parallelismo «reale», ma soltanto «formale» per fare risaltare il secondo termine di paragone che è Cristo!
Paolo, inoltre, pone il parallelismo con lo schema «uno-tutto» dove, per il principio di solidarietà, l’azione di uno determina le scelte dell’umanità. Paolo, tuttavia, lascia intendere che l’uomo è libero di accettare o di rifiutare tale influsso e presenta il «destino» dell’uomo come azione della volontà e come scelta personale.
Vangelo: Matteo 4,1-11
(vedi presentazione power point)
|
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.
|
Il capitolo 4 del Vangelo di Matteo si apre con la scena delle tentazioni che Gesù subisce nel deserto ad opera del diavolo. Lo spirito del male è una creatura spirituale che combatte il disegno di Dio. La scena è costituita dalla successione di tre sequenze: il deserto, il tempio di Gerusalemme, un monte altissimo.
Il testo è scandito da un triplice «allora» (vv. 5,10,11) in modo analogo al brano che precedeva il battesimo (3,5-15); il terzo introduce una conclusione che ricorda la fine del dialogo tra Giovanni e Gesù (3,15): «Allora il diavolo lo lasciò…» (v. 11), mentre il duplice «ed ecco» della scena del battesimo (3,16.17) viene qui ripreso come un’eco: «…ed ecco gli angeli gli si avvicinarono e lo servivano» (v. 11).
La pericope si articola in diversi momenti: introduzione con presentazione dei personaggi fondamentali (vv. 1-2); racconto vero e proprio con le tre scene di tentazione (vv. 3-10); conclusione con il ritiro del tentatore e la presenza degli angeli (v. 11).
Il deserto è convenzionalmente il luogo del ritiro, in cui l’uomo si pone di fronte alle scelte essenziali della vita. Come il popolo d’Israele matura la sua vocazione di popolo di Dio nel deserto, così Gesù, prima di iniziare la sua missione, va nel deserto. Il Signore, però, al contrario d’Israele vince la triplice tentazione dei beni materiali, del successo e del potere, tentazione nella quale era caduto l’uomo nel giardino dell’Eden (Gen 3 1-7): dove l’antico Israele soccombeva, colui che simboleggia il nuovo Israele resiste e vince.
Le tre tentazioni conducono Gesù a rifiutare il potere temporale, il facile ricorso al miracolo e soprattutto la seduzione dell’idolatria.
Gesù si distanzia energicamente da queste tre tentazioni rinunciando ad ogni costo a utilizzare la strada del potere, del prestigio e del facile miracolo. Lo testimoniano chiaramente anche gli altri Sinottici, lo ricorda lo stesso Giovanni (6.6).
Altro dato fondamentale della pericope è lo stretto legame che intercorre tra la tentazione di Gesù e il Battesimo. È lo Spirito, disceso in occasione del Battesimo, che conduce Gesù nel deserto, per esservi tentato dal diavolo (4,1). La missione di Gesù viene caratterizzata fin dall’inizio dalla presenza ostile del demonio che sosterrà una lotta continua contro il Figlio di Dio in tutta l’area del suo ministero di prova: adempiere ogni giustizia (5,10) significa proprio vincere al male.
La presentazione delle tentazioni è caratterizzata, intessuta e cadenzata dalle citazioni dell’Antico Testamento. Sembra chiaro che Matteo voglia presentare, in un contesto catechetico o meglio ancora liturgico, Gesù come colui al quale è ordinata l’intera storia d’Israele.
Poiché Gesù colma l’attesa del suo popolo, egli assume tutte le dimensioni della sua storia e dal momento che egli adempie ogni giustizia realizzando il beneplacito del Padre, egli trionfa delle tentazioni alle quali in altri tempi il popolo ebreo aveva invece ceduto e, così, si rivela veramente come il figlio di Dio.
Il tentatore eccelle nell’arte di abbellire le immagini e con pochi elementi egli abbozza un quadro grandioso: il pinnacolo del tempio che domina la città santa, le mura alte che cadono a picco, la presenza degli angeli invocati come possibili «aiutanti» celesti di Gesù… Come un regista esperto vuole far giocare a Gesù il ruolo del Messia trionfatore, che viene tra i suoi con potenza e che si manifesta al mondo intero con gesti altamente e chiaramente potenti. Ma ciò non si realizza!
Nella prima tentazione Gesù rifiuta il ruolo messianico in un contesto spettacolare e prodigioso, ma lo vive nella fedeltà a Dio come ogni uomo giusto e credente. Nella seconda Gesù supera tutte le deformazioni religiose che hanno nella magia e nel miracolismo il loro modello. Nella terza tentazione Gesù mostra chiaramente come sia perversa e diabolica l’idea di una conquista e di un potere imperialistico in nome di Dio.
È la triplice tentazione di Gesù: una tentazione che, al di là del tempo e del luogo circoscritto dall’evangelista, abbraccia e tocca tutta la vita del Messia, che diventa giorno per giorno tentazione e prova continua. Non si tratta della descrizione di un giorno di vita di Gesù, ma della riflessione completa sulla vita stessa di Gesù, rispecchiata, o meglio ancora anticipata, nel riassunto molto sintetico e schematico delle tre tentazioni.
Le letture del ciclo quaresimale «A» sono legate al catecumenato e all’iniziazione cristiana che culmina nel battesimo impartito nella notte pasquale. Nella prima domenica, ad Adamo che soccombe alla tentazione (I lettura) fa riscontro Gesù che vince la tentazione (vangelo) e offre a ogni cristiano la possibilità di fare delle proprie cadute l’occasione di conoscere la grazia di Dio (II lettura).
Il binomio peccato-morte con cui Paolo interpreta la caduta primordiale si presta a una rilettura a partire dalla pagina genesiaca. La tentazione agisce interiormente all’uomo a partire dalla parola con cui Dio gli comanda di mangiare di tutto eccetto una sola cosa (Gen 2,16-17). In caso contrario, l’uomo incontrerà certamente la morte. La tentazione agisce nel cuore umano anzitutto come frustrazione («se sono privato di una cosa, sono privato di tutto»: Gen 3,1). La proibizione dell’unico frutto, più che il permesso-comando di mangiare tutto il resto, colpisce e ferisce la creatura che si vede attratta da ciò che è interdetto. E dalla potenza del desiderio essa si difende con interdetti ulteriori che inaspriscono il divieto divino: «Non lo dovete toccare» (Gen 3,3). E specifica: «altrimenti morirete» (Gen 3,3). La morte è già presente nel mondo, sta agendo nella mente e nel cuore della creatura umana e sta producendo paura. E proprio le parole che assicurano: «Non morirete affatto», vincono le resistenze della donna e la spingono alla trasgressione. Dunque: dalla morte viene il peccato, più ancora che il contrario. O meglio, dalla paura della morte. Il peccato fa leva sulla paura della morte. Noi pecchiamo e la diamo vinta alle tentazioni per illuderci di darci vita nella via del possesso, dell’abuso, dell’accumulo, del potere, del consumo… Ma l’esito di questo è mortifero e l’uomo si ritrova schiavo di ciò che l’ha vinto. Il Nuovo Testamento afferma che Cristo ha ridotto all’impotenza colui che della morte ha il potere, il diavolo, liberando così gli uomini che, per paura della morte, erano soggetti a schiavitù tutta la vita (Eb 2,14-15).
Gesù attraversa la tentazione, non la rimuove. Cioè, egli accetta di misurarsi con essa in se stesso: non proietta l’immagine del nemico su realtà esterne, ma accetta che la potenza della tentazione si dispieghi nell’intimo, nel cuore. Solo chi vince la potenza del divisore in se stesso può cacciare i demoni dagli altri umani.
La vittoria di Gesù è interiore e spirituale: egli vince ricordando la parola di Dio. E la parola ricordata gli fa ripercorrere il cammino del popolo dopo l’uscita dall’Egitto. Le tentazioni matteane riproducono il cammino di Israele nei quarant’anni nel deserto rinviando (attraverso le tre citazioni del Deuteronomio in bocca a Gesù) a tre episodi fondamentali dell’esodo: la manna e le quaglie (Es 16); Massa e Meriba (Es 17,1-7); il vitello d’oro (Es 32). Il ricordo della parola di Dio, la memoria Dei, è ciò che guida Gesù alla vittoria. E la memoria Dei non è semplice ricordo di frasi bibliche, ma evento spirituale che interiorizza la presenza di Dio nel cuore dell’uomo.
Le tentazioni di Gesù non sono solo le tentazioni del miracolistico, del sacrale e del potere (o, rispettivamente, le tentazioni economica, religiosa, politica), ma qualcosa di ulteriore. Nella prima scena vi è anche la tentazione che nasce quando la nostra esperienza della realtà è l’esperienza di un deserto, di durezze pietrose, quando la realtà appare sterile, feconda solo di disillusioni e incapace di nutrire. Nella seconda scena si apre la via alla tentazione che nasce quando si è andati oltre le immagini idealizzate del sacro e del religioso, quando cioè le immagini gratificanti e consolatorie del divino sono crollate e lo spazio per Dio si restringe sempre più. E nella terza scena si dischiude la tentazione successiva alle illusioni del potere, della ricchezza, della gloria: quando cioè queste realtà svelano la loro inanità e nell’uomo può farsi strada il cinismo, la disillusione, magari il risentimento. Gesù passa attraverso tutto questo e ciò che rimane è un corpo spoglio che, nella nuda fede, ricorda e ripete la parola di Dio. È così nel deserto, sarà così sulla croce (Mt 27,46).
La tentazione
Il deserto richiama alla mente un altro luogo dello Spirito: la tentazione. Non le nostre piccole tentazioni quotidiane, ma l’unica tentazione, la grande tentazione escatologica, quella degli ultimi giorni in cui già stiamo vivendo. Dobbiamo riconoscere questa tentazione in ogni cosa che ci accade, come nelle contraddizioni e nelle sofferenze che ci circondano. «Considerate perfetta letizia», dice san Giacomo all’inizio della sua Lettera, «quando subite ogni sorta di prove»; è per questo che siamo nel mondo… È nell’ora della tentazione che la testimonianza dello Spirito si fa chiara ed eloquente in noi, ed è nel pieno mezzo della tentazione che i cristiani si riconoscono fratelli. La tentazione ci pone davanti a Dio in modo completamente nuovo. Una breccia si apre in noi: ogni tentazione mette in discussione un certo numero di strutture non solo ecclesiali, ma anche strutture della nostra intima personalità. Sconcertandoci e togliendoci il terreno da sotto i piedi, aprendo una breccia e smantellando qualcosa a cui siamo intimamente legati, la tentazione porta con se la possibilità di una ricca effusione della grazia, e può farci crescere nello Spirito santo. Se riusciamo ad accettare questo scombussolamento e a mostrarci in tutta la nostra debolezza e povertà, queste ultime verranno d’un tratto rimpiazzate e rilevate dalla potenza di Dio che dispiega tutta la sua forza nella nostra debolezza. È questa accettazione a costituire ciò che le Scritture chiamano hypomone: pazienza, perseveranza.
(A. Louf, La vita spirituale, Magnano (Biella), Edizioni Qiqajon/Comunità di Bose, 2001, pp. 9-20).
Antonio e i suoi compagni
Non è strano che Antonio e i monaci suoi compagni considerassero un disastro spirituale l’accettare passivamente i principi e i valori della loro società. Essi erano riusciti a capire quanto fosse difficile non solo per il singolo cristiano, ma anche per la chiesa stessa, resistere alle seducenti imposizioni del mondo. Quale fu la loro reazione? Fuggirono dalla nave che stava per affondare e nuotarono verso la vita. E il luogo della salvezza è chiamato deserto, il luogo della solitudine…
La solitudine è la fornace della trasformazione. Senza solitudine, rimaniamo vittime della nostra società e continuiamo a restare impigliati nelle illusioni del falso io. Anche Gesù è entrato in questa fornace. Fu tentato con le tre seduzioni del mondo: essere importante («trasforma le pietre in pane»), essere spettacolare («gettati dalla torre»), essere potente («ti darò tutti questi regni»). Gesù ha affermato Dio come unica sorgente della sua identità («Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto»). La solitudine è il luogo della grande lotta e del grande incontro – lotta contro le imposizioni del falso io e incontro con il Dio dell’amore che offre se stesso come sostanza del nuovo io.
(J.M. Nouwen, La via del cuore, in ID., Mostrami il cammino. Meditazioni per il tempo di Quaresima, Brescia, Queriniana, 2003, 94).
La mia cella nel mondo
La cella, luogo di ritiro, è una semplice camera che abbisogna soprattutto di silenzio in modo che possa assicurare, con l’arredamento essenziale, tutto quello che serve per riposare (il letto), per leggere e scrivere (la sedia e il tavolo), anche o soprattutto di notte (la lampada). Per secoli la cella è stata ed è ancora questo per ogni monaco d’Oriente e d’Occidente: il luogo in cui il monaco impara ad habitare secum, ad abitare con se stesso, in cui cerca Dio nella solitudine e nel silenzio, in cui si impegna e si esercita a lottare contro le pulsioni malvagie che lo abitano e in cui si addestra alla comunione con gli uomini tutti.
Così è stato per me, fin da quando, giovane studente universitario, ho intrapreso, al di fuori delle strutture allora esistenti, l’itinerario monastico che rimane fondamentalmente identico al di là dei contesti storici, culturali ed ecclesiali in cui si inserisce. E come tutti quelli che mi avevano preceduto in questo cammino, mi sono presto accorto che non era facile rimanere, sostare, abitare una cella, quel luogo troppo piccolo, privo di sbocchi e di mutamenti, un luogo capace addirittura di incutere paura. Sapevo bene che la battaglia della cella era una delle prime che avrei dovuto combattere e, infatti non appena vi entravo, avvertivo una voglia di uscirne, mi si affollava nella mente le urgenze che mi chiamavano “fuori”: il richiamo a vivere fuori da me stesso si insediava nella mia mente […].
Come accade a ogni monaco, anch’io ho conosciuto la cella come luogo di reclusione e di prigione ma poi, perseverando, l’ho scoperta come luogo in cui poco alla volta si impara ad abitare con se stessi in verità, intenti alla propria unificazione interiore. Con un sapiente gioco di parole, Guglielmo di Saint-Thierry accostava “cella” e coelum, interpretandoli entrambi come derivati dal verbo “celare”, nascondere: qui e là si ritrova Dio, il Dio segreto, nascosto. Del resto Gesù stesso, rivolgendosi a ogni discepolo – e quindi non solo ai monaci… – aveva rivolto un invito ben preciso: “Tu, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo che è nel segreto” (Matteo 6,6,). Pregare nel segreto della cella, dove nessuno vede, nessuno controlla: questo è esempio di autenticità e luogo di verifica dell’eloquenza della fede. Antidoto contro ogni ostentazione ed esibizione religiosa, la cella diventa effettivamente il luogo in cui si può “dare del tu a Dio”, parlare a Dio e vincere la tentazione di parlare di lui. Se questo “faccia a faccia” è franco, può assumere i tratti di un intimità amorosa: allora la cella diviene “cella vinaria”, la stanza del Cantico dei Cantici, autentica cantina dove si consuma l’incontro amoroso inebriati dal profumo e dal gusto del vino. Come dice il profeta: Exultabit solitudo, “La solitudine esulterà”.
(Enzo BIANCHI, Ogni cosa alla sua stagione, Enaudi, Torino, 2010, Prologo)
Intuizioni patristiche dedicate al brano evangelico delle tentazioni
«Dopo il battesimo nell’acqua lo Spirito conduce Gesù al battesimo nella tentazione, ma non come una persona ne costringe un’altra, ma come qualcuno consente a chi ha deciso. E’ provato nella solitudine, così come Eva fu tentata quando si trovò sola. Il potere di Dio non si fa conoscere con tali prove, perché Dio non fa mai nulla d’inutile. Chi conosce la propria forza, infatti, non cerca di sfoggiarla. Se dunque il digiuno non vi gioverà per non essere tentati, vi consentirà non di meno di essere fortificati tanto da vincere la tentazione».
(S. Giovanni Crisostomo)
«Come tentò per la gola il primo Adamo, così tenta il secondo per la fame. Il maligno, vincitore del primo, sarà vinto dal secondo e come tentò i primogeniti con la vanagloria, dicendo che sarebbero stati come Dio, ora tenta Cristo con la superbia».
(S.Gregorio Magno)
«Gesù vuol vincere con l’umiltà e con l’autorità delle divine scritture e non con i segni del suo potere divino. In questo modo confonde di più il nemico e dà maggior onore alla natura umana indicando con quali armi anch’essa può vincere il maligno. Il maligno aveva tale potere perché usandone giungesse la sua sconfitta. Così verrà permesso ai malvagi di crocifiggerlo perché ne giungesse la salvezza».
(S. Girolamo)
«Anche Satana cita la bibbia, ma certe citazioni non illuminano: fanno buio».
(S. Ambrogio)
40 giorni nel deserto
Un uomo d’affari stressato e logorato dai troppi impegni si presentò ad un maestro di vita spirituale a chiedere un consiglio.
Gli disse il maestro: “Quando un pesce finisce al secco comincia a morire. Anche tu cominci a morire quando ti lasci prendere dalle cose del mondo. Il pesce può salvarsi se torna subito nell’acqua. Tu devi tornare nella solitudine”.
L’uomo d’affari si spaventò: “Devo lasciare tutti i miei affari e rifugiarmi in un convento?”
“No no, conserva i tuoi affari e rifugiati nel tuo cuore”.
Non di solo pane
«Anche se ormai pochi ci fanno caso, ogni volta che le comunità cristiane si riuniscono per celebrare il grande mistero della loro fede lo fanno con il pane e il vino disposti su una mensa che i cristiani chiamano la «tavola del Signore».
È così che mettono davanti a Dio tutta la creazione, tutto l’universo fisico, sintesi di ciò che vive, e insieme il lavoro dell’uomo, sintesi della fatica, della tecnica, della scienza, della capacità di abitare il mondo. E con spirito di profezia compiono sul pane e sul vino il gesto compiuto da Gesù, promessa di trasfigurazione di questo mondo e delle loro vite nella vita del loro Signore: al cuore della vita spirituale più intensa, il pane con la sua materialità e il suo significato appare come la realtà, il cibo capace di narrare il più grande mistero cristiano.
Anche cosi si illumina la capacità del pane di essere simbolo della condivisione: chi mangia il pane con un altro non condivide solo lo sfamarsi, ma inizia con il condividere la fame, il desiderio di mangiare, che è anche il primo impulso dell’essere umano verso la felicità.
Noi uomini abbiamo fame, siamo esseri di desiderio e il pane esprime la possibilità di trovare vita e felicità: da bambini mendichiamo il pane, divenuti adulti ce lo guadagniamo con il lavoro quotidiano, vivendo con gli altri siamo chiamati a condividerlo. E in tutto questo impariamo che la nostra fame non è solo di pane ma anche di parole che escono dalla bocca dell’altro: abbiamo bisogno che il pane venga da noi spezzato e offerto a un altro, che un altro ci offra a sua volta il pane, che insieme possiamo consumarlo e gioire, abbiamo soprattutto bisogno che un Altro ci dica che vuole che noi viviamo, che vuole non la nostra morte ma, al contrario, salvarci dalla morte».
(Enzo BIANCHI, Il pane di ieri, Torino, Einaudi, 2008, 44-45).
Non temere la lotta!
«Se dopo il battesimo ti assalirà colui che ha perseguitato e inseguito la luce – e di certo ti assalirà dal momento che ha assalito anche il Verbo e mio Dio a causa del rivestimento della carne aggredendo la luce nascosta attraverso ciò che era visibile – tu hai modo di vincerlo, non temere la lotta! Opponigli l’acqua, opponigli lo Spirito, nel quale si spegneranno tutte le frecce infuocate del Maligno. È Spirito, ma che dissolve le montagne [cfr. Sal 96 (97),5]; è acqua, ma che spegne il fuoco. Se [il Divisore] ti assale ponendoti sotto gli occhi la tua povertà – ha osato farlo con Cristo – e cercherà di ottenere che le pietre divengano pane (cfr. Mt 4,3-4) facendoti vedere che hai fame, non ignorare i suoi propositi. Insegnagli quello che non ha imparato, opponigli la parola di vita che è il pane disceso dal cielo e che dona vita al mondo (cfr. Gv 6,33). Se ti tende un laccio attraverso la vanagloria – lo fece anche con Cristo conducendolo sul pinnacolo del tempio e dicendogli: «Gettati di sotto» (Mt 4,6) perché mostrasse la sua divinità – non farti trascinare in basso dal desiderio di innalzarti. Se ottiene questo, non si fermerà qui. E insaziabile, ricorre a tutti gli espedienti. Lusinga con il bene, ma conclude con il male. Questo è il suo modo di combattere. Ma il ladrone è esperto anche nella Scrittura. Da essa trae lo «sta scritto» a proposito del pane (cfr, Mt 4,3-4) ; da lì lo «sta scritto» a proposito degli angeli: «Sta scritto, infatti, che darà ordine ai suoi angeli riguardo a te, e che essi ti solleveranno con le loro mani [Sal 90 (91),11-12; Mt4,6]. Oh! Tu, sapiente nel fare il male, come hai potuto tacere quanto è scritto subito dopo? Io lo conosco bene anche se tu hai taciuto. «Io ti farò camminare sopra l’aspide e il basilisco e ti farò calpestare i serpenti e gli scorpioni « [Sal 90 (91),13], perché sei protetto dalla Trinità. Se poi egli ti assalirà ricorrendo all’insaziabilità, mostrandoti in un istante e in un batter d’occhio tutti i regni del mondo come se gli appartenessero (cfr. Mt 4,8-9) e ti chiederà di adorarlo, disprezzalo: è povero. Digli, confidando nel sigillo [impresso su di te con il battesimo] : «Anche io sono immagine di Dio. Non sono ancora stato rigettato dalla gloria dell’alto come te a causa della superbia. Ho rivestito Cristo (cfr. Gal 3,27), mi sono trasformato in Cristo per mezzo del battesimo. Sei tu che devi adorarmi». Si allontanerà da te, ne sono certo, vinto e coperto di vergogna a causa di queste parole. Come dovette abbandonare Cristo, la prima luce, così lascerà anche quelli che sono stati da lui illuminati».
(GREGORIO DI NAZIANZO, Discorsi 40,10, SC 358, pp. 216-218).
Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto (Mt 4,10).
Il principale interesse di Gesù era quello di obbedire al Padre suo, di vivere costantemente alla sua presenza. Solo dopo divenne chiaro per lui quale fosse il suo compito nelle sue relazioni con la gente. Questa è la via che egli propone anche ai suoi apostoli: «In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli» (Gv 15,8). Forse dobbiamo continuamente richiamare alla nostra memoria, che il primo comandamento, quello che esige da noi di amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima e con tutta la nostra mente, è veramente il primo.
Mi chiedo se questo lo crediamo davvero. In realtà, sembra che viviamo come se dovessimo dare il cuore, l’anima e la mente il più possibile ai nostri simili, gli esseri umani, cercando di fare di tutto per non dimenticarci di Dio. O per lo meno sentiamo che la nostra attenzione va divisa equamente tra Dio e il nostro prossimo. Ma Gesù chiede qualcosa di molto più radicale.
Domanda un impegno esclusivo per Dio e per Dio solo. Dio vuole tutto il nostro cuore, tutta la nostra mente, tutta la nostra anima.
È questo amore di Dio incondizionato e senza riserve, che ci spinge a prenderci cura del nostro prossimo, non come un’attività che ci distrae da Dio o si mette in concorrenza con la nostra attenzione a Dio, bensì come un’espressione del nostro amore per Dio che si rivela a noi come il Dio di tutti.
È in Dio che troviamo nostro prossimo e scopriamo la nostra responsabilità nei suoi confronti. Potremmo addirittura dire che solo in Dio il nostro prossimo diventa nostro prossimo e non una violazione della nostra autonomia, e che solo in Dio e attraverso Dio diventa possibile il servizio.
(J.M. Nouwen, Un ricordo che guida, in ID., Mostrami il cammino. Meditazioni per il tempo di Quaresima, Brescia, Queriniana, 2003, 20-22).
La solitudine
La solitudine è un elemento antropologico costitutivo: l’uomo nasce solo e muore solo. Egli è certamente un «essere sociale», fatto «per la relazione», ma l’esperienza mostra che soltanto chi sa vivere solo sa anche vivere pienamente le relazioni. Di più: la relazione, per essere tale e non cadere nella fusione o nell’assorbimento, implica la solitudine. Solo chi non teme di scendere nella propria interiorità sa anche affrontare l’incontro con 1’alterità. Ed è significativo che molti dei disagi e delle malattie «moderne», che riguardano la soggettività, arrivino anche a inficiare la qualità della vita relazionale: per esempio, l’incapacità di interiorizzazione, di abitare la propria vita interiore, diviene anche incapacità di creare e vivere relazioni solide, profonde e durature con gli altri. Certo, non ogni solitudine è positiva: vi sono forme di fuga dagli altri che sono patologiche, vi è soprattutto quella «cattiva solitudine» che è l’isolamento, il quale implica la chiusura agli altri, il rigetto del desiderio degli altri, la paura dell’alterità. Ma tra isolamento, chiusura, mutismo, da un lato, e bisogno della presenza fisica degli altri, dissipazione nel continuo parlare, attivismo smodato, dall’altro, la solitudine è equilibrio e armonia, forza e saldezza.
Chi assume la solitudine è colui che mostra il coraggio di guardare in faccia se stesso, di riconoscere e accettare come proprio compito quello di «divenire se stesso»; è l’uomo umile che vede nella propria unicità il compito che lui e solo lui può realizzare. E non si sottrae a tale compito rifugiandosi nel «branco», nell’anonimato della folla, e neppure nella deriva solipsistica della chiusura in sé. Sì, la solitudine guida l’uomo alla conoscenza di sé, e gli richiede molto coraggio.
La solitudine allora è essenziale alla relazione, consente la verità della relazione e si comprende proprio all’interno della relazione. Capacità di solitudine e capacità di amore sono proporzionali. Forse, la solitudine è uno dei grandi segni dell’autenticità dell’amore. Scrive Simone Weil: «Preserva la tua solitudine. Se mai verrà il giorno in cui ti sarà dato un vero affetto, non ci sarà contrasto fra la solitudine interiore e l’amicizia; anzi, proprio da questo segno infallibile la riconoscerai».La solitudine è il crogiuolo dell’amore: le grandi realizzazioni umane e spirituali non possono non attraversare la solitudine. Anzi, proprio la solitudine diviene la beatitudine di chi la sa abitare. Facendo eco al medievale «beata solitudo, sola beatitudo», scrive MarieMadeleine Davy: «La solitudine è faticosa solo per coloro che non han sete della loro intimità e che, di conseguenza, l’ignorano; ma essa costituisce la felicità suprema per coloro che ne hanno gustato il sapore».
In verità, la solitudine, certamente temibile perché ci ricorda la solitudine radicale della morte, è sempre solitudo pluralis, è spazio di unificazione del proprio cuore e di comunione con gli altri, è assunzione dell’altro nella sua assenza, è purificazione delle relazioni che nel continuo commercio con la gente rischiano di divenire insignificanti. E per il cristiano è luogo di comunione con il Signore che gli ha chiesto di seguirlo là dove lui si è trovato: quanta parte della vita di Gesù si è svolta nella solitudine! Gesù che si ritira nel deserto dove conosce il combattimento con il Tentatore, Gesù che se ne va in luoghi in disparte a pregare, che cerca la solitudine per vivere l’intimità con 1’abba e per discernere la sua volontà. Certo, come Gesù, il cristiano deve riempire la sua solitudine con la preghiera, con la lotta spirituale, con il discernimento della volontà di Dio, con la ricerca del suo volto.
Commentando Giovanni 5,13 che dice: «L’uomo che era stato guarito non sapeva chi fosse [colui che l’aveva guarito]; Gesù infatti era scomparso tra la folla», Agostino scrive: «È difficile vedere Cristo in mezzo alla folla; ci è necessaria la solitudine. Nella solitudine, infatti, se l’anima è attenta, Dio si lascia vedere. La folla è chiassosa; per vedere Dio ti è necessario il silenzio». II Cristo in cui diciamo di credere e che diciamo di amare si fa presente a noi nello Spirito santo per inabitare in noi e per fare di noi la sua dimora. La solitudine è lo spazio che apprestiamo al discernimento di questa presenza in noi e alla celebrazione della liturgia del cuore.
Il Cristo poi, che ha vissuto la solitudine del tradimento dei discepoli, dell’allontanamento degli amici, del rigetto della sua gente, e perfino dell’abbandono di Dio, ci indica la via dell’assunzione anche delle solitudini subite, delle solitudini imposte, delle solitudini «negative». Colui che sulla croce ha vissuto la piena intimità con Dio conoscendo l’abbandono di Dio, ricorda al cristiano che la croce è mistero di solitudine e di comunione. Essa, infatti, è mistero di amore!
(Tratto dal libro: Enzo BIANCHI, Le parole di spiritualità. Per un lessico della vita interiore, Milano, Rizzoli, 21999, 181-184).
Lettera di Nichi Vendola a don Tonino Bello
«…Vedi, don Tonino, io sento nostalgia struggente della tua voce e della tua cosmogonia, perché ho l’impressione che le cose si siano fatte molto più complicate… Oggi vincono e convincono quelli che non hanno tempo per occuparsi di vittime, di poveri, di esuberi, di quelle “pietre di scarto” che nel Vangelo saranno “pietre angolari” dell’edificio della salvezza: quelli che girano lo sguardo da un’altra parte, quelli che fingono di non vedere l’orrore, quelli che sono gli eroi di cartapesta del nostro immaginario e della nostra etica pubblica. Oggi gli afflitti vengono ulteriormente afflitti e i consolati ulteriormente consolati…. La crisi del mondo scopre le proprie carte persino con uno sconosciuto vulcano islandese che risvegliandosi ed eruttando, con la sua nube premonitrice avvolge l’intera Europa. Non c’è varco che indichi l’intangibilità della vita: l’economia appiccica prezzi e toglie valore alle persone, la mercificazione non ha senso del limite, anche i bambini sono merce-lavoro esposti a qualsivoglia violazione, i vecchi sono de localizzati dalla finanza domestica a rottami o esiliati, le donne pagano a prezzo salatissimo la rivendicazione della propria libertà (cioè della propria dignità), torna la stagione degli acchiappafantasmi. Ognuno ha la propria ossessione, il proprio fantasma da esorcizzare.
La pace di Isaia, il disarmo dei pacifisti, il digiuno che purifica, l’astinenza dall’odio: dov’è tutto questo, carissimo don Tonino? Dov’è la Pasqua della responsabilità sociale e della convivialità culturale?
Anche la Chiesa spesso pare più vocata all’autodifesa che non all’annuncio. L’Annuncio, sì carissimo pastore, quello che tu hai saputo incarnare nella ferialità di un amore senza misura (charitas sine modo): amore capace di giudizio storico, capace di passione civile, capace di condivisione radicale… Tu sapevi essere la sentinella che annuncia l’alba.
Ti ho scritto questa lettera in tono apocalittico, perché tu mi hai insegnato che bisogna denunciare il male non per stimolare cinismo e rassegnazione, ma per allenare la coscienza alla ricerca del bene, del giusto, del bello».
(Lettera scritta da Nichi Vendola nella «Gazzetta del Mezzogiorno» (19 aprile 2010).
La sapienza dei Padri
Nella vita dei Padri del deserto, si narra di Bessarione, grande monaco vissuto nel secolo IV. Capitato in una chiesa durante la predica, gli toccò sentire il presbitero scacciare un peccatore, giudicato indegno di stare tra la gente per bene. Bessarione non mosse ciglio, si alzò con lui dicendo: “anch’io sono un peccatore”.
Preghiera
Signore Gesù, domani inizia il tempo di quaresima.
È un periodo per stare con te in modo speciale, per pregare, per digiunare, seguendoti così nel tuo cammino verso Gerusalemme, verso il Golgota e verso la vittoria finale sulla morte.
Sono ancora così diviso! Voglio veramente seguirti, ma nel contempo voglio anche seguire i miei desideri e prestare orecchio alle voci che parlano di prestigio, di successo, di rispetto umano, di piacere, di potere e d’influenza. Aiutami a diventare sordo a queste voci e più attento alla tua voce, che mi chiama a scegliere la via stretta verso la vita.
So che la Quaresima sarà un periodo difficile per me. La scelta della tua via dev’essere fatta in ogni momento della mia vita. Devo scegliere pensieri che siano i tuoi pensieri, parole che siano le tue parole, azioni che siano le tue azioni. Non vi sono tempi o luoghi senza scelte. E io so quanto profondamente resisto a scegliere te.
Ti prego, Signore: sii con me in ogni momento e in ogni luogo. Dammi la forza e il coraggio di vivere questo periodo con fedeltà, affinché, quando verrà la Pasqua, io possa gustare con gioia la vita nuova che tu hai preparato per me. Amen.
(J.M. NOUWEN, In cammino verso l’alba, in ID., La sola cosa necessaria Vivere una vita di preghiera, Brescia, Queriniana, 2002, 237-238).
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Lezionario domenicale e festivo. Anno A, a cura della Conferenza Episcopale Italiana, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2007.
– Giuseppe TURANI, Quaresima-Pasqua 2011. Cristo mia speranza è risorto!, in «Vita pastorale. Supplemento» (2011) 1, 113 pp.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, «Allegato redazionale alla Rivista del Clero Italiano» 91 (2010) 10, 71 pp.
– COMUNITÀ DI BOSE, Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche. Anno A, a cura di Enzo Bianchi et alt., Milano, Vita e Pensiero, 2010.
– C.M. MARTINI, Incontro al Signore risorto. Il cuore dello spirito cristiano, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009.
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– Temi di predicazione. Omelie. Ciclo A, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2004.
– J.M. NOUWEN, Un ricordo che guida, in ID., Mostrami il cammino. Meditazioni per il tempo di Quaresima, Brescia, Queriniana, 2003.
– Fernando ARMELLI, Ascoltarti è una festa. Le letture domenicali spiegate alla comunità, Anno A, Padova, Messaggero, 2001.

Massimo Recalcati, Cosa resta del padre?, Cortina Editore, pag. 190, euro 14.
“Papi”: è così che gli adolescenti di oggi chiamano il proprio genitore, con un nomignolo che suona come un sinonimo dello svuotamento di autorità della figura paterna. Per dirla meglio, con Massimo Recalcati: «La figura del padre ridotta a “papi”, invece di sostenere il valore virtuoso del limite, ne autorizza la sua più totale dissoluzione. E riflette la tendenza di fondo della famiglia ipermoderna: entrambi i genitori sono più preoccupati di farsi amare dai loro figli che di educarli. Più ansiosi di proteggerli dai fallimenti che di sopportarne il conflitto, e dunque meno capaci di rappresentare ancora la differenza generazionale». Recalcati è uno psicoanalista, e lacaniano per giunta, eppure il suo Uomo senza inconscio ha venduto più di diecimila copie. Un successo dovuto alla capacità di raccontare i disagi della nostra civiltà senza un eccesso di tecnicismi scolastici.
Oggi esce il suo nuovo libro sulla paternità nell’epoca ipermoderna, sull’evaporazione del padre, secondo l’espressione coniata da Lacan già alla fine degli anni Sessanta. È un tema che incide sui cambiamenti della cultura occidentale, venendo a mancare il principio fondativo della famiglia e del corpo sociale – oltre a investire profondamente la condizione esistenziale di ciascuno. Già l’interrogativo del titolo allude a un vuoto difficilmente colmabile: Cosa resta del padre? (Cortina, pagg. 190, euro 14).
Cosa resta dell’uomo che assicurava l’ordine del mondo e della vita dei suoi figli?
«Certamente non l’ideale del Padre, il pater familias, il padre come erede in terra della potenza trascendente di Dio, e nemmeno il padre edipico celebrato da Freud come perno della realtà psichica. Non possiamo più ricorrere all’autorità simbolica del padre, che ormai si è dissolta: lo dicono gli psicoanalisti, i sociologi, i filosofi della politica… Si tratta allora di pensare al padre come “resto”, non più Ideale normativo ma atto singolare e irripetibile, antagonista all’insegnamento esemplare, all’intenzione pedagogica. Quel che resta del padre ha la dimensione di una testimonianza etica, è l’incarnazione della possibilità di vivere ancora animati da passioni, vocazioni, progetti creativi. Seppure senza il ricorso alla fede nella parola dogmatica o attraverso sermoni morali».
Il padre è un uomo che sa ancora trasmettere il sentimento della speranza?
«È un uomo che dice “sì!” a ciò che esiste, senza sprofondare nell’abisso di un puro godimento distruttivo, senza rendere la vita equivalente alla volontà di morire o impazzire. La verità che può trasmettere è necessariamente indebolita, perché non vanta modelli esemplari o universali: la sua testimonianza infatti buca ogni esemplarità e ogni universalità, risultando eccentrica e anarchica nei confronti di qualunque retorica educativa. Quel che conta – e resta a un figlio – è come, nella buia notte di un mondo senza Dio, un padre mantenga acceso il fuoco della vita, non la manifestazione di una pura negazione repressiva, ma piuttosto la donazione della fiducia nell’avvenire».
In un rapporto che rimane del tutto asimmetrico?
«Assolutamente. Le farò un esempio molto semplice: l’insulto di un padre rivolto a un figlio può avere un effetto indelebile che il contrario non comporta in alcun modo… Quando Freud gli attribuiva il saper “tenere gli occhi chiusi”, intendeva sottolineare il carattere “umanizzato” della Legge che rappresenta. Non ascoltare una parola insolente o non vedere un gesto osceno, a volte può essere la condizione per proseguire la partita… È il doppio compito della funzione paterna: introdurre un “no!” che sia davvero un “no!”, e al tempo stesso saper incarnare un desiderio vitale e capace di realizzazione».
Famiglie monoparentali, ultracinquantenni che diventano mamme senza un compagno, coppie gay con figli, single con diritto all’adozione… C’era una volta lo schema edipico – sintetizzando: il padre “interdice” il godimento incestuoso e “separa” la madre dal figlio. Ma il mondo non sarà davvero “nuovo” e certi modelli ormai inservibili?
«Lo schema edipico continua ad avere il suo valore, se però si abbandona il teatrino familiare.
Intesa come legame “naturale”, la famiglia composta da una coppia eterosessuale e dai loro figli non è più il nucleo immobile dei legami sociali. Esistono organizzazioni sociali e culturali sempre più complesse, l’importante è che non venga meno la funzione educativa del legame familiare che vuol dire umanizzare la vita, iscriverla in un’appartenenza, farla partecipare a una cultura di gruppo, darle una casa e cioè una radice, una disponibilità alla cura e alla presenza… Se non si può più trasmettere il vero senso della vita, è però ancora possibile mostrare di dare un senso alla vita».
Oltre a Freud e soprattutto Lacan, lei ricorre alla letteratura con Philip Roth (Patrimonio) e Cormac McCharty (La strada). E poi a quel cinema di Clint Eastwood che rompe appunto “l’ordine del sangue”. Prendiamo Million Dollar Baby…
«Intanto ogni paternità, come amava ripetere Françoise Dolto, è sempre adottiva, è sempre un’adozione simbolica che trascende il sangue e la biologia… “Io voglio lei!”. “Sarò il tuo allenatore!”: Frankie riconosce il desiderio di Maggie di diventare un pugile professionista, di avere lui e non altri come allenatore, risponde alla sua domanda facendo eccezione alla propria etica (“Io non alleno ragazze!”) e al funzionamento della sua palestra, frequentata solo da uomini. In questo modo l’atto della paternità si produce come rottura di un ordine universale: l’ordine della morale normativa, del sangue e della genealogia, l’ordine dei dogmi. Frankie accoglie Maggie, non l’abbandona come “una causa persa”, alla fine sarà il suo infermiere, la sua luce, il suo padre amato».
Ma a cosa è legata oggi la funzione del padre?
«Se non può più essere legata al sangue, al sesso, alla biologia, alla discendenza genealogica, allora aveva forse ragione papa Luciani a sconvolgere secoli di teologia dicendo che Dio è anche madre».
in “la Repubblica” del 9 marzo 2011

Accade ai grandi vecchi dell’arte, una volta che hanno dimostrato nel corso della loro esistenza virtuosismi tecnici di pennello o scalpello capaci di rendere ai più alti livelli la bellezza delle forme, di lasciarsi andare alla ricerca sulla materia pura e di regalare alcuni dei massimi capolavori del genio umano. Il vecchio Michelangelo, abbandonando le polite levigatezze del David o della giovanile Pietà vaticana del 1499, cerca, attraverso la tecnica del non finito, di liberare lo spirito umano dal carcere della materia in piena sintonia con le teorie del Neoplatonismo cinquecentesco. E
una delle opere in cui più evidente è lo sforzo di liberare dal marmo il sussulto del divino è la Pietà Rondanini, alla quale Michelangelo lavorò dagli anni ’50 del Cinquecento fino alla morte avvenuta nel 1564. Proprio attorno a questo capolavoro mai finito, così importante per Milano, che sembra testimoniare un modernissimo conflitto spirituale, ruota la mostra «L’Ultimo Michelangelo» , curata da Alessandro Rovetta e visitabile nelle sale 13-15 del Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco dal 18 marzo. Fino all’otto maggio, con lo stesso biglietto è possibile conoscere un altro volto dell’eclettica produzione del genio di Caprese visitando l’attigua mostra «Michelangelo architetto nei disegni della Casa Buonarroti» a cura di Pietro Ruschi. Anche qui, paradossalmente, la poetica del non finito ha un suo spazio, perché non sempre l’attività architettonica di Michelangelo si è incarnata in quella materia da lui tanto amata, il marmo delle Apuane, dove già scorgeva nei blocchi informi colonne, mensole e capitelli. Più spesso, a causa delle tempestose vicende politiche e dei rovesci dei governi che coinvolgevano gli Stati della Penisola in quegli anni, di quest’arte monumentale sono rimasti solo segni a matita. su fogli di carta scoloriti a indicare la genialità e l’infinitezza di vedute dell’artista di Caprese. Il rapporto carta-marmo è, perciò, essenziale nelle due mostre. Perché ogni realizzazione ha alle spalle bozzetti, disegni, prove a matita. Come afferma Alessandro Rovetta: «Questa è un’occasione unica e irripetibile di ammirare i disegni dell’ultimo Michelangelo posti di fianco alla Pietà Rondanini. Si tratta di disegni di soggetto religioso che hanno un trattamento stilistico non dissimile da quello utilizzato per la sua ultima scultura». Ma le carte esposte non recheranno su di sé solo disegni, bensì anche le ultime Rime dell’artista di Caprese provenienti dalla Biblioteca Vaticana. Afferma ancora Rovetta: «Obiettivo della mostra è illustrare gli ultimi quindici anni di vita di Michelangelo. Oltre all’unico disegno preparatorio per la Pietà Rondanini, anticipato da una serie di studi che fin dagli anni Trenta evidenziano le preferenze compositive e tematiche culminate nella scultura oggi al Castello Sforzesco, sono presenti altri fogli sui quali Michelangelo affronta diversi soggetti sempre legati alla Passione e al legame tra Maria e Cristo. Spiccano in particolare sei drammatiche e commoventi Crocifissioni, considerate le sue ultime opere grafiche realizzate in una forma uasi trasfigurata, modernissima, molto simile al modo di lavorare il marmo della Rondanini».
Michelangelo Cercando l’assoluto
di Giorgio Rozza
in “Corriere della Sera” del 9 marzo 2011
“La riflessione sui linguaggi sviluppati dalle nuove tecnologie è urgente”.
È quanto ha ribadito oggi Benedetto XVI ricevendo in udienza i partecipanti all’assemblea plenaria del Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali.
Il Papa ha sottolineato l’importanza del “lavoro che svolge il Pontificio Consiglio nell’approfondire la ‘cultura digitale’, stimolando e sostenendo la riflessione per una maggiore consapevolezza circa le sfide che attendono la comunità ecclesiale e civile.
Non si tratta solamente di esprimere il messaggio evangelico nel linguaggio di oggi, ma occorre avere il coraggio di pensare in modo più profondo, come è avvenuto in altre epoche, il rapporto tra la fede, la vita della Chiesa e i mutamenti che l’uomo sta vivendo”.
Il Pontefice ha ricordato che “la cultura digitale pone nuove sfide alla nostra capacità di parlare e di ascoltare un linguaggio simbolico che parli della trascendenza.
Gesù stesso nell’annuncio del Regno ha saputo utilizzare elementi della cultura e dell’ambiente del suo tempo: il gregge, i campi, il banchetto, i semi e così via.
Oggi siamo chiamati a scoprire, anche nella cultura digitale, simboli e metafore significative per le persone, che possano essere di aiuto nel parlare del Regno di Dio all’uomo contemporaneo”.
Per Benedetto XVI, “è l’appello ai valori spirituali che permetterà di promuovere una comunicazione veramente umana: al di là di ogni facile entusiasmo o scetticismo, sappiamo che essa è una risposta alla chiamata impressa nella nostra natura di esseri creati a immagine e somiglianza del Dio della comunione”.
Per questo, “la comunicazione biblica secondo la volontà di Dio è sempre legata al dialogo e alla responsabilità, come testimoniano, ad esempio, le figure di Abramo, Mosè, Giobbe e i Profeti, e mai alla seduzione linguistica, come è invece il caso del serpente, o di incomunicabilità e di violenza come nel caso di Caino.
Il contributo dei credenti allora potrà essere di aiuto per lo stesso mondo dei media, aprendo orizzonti di senso e di valore che la cultura digitale non è capace da sola di intravedere e rappresentare”.
In conclusione il Pontefice ha ricordato la figura di padre Matteo Ricci, “del quale abbiamo celebrato il IV centenario della morte”: “Nella sua opera di diffusione del messaggio di Cristo ha considerato sempre la persona, il suo contesto culturale e filosofico, i suoi valori, il suo linguaggio, cogliendo tutto ciò che di positivo si trovava nella sua tradizione, e offrendo di animarlo ed elevarlo con la sapienza e la verità di Cristo”.

1. Vogliamo vedere Gesù
“Vogliamo vedere Gesù.” (Gio 12, 21). Era di fronte a loro, l’uomo, Gesù.
‘Non era che un uomo, canta Maria Maddalena nel film Jesus Christ Superstar;
e l’armonia sorprendente di quel canto ha attraversato, qualche anno addietro, le Contrade del mondo.
Non era che un uomo… Ma l’affermazione torna carica di evocazione e di mistero.
Non era che un uomo quando, entrato di sabato nella sinagoga, vi trova un uomo dalla mano inaridita: ‘e lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato e poi accusarlo…
– mettiti nel mezzo.
– è lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla?
– Ma essi tacevano.
– E guardandoli tutt’intorno, con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori,
disse a quell’uomo:
– stendi la mano!
– la stese e la sua mano fu risanata. (Cfr. Marco, 3, 1 e ss.)
Non era che un uomo quando la morte dell’amico lo sorprende.
– Se fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, suona carica di amarezza la voce
della Sorella…
– Tuo fratello risusciterà!
– So che risusciterà nell’ultimo giorno.
– Io sono la risurrezione e la vita. …
E, detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori!
E il morto uscì con i piedi e le mani avvolti in bene e il volto coperto da un sudario.
Gesù disse loro: Scioglietelo e lasciatelo andare.
Non era che un uomo quando gli portano una donna colta in flagrante adulterio e insinuano: Mosé, nella legge, ci ha ordinato di lapidare donne come questa.
Tu che ne dici?
Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra.
E sulla loro insistenza:
– Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra contro di lei.
E chinatosi di nuovo, scriveva per terra.
Ma quelli, udito ciò, se ne andarono, uno per uno, cominciando dai più anziani, fino agli ultimi.
– Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?
– Nessuno, Signore.
– Neanch’io ti condanno; va’ e non peccare più.
Non era che un uomo quando umiliato e vilipeso, sfigurato dal dolore, rivendica alta e sovrana la sua dignità.
– una delle guardie diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: così rispondi al sommo sacerdote?
Gli rispose Gesù: “ Se ho parlato male, dimostrami dov’è il male; ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?” (Gio. 18, 22-23)
– e al potente di turno che presume di avere ogni potere su di lui, ricorda:
“Tu non avresti alcun potere su di me se non Ti fosse stato dato dall’alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande.” (Gio.19, 11)
Non era che un uomo?
Il centurione romano lo accompagna, scorta d’onore, fino alla croce. Lo vede morire di una morte atroce, come può morire un uomo.
E tuttavia vedendolo spirare in quel modo, come nessun uomo muore, disse: “Veramente quest’uomo era figlio di Dio!” (Mc 15, 39).
Allora i Greci avevano ragione: volevano vedere Gesù. I suoi i gesti e le sue parole rivelavano, ma contemporaneamente nascondevano chi era veramente Gesù.
Dietro il volto palese e fascinoso si sottraeva la vera figura del Maestro:
restava nascosto il segreto di Gesù
RPR 10 marzo ’11

La purezza cristallina del suo pensare lo rivela come un teologo rigoroso (non per nulla è uno dei pochi a fregiarsi della laurea honoris causa di un’università così prestigiosa com’è quella di Heidelberg).
L’ardore della sua comunicazione scritta e orale ne manifesta la missione di pastore ecclesiale.
L’essenzialità trasparente e poco ornata del suo dettato ne denota la qualità di autore letto e ascoltato (per questo ha una specifica collana di libri che reca il suo nome).
L’intensità delle sue pagine e la testimonianza della sua vita gli assegnano il titolo che forse gli è più caro, quello di cristiano evangelico.
Stiamo parlando di Paolo Ricca, teologo, pastore, docente e credente appassionato, appartenente alla comunità valdese, ma anche fervido protagonista dell’ecumenismo.
Anche se egli, per primo, vorrà schermirsi dal profilo che abbiamo tracciato e ai miei occhi può far velo l’antico legame d’amicizia che a lui mi unisce, appoggio con calore la lettura delle sue pagine o l’ascolto dei suoi frequenti interventi radiofonici a Uomini e profeti di Rai 3, nonostante la diversità delle nostre situazioni (lui protestante, io cardinale della Chiesa cattolica).
Il suo messaggio, infatti, punta sempre al cuore dell’annuncio biblico, ove tutti i cristiani dovrebbero trovare la loro patria comune, ma la sua sensibilità è tale da coinvolgere anche chi non aderisce a questo o ad altro credo.
È il caso di un libretto che apparentemente è eterogeneo, perché raccoglie 17 contributi pubblicati o pronunciati in momenti e ambiti diversi, ma che si ricompone a mosaico proprio attorno al tema enucleato dal titolo, Le ragioni della fede.
In questo si svelano le nostre coincidenze di fondo: io stesso ho appena edito un libro intitolato Questioni di fede, muovendomi sul suo stesso territorio e partendo proprio con una sorta di “grammatica della domanda”, così come Ricca in apertura al suo testo delinea «l’uomo come domanda».
Fede e ragione sono state variamente coniugate e separate tra loro, anche secondo le diverse prospettive teologiche cattoliche o protestanti.
È per questo che Ricca opta per la formula «le ragioni della fede» e, per capire il suo approccio, è indispensabile citare un suo paragrafo: «Questa espressione ha un doppio significato.
Può significare in primo luogo le ragioni che la fede elabora su quello che crede, la fede cioè che pensa se stessa e riflette sul suo statuto e sui suoi contenuti, li illustra, li spiega, li motiva.
In secondo luogo può significare le ragioni che si possono addurre per credere.
Queste ragioni non sono prove né dimostrazioni, sono però argomenti che possono essere offerti alla riflessione di chiunque.
La fede, lo sappiamo, non viene dalla ragione e parlare delle ragioni della fede non significa affermare, implicitamente, che la fede abbia ragione.
Significa però darle la parola e invitarla a spiegarsi, sostenendo le sue ragioni.
La fede insomma non è muta e sa organizzarsi come discorso».
Proprio perché la fede non è cieca, segue un suo coerente statuto epistemologico che partecipa ma non si identifica con quello della razionalità (non è ciò che accade anche per l’arte e per il linguaggio d’amore?) e offre un suo progetto interpretativo profondo dell’essere e dell’esistere, dovrebbe essere normale che anche il non credente ascoltasse «le ragioni della fede».
Esse sono tutt’altro che assurde o infantili, come vorrebbe suggerire un certo ateismo nazionalpopolare molto sommario e superficiale.
Ricca in queste pagine opta per una serie di scorci: ad esempio, apre squarci sulla salvezza, sul pensiero, sulla misericordia, sulla giustizia, sulla libertà, sul «timore e tremore», sull’escatologia, su Paolo e Cristo.
Ma non teme di inoltrarsi sui sentieri d’altura, come nel caso del bellissimo capitoletto sull’«Ineffabile dai molti nomi», ossia su quel Dio che è, sì, trascendente e ineffabile ma invocabile, affidabile, reperibile.
Non esita neppure a costeggiare la frontiera.
Citando in questo caso Pico della Mirandola, si domanda se «il dubbio può essere l’anticamera della fede».
Lo stesso Manzoni, nella sua Storia della Colonna infame, consigliava che «è men male l’agitarsi nel dubbio che il riposar nell’errore».
Il nostro autore sottolinea il paradosso della fede nella quale il dubbio è legittimo e illegittimo al tempo stesso: «Sì, perché l’invisibile non si mostra, e qui il dubbio ci può stare; no, perché la fede, a modo suo, dimostra l’invisibile».
In questa luce si può condividere con Ricca la nota definizione del teologo Paul Tillich secondo la quale la fede è Mut zum Sein, o Courage to be.
Ci vuole coraggio per imboccare questa via perché il suo obiettivo è quello di condurti a essere e a comprendere l’ultima radice dell’essere.
Folgorante, come spesso gli accadeva, è Kierkegaard in Timore e tremore: «La fede è la più alta passione d’ogni uomo.
Ci sono forse in ogni generazione molti uomini che non arrivano fino ad essa, ma nessuno va oltre».
in “Il Sole 24 Ore” del 6 marzo 2011